Testo
Un po' di storia
[Torna all'indice]
Capitolo I.
Nascita e primi passi dell'opera in musica
Chi riuscirà mai ad ottenere che gli scrittori di Storie letterarie non dicano nei loro manuali che il melodramma è una creazione della «Camerata fiorentina»? Già da tempo i musicologi hanno messo in guardia contro questo errore, ma esso viene ancora ripetuto con una insistenza e una monotonia davvero sconfortanti.
La «Camerata fiorentina» era un'accolta di eruditi d'ogni specie che su la fine del cinquecento si adunava in Firenze nella casa del Conte Giovanni Bardi, e partito questi per Roma, continuò a riunirsi nella casa di Messer Jacopo Corsi. Nel numero di questi eruditi, letterati, umanisti, musicisti e poeti, era il liutista e compositore, Vincenzo Galilei, padre del sommo fisico, il quale sosteneva che si doveva «far ragionare un solo cantando et non tanti nell'istesso tempo come oggi (contr'ogni dovere) si costuma». Nei madrigali e in generale nella musica polifonica «tanti nell'istesso tempo» cantavano, e questo accadeva da almeno due secoli. La mira è dunque contro la polifonia[1] e in sostegno del canto monodico. Nello stesso tempo il cantore Giulio Caccini compone arie e canzonette a una sola voce, che poi raccoglierà nel 1601 sotto il titolo significativo di «Nuove Musiche».
Un altro intento ancora si proponevano gli uomini della «Camerata», e cioè di far rivivere la tragedia greca. Ma nulla sapevano della musica dei Greci, non ostante gli Inni di Mesomede pubblicati, ma non saputi interpretare, dal Galilei. Non avevano che delle cognizioni vaghe, tratte dalle letture dei classici. Partirono dall'idea di creare un recitativo che stesse tra il canto melodico e il discorso parlato, «una sorta di musica - scrive il Caccini - per cui altri potesse quasi che in armonia favellare», un «ragionare cantando». Erano persuasi, così facendo, di aver resuscitato la maniera di cantare «usata dagli antichi Greci nel rappresentare le loro tragedie». Chi poteva tenerli dal fare subito un tentativo? Ed ecco allora Jacopo Peri, detto «il Zazzerino» per la lunga e bella chioma, cantore anch'egli e dicitore finissimo, musicare nel 1599 la Dafne del poeta Ottavio Rinuccini. Entrambi erano componenti della «Camerata». Dell'opera non rimangono che frammenti dai quali non è possibile farsi un'idea precisa del risultato complessivo. E nulla ci rimane degli altri tentativi fatti fino dal 1590 da Emilio de' Cavalieri (altro cameratista) su la favola pastorale di Laura Guidiccioni: Il satiro.
Ma una grande occasione si presentava per un'altra prova più decisiva: le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia. Fra i festeggiamenti solenni che si fecero a Firenze in tale occasione, rimase memorabile la rappresentazione dell'Euridice del poeta Rinuccini, musicata dal Peri, avvenuta a Corte, e perciò davanti a un pubblico ristretto di nobili e di intellettuali, la sera del 6 ottobre del 1600. Due anni dopo il medesimo poema veniva musicato dal Caccini; e queste opere per fortuna ci sono rimaste. Ma questi ricercatori della tragedia greca, dopo aver scartato ogni soggetto tragico, e prescelto favole pastorali e mitologiche a lieto fine, infilano una serie di recitativi in cui la voce accentua con scarsi movimenti il suono o il significato delle parole, o accenna appena musicalmente le modulazioni del linguaggio naturale. Qua e là qualche breve coro pastorale, ancora in forma madrigalesca, se pure con un polifonismo attenuato; il tutto sostenuto dall'accompagnamento di un'orchestra formata di pochi istrumenti (liuti, chitarroni, cembali e qualche flauto) le cui parti non erano scritte, ma venivano improvvisate (o combinate alle prove) su un «basso cifrato», dove le cifre indicano le note fondamentali dell'accordo. In ben pochi momenti l'ispirazione del musicista si abbandona a slanci lirici che abbiano forma di melodia compiuta. Uno di questi è il canto trionfale di Orfeo che riconduce alla vita Euridice: «Gioite al canto mio», nell'opera del Peri.
Orbene, tutto questo non è la tragedia greca: su questo punto il fallimento è completo. Ma non è neppure quello che verso il 1650 verrà chiamato l'opera in musica, e più tardi il melodramma, cioè una successione di arie, recitativi, duetti concertati, non importa se staccati o fusi, in cui il canto, lirico o drammatico, accentri in sé il maggior interesse e la maggiore efficacia espressiva del dramma.
D'altra parte va ricordato che mentre solo alla fine del secolo XVI la Camerata fiorentina teorizza e procura di attuare la tragedia greca come manifestazione d'arte scenica poetico-musicale, già fino dai primi anni del secolo stesso in varie altre città d'Italia si pongono in musica tragedie, favole mitologiche e commedie. Vale la pena di ricordare L'Alidoro di Gabriele Bombasi, rappresentatesi a Reggio Emilia il 2 novembre 1568, e il Proteo pastor del mare musicato da Giuseppe Zarlino e Claudio Merulo su poesia di Cornelio Frangipane, e rappresentato a Venezia nel 1574 per la venuta di Enrico III, mentre a Modena, pare nel 1594, quell'arguto spirito e sommo polifonista che fu Orazio Vecchi, musicava per intero, ma in forma polifonica (e perciò scenicamente irrappresentabile) e senza accompagnamento strumentale, una «commedia harmonica» di sua invenzione, con gli immortali tipi delle nostre maschere (ciascuna delle quali si esprime a mezzo di un coro di cinque voci), con scene burlesche, satiriche, sentimentali e drammatiche, intitolato L'Ampfiparnaso. Il faceto vi si sposa al grave, perchè, scrive il Vecchi, la musica dev'essere «specchio dell'humana vita». Alle vicende amorose di Lucio e di Isabella, che sfiorano la tragedia, si intrecciano i capricci senili di Pantalone per la cortigiana Ortensia, le presuntuose ambizioni del Dottor Graziano per la figlia di Pantalone e le spropositate strampalerie dei suoi madrigali, le spagnolesche pose di conquistatore del Capitan Cardon, che Isabella finemente deride e delude, le ingenue schiocchezze e furberie dei servi Pedrolino, Zane e Francatrippa, e, capolavoro d'umorismo, il dialogo di questi con gli Ebrei. Anche senza l'orchestra, anche senza la possibilità di visione scenica, sta di fatto che nell'Ampfiparnaso (come più tardi nelle Veglie di Siena dello stesso Vecchi) situazioni e caratteri sono musicalmente scolpiti con forza rappresentativa. Ed è per questa forza che Ampfiparnaso e Veglie debbono essere considerate «teatro» più ancora delle modeste espressioni monodiche dell'Euridice di Peri e di Caccini.
Ma all'opera in musica tendevano potenzialmente i drammi liturgici, e le rappresentazioni sacre del medioevo, e i popolari «maggi» dell'appennino tosco-emiliano; ed antica era la consuetudine di introdurre .musiche fra le scene e nelle scene di drammi e di commedie, mentre totalmente musicati erano gli «intermezzi», piccole commedie e farse che si inserivano fra un atto e l'altro delle tragedie e commedie rappresentate, per sollevare e riposare (notate il delicato pensiero!) lo spirito degli uditori.
Tutto questo ci avrebbe condotto fatalmente al melodramma anche senza la Camerata fiorentina, la quale mirava non a creare una forma d'arte nuova, ma a ripristinarne una antichissima.
Nello stesso anno 1600 in cui si eseguiva l'Euridice di Peri, a Roma Emilio de' Cavalieri faceva eseguire la Rappresentazione di Anima et di Corpo, su testo del Padre Agostino Manni. Era questa una rappresentazione scenica di carattere morale-religioso che si distoglieva dalle fiabe mitiche per mettere in scena il conflitto fra il piacere e la virtù, fra il Corpo che agogna il piacere dei sensi e l'Anima che aspira alla purità della vita e alle gioie ultraterrene. I recitativi hanno un carattere un po' più mosso e drammatico di quelli dell'Euridice, i cori presentano maggior vivezza di ritmi.
Un passo decisivo verso il melodramma fu però compiuto solo sette anni dopo, quando il 24 febbraio 1607 alla Corte dei Gonzaga a Mantova venne rappresentato l'Orfeo di Claudio Monteverdi, composto su poesia di Alessandro Striggio figlio. Il Monteverdi ha dato nuova vita al recitativo intensificandone l'espressione, allargandone e melodizzandone le linee, così da farne una specie di «arioso», di canto lirico, narrativo, o drammatico. Inoltre non rifugge dalle forme strofiche, ed anche da melodie del tipo «canzone a ballo» in cui l'elemento popolaresco della melodia porta un nuovo contributo di schiettezza, di varietà e di bellezza. Amplia e rende più numerose le sinfonie strumentali e i ritornelli dando loro un carattere descrittivo o psicologico. Non scrive ancora, salvo rari casi, le parti degli strumenti negli accompagnamenti ma segna momento per momento quali di essi debbono suonare, con evidenti precise intenzioni drammatiche e descrittive; ne accresce anche il numero introducendo organi, violini, viole, bassi da gamba, cornetti, trombe, tromboni, flauti e clarinetti. Mentre nell'Euridice di Peri e di Caccini la caratterizzazione dei personaggi era scarsa o nulla, nell'Orfeo di Monteverdi e nelle sue opere successive il canto penetra nello spirito dei personaggi e li individua fortemente, anche con una opportuna scelta dei registri di voce più adatti. In qualche pagina la profonda umanità dell'espressione drammatica del canto è tale che oggi, dopo tre secoli, non possiamo desiderarla maggiore. Valga come esempio il racconto della Messaggera che annunzia la morte di Euridice, così pieno di doloroso stupore e di orrore, e lo sconsolato pianto di Orfeo e il suo sublime addio alta Terra e al Sole allorché delibera di scendere agli Elisi per riportare con sé la sposa. Con queste pagine nasce per la prima volta nella storia della musica l'espressione tragica.
Il successo dell'opera fu enorme, ma il Cremonese ne scontava la gioia con un atroce dolore: quello della morte della sua giovane moglie Claudia Cattaneo. Nell'opera che scrisse l'anno successivo in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Francesco Gonzaga con Margherita di Savoia, l'Arianna, l'eco di questo suo dolore è passato nel famoso «lamento»: «Lasciatemi morire», che purtroppo è l'unico superbo frammento che di essa ci rimanga. Dal fondo della più cupa disperazione era sorta la voce melodiosa del più accorato rimpianto: il dolore è divenuto poesia e sollevato verso le stelle come una fiamma votiva.
Ormai l'esempio del Monteverdi è seguito altrove, con varia fortuna; specialmente a Roma, ove compongono opere maestri illustri come Domenico Mazzocchi, Marco Marazzoli, Stefano Landi e Luigi Rossi, mentre accanto al Monteverdi scrive il fiorentino Marco da Gagliano, il quale tuttavia appare ancora in gran parte legato agli schemi teorici della «Camerata fiorentina».
Però l'opera romana acquista caratteri differenti, sia perchè il recitativo perde d'interesse, mentre emerge l'aria e la canzone strofica, sia perchè il gusto della società romana, di cui si faceva interprete nei suoi libretti il cardinale Giulio Rospigliosi (poi Papa Clemente IX), andava verso una rappresentazione in cui la scenografia, la coreografia e le macchine fantasiose (nubi e carri sospesi tra ciclo e terra con apparizioni di divinità, draghi e mostri di varia natura, voragini infernali che vomitavano fiamme, improvvise trasformazioni di scene) tendevano ad avere maggiore interesse della musica. Dell'importanza che si attribuiva alla scenografia fa testimonianza il fatto che essa fu in vari casi affidata a un artista dell'altezza di Gian Lorenzo Bernini.
Ora, è da ricordare che il Teatro Barberini, nel quale avevano luogo a Roma gli spettacoli d'opera, se non era aperto al pubblico pagante, era però capace di 3000 posti, il che praticamente equivale a uno spettacolo pubblico. Ma nel 1637 il musicista e poeta Benedetto Ferrari si reca a Venezia, acquista l'antico teatro S. Cassiano e lo apre al pubblico con l'Andromeda, opera composta su un suo libretto dal musicista romano Francesco Manelli. Con questa esecuzione l'opera romana viene trapiantata a Venezia e vi subirà nuovi sviluppi. Ma l'avvenimento sensazionale non è l'opera del Manelli, bensì l'apertura al pubblico di un teatro d'opera. Ciò avrà un'importanza enorme non solo per la diffusione di una forma d'arte ormai consacrata dal genio di tanti artisti, e specialmente del Monteverdi, ma per l'influenza che il pubblico, coi suoi gusti e le sue tendenze, eserciterà sull'opera stessa.
Non è a dire quale entusiasmo destasse questa novità, di cui già tanto si era sentito parlare, in termini della più mirabolante ammirazione, così da suscitare la più acuta curiosità di chi non aveva avuto la fortuna di assistervi. Il nuovo pubblico non aveva la cultura, l'educazione artistica, la finezza di gusto del pubblico umanistico presso il quale l'opera era stata tenuta a battesimo. Era un pubblico chiassoso, incolto, dai gusti semplici, schietti, popolani, però assai pronto a intendere e ad assimilare, facile all'entusiasmo come all'ira, ricco di fantasia, aperto alla poesia quando questa giungeva fino a lui per le vie più immediate. Un pubblico che portava nel teatro le passioni della strada, in cui si formavano partiti i quali sostenevano questo o quell'artista con un fanatismo che oggi, in termine sportivo, si direbbe «tifoso».
Davanti a questo pubblico il già vecchio Monteverdi, ormai da quasi trent'anni Maestro della Serenissima, fece rappresentare nel 1642 l'ultima sua opera, il suo capolavoro massimo: L'Incoronazione di Poppea. L'anno dopo il glorioso Musicista si spegneva all'età di 76 anni, ma lasciava un grande allievo: il cremasco Francesco Caletti Bruni, più noto come Cavalli, dal nome del suo protettore.
L'Incoronazione di Poppea, su libretto di Gian Francesco Busenello, reca nell'opera elementi nuovi: anzitutto il distacco dai soggetti mitologici e pastorali e l'ambientazione storica. Qui non più Orfeo, Arianna, Ulisse, ma Nerone, Seneca, Ottavia, Poppea sono i personaggi principali. Non combattimenti con mostri, non intervento di divinità, ma avvenimenti umani, crudeli come l'uccisione di Seneca e il ripudio di Ottavia, sensuali come gli amori di Nerone e Poppea, psicologici come l'ambizione e l'astuzia di Poppea per salire al trono.
Il recitativo monteverdiano si fa anche più penetrante, e plasma con forza e con rilievo i caratteri dei personaggi. La musica crea atmosfere e contrasti, scende negli intimi recessi del cuore umano e con pennellate vivide ne mette in luce miserie e grandezze, gioie e tormenti, entusiasmi e abbattimenti, nobiltà e frodi. E vi appare anche l'elemento comico, nuovo alla scena musicale, che Monteverdi aveva già affrontato nell'indimenticabile figura di Iro il pitocco nell'opera Il ritorno di Ulisse. La comicità nell' Incoronazione di Poppea sprizza dalle macchiette dei due soldati poltroni che dovrebbero far la guardia agli amori di Nerone, e invece si addormentano, e svegliati di soprassalto maledicono l'Imperatore, la sua amante, e Roma, e la milizia! Un'altra scena festevolmente umoristica è quella della Damigella che insegna il bacio al Paggetto. Il tragico emerge invece nell'austera morte di Seneca e nel pianto dei suoi amici, e nell'addio a Roma di Ottavia ripudiata; il cinico nei canti di Nerone e dei suoi commensali per la morte di Seneca. Ma non mancano neppure episodi secondari nei quali il Maestro trasfonde un senso di grande poesia, come nella canzone di Arnalta per addormentare Poppea.
Il Cavalli alitò nei suoi canti una grande nobiltà di sentimento, raggiunse anche in certe scene una forte intensità drammatica e lirica, ma non ci lasciò opere di così perfetta unità stilistica e di così continua ispirazione, come sono l'Orfeo e la Incoronazione. In Monteverdi aria e recitativo formano un tutto unico; con Cavalli incominciano già a staccarsi. Ma ci sono in talune opere di Cavalli arie in cui la melodia raggiunge un'ampiezza di respiro inusitata, e certi recitativi impressionano per la loro incisiva potenza. L'elemento magico trova in lui un rilievo plastico efficace, com'è nel recitativo e aria di Medea nell'opera Giasone (1649), e vigoria di tinte mostrano pure i quadri d'assieme. Ma quando Re Serse esprime il desiderio di una vita libera dalle gravi cure e dalle ipocrisie delle Corti, la sua musica tocca accenti di nuova e malinconica nostalgia; e nell'espressione del pianto, come nell'aria «Piangete occhi dolenti» dell'Egisto, il musicista raggiunge una verità commovente. Dopo il «lamento d'Arianna» molte altre opere della seconda metà del seicento contengono «lamenti»: la forma espressiva ha toccato la sensibilità del pubblico ed è divenuta popolare.
Con Fra Marcantonio Cesti, aretino, la melodia acquista ancor più in finitezza formale, e rivolge il suo campo espressivo ai sentimenti amorosi, ai quali particolarmente si mostra sensibile la vena del musicista che, malgrado la tonaca fratesca, sembra non fosse indifferente alle grazie femminili. La sua ispirazione è tenera e languida, mollemente sensuale, e pure non priva di poesia e di spiritualità. Una delle pagine più significative è certo la bellissima aria «Intorno all'idol mio» dell'opera Orontea (1649) tutta un sospiro carezzevole e commosso. È questa un'«aria del sonno», forma delicatamente cullante e sognante che, dopo quella di Arnaita nell'Incoronazione di Poppea del Monteverdi, diventerà anch'essa una specie di luogo comune indispensabile in ogni opera che voglia farsi applaudire.
Col bergamasco Giovanni Legrenzi entra nell'opera la grazia leggera della canzonetta, mentre il recitativo perde sempre più d'importanza e diventa ormai il «recitativo secco» inespressivo e monotono, cioè un recitativo fatto di alcune formule vocali che si ripetono con insistente uniformità, senza alcun nesso espressivo con la parola o tutt'al più con le inflessioni vocali del linguaggio parlato. Ci si avvia dunque verso un più aperto indirizzo edonistico, dove il fine non è più l'espressione dei caratteri, dei sentimenti e delle situazioni, ma il piacere di una melodia bella in sé stessa e cantata (ed anche infiorata di vocalizzi arbitrari) da una bella voce. Al di sopra del compositore incomincia ad emergere la personalità del cantante, che diverrà nel Settecento un vero tiranno del teatro.
Se con Alessandro Stradella, modenese, i vocalizzi diventano ormai un sistema obbligato che l'autore accetta scrivendoli egli stesso, va però segnalato che il musicista tende a volgerli a fine espressivo. Ma di Alessandro Stradella dev'essere ricordato pure che è il primo autore di un'opera totalmente comica. Dopo le scene comiche, rare in verità, sparse dal Monteverdi nelle ultime sue opere, l'introduzione di personaggi buffi (caricature e macchiette di vecchi balordi, di servi marioli, di soldati smargiassi, di nutrici sguaiate, di gobbi e di balbuzienti) diventa sempre più frequente ed ha l'evidente scopo di creare una maggiore varietà nell'opera e di controbilanciare le scene patetiche e drammatiche. Nell'opera di Stradella Il Trespolo tutore abbiamo finalmente la prima «opera buffa».
I precedenti dell' «opera buffa» si trovano non solo nelle scene e nei personaggi comici introdotti, dal Monteverdi in poi, in tutte le opere serie, perfino in quelle di carattere sacro come il Sant'Alessio di Stefano Landi, ma anche negli «intermezzi», ai quali s'è precedentemente accennato, quasi tutti di carattere burlesco o satirico. Se si vuole risalire a precedenti più lontani conviene pensare all'Amfiparnaso, alle Veglie di Siena e a certe canzonette di Orazio Vecchi, alla Pazzia senile e alle altre composizioni del genere di Adriano Banchieri, al Cicalamento delle donne al bucato di Alessandro Striggio padre, alla Trincea musicale di Giovanni Croce, tutte forme madrigalesche; e più indietro ancora alle «villote» quattrocentesche [2]. Ma in tempi più recenti già tentativi d'opera buffa si possono considerare la Diana schernita di Giacinto Cornacchioli, su libretto di Giacomo Francesco Parisani, eseguita in Roma nel 1629, benché si tratti di favola pastorale; e successivamente Il falcone di Mazzocchi e Marazzoli, Dal bene al male di Marazzoli e Antonio Abbatini, entrambe su libretti del cardinale Rospigliosi, eseguite rispettivamente nel 1639 e nel 1653. Più decisamente sulla via di quella che sarà l'opera buffa dei secoli successivi, è La Tonda o Il Podestà di Cològnole di Jacopo Melani, la cui esecuzione avvenne in Firenze nel 1657. Ma Il Trespolo di Stradella, su libretto (in verità molto modesto) di Giov. Batt. Ricciardi, è, per la musica e per il soggetto, già completamente nello spirito di quella che dal settecento in poi fu conosciuta per «opera buffa», ed il protagonista è il capostipite di tutti i vecchi balordi di cui pullulano le opere buffe dei secoli XVIII e XIX, fino al Dottor Bartolo del Barbiere rossiniano. Del Trespolo di Stradella non si conosce la data della rappresentazione. Tutta la vita e l'opera di questo compositore e rapitore di fanciulle e di spose, perseguitato dai suoi rivali, ferito a Torino e alla fine assassinato a Genova nel 1682, è avvolta nel più fitto mistero. Ma da varie osservazioni si può precisare che «Il Trespolo» non fu eseguito prima del 1679.
Frattanto, nel 1651 il melodramma raggiunge anche Napoli. Francesco Provenzale, il quale viene considerato come il fondatore della «scuola napoletana» contribuisce alla sua affermazione e diffusione con opere proprie, seguito subito dal ben più robusto, estroso e fecondo Alessandro Scarlatti, palermitano, padre del grande clavicembalista Domenico. Alessandro portò nel melodramma una purezza di forme, un'eleganza stilistica e un aperto quadrato senso della melodia vocale in cui palpitano una grazia e un calore del tutto meridionali. Egli inoltre dette all'armonizzazione più sciolta libertà di movenze e audacia di atteggiamenti, rese più denso il contrappunto e arricchì l'orchestra, di cui gli archi formano ormai la base fondamentale, ridonandole quell'efficacia drammatica che dopo il Cavalli si era venuta perdendo. Scarlatti compose 117 opere teatrali: numero cospicuo che è prova di una fecondità sbalorditiva se si tien conto che non a queste sole si limita l'attività di Scarlatti padre, ma che alle opere teatrali bisogna aggiungere 600 cantate, una ventina di oratori, circa 200 messe e varia altra musica sacra e strumentale. Di tali opere alcune, quali il Mitridate Eupatore (1707), il Tigrane (1715), la Griselda (1721), rimasero per lungo tempo modelli di perfezione stilistica anche ai musicisti stranieri. Altra novità da non trascurare è l'intenzione drammatica per la quale Scarlatti non si fa scrupolo, se l'azione lo richiede, di spezzare e non concludere un'aria, ed anche di fissare di frequente un'orchestrazione sotto determinati recitativi (il che era stato fatto saltuariamente anche da Stradella) costituendo così quello che venne chiamato «recitativo obbligato». Va ricordato inoltre ch'egli fissò la sinfonia, non drammaticamente legata al soggetto dell'opera, in tre movimenti: un Allegro, un Grave e un Balletto, e che questo schema ebbe pure una lunga stabilità, così in Italia come all'estero.
Dopo che in Italia si aprirono teatri al pubblico, la popolarità e l'entusiasmo che circondarono il melodramma destarono la più viva attenzione degli stranieri. Coloro di essi che avevano potuto assistere ai nostri spettacoli scrissero ai loro paesi meraviglie di questa originale creazione e dei nostri cantanti. Ben presto i nostri compositori e i virtuosi vennero chiamati all'estero; il melodramma italiano inondò come una enorme marea musicale l'Europa, e trovò imitatori.
La Germania ebbe in Enrico Schutz, allievo di Giovanni Gabrieli, l'artista che apriva gloriosamente la via al melodramma italiano innestandolo su l'arte tedesca. Egli musicò di nuovo la Dafne del Rinuccini in un rifacimento di Martino Opitz, e la fece eseguire a Torgau nel 1627. Il tentativo però di creare un'opera nazionale andò fallito, non ostante gli sforzi di taluni musicisti tedeschi sapienti e non privi di vena, quali Sigismondo Kusser, Reinhard Keiser e Gaspare Kerl. Il primo favorì l'importazione di opere e di musicisti italiani; il secondo, fecondissimo, appare drammaticamente debole e anch'esso troppo influenzato dall'arte nostra e in special modo da quella di Agostino Steffani. Anche il Kerl è un imitatore di Pier Francesco Valentini e di Giacomo Carissimi.
Fra le opere italiane che ebbero maggior successo in Germania meritano di essere ricordate l'Egisto di Cavalli, il Paride di Giov. Andrea Bontempi, l'Enrico Leone dello Steffani. La festa di Imeneo di Attilio Ariosti, e il Polifemo di Giovanni Bononcini.
In Inghilterra i primi saggi del melodramma italiano giunsero con le opere di modesti autori, quali Tommaso Lupo, Angelo Notari e, meglio, Alfonso Ferrabosco. Solo nella seconda metà del Seicento vi si recò un artista veramente insigne: Bernardo Pasquini. Sotto l'influenza diretta dell'opera italiana, e in particolare dello stile del Pasquini, si sviluppa e si rivela il maggior compositore inglese del secolo XVIII. Fu questi il precoce Enrico Purcell (a nove anni pubblicava la prima composizione) i cui maestri erano stati allievi di Giambattista Lulli. Delle sue opere teatrali solo Didone ed Enea (1689) ci è giunta intera, ed è l'unica interamente musicata, mentre si sa che delle altre musicò solo talune parti liriche. Egli volle adattare il «recitar cantando» dei fiorentini alle inflessioni della lingua inglese, e perciò il suo modo di cantare è strettamente legato alla pronuncia di tale lingua, così da perdere gran parte della sua efficacia in una traduzione. D'altra parte la morte, avvenuta a soli trentasette anni, impedì a Purcell di portare a maturità le doti musicali di cui era riccamente fornito.
Fu il Cardinal Mazzarino a far conoscere ai Francesi il melodramma e i cantanti italiani. La prima opera, eseguita a Parigi nel 1645, fu il Nicandro e Fileno di Marazzoli. Nello stesso anno veniva rappresentata La finta pazza del parmigiano Francesco Paolo Sacrati. Ma il trionfo decisivo lo riportò l'Orfeo di Luigi Rossi (su libretto dell'abate Francesco Buti) andato in scena nel 1647; opera di squisita bellezza lirica, anche se povera di drammaticità, di una fantasiosità scenica senza pari, ma di una lunghezza estenuante (durava sei ore!). Il successo determinò una reazione nazionalistica francese: l'autore e il Cardinale protettore furono attaccati con satire e parodie. Mazzarino mandò taluni degli avversar! alla Bastiglia, e chiamò altri maestri italiani, fra i quali Carlo Caproli, di cui fu eseguita la commedia-ballo Le nozze di Peleo e di Theti, e il Cavalli di cui furono eseguite le opere Serse e l'Ercole amante. E chiamava in Francia anche un architetto italiano, il modenese Gaspare Vigarani, per affidargli la costruzione del teatro delle Tuileries.
Intanto due artisti francesi, il poeta Pietro Perrin e il musicista Roberto Cambert, tentarono di creare un'opera nazionale, ma non ebbero fortuna e i due autori-impresari fallirono. Un ballerino e violinista d'origine fiorentina, che era già entrato nelle buone grazie di Re Luigi XIV per il successo ottenuto da certi balletti da lui musicati, riuscì a subentrare ai falliti, ed ebbe inoltre dal Re la direzione di tutte le istituzioni musicali di Francia: quest'uomo si chiamava Giambattista Lulli. A quest'Italiano era riserbata la creazione dell'opera nazionale francese. Egli passò dalla composizione dei balletti a quella di melodrammi, associandosi come poeti Giovanni Battista Molière e Filippo Quinault. L'innovazione più importante ch'egli introdusse nell'organismo melodrammatico fu la fusione del ballo con il dramma. In questo egli colse nel gusto speciale dei Francesi, i quali erano fanatici dei balletti fino da quando un altro italiano, il torinese Baltazarini, detto Beaujoyeux, aveva presentato ai parigini nel 1581 il Ballet comique de la Reyne. Da allora i Ballets de cour furono la delizia del pubblico francese.
Nelle sue opere Lulli modifica anche la sinfonia, che chiamò ouverture, invertendo l'ordine dei movimenti della sinfonia scarlattiana, e cioè portando l'Allegro al centro e il Grave ai due estremi. Inoltre fonde i recitativi alle arie e ai duetti passando dall'una all'altra forma insensibilmente, variando anche spesso il ritmo, per modo che ne risulta un più sentito movimento di vita e una maggiore unità. Ma l'eleganza leggera e l'inflessione lirica del suo linguaggio musicale, aderente alla recitazione dei grandi tragici francesi, è il carattere pel quale la sua arte assurge ad arte nazionale francese.
È pure nota l'eccellenza delle sue esecuzioni; insignito di poteri pressoché dittatoriali, egli creò scuole, rifece dalle basi orchestre e cori, istruì sonatori e cantanti. Direttore esigente, talvolta anche violento, dotato di un senso ritmico eccezionale, egli otteneva una perfezione di attacco (il famoso «coup d'archet») e una fusione che gli crearono attorno una fama mondiale. Taluno parlò di Lulli come di un uomo senza scrupoli e moralmente abbietto. Non è possibile oggi dire quanto ci sia di vero e di inventato, poiché egli fu anche odiato da coloro che furono toccati nei loro interessi dalla sua attività. Certo è che violento, almeno quando dirigeva, doveva esserlo se a qualche suonatore disattento ruppe il violino sulla testa. Nella foga di battere il tempo (dirigeva con un grosso bastone che percuoteva al suolo per marcare il ritmo) si colpì con tale violenza un piede da ferirsi gravemente. La ferita degenerò in cancrena che lo condusse a morte. «Bruciate l'ultima vostra opera, se volete l'assoluzione» gli disse il sacerdote che lo aveva confessato; ed egli obbedì. Poco dopo, rimproveratene da un amico, gli rispondeva malizioso e tranquillo: «Ma ne avevo un'altra copia!»
Fra le sue opere più perfette sono Thesée, Isis, Atys, che fu la preferita di Luigi XIV e fu detta perciò «l'opera du Roi»; e soprattutto Acis et Galathée (1686), favola pastorale, ricca di fresca poesia.
Per oltre un secolo l'arte di Lulli dominò in Francia ed ebbe imitatori anche all'estero, ma nessuno dei compositori francesi venuti dopo di lui, neppure il migliore di essi, che fu Antonio Charpentier, seppe sollevare l'opera al di sopra della mediocrità.
[Torna all'indice]
Capitolo II.
Fasti e nefasti dell'Opera nel Settecento
Sul principio del settecento, non ostante i nobili sforzi dello Scarlatti, il melodramma era già in piena decadenza. Esso non era ormai che un'infilata di arie e di duetti, con qualche raro pezzo a più voci e, ancor più raramente, qualche coro; il tutto inframezzato ma non collegato da monotoni «recitativi secchi», sempre uguali a sé stessi, senza alcun valore artistico. In Francia, come s'è detto, l'azione drammatica si era fusa con la rappresentazione coreografica. All'opera il pubblico andava per la spettacolosità della scenografia, per lo sfarzo dei costumi, e soprattutto delle macchine celesti e infernali, e per udire le meravigliose trine di note che uscivano dalle voci dei cantanti, e tutto ciò destava fanatismo.
L'enorme diffusione e interesse del pubblico per il melodramma costrinse a creare appositi teatri. È in quest'epoca che, su disegni di architetti illustri, sorgono i più sontuosi teatri d'Italia: la Fenice di Venezia e il Nuovo (oggi Comunale) di Trieste, entrambi di Giannantonio Selva, il Filarmonico di Verona di Francesco Bibbiena, il Comunale di Bologna di Antonio Bibbiena, la Scala di Milano di Giuseppe Piermarini, il Regio di Torino (ora distrutto da un incendio) di Benedetto Alfieri, l'Argentina di Roma di Girolamo Teodoli, il San Carlo di Napoli di Angelo Caravale. Modelli di eleganza signorile e di acustica perfetta.
Il trionfo della monodia, permettendo alle voci di emergere da sole, aveva fatto fiorire in Italia l'arte del canto solista. Insegnanti privati, e più tardi i Conservatori musicali, educavano al bel canto coloro che, dopo avere iniziato ancora fanciulli la loro carriera, come spesso accadeva, nelle chiese, conservavano, trascorsa la fanciullezza, una voce chiara e sonora, pur cambiando registro. E l'insegnamento durava a lungo, poiché l'allievo doveva superare tutta una serie crescente di virtuosistiche difficoltà, per riuscire finalmente o modulare la voce con la più perfetta sicurezza nelle maniere più svariate, usignolesche e funambolistiche. Il pubblico andava pazzo per questi cantanti, i migliori dei quali raggiungevano una pronta celebrità. Potevano allora permettersi tutto quello che volevano, trasformando la purezza di una melodia, foss'anche la più ispirata e celestiale, in una girandola di suoni, in un vortice di note, in un miracoloso prodigio di svolazzi e di arabeschi. Il pubblico si beava a questa pirotecnia sonora e non prestava più attenzione ai recitativi. Ascoltava in silenzio i grandi virtuosi, «i divi», ma chiacchierava ad alta voce chiamandosi e rispondendosi dalla platea ai palchi durante i recitativi, e divorava sorbetti quando le parti di secondo piano cantavano le loro arie, che appunto per ciò vennero chiamate «le arie del sorbetto». La decadenza doveva essere già molto avanzata nella seconda metà del seicento se Salvator Rosa, il quale oltre che paesista stupendo era musico estroso e poeta, poteva scrivere: «Musica pregio vil d'anime basse», prendendosela con la diffusione e l'importanza che la Musica aveva assunto presso le Corti:
«Alla musica in Corte ogn'uno attende,
«Do, Re, Mi, Fa, Sol, La canta chi sale,
«La, Sol, Fa, Mi, Re Do, canta chi scende».
La causa prima della decadenza dell'opera in musica deve ricercarsi nel suo contatto col pubblico, il quale dimostrò subito di intendere e preferire la musica sotto la specie di un edonismo sensoriale: godimento d'occhi e d'orecchi. Esso voleva divertirsi: «parola odiosa per un autore», scriverà Verdi un secolo e mezzo dopo. Gli impresari, - perchè ormai, dopo l'apertura di pubblici teatri, è sorta anche questa categoria di mercanti dell'arte musicale - per desiderio di lucro si erano fatti tiranni di musici e di poeti, imponendo loro i gusti dei clienti e infischiandosi della verità drammatica e della nobiltà dell'arte. Fra i maggiori clienti ben paganti erano i protettori illustri delle cantanti, le quali pertanto imponevano agli impresari e ai compositori i loro capricci, spesso stravagantissimi. Né meno vanitosi erano i cantanti maschi, la maggior parte evirati per ottenere una voce di soprano particolarmente limpida e dolce: la cosidetta «voce bianca». A costoro erano affidate le parti principali, mentre i baritoni e i bassi venivano sacrificati in parti odiose. Cosicché il compositore rinunziava, per necessità di guadagno, alla libertà della propria fantasia e alla propria dignità di artista, mentre i poeti, anch'essi ridotti in schiavitù, degradavano l'arte librettistica ad un puro mestiere. Tanto, la scelta dei soggetti, lo sviluppo del dramma, la psicologia dei caratteri e la stessa fattura dei versi non interessavano più nessuno. Verrà poi il momento che si andrà a teatro principalmente per godere lo spettacolo che il pubblico offre a sé stesso con lo sfarzo degli abbigliamenti, e per passare qualche ora in piacevoli conversazioni ed altri passatempi. Allora non si baderà neppur più alle arie, e un maestro famoso come Tommaso Traetta sarà costretto a levarsi dal suo posto al cembalo per pregare il pubblico di un po' di attenzione ad un'aria ch'egli riteneva avesse qualche pregio.
Le arie dovevano essere preferibilmente gaie e leggère, su strofette agili di settenari, senari e quinari; più canzonette che arie. Del resto, come dicevamo, serie o gaie, i virtuosi le infioravano e soffocavano di gorgheggi a loro arbitrio. Il Metastasio offriva i più autorevoli e ammirati modelli della librettistica settecentesca, seguito da una turba di mediocri imitatori.
Già fino dai primi esperimenti monodisti della Camerata fiorentina il canto fu oggetto di studio e di cure speciali, e alle esecuzioni dell'Euridice di Peri e di Caccini, come poco dopo a quelle delle opere di Monteverdi, presero parte artisti di grande abilità e di stupenda voce. Gli stessi Peri e Caccini furono cantanti ammirevoli, e così le figlie del Caccini, Francesca detta «la Cocchina» e Settimia. Celebri cantanti furono pure Francesco Rasi, Melchiorre Palantrotti (basso), la moglie di Monteverdi Claudia Cattaneo. Poi Virginia Andreini detta «Florinda», moglie al poeta Giov. Batt. Andreini e grande interprete dell'Arianna di Monteverdi, la quale sostituì un'altra giovanissima, bellissima e celebre artista: Caterina Martinelli detta «la Romanina», morta di vaiolo poco prima dell'andata in scena dell'opera. nè va dimenticata Adriana Basile detta «la Sirena di Posilipo», che cantava accompagnandosi su l'arpa o su la chitarra spagnola, dei quali istrumenti era espertissima suonatrice. Anche la sorella Margherita e la figlia Eleonora, detta «Adrianella», furono valenti cantatrici del secolo XVII.
Il settecento delirò per le voci d'oro e le ugole meravigliose di Balda&sarre Ferri, di Gaetano Majorana detto «Caffarelli», di Francesco Grossi detto «Siface», che fu trucidato per gelosia (ed era un sopranista...); di Carlo Broschi detto «Farinelli», che il Metastasio chiamava nelle lettere «mio adorabile gemello», e il poeta Tommaso Crudeli «Orfeo novello». Di lui si diceva che avesse guarito col canto Filippo V di Spagna dall'ipocondria e salvato da morte Ferdinando VI. Ma Farinelli va ricordato come un'eccezione fra i suoi simili per la cultura, la distinzione, il disinteresse e la modestia. Non altrettanto può dirsi di Francesco Bernardi detto «il Senesino», di Gaspare Pacchierotti, di Luigi Marchesi detto «Marchesini» che lo Stendhal chiama «l'ammaliatore», e pel quale tutte le donne impazzivano; di Gioacchino Conti detto «Gizziello», di Antonio Bernacchi, di Giovanni Carestini detto «Cusanino», di Vittoria Tesi, di Brigida Banti, di Faustina Bordoni, sposa del compositore Adolfo Hasse, di Caterina Gabrielli, di Marianna Benti Bulgarelli (la «Romanina» del Metastasio), di Francesca Cuzzoni. Tutte voci incantevoli e artisti di una abilità virtuosistica più da istrumento che da voce umana, capaci di far piangere se cantavano con espressione, di sbalordire se si mettevano a fare variazioni; ma tutti di una vanità spropositata, presuntuosi, prepotenti, capricciosissimi.
Si narra che una volta, mentre cantava il Pacchierotti, l'orchestra si fermò di suonare. «Che fate?» domandò l'artista; gli fu risposto: «Piangiamo!». Caterina Gabrielli, invitata in Russia, chiese alla czarina una somma enorme. «Pago appena così i miei marescialli» le disse Caterina II. «Ebbene - rispose spavalda andandosene la Gabrielli - fate dunque cantare i vostri marescialli». Ma la Sovrana la richiamò.... e pagò. Il Marchesi pretendeva di entrare in scena scendendo da un colle, con elmo piumato in testa e rilucente armatura. Uno squillo di tromba doveva annunziarne l'arrivo; poi, giunto alla ribalta, cantava invariabilmente una tenerissima aria amorosa appositamente composta per lui da Giuseppe Sarti. E questo, si badi, qualunque fosse l'opera e la parte ch'egli vi rappresentava!
Per un'inezia taluno snudava la spada, come fece il Caffarelli contro un librettista che lo aveva rimproverato d'essere giunto in ritardo alla prova. Ma commosso da una dolce parola della cantante Vittoria Tesi, gettava subito l'arma e le si inginocchiava teatralmente dinanzi.
Frequenti poi erano le risse dovute a rivalità, come quella tra Faustina Bordoni e Francesca Cuzzoni, avvenuta a Londra durante la rappresentazione dell'Astianatte del Bononcini. Le due donne si accapigliarono strillando, cosicché fu necessario calare la tela. Capricci e bizze senza fine cui nessuno osava ribellarsi. La cosa più bizzarra dell'opera settecentesca fu costituita dal fatto che uomini (sopranisti evirati) cantassero in vesti femminili, e che le donne sostenessero spesso parti maschili; costumanza questa ultima ancora in uso nel primo ottocento. Anche gli abiti erano spesso stravagantissimi, e non avevano niente a che fare con l'epoca in cui il personaggio rappresentato era vissuto.
Tutto questo ha dato origine a satire e critiche numerose, tanto vivaci quanto, purtroppo, vane. La più spiritosa è Il teatro alla moda (1727) di Benedetto Marcello. Il grande compositore dei Salmi, dei Concerti e dell'Arianna vi espone una serie di consigli (s'intende, a rovescio) ch'egli crede opportuno dare ai librettisti, ai compositori, ai cantanti, ai ballerini, ai suonatori e perfino ai suggeritori, ai copisti ai sarti e ai pittori, affinchè l'opera riesca perfetta. Tutto ciò ch'essi fanno, e che non dovrebbero mai fare, vi è suggerito con arguzia mordace e fine ironia, cosicché leggendo questo libro noi abbiamo un quadro veritiero (se pur volutamente caricato) di ciò che era il teatro musicale del settecento.
Ai Poeti il Marcello consiglia l'ignoranza più assoluta della letteratura, della poesia e della metrica. Copierà il Poeta da altri, e chiamerà il furto «lodevole imitazione». Egli non deve intendersi punto di musica. Faccia quanto chiede l'impresario e non spieghi le proprie intenzioni agli artisti. Dia invece consigli al compositore, e visiti spesso la «prima Donna» poiché da questa dipende l'esito dell'opera.
Parimenti il compositore «non dovrà possedere notizia veruna delle regole di ben comporre», «saprà poco leggere e manco scrivere» e non s'intenderà di Poesia nè di metrica. Non leggerà tutto il libretto, ma comporrà verso per verso, e cerchi piuttosto lo strepito che l'armonia. Composta un'aria o una scena la faccia sentire alla moglie o al servitore, al copista, ecc., e in generale «agli amici che nulla intendono». Sfugga la varietà e insegni ai cantanti a pronunciar male le parole.
Quanto ai cantanti Benedetto Marcello li avverte che non dovranno conoscere il solfeggio «per non cadere nel pericolo di fermar la voce, d'intonar giusto, d'andar a tempo, ecc.». Anche il cantante non è necessario che sappia leggere e scrivere e neppure pronunciare bene. Nè importa che capisca il senso delle parole che canta. Faccia «trilli, appoggiature e cadenze lunghissime», e dica spesso che non è in voce e che ha mille malanni addosso. Si lamenti sempre della parte dicendo che non è adatta alla sua abilità. Canti piano, non si preoccupi di far capire una sillaba di quello che dice, alteri i tempi e la melodia a proprio capriccio, e se stona dia la colpa al cembalo. Mancherà a molte prove; alla rappresentazione, mentre altri cantano, saluterà le persone in platea e nei palchetti.
E il libro mordace del Marcello continua con analoghi spassosi consigli agli impresari, ai protettori, alle madri delle virtuose, ai suonatori, ai ballerini, alle parti buffe, ai sarti, ai paggi, alle comparse, e perfino ai suggeritori e ai copisti.
Al Marcello fanno eco il Metastasio, il Goldoni, il Da Ponte, il Calzabigi, il Casti, l'Algarotti, l'Arteaga, quali con critiche severe quali con satire pungenti.
Ecco, ad esempio, il Goldoni, il quale racconta che avendo annunziato al celebre sopranista Caffariello o Caffarelli che egli avrebbe dovuto aprire il dramma Amalasunta subito alla prima scena, si sentì rispondere: «Come, voi fate aprire la scena al primo attore, e lo fate comparire in teatro fra lo strepito della gente che arriva e si mette a sedere? In verità, signore, che non mi avrete!». Ed ecco negli intermezzi del Metastasio La cantatrice e l'impresario, gli argomenti satirici del Marcello ripresi e sviluppati in un pungente dialogo scenico sotto forma di consigli che l'impresario Nibbio da alla Virtuosa Dorina: «Eh non si prenda affanno: - Il libretto non dev'esser capito... - Si canti bene, e non importa il resto». - «Ma ne' recitativi...» chiede Dorina; e l'Impresario: - «potrà - cantar con quella lingua che le pare, - che allor, com'ella sa, - per solito l'udienza ha da ciarlare». E per farle un elogio l'Impresario le dice che è «miracolosa - nel divorar biscrome a cento a cento».
L'abate Casti nella farsa satirica Prima la musica poi le parole fa dire al Maestro di Cappella: «La mia musica ha questo d'eccellente - che può adattarsi a tutto egregiamente». Il Conte Francesco Algarotti prese le cose molto sul serio, e, in una critica acuta e serrata, additò gli errori artistici principali del teatro d'opera: l'indifferenza del compositore per la scelta del libretto e del suo argomento; la mancanza di verità nei rapporti fra musica e parola, fra musica e caratteri, fra musica e azione; la boria e le soperchierie di tutti verso il musico e il poeta; il nessun nesso della sinfonia col dramma al quale è preposta; il soffocante virtuosismo canoro; la trascuratezza e la monotonia dei recitativi; il nessun interesse per il contributo che l'orchestra può dare all'espressione del dramma; le inutili e ridicole ripetizioni delle stesse parole; il non senso dei «da capo»; la mancanza di espressioni mimiche nei cantanti e il loro assurdo sorridere e inchinarsi agli amici nei palchetti; il continuo parlottare, giocare, cenare e far visite del pubblico. Non sono risparmiati dalla critica precisa dell'Algarotti neppure i ballerini, le scene mancanti di prospettiva e di proporzioni in contrasto con la reale statura degli artisti.
Anche Stefano Arteaga, che pure nel suo volume Le rivoluzioni del Teatro musicale italiano definisce l'opera in musica «la più bella invenzione dell'umano spirito», lamenta i numerosi difetti per cui essa diventa «sconnessa, grottesca e ridicola», specialmente in quanto la musica si propone «per fine di grattar l'orecchio e non di muovere il cuore nè di rendere il senso delle parole». Anzi l'Arteaga avverte la frequente sconcordanza fra azione e musica. Raniero de' Calzabigi, il collaboratore di Gluck nella riforma del melodramma, scrisse anch'egli una commedia satirica dal titolo L'opera seria, ponendo l'azione «in ogni città ove si fanno Opere in musica». In essa, fra l'altro, il poeta Delirio dice all'Impresario Fallito:
«Stupisco che non sa
«La legge impreteribile dettata
«Da' più antichi Licurghi
«Del musico teatro: un personaggio
«Per quanto va di fretta
«Di scena non può uscir senza l'arietta».
E il compositore Sospiro per conto suo aggiunge:
«...Io non bado
«che al mio motivo musico; e considero
«se mi circola bene e bene attacca:
«e poi la poesia non stimo un'acca».
A un certo punto l'impresario e il coreografo tirano le somme con questa sbalorditiva conclusione:
«Dal cervello di qualche Demonio
«L'invenzione dell'Opera in musica
«Per flagello degli uomini uscì!»
La concordanza di tutti questi scrittori non lascia dubbio su la realtà dei difetti criticati[3]:
Diversi musicisti tentarono di risollevare il melodramma dalla decadenza: l'Arianna di Benedetto Marcello è un'opera di ribellione ai costumi teatrali del tempo. Egli da ai recitativi un disegno più mosso e vigoroso, alle arie una più forte intensità espressiva, raggiungendo nel dolore («Lamento d'Arianna») una toccante dolcezza mai più udita dopo il Monteverdi; ai cori e agli accompagnamenti una maggior elaborazione, e un più largo sviluppo alle pagine ispirate a voci della natura: canti di uccelletti, tremolìo di onde, mormorìo di fronde, visioni campestri idilliche, danze satiresche. Ma l'esempio non fu compreso, e l'opera troppo presto dimenticata. D'altra parte Marcello non insistette nella prova.
Un altro audace tentativo riformatore fece Giambattista Pergolesi con l'Olimpiade, caduta fra un subisso di fischi e di scherni a Roma nel 1735, a un anno dalla morte di questo grande genio vissuto appena ventisei anni. Per il rilievo del disegno melodico, la plasticità dei recitativi strumentati e la forza espressiva, Pergolesi appare in quest'opera un precursore di Gluck. Ma ben più grande è il valore dei due brevi «intermezzi» che costituiscono La serva padrona (1733), in cui i tentativi di opera buffa precedenti trovano una forma definitiva che consacra il genere a un glorioso avvenire. Non importa se i recitativi sono «secchi», ma le arie e i duetti hanno una vita superba per brio, civetteria, sentimento, varietà di atteggiamenti. E tali pagine bastano a scolpire i caratteri con un rilievo indimenticabile. In quest'opera il mondo fittizio degli eroi degli dei e semidei, con le loro assurde imprese, i loro fatui amori, la loro inconsistenza psicologica, è abbandonato, mentre un'ampia finestra si apre sul mondo reale sia pure in forma di bonaria caricatura. Per la prima volta la musica non ammette virtuosismi canori, ma fluisce con una schiettezza che non tollera deformazioni, con un'acutezza d'introspezione psicologica che è frutto di un'istintiva capacità di osservazione e di trasfigurazione fantastica.
Da questo momento l'opera buffa entra trionfalmente nella storia della musica, spesso modificata in senso comico-sentimentale. Fra le opere più notevoli citiamo Il filosofo di campagna di Baldassare Galuppi, il Don Trastullo di Niccolò Jommelli, Le serve rivali di Tommaso Traetta, La buona figliola o la Cecchina di Niccolò Piccinni, Il Socrate immaginano e il Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello, mentre La bella molinara e specialmente La Nina o la pazza per amore sono opere drammatico-sentimentali a lieto fine.
La vena di questi Maestri tocca nuove corde dello spirito: si fa popolaresca, arguta, affettuosa, buffonesca, brillante, dolente, per accostare questo nuovo mondo di borghesi ambiziosi, di contadini sempliciotti, di mercanti affaristi, di aristocratici presuntuosi o cerimoniosi, di giovinette ingenue e innamorate, di servette furbe e maliziose, di soldati spavaldi e smargiassi. Abbandona i modi falsamente pomposi per tornare alla schiettezza semplice e cordiale dell'ispirazione, senza fronzoli, senza retorica. La vita comune di ogni giorno è guardata con interesse nuovo: ci si accorge che non c'è bisogno di risalire agli dei e agli eroi per cantare, ma che basta rivolgersi a chi ci sta intorno per sentire nell'affanno amoroso delle persone più umili, nella cattiveria di qualche prepotente, nella burla spiritosa di qualche bell'umore, nella mania di qualche innocuo scervellato, nella civetteria di qualche ragazza, nel ringalluzzito ardore di qualche vecchietto o di qualche matrona attempatella, nell'invidia e nelle rivalità di certi innamorati delusi, un vasto orizzonte che può offrire nuova materia musicale.
È un mondo visto talvolta come attraverso una lente deformante, che trasforma il difetto in caricatura e in goffaggine, l'allegria in buffoneria, l'ironia in una smorfia grottesca. La musica è costretta a rifarsi involontariamente, ma con altre forme e stile, allo spirito da cui sbocciarono un secolo e mezzo prima le figure schiette, vive e immortali dell'Amfiparnaso e delle Veglie di Siena di Orazio Vecchi.
Alle volte la visione dei Maestri del Settecento passa dal caricato al delicato e al galante; si affina e assottiglia fino a dare nel languido, nel sentimentale e nel lacrimoso, con qualche affettazione. Eppure anche da queste deformazioni e da questi raffinamenti nasceranno germi da cui prenderanno vita nuovi e più vigorosi frutti per l'avvenire. Soprattutto Piccinni e Paisiello seppero nelle loro opere dare un più intimo senso di vita musicale ai personaggi di questo nuovo mondo operistico, anche se, come s'è detto, la loro vena sentimentale superò quella comica.
Il vero grande capolavoro comico, l'opera «buffa» trionfatrice del tempo, accanto alla Serva padrona di Pergolesi, è Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, composto su libretto di Giovanni Bertati. Il suo successo alla prima rappresentazione, avvenuta a Vienna il 7 febbraio 1792 fu tale che l'opera venne replicata per intero la stessa sera! Ora, Il Matrimonio segreto è una delle pietre miliari nel cammino dell'opera buffa. Esso segna il distacco sensibile dall'opera buffa e comico-sentimentale precedente, per la vivezza con cui sono ritratti i personaggi, per la varietà dei tipi e per la finezza delle loro emozioni, per la tendenza caricaturale garbata, per la fluida limpidezza della melodia, per la festosa serenità dei motivi allegri. Se l'aria di Paolino «Quando spunta in ciel l'aurora» è di un'eleganza e di un sentimento intimo affatto nuovi, la scena del contratto fra Geronimo e il Conte Robinson apre ormai la via alla satira e alla risata rossiniane.
Frattanto i tentativi di ricondurre il melodramma serio su una linea di maggiore verità drammatica continuano da parte di vari maestri, segnatamente di Niccolo Jommelli, il quale legò più strettamente la sinfonia all'opera, ' usò uno strumentale più ricco e vario, ebbe audacie ritmiche e armoniche, intuì l'efficacia dei crescendo, rinunziò al convenzionale «da capo» nelle arie, e rinvigorì i recitativi «obbligati» (strumentati) così da meritare di esser chiamato, con qualche esagerazione, «il Gluck italiano». Più decisamente indirizzato verso uno stile drammatico fu Tommaso Traetta. Egli ebbe vigoria di canto e arditezza d'armonie, ma la tirannia degli usi teatrali italiani gli impedì di attuare in pieno la riforma meditata; la quale, del resto, avrebbe dovuto iniziarsi dal libretto. Ne risultarono perciò opere che risentono di forti squilibri: dove gli era possibile liberarsi dalle imposizioni, il suo genio vola alto; ma le consuetudini edonistiche lo trascinano spesso a dover ripiegare le ali. Importanza ben maggiore di questi due nobili artisti ebbe, come s'è detto, Alessandro Scarlatti per la fecondità e per la ricchezza dell'ispirazione melodica, la varietà degli accompagnamenti e dello strumentale, oltreché per i sentiti accenti dei recitativi. Tuttavia anche in lui gli accenti drammatici non prevalgono, nè appaiono sufficientemente incisivi e profondi. L'aria, con le sue forme quadrate e la sua espressione lirico sensuale, è sempre l'elemento dominante, mentre i libretti accusano i consueti difetti di superficialità e di frammentarietà.
Fu in Francia, per opera di un musicista tedesco, Cristoforo Gluck, e per i consigli del suo poeta italiano, Raniero dei Calzabigi, che venne attuata la maggiore riforma del melodramma nel secolo XVIII. Essa riporta il melodramma all'altezza a cui lo aveva abbandonato Monteverdi, e si riallaccia alla riforma che un altro tedesco, Riccardo Wagner, attuerà nel secolo XIX. La riforma gluckiana si inizia nel 1774 col rifacimento dell'Orfeo (già eseguito a Vienna nel 1762), prosegue con l'Ifigenia in Aulide, coll'Alceste (anch'esso eseguito a Vienna nel '67 e rifatto per Parigi nel '76), con l'Armida, per sboccare nell'Ifigenia in Tauride (1779).
Nell'opera di Gluck è eliminato ogni virtuosismo vocale. Il recitativo è sempre orchestrato con forte intensificazione drammatica, ed anche l'aria riceve uno svolgimento drammatico. Gluck vagheggiava un canto semplice, naturale, che seguisse la verità del linguaggio parlato, e soprattutto la verità dell'emozione contenuta nelle parole. Perciò il suo canto, che raramente si piega a dolcezza sensuale di melodia, è scolpito con maschia e drammatica energia; non ha seduzioni di melismi, ma si atteggia ad austera movenza e respira l'aria di altitudini solitarie. Gluck non ha altra guida alla sua ispirazione che l'umanità o il sentimento eroico dei suoi personaggi, nei cui accenti sembra vibrare l'oscura e immane potenza del Fato greco. Il coro partecipa anch'esso all'azione con motivi solenni e gravi di profondo contenuto dolore, simili a colonne di un tempio dorico. Le danze si svolgono su ritmi arcanamente aerati e su melodie trasognate, o su vortici di suoni tempestosi gonfi di orgiastico e demoniaco furore. L'orchestra non è più una semplice accompagnatrice. Accresciuta nello strumentale, diventa parte espressiva integrante del dramma con nuova ricchezza di effetti timbrici e di scanditi ritmi. La Natura e i suoi fenomeni hanno in lei un'interprete densa di colori descrittivi.
Tutto ciò non avvenne senza forti contrasti. Infatti, com'è noto, si formò un partito contrario ad ogni riforma e favorevole al bei canto. Per suggerimento dell'ambasciatore Caracciolo fu chiamato a Parigi Niccolò Piccinni, ma l'elegante Barese si trovò a rischio d'infrangersi ad ogni momento come un fragile calice di cristallo urtato dal grosso bicchierone da birra bavarese. Dati gli opposti non confrontabili indirizzi della loro arte, la lotta fra i due musicisti, rinfocolata da pettegolezzi, maldicenze e raggiri d'ogni sorta, era assurda. Non si può mettere a confronto il dolce canto dell'usignolo con la robusta canorità del gallo. Quando si dava un'opera di Gluck, i piccinnisti si recavano a teatro pronti a farne giustizia sommaria; quando si dava un'opera di Piccinni erano i gluckisti che tentavano con ogni mezzo di farla naufragare. Ma la lotta si svolgeva all'infuori della volontà dei compositori, i quali anzi avevano l'uno per l'altro una grande stima. Si offrì a Gluck un libretto da musicare (Rolando) senza dirgli che lo stesso libretto era stato dato a Piccinni. Quando Gluck venne a saperlo, stracciò il manoscritto. Portati a pranzare insieme, i due si abbracciarono, consapevoli della loro differenza, dei loro meriti reciproci, e del fatto che l'idea della lotta era ben lontana dal loro animo. Si cercò anche di provocare un giudizio del musicista Padre Martini su i due contendenti, ma quegli rispondeva serenamente: «Siccome il carattere e lo stile dell'uno è diverso da quello dell'altro, perciò ho tutto il campo di lodarli ambidue»; e poiché chi gli aveva richiesto il giudizio era un gluckista, il buon Padre precisava; «Ella vorrebbe che mi dichiarassi tutto per il sig. Cav. Gluck e contro del sig. Piccinni. Questo è quello che non farò mai, perchè è fuori del giusto e contro l'equità». Accadde che le opere serie del Piccinni, troppo povere di drammaticità, furono presto dimenticate; quelle di Gluck sopravvivono ancora oggi, anche dopo il più complesso e potente Wagner.
Un'altra celebre competizione ebbe luogo a Londra fra Giorgio Federico Hàndel e il compositore modenese Giovanni Bononcini, chiamatovi dall'ambasciatore estense Giuseppe Riva. Anche in questo caso la competizione era assolutamente assurda. Hàndel non era un'operista, mancava del senso del teatro, e la sua musica, anche le pagine più belle, come la famosa aria del Serse.
«Ombra mai fu», hanno un severo carattere che le rende più adatte all'oratorio che al melodramma. E l'oratorio infatti è la forma che rese celebre Hàndel. Bononcini è tutto grazia, leggerezza e sentimento. Egli ha il senso delle situazioni drammatiche, sa penetrare nella psicologia di personaggi «umani» agitati da passioni amorose. I soggetti dell'epoca, anche quelli che hanno per protagonista figure eroiche, sviluppano sempre un'azione che si impernia su un contrasto amoroso. Nella espressione di tali soggetti Bononcini, all'opposto di Hàndel, è a suo agio. Ma la sua vena è sempre troppo galante e aggraziata.
Ciò non ostante, attorno ai due campioni, come a Parigi attorno a Gluck e a Piccinni, si formarono due partiti: hàndelisti e bononcinisti. La lotta si complicò in quanto i due partiti musicali misero capo a due partiti politici, essendo il Duca di Malborough protettore dell'Italiano, e la Corte protettrice del Tedesco. Perciò hàndelisti furono i whigs, e bononcinisti i torys. Ma i due compositori non ebbero astio l'uno per l'altro, anzi è noto che Hàndel confessò di avere ammirato e a lungo studiato il rivale. Ma il Bononcini si rovinò da sé stesso presentando come proprio un madrigale di Antonio Lotti. Era a corto di fantasia? Aveva avuto una richiesta urgente di musica alla quale per mancanza di tempo non poteva provvedere? O credette ingenuamente e disonestamente di potersi far bello di una composizione d'altri? Fatto sta che l'appropriazione indebita fu scoperta, ed egli dovette allontanarsi da Londra per sempre. Le opere sue però continuarono a rappresentarsi, e la lotta continuò, imperniandosi su altri nomi: quelli di Attilio Ariosti, di Niccolò Porpora e di altri minori, languendo e spegnendosi poi a poco a poco per progressivo esaurimento di interesse. E l'opera italiana continuò a dilagare in Inghilterra, mentre in Francia, dopo Luili e Gluck, il melodramma fu ripreso da compositori nazionali.
Il problema più dibattuto è naturalmente quello del recitativo e la difficoltà sempre aperta e sempre più sentita, quella di creare uno stile drammatico. Il linguaggio operistico con Filippo Rameau (armonista e teorico insigne) si volge all'imitazione della natura e del linguaggio naturale, ma ciò lo conduce verso una sensibile tendenza razionalista, compensata da un'aggraziata eleganza tipicamente francese, particolarmente notevole in Castore e Pollucce (1737). Naturalmente Rameau non rinunzia al ballo, delizia dei pubblici francesi. Gian Giacomo Rousseau scivola invece verso una forma più italianizzante, poiché egli trova che l'opera italiana attua il suo ideale filosofico del «ritorno alla natura». Però il suo Indovino del villaggio (1752) è opera graziosa ma schematica e quasi più «intermezzo» che melodramma.
Il delicato Grétry e il più drammatico Méhul, rispettivamente col Riccardo cuor di leone (1784) e col Giuseppe (1807) (citiamo le due opere migliori), pure inserendosi meglio nello spirito francese, non fanno fare grandi progressi all'opera nazionale, nè, del resto, alcuno di questi maestri del '700 si avvicina neppure lontanamente alla verità drammatica e alla robusta classicità di Gluck.
Con Gluck incomincia l'ascensione del teatro musicale tedesco, che continua con Wolfango Amedeo Mozart. Questi porta sul teatro la freschezza giovanile delle sue melodie, intessute di grazia elegante e a quando a quando immalinconite da qualche lacrima che trema e non cade, mentre il labbro ancora sorride. Mozart è un eterno divino fanciullo che, si direbbe, sente passare su la sua anima profondamente serena l'ombra incerta e il presagio vago della fine immatura. Ma sorrisi e lacrime, gioie e malinconie sono spiritualizzati da una superiore forza trasfiguratrice che illeggiadrisce ogni cosa, mentre il sapiente uso del contrappunto densifica l'emozione, e lo strumentale più nutrito la tinge di vivi colori.
Però, tra lacrime contenute e sorrisi appena accennati, tra malinconie e sogni, v'è pure nella vena musicale di Mozart un filone di allegrezza schietta, che prorompe nelle più vivaci scene delle sue opere comiche, e un senso drammatico, anzi tragico, sia umano che fantastico, il quale uguaglia, e quasi sempre supera, la forza espressiva di Gluck. Sorregge questo nuovo stile un'orchestra più efficace e robusta, ricca di disegni e di colori, pronta sempre ai più suggestivi commenti e alle più avvincenti evocazioni. Ciò è sensibile specialmente in quel Don Giovanni che a quasi due secoli dalla nascita reca i segni di una perfezione intatta e di una bellezza immutata.
Mozart abbandona quasi sempre i soggetti mitici e classici di Gluck per dar vita anch'egli a figure d'ogni giorno della borghesia e del popolo; e solo in un caso (Il flauto magico) accetta eccezionalmente personaggi di un astratto simbolismo fiabesco. Ma i personaggi più vivi delle sue opere sono gli umili: la vispa serva Susanna, il giovinetto Cherubino, colto in quell'età in cui animo e sensi si schiudono al desiderio dell'amore, il pavido Leporello, Don Giovanni, non tanto come cavaliere ma come libertino, Zerlina civettuola, Masetto comicamente geloso, e il bizzarro uccellatore Papageno.
Con Mozart l'aria acquista un più poetico e libero volo.
Del resto, il suo schema operistico è sempre quello italiano a pezzi staccati e a recitativi secchi. Italiano nei suoi capolavori, che sono Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787), e Così fan tutte (1790), composti su testo in lingua italiana. Italiano perfino nel Flauto magico (1791), benché con quest'opera egli avesse voluto creare l'opera nazionale tedesca. Ma di germanico non c'è che una maggiore austerità di ispirazione, una maggiore elaborazione e il testo in lingua tedesca. Il capolavoro più perfetto resta Don Giovanni, in cui tragico e comico, reale e fantastico si fondono in un blocco che in certe scene, specialmente l'ultima, appare di una compattezza e di una vigoria monumentali.
Il suo rivale, l'italiano Antonio Salieri, dotto ma modestamente ispirato, rimaneva fermo nelle posizioni acquisite dal teatro settecentesco. Benché ai suoi contemporanei sembrasse emergere nelle opere serie, quali Tarare, e Le Danaidi (1784), che riportarono clamorosi successi, oggi a noi egli appare più spontaneo nel genere comico, come La grotta di Trofonio (1785) che del resto ebbe pure successo pari a quello delle Danaidi.
L'ultimo tentativo per riportare a maggiore dignità e a più complessa elaborazione l'opera seria fu compiuto tra la fine del secolo XVIII e il principio del XIX da Luigi Cherubini specialmente con la Medea (1797).
Cherubini lavorò in Francia, in un ambiente cioè da lungo tempo preparato, specie dopo l'attività svoltavi da Gluck, ad accogliere una riforma del melodramma. La vena austera, la dottrina fortissima, la nobiltà della concezione, la sapienza costruttiva, favorirono la difficile iniziativa di Cherubini, che incontrò la non facile ammirazione di un Beethoven. Tuttavia l'amore della classicità, il rispetto per la severità della forma, e un troppo rigido controllo del raziocinio frenarono spesso il libero volo della fantasia. L'ineguaglianza dell'ispirazione che si riscontra in ogni sua opera, è la conseguenza di questo dissidio interiore che ha reso poco vitali le sue opere, malgrado l'altezza stupenda di molte pagine. Altezza che si mantiene più costante nelle composizioni sacre del Maestro, e anche in talune opere semiserie, come L'osteria portoghese e Le due giornate o Il portatore d'acqua (1800), in cui la vena scorre più sciolta, limpida e festosa. Ad ogni modo il suo stile è un vigoroso colpo di timone, verso le forme che l'ottocento svilupperà, specie per l'importanza data all'elemento sinfonico che sarà il vero trionfatore del nuovo secolo.
[Torna all'indice]
Capitolo III.
Il romantico Ottocento
Tecnica densa e intenzioni austere informano le opere non solo di Cherubini, ma anche quelle di Gaspare Spontini. Se non che, per la mole, per la spettacolosità scenica, e per lo sviluppo dato ai ballabili, le opere dello Spontini si avviano già verso quella che verrà detta la «grand-opéra». In tutti questi caratteri è da vedere l'influenza decisa dell'ambiente francese, poiché anche il Marchigiano visse a lungo a Parigi. Olimpia, Fernando Cortes, e specialmente La Vestale (1807) sono tre opere che portano su la scena una nuova solennità e drammaticità, un ampliamento dell'espressione sinfonica e corale con un indirizzo già sensibilmente romantico dell'ispirazione, pure nella classicità dei quadri scenici. Però la vena di Spontini soffre spesso di un raffreddamento che in parte è dovuto a una certa secchezza della fantasia, in parte a una specie di impotenza a raggiungere quella compiuta e minuziosa espressività ch'era nelle sue aspirazioni.
Quando si dice che la sua arte subì l'influenza dell'ambiente, non si deve credere che questo ambiente non avesse le sue spine. Anche a Parigi e all'Opera i cantanti avevano i loro capricci. La Vestale non andò in scena senza difficoltà. Di fronte alla novità della musica spontiniana il basso Adrien rifiutava la parte del Gran Sacerdote, e pretendeva che Spontini cambiasse la musica. Il Maestro, in uno scatto d'ira, gli strappò di mano la parte e la gettò nel fuoco, ma il Dérivis pronto la salvava e chiedeva per sé l'onore di cantarla. Ma gli avversari di Spontini erano numerosi a Parigi come in Germania. A Berlino la sua arte originò polemiche per un attacco del poeta e critico Luigi Rellstab, al quale il musicista reagì con violenza. Una sua frase male interpretata gli fruttò un processo e una condanna a nove mesi di arresto per lesa maestà. La pena gli venne condonata, ma l'ostilità contro di lui continuò anche dopo la sua morte. Ciò nonostante, la sua arte ebbe una notevole influenza sui contemporanei, e perfino su Wagner.
Frattanto un nuovo astro era sorto: un giovane romagnolo dalla risata rumorosa, dall'esuberante vivacità, dalla satira turlupinatoria e mordace, dall'umore faceto e colossalmente burlesco, ma anche dalle estasi canore fiorite e serene. Questo giovane era Gioacchino Rossini. Egli faceva gorgheggiare i cantanti come usignoli. Egli stesso scriveva questi gorgheggi, ed era in lui un'abile astuzia per frenare i divi e impedire loro di storpiargli le arie con sovrapposizioni virtuosistiche arbitrarie e antiartistiche, com'era tuttora costume dei cantanti in Italia. E in quella prima metà dell'ottocento vi erano cantanti famosi per estensione, uguaglianza, splendore di voce, e per prodigiosa bravura.
È da ricordare che in fatto di cantanti nell'Ottocento accaddero diverse novità. Anzitutto l'avvento del romanticismo e la ricerca della verità espressiva hanno fatto scomparire dalla scena i sopranisti evirati, gli ultimi dei quali sopravviveranno ancora per poco nei Cori della Cappella Sistina solamente, e cioè fino al pontificato di Pio X, il quale abolì questa consuetudine mostruosa. Uno degli ultimi celebri sopranisti fu quel Giambattista Velluti che trasformò le melodie dell'Aureliano in Palmira di Rossini in una girandola pirotecnica di acrobazie sonore, così da decidere l'autore a scrivere da allora in poi egli stesso gli abbellimenti entro limiti tollerabili di ampiezza e di buon gusto. Quanto ci si era allontanati dalla nobile arte di un Monteverdi, il quale voleva che i cantanti avessero voce «chiara ferma et di bona pronuntia» e che non facessero «gorghe nè trilli»!
Ancora, nell'Ottocento, e specialmente per merito di Rossini, i bassi, limitati nel secolo precedente a sostenere le parti di personaggi odiosi o buffi, conquistano ruoli di primo piano in parti a caratteri svariati. La consacrazione più decisiva e artisticamente avvincente si ebbe appunto nel 1818 per merito di Rossini con l'opera Mosè. Con Rossini anche un'altra novità si impone: la distinzione tra basso e baritono. Quest'ultimo registro, confuso prima coi bassi aventi la voce estesa verso l'acuto o coi tenori baritonali, si stacca per costituire un registro a sé, che avrà nel melodramma dell'Ottocento, e specialmente in quello verdiano e postverdiano, un'importanza grandissima. Allo stesso modo, progredendo la caratterizzazione musicale dei personaggi, anche il contralto si distinguerà dal soprano, e ogni categoria di cantanti genererà numerose divisioni specializzate: il tenore di grazia e il tenore drammatico; il soprano leggero e il soprano drammatico; il mezzo soprano e il contralto; il basso drammatico e il basso comico.
Fra i maggiori cantanti della prima metà del secolo XIX basterà citare fra i soprani: Luigia e Virginia Boccabadati (rispettivamente madre e figlia); Angelica Catalani, dalla voce di una purezza incantevole, ma fredda; ed Eugenia Tadolini, troppo bella di persona e di voce, e troppo perfetta cantante, secondo l'opinione di Verdi, per fare il Macbeth, ma di sorprendente agilità. nè vanno dimenticate le sorelle Giuditta e Giulia Grisi, la prima delle quali sposò il tenore Mario.
Ricordiamo i mezzi-soprani Geltrude Righetti Giorgi, la prima Resina rossiniana, e Isabella Coibran, che fu la prima moglie di Rossini, e della quale, come artista, il Carpani scriveva: «grande nei così detti pezzi di bravura, felicissima nei passi arpeggiati e nelle rapide volate, non ha chi la pareggi nella musica tragica o declamativa, e nel difficile talento dell'espressione». Giuditta Pasta, la cui arte aveva la potenza di far piangere Vincenzo Bellini, che la considerava «inarrivabile, specialmente nel sublime tragico». Alla voce estesa ma non tutta bellissima e un poco dura e opaca, accompagnava un'arte scenica di grande efficacia. Somma artista fu l'avvenente, appassionata e gentile Maria Malibran, che Vincenzo Bellini definì: «genio angelico», ed anche «diavoletta» per la vivacità e l'ardore espressivo ch'ella poneva nelle proprie interpretazioni. Aveva voce così estesa che poteva cantare da soprano e da contralto, eseguendo con uguale bravura il tragico e il gaio, e cantando, quando occorreva, in varie lingue, della cui pronuncia era sicurissima. È noto per numerosi episodi il suo generoso spirito caritativo, e come il teatro veneziano che porta il suo nome le fu intitolato dall'impresario Gallo perchè, in procinto di fallire, fu salvato dalla generosità della Malibran che cantò per lui due sere senza compenso. Mentre la Pasta rappresentava un aspetto dell'arte di grandiosa classicità, la Malibran era squisitamente romantica e sensitiva, ma talvolta ineguale per mancanza di controllo e perchè aveva il registro acuto piuttosto stridulo. Non conobbe tramonto; morì a soli 28 anni per le conseguenze di una caduta da cavallo. Poeti ne piansero la morte, e De Musset la definì «arpa vivente attaccata a un cuore».
Celebre contralto fu pure Giuseppina Grassini, dallo stile improntato a larga cantabilità. Fu la prima a imporre ai compositori il problema della voce di contralto e le sue risorse liriche e scenico-drammatiche. Famosa anche per la incisiva dizione, ma priva di attitudine pel comico. Non va dimenticata Benedetta Pisaroni, bruttissima e svaiolata, ma in possesso di una voce di contralto potente, estesa, limpidissima che faceva dimenticare la sua tozza e sgraziata figura.
Dei principali tenori 'ricordiamo Domenico Donzelli, caro a Rossini; Giovan Battista Rubini, una delle voci più splendenti e più estese, per la quale Bellini scriveva nei Puritani un re sopra il rigo! Anche se fatto di testa esso però usciva con la stessa forza delle note di petto. Vero usignolo pel virtuosismo vocale, era anche buon attore. E ancora: il drammatico e impetuoso Manuel Garcia, discreto compositore e padre della Malibran; e Andrea Nozzari, dalla voce robusta, non adatta alle espressioni delicate, ma perfettamente a posto nelle forti declamazioni, anch'egli sicuro ed efficace padrone della scena.
Ancor più potente fu Gilberto Duprez, il primo a usare il «do di petto», nel Guglielmo Tell di Rossini. Quando il maestro l'udi la prima volta in casa propria emettere questo formidabile acuto, corse ad assicurarsi che le cristallerie non fossero andate in frantumi; ma dichiarò poi sempre che questo urlo non era di suo gusto. Tuttavia l'effetto di grande potenza sonora e drammatica, purché la nota esca limpida e in apparenza senza sforzo, piacque alle folle e trovò presto imitatori. Accanto a lui non va dimenticato lo sventurato Adolfo Nourrit, artista nobilissimo e colto. Ambiva staccarsi dall'elegante maniera di canto francese per acquistare una più intensa e drammatica espressione. Donizetti e Rossini lo consigliarono, ma egli fu preso da mille dubbi che lo avvilirono e ne alterarono la mente. Pensò di non poter conquistare il modo di cantare italiano, avendo ormai perduto quello francese, temette di essersi rovinata per sempre la voce, intrvvide il tragico fallimento di ogni sua aspirazione artistica; la popolarità del Duprez e il suo do squillante finirono per sconvolgerlo, e in un accesso di disperazione si suicidò.
Sono note le avventurose vicende della vita del tenore Mario. Il suo nome era veramente Giovanni De Candia; Mario è lo pseudonimo col quale mascherò le sue nobili origini. Di idee liberali, in drammatica opposizione con quelle del padre, generale retrivo e ligio ai Savoia, dovette fuggire di casa dandosi all'arte. Dotato di una voce potente ed estesa, ottimo attore, visse esule, specialmente in Francia e in Inghilterra, ove ottenne successi trionfali. Portò nel teatro una grande e nuova signorilità nel vestire e una aristocratica distinzione di atteggiamenti. Tra gli avvenimenti più curiosi della sua carriera artistica è rimasta famosa una serata a New York in cui dovette, con gli altri artisti, cantare la Norma coll'ombrello aperto, piovendo a dirotto dal soffitto del palcoscenico diroccato.
Il primo grande baritono lirico fu Antonio Tamburini. Tra i bassi i nomi più famosi sono quelli di Filippo Galli e Luigi Lablache. Il primo possedeva una voce formidabile e una mimica fortemente espressiva. Lo Stendhal scrisse di lui: «Voce bella, superba, fioriture scroscianti, attore insuperabile per altezza tragica». Quanto al Lablache, esso era ammirato non solo per la voce altrettanto formidabile, e per l'arte del canto, ma per l'acuta intelligenza interpretativa, e per il gusto nel vestire e nel truccarsi con studiosa fedeltà storica (il che costituiva una novità nei riguardi del secolo precedente). Grande attore nel serio come nel comico. Che fosse artista sommo sotto ogni rapporto può attestarcelo il solo fatto che l'esigentissimo Verdi, allorché meditava di scrivere il Re Lear, avesse pensato a lui come protagonista. Era anche amato pei suoi impulsi generosi.
Certo si tratta ancora in gran parte di artisti che in teatro la facevano da padroni, che tentavano di tiranneggiare l'impresario, di imporre la propria volontà, spesso il proprio arbitrio capriccioso al direttore d'orchestra, magari anche all'autore. Artisti che adoravano spesso, al pari dell'arte, tre altre divinità: il denaro, il loggione e la cinque. Artisti spesso in lotta di rivalità fra di loro e non sempre ad armi cortesi. Ma con l'Ottocento si va affermando un indubbio miglioramento, e più tardi, quando gli artisti si scontreranno con la ferrea e rude volontà di Verdi, il risollevamento del teatro procederà con speditezza sicura. Riteniamo inutile continuare un freddo elenco di nomi, testimonianza di una fastosa gloria artistica, per noi, purtroppo, muta. Torniamo agli operisti.
Rossini, avendo ripreso e sviluppato l'opera buffa cimarosiana, ne esaltava il brio e la comicità gioviale portandola alle stelle in quelle eterne creazioni che si chiamano Il Barbiere di Siviglia (1816), La Cenerentola, L'Italiana in Algeri. Il pubblico non sempre accetta di buona voglia le sue novità, e subissa in un inferno di fischi e di schiamazzi Il Barbiere e la Cenerentola, salvo di lì a poco a ricredersi e a entusiasmarsene. Rossini, del resto, non temeva il pubblico, anzi talvolta lo andava provocando, come quando nel Signor Bruschino fa battere gli archetti dei violini sui paralumi come se fossero strumenti musicali, e introduce un personaggio buffo e balbuziente su un motivo di marcia funebre. Cerca pure di risollevare l'opera seria; e le tappe di questo suo cammino sono il Tancredi, V Otello, il Mosè, la Semiramide. Elevata ispirazione, ricchezza di stile strumentale, varietà di ritmi, tutto ciò egli getta nella fucina con una prodigalità stupenda. Ma il pubblico è lento e restìo a seguirlo: il suo maestro lo chiama «il tedeschino», il direttore del Conservatorio di Napoli proibisce agli studenti di leggere le sue partiture. Quegli subodora in certe movenze haydniane e mozartiane del suo canto e della sua orchestra un «imbarbarimento» dell'arte italiana; questi scambia le sue audacie per grossolani errori di armonia e di contrappunto dettati da ignoranza. Il pubblico poi ha in orrore i finali tragici: non vuol vedere Desdemona sgozzata. E allora Rossini, con quel suo spregiudicato umorismo accondiscendente, chiude l'Otello con un finale burlesco. «Che fai - grida la minacciata Desdemona - sono innocente.» - «Ah sì?» risponde Otello; e rinfoderato il pugnale prende gentilmente per mano la sposa e viene con lei alla ribalta a cantare un duettino sentimentale. Altrove si trasforma Otello in un uomo di razza bianca per non vedere una gentil donzella veneziana innamorata di un Moro «il cui aspetto - dice un giornale dell'epoca - fra noi orrido e deforme reputasi».
Contro tutti questi vizi del teatro melodrammatico italiano Rossini lottò a lungo; poi stancatesi, ed anche per sfuggire a temute minacce politiche, si trasferì a Parigi. Ivi l'ambiente più favorevole e libero gli permise di riformare alcuni suoi melodrammi fra cui il Mosè (1827), e di creare quel sublime capolavoro che è il Guglielmo Tell (1829), dove tutto, dalla sinfonia al finale dell'opera, è monumentale, e dove nel 1° atto si vede per la prima volta la folla corale divenire personaggio attivo e fondamentale del dramma.
Ma il Guglielmo Tell per la sua mole, le danze e la coreografia dell'azione si accosta alla grand-opéra ancor più delle opere di Spontini. Alle danze i francesi, dal seicento in poi, non avevano mai rinunziato. Dal Balletto della Regina di Baltazarini si era giunti ai «Balletti di Corte» alle «Opere-ballo» e ai «Balletti» di Lulli. Lo stesso Gluck innesta nei suoi drammi pantomime e danze. Ormai, al principio dell'Ottocento, in Francia, e in particolare all'Opera di Parigi, non si concepisce più spettacolo melodrammatico senza qualche scena di ballo. Anzi diviene obbligatorio, per un'opera che si rappresenti al massimo teatro di Parigi, contenere una o più scene a ballo. Se ve ne sarà una sola, essa deve trovarsi a metà spettacolo. A questo dogma dovrà sottostare perfino Wagner, il quale per rappresentare nel 1861 il Tannhauser a Parigi fu costretto ad ampliare il «baccanale» del 1° atto. Si rifiutò tuttavia di aggiungere un ballo a metà del 2°. Ora, all'inizio del 1° atto gli aristocratici, e specialmente i signori del Jockey Club, protettori del corpo di ballo, cenavano e non avrebbero perciò potuto ammirare le belle gambe delle loro protette. Fu questa - incredibile a dirsi! - una delle cause del colossale scandaloso insuccesso dell'opera wagneriana. Lo stesso Verdi, quando nel 1894 dette all'Opera l'Otello, dovette creare appositamente un balletto che inserì nel 3° atto. Tanto le cattive abitudini e i gusti banali sono duri da morire! Con che non s'intende dire male dei balli, i quali possono avere una loro artistica ragion d'essere, non solo in un'opera, ma anche a sé stanti; ed è inutile citare esempi che sono certamente nella memoria di tutti, dal Ballo delle Ingrate di Monteverdi ai moderni balletti russi di Diaghilew, ai balli e alle pantomime di Ciaicowski, di De Falla, di Strawinski, di Ravel, di Casella. Qui si intende solo di limitarne la presenza nell'opera ai momenti in cui l'azione li richiede, e di escluderli quando l'azione ne risenta disturbo.
Ma la grand-opéra è costruita con l'intenzione di far larga parte alla coreografia senza necessità. Essa è rappresentazione spettacolare, mastodontica, di enorme durata (non meno di 5 atti!), di fastosa grandiosità. Il vero creatore di questo genere fu Giacomo Meyerbeer, principalmente con le opere Roberto il Diavolo, Il Profeta, Gli Ugonotti (1836), L'Africana. Tutto quanto poteva divertire, nel significato più sensoriale della parola, l'occhio e l'orecchio, Meyerbeer lo ha radunato nelle sue ponderose interminabili opere. Non importa se i ballabili son tirati dentro a viva forza con un pretesto qualunque, se essi diluiscono inutilmente o interrompono dannosamente l'azione: l'importante è che ci siano, che ce ne siano molti, e che diano luogo a figurazioni decorative sfarzose. E ci devono essere pure altri elementi di divertimento: cortei, giuramenti solenni di congiurati o di popolo, feste campestri, processioni, apparizioni spiritiche, duelli, combattimenti, colpi di scena; tutto quello che il melodramma ha inventato in due secoli e mezzo di vita viene accumulato nella grand-opéra. Anche tutte le forme musicali vi figurano: sinfonie, preludi, a soli, arie, duetti, terzetti, settimini, imponenti concertati, vasti cori, banda in scena, campane, fucilerie, cannonate, esplosioni. E non basta: si aggiungono di tanto in tanto strofe buffe, canzoni, rataplan, preghiere, invocazioni, cementando il tutto con ampi recitativi orchestrati. Bisogna però dire che se spesso, per amore di orecchiabilità o di facile divertimento, molti motivi meyerbeeriani appaiono futili, superficiali, banalucci, molte altre volte egli prende le cose con una serietà ed anche con un senso di poesia ignoto ai suoi contemporanei (Rossini escluso), ed istrumenta e contrappunta con un gusto aristocratico e con fine sentimento lirico, a volte anche con drammatica efficacia.
Attorno a lui e a Rossini è tutta una pleiade di imitatori, più o meno forniti di qualche dote originale: Boieldieu, autore de La dama bianca; Hérold, autore della Zampa; Halevy, autore dell'Ebrea; Auber, autore de La muta di Portici e di Fra Diavolo, per non citare che i compositori maggiori e le opere più fortunate.
Frattanto in Germania, dopo il tentativo geniale di Beethoven di inserire col Fidelio (1805) lo spirito del canto tedesco e del sinfonismo (in verità più personale che tedesco) nella forma dell'opera italiana, Carlo Maria Weber tenta di opporsi al tipo melodrammatico corrente e di creare l'opera nazionale tedesca prendendo a soggetto delle sue opere le fantasiose leggende popolari romantiche del suo paese: Euriante, Oberon, Il franco cacciatore (1821). Il sentimento vivo della natura, l'elemento cavalieresco, favoloso, e anche diabolico, portano sulla scena motivi nuovi d'ispirazione musicale che trovano nella fantasia di Weber e nel suo ricco e vario colorito strumentale un'espressione spesso adeguata, specialmente dove le tinte romantiche sono più intense. A questi aspetti non corrisponde sempre una sufficiente forza drammatica, e nuoce loro il non essersi il compositore staccato dagli stampi consueti del melodramma. Per quanto antitaliano, egli subì l'influenza di Rossini e di Spontini.
In Italia il movimento artistico francese e tedesco non fu sentito che tardi e lentamente, tuttavia con Vincenzo Bellini un respiro nuovo, più drammaticamente profondo, penetra nel melodramma. Il recitativo si eleva e acquista in alcune pagine della Norma una potenza che scava nell'intimo del cuore umano e ne rileva i più delicati e riposti moti. La melodia, anch'essa penetrante e imbevuta di malinconia e di estasi notturna, gonfia talora di un pianto straziante, assume un'ampiezza di disegno mai dianzi conosciuta, e, ne La Sonnambula (1831), una delicatezza e purità di lineamenti e di tocchi atti a sollevare l'idillio a una grande altezza di poesia. Di fronte a tanta perfezione d'arte, a tanta forza di sentimento, pubblico e cantanti vanno perdendo i loro vecchi vizi, i loro gusti afflosciati. Non tanto che il pubblico non prenda ancora qualche grossa cantonata, come quando fischiò la Norma. I cantanti avanzano ancora pretese per ottenere qualche pezzo virtuosistico, ma il Maestro non cede, e il divo o la diva sono costretti a tacere e sono vinti dall'espressività vocale soggiogante del canto belliniano. Norma (1831) rappresenta una tappa nuovissima nel cammino del melodramma per l'alta vena lirica che vi si espande, in modo particolare nella «Casta Diva»; per la ricchezza espressiva dei recitativi, che hanno un rilievo drammatico ignoto fino a quel momento ai musicisti, e per la potenza catartica del finale in cui il dolore si trasfigura in accenti di liberazione sublime.
Quando parve che con I Puritani (1835) il compositore stesse per aprire alla propria arte una nuova via in cui anche l'orchestra acquistasse accanto alla voce umana un'interesse espressivo più ricco, il Catanese improvvisamente morì. Nelle sue opere precedenti il canto prevale nettamente su gli accompagnamenti orchestrali, cosicché taluno aveva pensato che esse avrebbero acquistato in bellezza abbigliandole con una più ricca veste strumentale e contrappuntistica. Anche il Bizet si era accinto a simile operazione con la Norma, ma dovette smettere poiché ben presto s'accorse che le melodie del Catanese non comportano altra veste che quella datale dall'autore. Ogni arricchimento ne soffocherebbe il respiro e ne deturperebbe la purezza. Le melodie di Bellini non abbisognano d'altro che di voci belle e di una dizione espressiva, e sotto quest'ultimo aspetto non v'ha dubbio che esse dettero una spinta enorme verso una nuova formazione stilistica dei cantanti.
«...Semplice nuda e sola,
«come nel tempio la colonna paria,
«la melodia che vince ogni parola!»
D'Annunzio con questi versi mostrò di sentire perfettamente il carattere ellenicamente puro ed esteticamente assoluto del canto belliniano.
Il melodramma italiano riceveva pure da Gaetano Donizetti altro e nuovo indirizzo; non tanto per gli accenti elegiaci e drammatici della Lucia di Lammermoor (1835), de La Favorita (1840), o di qualche parte di altre sue opere serie, quanto per lo sviluppo da lui dato al genere buffo rossiniano, fondendolo col semiserio e col sentimentale. Dotato di una vena che passava dal più fine e garbato umorismo alla elegante birichineria, e da questa al pianto nostalgico o alle effusioni tenere o gioviali, la commedia lo prese più della tragedia. L'Elisir d'amore (1832), il Don Pasquale (1834), la Linda di Chamounix sono creazioni che toccano sentimenti e aspetti della vita ch'erano rimasti ancora ignoti all'espressione musicale. Donizetti li evoca con alta genialità d'ispirazione, aggiungendo spesso al canto un commento orchestrale di grande leggiadrìa e arguzia, sviluppando ampiamente una forma di canto-recitativo illuminato da scorrevoli e spiritose melodie dell'orchestra, forma che egli aveva ereditato direttamente da Cimarosa e soprattutto da Rossini. La clamorosa risata rossiniana non c'è più, c'è solo un umano delizioso riso in fondo al quale trema «una furtiva lagrima». Anche Dulcamara, chiacchierone, e furbo vendifrottole, è però cordiale e galante, ed è felice d'aver fatto involontariamente del bene. Norina prova in fondo un sentimento di amarezza nel dover maltrattare Don Pasquale, ma vi è costretta. Ha una natura arguta e innamorata, ma non cattiva. Così ce la dipinge la musica del Bergamasco, aggraziato e distinto, ricco di sentimento e di gaia giocosità.
Quanto al virtuosismo dei cantanti, esso, da Rossini in poi, è sfruttato solo per particolari fini espressivi o limitato a qualche «rondò» finale (pezzo di bravura nelle chiuse gioiose delle opere) o tutt'al più a qualche svolazzo-cadenza al termine delle arie.
In questo ambiente si formò Giuseppe Verdi e uscirono le prime opere sue. Ma egli portava nel vecchio organismo melodrammatico una forza tragica nuova. Di tale forza la terza sua opera, che fu il Nabucco, dà ormai la compiuta certezza; le opere successive non faranno che svilupparla e approfondirla. Il suo stile è, fino alle ultime opere, quasi esclusivamente vocale, e si distingue per una incisiva energia del recitativo, per l'ampiezza ariosa del fraseggio melodico, per la concitazione irruente dei ritmi, per la violenza degli accenti drammatici, per certi slanci gagliardi e per certa tristezza cupa che è al fondo dei suoi canti. Nelle prime sue opere l'orchestra segna il ritmo e accentua con moderazione. Ma lo stile verdiano si matura di opera in opera, e dopo una diecina d'anni di ricerca, esplode luminoso in quel torrente di passioni, di colore, di vita che costituisce la musica di Rigoletto, Trovatore, Traviata (1851-1853). È una travolgente e maschia vigorìa che canta l'amore e il dolore con stringata eloquenza pari all'altezza dell'ispirazione. È un'arte aggressiva che aderisce alla «parola scenica», alla parola essenziale, e che mettendo a nudo il cuore d'un uomo ci rivela un. mondo, che non scende da mistiche regioni, ma che balza dalla terra a Dio, che ci afferra con una potenza titanica e ci scuote nelle più profonde fibre. Se Violetta piange, se Rigoletto impreca, se Azucena rievoca l'orrenda morte del figlio nel rogo, tutto crolla intorno a noi, tutto si concentra in questi canti in cui spasima, ama, maledice e spera anche l'anima nostra.
La popolarità raggiunta da Verdi ha le sue radici in questa immediatezza espressiva, in questa forza penetrante di accenti drammatici e in quel loro seguirsi incalzante che non lascia respiro, che trascina con un'evidenza difficilmente spiegabile su la base dei soli elementi tecnici. C'è qualche cosa di rude, talvolta anche di rozzo, a cui non si resiste, e che proviene anche dal senso di una vitalità dinamica interiore fino allora ignota all'arte dei suoni. Sono canti quelli di Verdi che si direbbero nati da sempre, e che trovarono, e trovano tuttora, una strana e prontissima rispondenza nell'anima del popolo. Una rispondenza che a un certo momento non parve solo artistica e psicologica, ma anche politica. Qualche cosa di elementare, di primitivo e di selvaggio è in essi, e insieme anche di nobile e di umano che esercita un fascino profondo e ineluttabile.
Quella di Verdi è una musica che caratterizza e scolpisce individui e stirpi, re e popoli, cortigiane e spiriti eletti, senza distinzione di epoche e di paesi. Una musica che fa rivivere il pianto degli Ebrei esuli, come l'eroica passione dei guerrieri del Carroccio, che rievoca l'Egitto dei Faraoni e la gloria della Repubblica veneta, che dipinge il chiaro di luna sul Nilo, come la tempesta furiosa del mare e del cielo, che grida la disperazione di un buffone e crea l'atmosfera di morte della stanza d'una tisica, che piange con Violetta la giovinezza e l'amore fuggiti, e ride bonaria attorno al grossolano frate Melitone. Non ci sono limiti a quest'arte: in cinquant'anni di lavoro Verdi ha dato fondo all'universo. Innumerevoli figure d'uomini e di donne che i libretti appena abbozzavano, hanno trovato nella musica verdiana un volto indimenticabile. Essi restano scolpiti nel nostro cuore con la loro umanità, che è la nostra stessa umanità; quella d'ogni tempo e d'ogni luogo. È la vita, è la verità, scavata dal profondo della coscienza umana, dal profondo della storia e dei secoli per mezzo di suoni che una volta uditi non si cancellano più. Non è più possibile riudire certe tragedie, o leggere certi romanzi da cui furono tolti i soggetti delle opere di Verdi senza pensare alla sua musica; certe frasi solamente recitate sembrano vuote di senso e richiamano alla nostra memoria imperiosamente il loro completamento sonoro, di cui sembrano ormai non poter più fare a meno per vivere. Eppure non è tutto istintivo nella musica di Verdi. Fino da giovane, fino da quando si accostò per la prima volta a Shakespeare musicando il Macbeth, opera senza duetti d'amore e senza quasi parte di tenore, tutta immersa nell'ombra fonda e paurosa del delitto e del rimorso, egli mostrava di possedere una concezione nuova del melodramma. Accanto al cuore che cantava, il cervello meditava. Purtroppo l'ambiente non era preparato a un rapido rivolgimento, nè egli stesso aveva ancora una visione precisa della nuova forma operistica, nè possedeva ancora i mezzi tecnici, nè la maturità spirituale per attuarla. Ma egli non perdette di vista la mèta che, attraverso un travaglio lento e faticoso, fors'anche doloroso, gli apparve sempre più distinta e chiara. Nessun ostacolo interno o esterno lo fermò e lo dissuase.
Fu specialmente dopo la trilogia umana che si svolse la lotta interiore per un raffinamento della forma, per un approfondimento della sensibilità, e per una conquista sempre più piena dell'espressione strumentale. Questa lotta lo condusse al Ballo in maschera (1859), a La forza del destino rifatta (1869), al secondo Don Carlo (1884), e infine, culminò altissimo di un totale rinnovamento, all'Aida (1871), all'Otello (1887) e al Falstaff (1893). Nuovi incubi e nuovi sorrisi, rievocazioni di mondi remoti e scomparsi, passioni che la musica non aveva mai tentato, disegni, colori, forme, tratti non si sa di dove e pieni di un fascino e di una suggestione a cui non si può sfuggire; e sempre, dovunque, il cuore dell'uomo con le ansie, le gioie e i tormenti, divenuti torrenti di forza, fatti mari di vampe voraci o luci astrali.
Tutto questo è avvenuto negli anni che vanno dal 1842 al 1893: in cinquant'anni di attività indefessa e di ascesa dura e continua. Al vertice di quest'ascesa sta il Falstaff: mirabile fusione di comico e di sentimentale, di arguzia fine e di brio spigliato, di umoristico e di fiabesco; e mirabile equilibrio di canto vocale e orchestrale in cui le vecchie forme chiuse si sciolgono in un fiotto melodico perenne scintillante.
Verdi non fu di proposito un rivoluzionario, non teorizzò nè polemizzò; tuttavia, a chi confronti il Nabucco con l'Otello e col Falstaff risulta evidente che una trasformazione profonda si è compiuta per opera sua nell'organismo melodrammatico. Essa può anche essere stata accelerata dalla rivoluzione wagneriana, ma non ha nulla in comune con i criteri che condussero il Lipsiano alla creazione del suo «dramma musicale». Verdi conserva all'opera il predominio del canto melodico vocale, anche se le forme chiuse tradizionali si sciolgono in più liberi e aderenti disegni; e tale predominio estende al recitativo che nella maggior parte dei casi si dispiega in forma di arioso. L'orchestra acquista, sì, un'importanza drammatica e descrittiva pari all'importanza della voce umana, ma essa non è mai costituita da un tessuto polifonico di grund-motiv; ed anche quando il canto per necessità espressive si foggia in un semplice «parlato», come, ad esempio, nel monologo di Otello «Dio, mi potevi scagliar tutti i mali», l'orchestra non intende sostituirsi al canto, ma accentuarne con un commento psicologico l'intima ambascia, il tormento meditativo, il senso umano profondo.
Anche quando Verdi fa uso di temi (pochissimi), questi si identificano sempre con qualche movente fondamentale del dramma: sono temi-cardini; ma l'uso non ne è nè continuo nè sistematico, nè diventano mai sinfonici, se non in qualche breve preludio. E, fino all'ultimo, Verdi tiene i piedi saldamente appoggiati alla terra, anche se l'ispirazione scende dal cielo o vi sale. L'ambiente, la natura, la religione, tutto è volto ad un unico fine: scavare nel cuore dell'uomo, illuminarne i più sublimi e i più tenebrosi recessi con rapida, ferma e scultorea concisione di tratti e di scorci, così nel tragico come nell'umoristico: Silva o Fra Melitone, Otello o Falstaff; nel sacro come nel profano: Ave Maria di Desdemona o Credo satanico di Jago.
Queste realizzazioni condussero Verdi dal melodramma all'opera-poema. La cinquantenne attività creatrice del Maestro rinnova perciò dalle basi il teatro musicale italiano, e corrisponde perciò nei risultati finali ad una rivoluzione. Ad essa egli è giunto non attraverso un sistema filosofico preordinato e nel quale egli abbia costretta la fantasia, ma attraverso all'esperienza diuturna, a un continuo perseverante sforzo di vaglio e di superamento, sorretto e vivificato dall'intuizione del genio. La sua opera perciò conclude il travaglio del primo Ottocento aprendo le porte al Novecento con un indirizzo al quale egli seppe conservare un'impronta nettamente italiana, senza intenzioni polemiche nè contro il colorismo e le raffinatezze francesi, nè contro il sinfonismo germanico, ma con un'affermazione di carattere profondamente nazionale e insieme universale.
Accanto al gigante pullulano i minori, in Italia e all'estero, i quali si sforzano di avere una personalità o si accontentano di un modesto eclettismo, imitando or questo or quello, e riuscendo ogni tanto a tradurre il loro sentimento in forme più o meno effimere; onde floscie su le quali galleggia qualche pagina, qualche scena, od anche più, che tuttora può ascoltarsi con piacere. E sono il Mercadante del Giuramento, che eseguito nel 1837 ha già accenti preverdiani, nè doveva essere rimasto ignoto al Bussetano delle prime opere; il Pacini della Saffo, il Petrella della Jone, i fratelli Ricci del vivace Crispino e la Comare, il Pedrotti del Tutti in maschera, il Marchetti del Ruy Blas, l'Usiglio delle Educande di Sorrento, il Cagnoni del sentimentale Papa Martin, il De Giosa del Napoli di Carnevale, e, più fortunato, il Ponchielli dei Promessi Sposi, del nobile Figliol Prodigo, della Marion Delorme, e della ancora ben viva e forte Gioconda (1876) la cui musica, malgrado qualche gonfiezza, ha pagine felicemente ispirate e di efficace drammaticità.
Un posto a sé occupa Arrigo Boito col suo Mefistofele (1875). Egli intese ribellarsi alla forme tradizionali del vecchio melodramma, scegliendo per la propria opera un soggetto metafisico, riducendo egli stesso - poeta abilissimo - le parti più idonee del poema goethiano a libretto, e presentando su la scena situazioni ancora intentate dalla musica. Non lo sorresse sempre una fantasia musicale originale e adeguata all'alta intenzione, nè una sufficiente sensibilità strumentale, per cui l'opera è rimasta in molti punti al di sotto della mèta alla quale il compositore mirava. Tuttavia essa non manca di parti ancora ben vive e ispirate, anche se qua e là difettose, come ammirevole fu il gesto d'audacia che lo portò alla concezione e alla creazione di quest'opera eccezionale. Ma le parti più belle (all'infuori del Prologo) sono dentro il quadro dell'antico melodramma, dal quale non seppe uscire neppure col Nerone, a cui lavorò per oltre quarant'anni, e che fu eseguito soltanto nel 1924, dopo la morte del suo autore.
Fra gli stranieri basterà ricordare il Flotow della idillica Marta, il Nicolai delle indovinate Vispe comari di Windsor, il Goldmark della Regina di Saba, il Delibes di Lakmé, il Thomas della soave Mignon. Ma all'estero vissero compositori ben più importanti che segnarono con le loro opere indirizzi e forme espressive che si staccano dalla tradizione. Uno di questi fu Carlo Gounod, il cui Faust (1859) sfruttando in forma prettamente melodrammatica il romanzo amoroso di Margherita (il ringiovanimento di Faust e l'attività di Mefistofele sono soltanto un pretesto fiabesco da cui esula ogni intenzione trascendentale) si impone per l'eleganza signorile delle melodie, dell'armonizzazione, la delicatezza sobria dei colori strumentali, e per il soffio lirico ricco di passione.
Con la Carmen (1875) Giorgio Bizet inaugura il cosidetto «melodramma verista», denominazione non poco inesatta perchè antitetica al termine «musica», la quale per sua natura è antiverista e spirituale. Ora, Carmen è piena di bella musica, prevalentemente lirica nei primi due atti, drammatica negli ultimi due, di un colorismo ambientale acceso dovunque, ed è un autentico capolavoro per la vita ritmica, la luminosità calda delle melodie, la cesellatura dello strumentale, la forza drammatica con cui sono dipinti i caratteri dei tre personaggi principali.
A Praga, frattanto, Federico Smètana dava vita a un teatro nazionale in cui ritmi, colori e aspetti della vita eroica e popolare della Boemia appaiono in una veste strumentale smagliante. Specialmente l'opera comica La sposa venduta (1866) presenta con maggior risalto le migliori e più personali caratteristiche di quest'arte, la quale fu seguita, però con minore intensità espressiva, da Antonio Dvoràk. Perciò nelle opere di questi si ammira di più la fine fattura armonica e orchestrale che non il vigore melodico e drammatico.
Su la fine del Settecento ha fatta la sua comparsa anche una scuola russa, che si afferma in maniera vitalissima nella prima metà dell'Ottocento con Michele Glinka, il quale ne La vita per lo Czar, che è il suo capolavoro, pure attenendosi alla struttura operistica italiana a pezzi staccati, introduce uno strumentale brillante, e una vita corale basata su melodie nazionali che verrà poi sviluppata dai successori. E i successori furono i componenti il noto «gruppo dei cinque», vale a dire Cesare Cui, Mily Balakirew, Alessandro Borodine (il pittoresco e poetico autore dell'opera Il principe Igor), Nicola Rimski-Korsakow e, maggiore di tutti, Modesto Mussorgski.
Con questi maestri, e in particolare con l'ultimo, l'elemento folkloristico entra decisamente nell'opera, salvandone i caratteri nazionali dall'influenza e dalle infiltrazioni dell'arte straniera. Ma l'espressione musicale di Mussorgski, così nel Boris Godunoff (1874) come nella Kovàncina, è di una profondità drammatica quale non si ritrova negli altri compositori russi precedenti, contemporanei e successivi, e quale si ritrova assai raramente anche presso i compositori di altre nazioni. Inoltre Mussorgski è un creatore di atmosfere particolarmente suggestivo, e talvolta tendente all'impressionismo. Le vecchie forme operistiche sono, specialmente nel Boris, superate da una vampata che non volle essere di proposito iconoclasta, ma che riuscì ugualmente a fondere i vecchi stampi per lo stesso ardore dell'ispirazione che sorgeva da stati emotivi nuovi.
[Torna all'indice]
Capitolo IV.
I ribelli
Mentre in Italia da Spontini e Rossini a Verdi, in un periodo esattamente di ottant'anni, la forma del melodramma subiva lente ma continue modificazioni, il che appare evidente solo che si confronti La Vestale di Spontini (1807) con l'Otello di Verdi (1887), e, nel campo dell'opera buffa, L'Italiana in Algeri di Rossini (1813) con il Falstaff di Verdi (1893); mentre in Francia Meyerbeer stereotipava lo stampo della grand-opéra, e in Russia «i cinque» fondavano il teatro nazionale che saliva con Mussorgski ad alta potenza espressiva, alcuni spiriti più indipendenti impazienti e ardimentosi tentavano vie nuove opponendosi risolutamente, anche mediante scritti polemici, ad ogni tradizione, ad ogni convenzionalismo. Per costoro non si trattava tanto di «riformare», come aveva fatto Gluck, ma di ricostruire dalle basi seguendo una concezione non solo differente, ma opposta a quella comunemente accettata.
Uno dei primi fu, in Francia, Ettore Berlioz, il quale sognava di mettere una mina sotto il Teatro Italiano di Parigi e di farlo saltare con dentro Rossini e tutti i rossiniani. Rossini per lui era il corruttore, l'importatore del cattivo gusto. Naturalmente la minaccia era una pura espressione pittorescamente violenta del suo sdegno e del suo spirito sempre acremente aggressivo; ma nei momenti di serenità egli riconosceva la fine strumentazione del Barbiere di Siviglia, l'arguzia di certe pagine del Conte Ory, il cui terzetto finale egli considerava anzi un capolavoro, mentre non aveva dubbi su la grandezza del Guglielmo Tell che difendeva contro l'incomprensione generale.
Queste predilezioni ci dicono già chiaramente quali erano i suoi ideali artistici. Le pagine di Rossini da lui più ammirate sono quelle in cui le vecchie forme sono disciolte davanti alle necessità drammatiche, davanti a una superiore verità estetica che deve guidare la mente dell'artista, il quale volta per volta crea le forme nuove che gli occorrono. Berlioz, infatti, senza distruggere il «pezzo», modifica la struttura delle forme a seconda dei suggerimenti che alla fantasia provengono dal testo o dalla situazione. Egli si getta contro la tradizione apertamente e violentemente perchè la tradizione era divenuta una barriera, una gabbia che impediva di raggiungere altri orizzonti. Egli cozza aspramente contro le regole e i loro difensori perchè la regola rappresentava per lui un carcere che impediva la libertà d'ogni movimento. Per questo avversò specialmente Cherubini che rappresentava la scuola, l'accademia, con le sue regole e con le sue tradizioni divenute una convenzione che tarpava il volo alla fantasia e contrastava ogni rinnovamento dell'arte. La tradizione è per Berlioz la via battuta che allontana dalla poesia e porta alla ripetizione pedissequa di formule fatte e all'isterilimento; l'antitradizione è la poesia e la vita.
Benché, per effetto delle circostanze, egli si sia dedicato più alla musica sinfonica che al teatro, fu già notato che da essa emerge sempre una tendenza spiccata verso il teatro. È tutta ispirata a episodi di vita (Sinfonia fantastica. Re Lear, Araldo in Italia, Romeo e Giulietta, Marcia funebre per l'ultima scena dell'Amleto, ecc.) e trabocca di riferimenti lirici che si direbbero suggeriti da una visione scenica. Nè, per essere musica sinfonica, essa è meno vivacemente rivoluzionaria; cosicché, se Berlioz avesse trovato maggior consenso di critica e più larga fortuna nel pubblico, non avrebbe mancato di esercitare un'influenza energica anche sul melodramma, e forse egli stesso si sarebbe rivolto più decisamente al teatro. L'attività rivoluzionaria berlioziana si indirizza in parte verso una nuova e più libera concatenazione delle armonie e verso un più fluido disegno della melodia. Questa viene da lui costruita non secondo le formule convenzionali, ma seguendo il libero volo di un'ispirazione che ha le sue radici in un mondo poetico-fantastico. Era piuttosto scarso in lui il senso della vocalità, perciò i suoi canti soffrono talvolta di freddezza, di imprecisione di linee, e appaiono più disegni strumentali obbedienti a un indirizzo prettamente fantastico che disegni vocalistici di espressione affettiva.
Il centro maggiore della sua attività fu la strumentazione. Dove la voce umana canta, l'orchestra non si limita più a segnare il ritmo e a creare il substrato armonico, ma aggiunge le proprie voci, separate o riunite in nuovi impasti, con effetti fino allora intentati, con una varietà di espressioni sconosciute. E quest'orchestra ha disegni melodici propri che contrappuntano quelli diversi del canto e ne costituiscono un commento, ne illustrano nuovi aspetti psicologici, vi creano attorno un'atmosfera ora pittoricamente fiabesca, ora intensamente lirica, ora poeticamente armoniosa, delicata o grandiosa, sfumata o vigorosa, sempre ricca di colore e tale da dilatare l'emozione del canto. L'alta documentazione di questa sua rara sensibilità orchestrale, che schiude all'espressione cieli non ancora esplorati, è il suo grande Trattato di istrumentazione e orchestrazione moderna. L'istrumento d'orchestra non è più concepito come un mezzo per sostenere e per colorire più o meno appropriatamente e suggestivamente il canto, ma per aggiungere dramma al dramma, fiaba alla fiaba, luce alla luce, ombra all'ombra, poesia alla poesia.
Su questa via Berlioz era stato preceduto da Meyerbeer; ma le realizzazioni meyerbeeriane appaiono come tentativi ancora pallidi e non sistematici se paragonati all'esuberante coloritissima orchestrazione di Berlioz. Non si tratta di qualche effetto nuovo di questo o di quell'istrumento gettato qua e là a illuminare e colorire determinati momenti di maggior interesse lirico o drammatico, nè di un maggior ripieno strumentale o di una maggiore sonorità nei concertati. In Berlioz l'interesse per l'orchestra è continuo, gli istrumenti si aggruppano per ottenere colori più intensi, e la varietà e la ricchezza degli effetti timbrici non ha soste.
È un caleidoscopio senza precedenti: lo sviluppo della strumentazione, che sembrava esaurito con Beethoven, si riapre con Berlioz verso altri orizzonti. Bisogna notare che quando Berlioz scriveva le sue opere maggiori, Wagner era appena agli inizi. «Ha preceduto Wagner in molti effetti», scriverà Verdi, ed è la verità. Ma Verdi acutamente addita anche la ragione profonda della poca fortuna incontrata dalle opere di Berlioz: «gli mancava quella calma e, dirò così, quell'equilibrio che produce le cose d'arte complete. Andava sempre al di là anche quando faceva cose lodevoli». Ciò che nocque a Berlioz fu dunque il suo temperamento focoso, eccessivo ed inquieto. Ma certamente egli trovò anche nei gusti arretrati del pubblico una causa notevole di incomprensione. Ciò ch'egli diceva era troppo diverso da quanto s'era detto fino allora perchè lo si potesse comprendere. Il suo era un linguaggio basato su una grammatica e una sintassi in gran parte nuove, che a loro volta traevano origine da una sensibilità diversa da tutte quelle dei predecessori e dei contemporanei suoi. E non è detto che nell'ostilità generale contro di lui non avesse gran parte il suo carattere aspro, scontroso e troppo liberamente maldicente, o per lo meno irrispettoso, verso fame ormai riconosciute e tenute in alto onore.
Un altro carattere importante dell'arte di Berlioz è quel rinnovarsi del ritmo in una libertà che pareva impossibile dopo Rossini. Bisognava uscire dalle formule rossiniane e beethoveniane mostrando la possibilità di creare ritmi nuovi atti a interpretare un più largo numero di stati emotivi.
Dati gli elementi di cui si compone l'arte berlioziana, e specialmente il prevalere dell'elemento strumentale su ogni altro, le sue opere, così il Benvenuto Cellini, Beatrice e Benedetto (opera comica) come I Troiani, colossale opera in due parti e 7 atti (1a parte: La presa di Troia; 2a parte: I Troiani a Cartagine), e la stessa più fortunata Dannazione di Faust (1846), («opera da concerto», come la chiamò l'autore, e che, malgrado tale denominazione e relativa destinazione extrateatrale, si dimostrò all'atto pratico la più ricca di teatralità delle opere berlioziane allorché nel 1893 il Gundsbourg ne fece un adattamento scenico), le sue opere, dicevamo, son piuttosto grandi poemi sinfonici programmatici col canto, che non veri e propri drammi musicali. Berlioz infatti si mostrò avverso così a Gluck come a Wagner. Non bisogna dimenticare, appunto, che i due tedeschi ponevano a base del loro sistema il principio che il testo, il dramma, dovesse prevalere su la musica (dramma musicale), reagendo al melodramma che poneva la musica al di sopra del dramma. La prolissità, gli squilibri di forma, di stile o d'ispirazione che si notano in tutte le opere teatrali di Berlioz, ad eccezione de La Dannazione di Faust, malgrado le tante pagine ricche di alta poesia e drammaticità de I Troiani e i caratteri fortemente scolpiti di Cassandra e di Didone, sono da porre fra le cause per cui esse non riuscirono ad imporsi e non esercitarono effettivamente sui compositori contemporanei e immediatamente successivi alcuna influenza.
È da notare poi che non ostante la sua volontà rivoluzionaria, nelle sue opere (salvo che nella Dannazione) accanto a pagine di una novità formale assoluta, di una originalità di ispirazione alta e potente, vi sono pagine concepite secondo forme convenzionali abusate, le quali creano col resto uno squilibrio di stile nocivo all'unità dell'opera d'arte stessa. Tale squilibrio favoriva senza dubbio l'incomprensione della critica e del pubblico, che si sentivano ora attratti da ciò che era secondo il loro vecchio gusto ora respinti da ciò che presupponeva un gusto nuovo già formato. In tal modo l'audace volontà rinnovatrice di Berlioz andò in gran parte perduta, e venne poi sopraffatta dalla più aggressiva e rivoluzionaria opera di Riccardo Wagner.
***
Wagner ha conosciuto il sinfonismo di Berlioz, e pur avvertendone la manchevolezze, specie nei rapporti dell'opera teatrale, confessa di essere rimasto «stordito dalla potenza di un virtuosismo orchestrale di cui non aveva ancora alcuna idea». Provava per lui avversione e se ne sentiva attratto, lo detestava e lo ammirava. Wagner però, pure dando al sinfonismo orchestrale uno sviluppo anche più ampio, vuole che il testo poetico primeggi su la musica. I suoi princìpi sono, in fondo, quelli proclamati dalla «Camerata fiorentina» nel sec. XVI, e poscia ripresi dal Gluck nel secolo XVIII. Il testo deve essere opera di vera e propria poesia, sorretta da uno spirito drammatico profondo. Come espressione altissima del sovrannaturale, la musica, secondo Wagner, è più adatta a rivelarci il mondo poetico delle leggende eroiche e dei miti che non le vicende pedestremente umane. Perciò Wagner si rivolge alle leggende dei cicli nordici: l'Olandese volante, Tannhàuser, Lohengrin, Tristano e Isotta, I Nibelunghi, Parsifal. In tali leggende e miti egli trova quel sentimento mistico che è tanta parte della sua anima di poeta, e il sentimento della Natura e dei suoi elementi primordiali (acqua, fuoco, forze naturali e celesti, che hanno la loro personificazione nelle Ondine, nei Nani, nei Giganti, negli Dei, nelle tempeste, nei filtri magici, su su fino alla colomba del San Gral). Rienzi non è che un tentativo operistico di quando Wagner era ancora alle prime armi, sotto l'influenza di Spontini, e non poteva che seguire la consuetudine dell'opera storica ottocentesca; e I Maestri Cantori costituiscono una pausa sorridente ironico-sentimentale, che gli permetteva di porre in ridicolo sotto la maschera del pedante Beckmesser i suoi avversari, e d'altra parte si tratta della rappresentazione di una lotta per la libertà dell'arte. I Maestri Cantori (1868) rientrano perciò nel suo piano polemico e rivoluzionario perchè il vincitore Walter di Stolzing trionfa della meschinità delle regole, della grettezza delle tradizioni, dell'aridità delle formule, in omaggio ai diritti dell'ispirazione spontanea. Nell'ultima scena dell'opera però il poeta Hans Sachs ammonisce il giovane cantore-poeta a non disprezzare il passato e le vecchie regole. Queste rappresentano il risultato di un lungo travaglio storico; non debbono costituire un ostacolo ma un semplice traguardo, per così dire, che solo l'audacia del genio può superare.
Wagner, ben consapevole della vastità dell'impresa alla quale si accingeva, rielabora da sé le vecchie leggende e gli antichi miti, che vivifica di una sostanza poetica nuova e densifica in sceneggiature essenziali, ricche di un contenuto anche etico, adoprando quei metri che meglio rispondessero alla espressione musicale del dramma. Il contenuto etico è (fatta eccezione per I Maestri Cantori che, come s'è detto dianzi, hanno un contenuto in gran parte polemico) la vittoria dello spirito sui beni materiali, e la redenzione attraverso all'amore e alla morte. La parola è il punto di partenza della creazione musicale, e il canto dei personaggi deve sorgere spontaneamente dal linguaggio poetico. Ma, a differenza dei cameratisti fiorentini, non è tanto l'intonazione del linguaggio ordinario ch'egli cerca (benché lo affermi), quanto l'intonazione «drammatica», quella cioè che rivela l'intimità del sentimento che la parola in sé racchiude, quella che rivela l'alone di emozioni che la circonda e le risonanze che desta negli altri personaggi. Perciò il canto (melopèa) deve scorrere con piena libertà di ritmo e di melodia, di agogica e di dinamica, non rinunziando al rilievo plastico che meglio risponde alla forza del sentimento di chi parla e che più profondamente eccita la fantasia e si scolpisce nel cuore di chi ascolta. Il dover seguire le cadenze del linguaggio appassionato, con le sue continue fluttuazioni di tono, porta il musicista verso un accentuato cromatismo che si impernia su un frequentissimo uso delle modulazioni. Da ciò quel senso di ansiosa inquietudine spirituale che la musica wagneriana sempre e così fortemente esprime.
Nonostante la bellezza dei poemi drammatici wagneriani, è soltanto attraverso alla musica che noi potremo penetrare il dramma in tutta la sua potenza. Non essendo Wagner un artista latino, i sentimenti che si muovono nell'animo dei suoi personaggi sono sempre assai complessi, perciò egli sente che il canto solo non gli basta. Un Bellini, un Verdi, possono concentrare in una sola linea canora la risultante delle emozioni che agitano il personaggio; ciò non è possibile alla mente analitica di un Wagner; egli ha bisogno di dir tutto, e perciò ricorre alla sinfonia orchestrale per affidarle la più completa espressione del mondo spirituale dei suoi eroi e Dei. Non si tratta più di «accompagnare» il canto, ma di aggiungere all'espressione del canto, mediante le numerose voci dell'orchestra, una più ricca, vasta e profonda espressione sinfonica.
Ed ecco sorgere allora la necessità di un'orchestra numerosa per lo meno come quella di Berlioz, di cercare nei diversi registri dei vari istrumenti e nei loro impasti i colori appropriati a dire tutto quello che il canto solo non può dire. Ed ecco nascere la necessità di affidare a questi istrumenti dei temi conduttori, dei leit-motiv, come li chiamò il Wolzogen, o meglio dei temi fondamentali o grund-motìv, come li chiamò Wagner stesso e come seguiteremo a chiamarli noi, temi che siano come i fili che nascono dai sentimenti dei personaggi e guidano le loro azioni. Ma questi motivi non vogliono avere un carattere descrittivo o verista, anche quando si riferiscono a oggetti o fatti materiali. Il tema della cavalcata delle Walkirie più che ricordare lo scalpitare dei cavalli e il loro caracollare fra le nubi, esprime con un disegno ritmico lento e solenne il carattere guerriero e divino delle cavalcatrici. L'oro diventa nel suo tema un balenìo misterioso e fatale; più audace e impetuoso quello della spada. Il tema del drago più che per il suo strisciare, ci colpisce per quel qualche cosa di bieco e di mostruoso che è nella cavernosità tetra e immane dei suoni. Ed è inutile continuare nell'enumerazione, tutti i motivi wagneriani ci danno in brevi disegni scultorei, espressioni simboliche, fantastiche, amorose, eroiche, drammatiche, di natura sempre psicologica ed antiverista.
Questi motivi nell'orchestra si seguono, passano da un istrumento all'altro a seconda dell'espressione particolare che in ciascun determinato momento del dramma debbono assumere, e si intrecciano formando un ampio tessuto sinfonico che svaria di continuo seguendo il pensiero dei personaggi e la loro azione, e creando attorno ad essi un'atmosfera di suoni-idee, di suoni-sentimenti, di suoni-immagini; tessuto che per il suo continuo sviluppo Wagner chiamò la e melodia infinita». Raramente questi motivi passano nel canto, il quale è legato alla parola, mentre le visioni, le emozioni e i ricordi che la parola suggerisce sono affidati all'orchestra. Questo tessuto orchestrale fluente, che dalle serafiche sonorità dei violini in sordina nelle note sovracute si estende fino ai robusti squilli dei «cantanti metalli», che dai cupi timbri dei contrabassi sale ai floridi arabeschi dei flauti, che fa cantare le arpe ed i timpani, che dai pianissimi di sogno ci conduce agli sgargianti fragori della piena orchestra, attraverso a una varietà e a una ricchezza di colori che sa di prodigio, suppone una concezione totalmente nuova dell'impiego degli strumenti e della loro funzione drammatica quale neppure Berlioz sospettava.
L'orchestra non fa parte della rappresentazione scenica, e perciò non dev'essere visibile allo spettatore. Anche questa è un'idea esposta per primo da Emilio de' Cavalieri fino dal 1600, ed anche Monteverdi conserva nelle sue opere l'orchestra «dietro la scena». Wagner riprende questa idea e con espressione trascendentale chiama «golfo mistico» la fossa in cui si raccoglie l'orchestra. Verdi parlerà anch'egli del «mondo fittizio» rappresentato dall'orchestra, in contrapposizione a quello reale dei personaggi scenici, e sarà anch'egli favorevole all'orchestra nascosta. Su la scena invece la concezione wagneriana dell'opera richiede il concorso di tutte le arti, canto, mimica, pittura, plastica, poesia: tutto deve contribuire a creare nell'animo dello spettatore un'impressione continua di «bellezza», tenendo presente che Wagner da a tale parola il significato di «trasfigurazione della realtà». I personaggi non sono che simboli attraverso ai quali dev'essere rivelato un mondo spirituale superiore, mondo la cui espressione richiede appunto la cooperazione sincrona di tutte le arti. Di queste però lo spettatore è tratto a dare maggiore importanza alla musica, perchè è quella che prima d'ogni altra e più vivamente lo colpisce, in quanto la realizzazione scenica svela sempre troppo facilmente, anche nei casi migliori, le sue deficienze e i suoi trucchi. Cosicché vien fatto talvolta di gustare maggiormente la poesia lirica o la drammaticità di certi brani musicali allorché noi chiudiamo gli occhi alla scena, oppure li ascoltiamo in concerto: Incantesimo del fuoco, Mormorio della foresta, Viaggio di Sigfrido sul Reno, Marcia funebre, Incantesimo del Venerdì Santo, e simili.
È facile comprendere come la concezione operistica di Wagner escluda non solo ogni virtuosismo canoro ed ogni concessione effettistica, ma anche e prima di tutto ogni distinzione di arie, recitativi, duetti, cori, ecc. nel senso di «pezzi chiusi» come si usavano nel melodramma. Anche la sinfonia non è più un pezzo a sé per ambientare musicalmente il pubblico in senso generico, o per dare anche all'orchestra il modo di mettersi in mostra da sola, come poi facevano ciascuno alla lor volta i cantanti nelle romanze, nelle cabalette e nei rondò di bravura. La sinfonia in Wagner non è nemmeno più un modo di presentare i motivi principali dell'opera più o meno abilmente cuciti fra loro e conclusi con una sonora ed enfatica perorazione. Wagner fa della sinfonia o del preludio un mezzo per introdurre in modo specifico nell'atmosfera del dramma (si pensi ai preludi mistici del Lohengrin e del Parsifal, e a quello magico-erotico del Tristano), o una sintesi vigorosa del dramma stesso, una specie di poema sinfonico in cui le cause del conflitto drammatico e la sua conclusione sono musicalmente espresse dai temi fondamentali, dai loro sviluppi, dal loro cozzo, e dal trionfo di uno di essi, quello risolutore, catartico (sinfonia del Vascello fantasma, del Tannhawer, dei Maestri Cantori).
Perciò l'opera di Wagner, specialmente dal Tristano (1865) in poi, non è più il «melodramma», neppure nel significato gluckiano di una più intima armonia fra parola e musica e di una più stretta collaborazione fra canto e orchestra. È qualche cosa di nuovo a cui Wagner dette il nome di dramma musicale (Wortton-drama). La sua realizzazione artistica non era facile per la complessità degli elementi che vi confluivano, e anche per la stessa complessità della partitura orchestrale. Si pensi che a Vienna si dovette metter da parte l'idea di rappresentare il Tristano dopo averne già fatto 54 prove!; che a Carisruhe e a Berlino lo si dichiarò ineseguibile; che Wagner stesso interruppe a un tratto la composizione dei Nibelunghi che ritenne inattuabile. Le condizioni indispensabili per una realizzazione del dramma musicale wagneriano furono trovate solo quando fu creato il teatro di Bayreuth per il munifico interessamento del re Luigi II di Baviera. Le difficoltà erano date soprattutto dall'impreparazione degli esecutori; cantanti e suonatori trovavano impossibile eseguire ciò che Wagner scriveva; gli stessi direttori d'orchestra erano imbarazzatissimi a capire ciò che l'autore esigeva. Si pensi poi che le migliori orchestre tedesche erano attrezzate per suonare al massimo Beethoven, Schubert, Mendelssohn e Schumann, e mancavano di molti istrumenti richiesti dall'orchestrazione wagneriana (otto corni e sei arpe nell'Oro del Reno; 4 tromboni e 5 tube nell'Oro e nel Sigfrido; archi spesso divisi in molte parti). Le difficoltà crescevano quando si trattava di far andare d'accordo orchestra e palcoscenico.
Oggi sappiamo che anche teatri modesti di provincia si possono permettere di far eseguire senza troppe difficoltà le opere di Wagner. Ma Bayreuth ha costituito una scuola per tutti, dagli impresari e dai registi agli esecutori e ai direttori d'orchestra, e ormai ci si è famigliarizzati con lo stile delle opere del grande Lipsiano. Ma quando egli scriveva, il distacco dal melodramma tradizionale era troppo forte perchè l'arte rivoluzionaria di Wagner non disorientasse completamente. Non parliamo poi del pubblico: niente più dolci romanze alle quali commuoversi, niente più pezzi di bravura in cui ammirare il funambolismo dei divi, niente più pezzi chiusi alla fine dei quali poter respirare e riposarsi. C'era invece su la scena la melopèa, ossia un recitativo così diverso dai consueti che parve un canto antimelodico perchè non aveva più i periodi finiti in disposizioni simmetriche; e c'era un'orchestra implacabile in cui molti strumenti differenti intrecciavano fra loro disegni diversi, senza sosta, senza lasciar prender fiato per oltre un'ora e mezza, od anche più. Si noti che dopo aver udito la sinfonia del Tannhanser, Verdi e Berlioz esclamarono: «è matto!». E se questa era l'incomprensione di uomini di genio, possiamo immaginare la cecità e l'ostilità del pubblico, tratto fuori dalle sue comode e facili consuetudini e immerso in questo mare di suoni; messo, per di più, di fronte a soggetti per lui stravagantissimi, come le contese fra gli Dei dell'Olimpo nordico, o a leggende ben lontane dalla tradizione melodrammatica ottocentesca, dove al massimo Weber e Meyerbeer avevano azzardata qualche scena demoniaca. Non vorremo gridargli il crucifige se non capì con prontezza. Si può riabilitare a una sera di distanza dai fischi un Barbiere, una Norma; non un Tristano o un Crepuscolo.
Wagner poi per conto suo, da buon tedesco, non era privo di prolissità. Personaggi che stanno a fissarsi per lungo tempo senza parlare, o che parlano sempre a uno alla volta (ogni associazione di voci, ogni a a due», scomparsi, salvo che nel finale del Sigfrido o in qualche momento del Crepuscolo) e non accennano più a finire, narrando lunghi e spesso complicati antefatti; duetti d'amore che, come quello del Tristano, durano quarantacinque minuti; opere intere in cui, come nel Sigfrido, non si ode voce di donna se non all'ultima scena dell'ultimo atto; via, siamo giusti: da un pubblico che ascoltava la Lucia o gli Ugonotti, era pretendere troppo che penetrasse di colpo in questo nuovo mondo e lo ammirasse! Qualche zelante esegeta, come il Wolzogen, credendo poi di aiutare il pubblico, diffuse in «guide tematiche» la sbagliata opinione che per capire Wagner fosse indispensabile conoscere tutti i temi delle sue opere e i loro andirivieni, dando in tal modo al congegno una importanza maggiore che non alla sostanza musicale. Ciò voleva dire spostare l'attenzione dell'ascoltatore su una strada falsa e per di più irta di difficoltà; concentrare tale attenzione su dei fatti tecnici e logici anziché estetici, mostrargli la tavolozza invece del quadro. Per tal modo il povero pubblico, già di per sé restìo e conservatore per vecchia consuetudine e per amore del quieto vivere, fu messo ancor più in diffidenza contro l'arte di Wagner dalle guide-spauracchio. Occorse perciò molto tempo affinchè Wagner trionfasse, e se ciò accadde fu perchè la forza del genio finisce sempre per imporsi, volenti o nolenti, a tutti.
Wagner polemizzò e teorizzò intorno al proprio sistema: Arte e Rivoluzione, L'Opera d'arte dell'avvenire. Opera e Dramma, sono le dissertazioni che non si leggono senza fatica per l'astrusità di un'esposizione che vuol essere filosofica, e per la prolissità delle discussioni, e non aiutarono certo le opere di Wagner a trionfare. Oggi uno qualsiasi del pubblico, anche un operaio incolto, può gustarle ed entusiasmarsene, senza aver letto una sola riga degli scritti del compositore. Le teorie nulla contano, ed anzi divengono una fredda pedanteria, un vuoto schema, se a sorreggerle non c'è il fuoco dell'ispirazione. È questo e soltanto questo che, talvolta anche a dispetto della teoria e contro di essa, ha formato la grandezza colossale e imperitura della musica di Riccardo Wagner.
La nuova maniera di canto wagneriano impose anche una nuova educazione vocale e scenica dei cantanti, una vera e propria «specializzazione». Anche i cantanti del melodramma italiano, s'è visto, erano spesso buoni attori drammatici, e tali in particolare dovevano essere quelli delle opere verdiane, specialmente dal Rigoletto in poi. A tutti sono note le difficoltà che si incontrano a trovare un tenore e un baritono che possano sostenere rispettivamente le parti di Otello e di Falstaff; e ciò non tanto per la voce quanto per le doti mimiche e di recitazione che tali parti richiedono.
Con Wagner le cose si complicano per gli atteggiamenti statuari ch'egli richiede da coloro che debbono interpretare vocalmente e scenicamente i suoi personaggi; per i gesti, che non debbono più essere generici ma pieni di significazione; per la speciale incisività della dizione e per l'intonazione eroica o, peggio, divina del canto. Nani e giganti, divinità e altre figure della mitologia nordica, dal solenne e tragico Wotan al mobilissimo e astuto Loge, eroi primitivi e brutali come Hunding, semidei audaci e baldi che ignorano il terrore come Sigfrido, mostri come il drago Fafner, aeree selvagge guerriere come le Walchirie, misteriose filatrici del destino come le Nome, spiriti profetici come Erda, e perfino un uccellino parlante; poi mistici cavalieri come Lohengrin e Parsifal, maghi perversi come Klingsor, indemoniate seduttrici come Kundry, e incantate fanciulle-fiori, e vittime trasognate di fatali magici filtri come Tristano e Isotta: le psicologie mitiche e fiabesche che gli attori-cantanti wagneriani sono chiamati a interpretare richiedono una cultura, un'intelligenza e un senso drammatico ben diversi da quelli che bastavano ai migliori esecutori del melodramma italiano. L'opera di Wagner richiede una totale immedesimazione dell'attore-cantante in personaggi che non sono di questo mondo, e che debbono appunto essere resi come tali nella pronuncia, nel canto e negli atteggiamenti.
Il teatro wagneriano ebbe perciò, fino dalle prime rappresentazioni tedesche, degli esecutori che dovettero specializzarsi. Fra i primi e più insigni vanno ricordati la soprano Wilhelmine Schróder-Devrient e il tenore Ludwig Schnorr von Carolsfeld. La prima possedeva così grande talento drammatico da far passare in seconda linea i difetti della voce non bella e delle emissioni qua e là difettose. Lo Schnorr, grande interprete del Lohengrin e del Tannhduser, fu anche il primo interprete del Tristano, ma le fatiche sopportate per studiare ed eseguire questa parte sembra siano state la causa prima della sua morte immatura, avvenuta pochi giorni dopo l'esecuzione dell'opera. Nel Tristano, in cui ebbe compagna per la parte di Isotta la moglie Malvina, riuscì così perfetto che, ebbe a scrivere Wagner, «la parte orchestrale sembrava essere assorbita nella sua interpretazione».
Altri ammirevoli interpreti tedeschi di Wagner furono il tenore Albert Niemann quale Sigfrido; il piccolo baritono Karl Hill, rissoso e perfido Alberico; i bassi Gustav Siehr nella parte del truce Hagen, e Franz Betz, imponente Wotan; Amalia Materna, prima ardente Brunilde, e il baritono Anton Mitterwurzer, magnifico Wolfram nel Tannhàuser, Teiramondo nel Lohengrin e Kurvenaldo nel Tristano. Quanto al tenore Josef Tichatschek, dalla potente e bellissima voce, egli non riuscì mai a staccarsi dalle interpretazioni troppo cantanti e scenicamente troppo convenzionali in uso nel melodramma corrente, rimase estraneo ai consigli di Wagner, e perciò la sua interpretazione ne falsò spesso le intenzioni. Ma il pubblico lo applaudiva per la voce stupenda!
Poi vennero, in tempi più recenti, Salomea Krusceniski, Isotta e Brunilde ammirevole, e il basso Adamo Didur, Wotan di superba fierezza.
Con la diffusione delle opere di Wagner in Italia sorsero anche fra noi insigni interpreti di esse. Fra gli artisti italiani si distinse per la bellezza della voce e la viva interpretazione scenica il baritono Giuseppe De Luca nella parte di Alberico nell'Oro del Reno e di Beckmesser nei Maestri Cantori; e soprattutto il tenore Giuseppe Borgatti, Sigfrido, Loge, Walter di Stolzing, e Parsifal indimenticabile non solo per voce, ma specialmente per la potenza della rappresentazione drammatica profondamente wagneriana di questi personaggi. Prima di dedicarsi alle opere di Wagner aveva cantato nella Tasca di Puccini e in altre opere della scuola italiana, ed era stato il primo felicissimo interprete dell'Andrea Chénier di Giordano. Sono da ricordare pure per la nobiltà e fedeltà delle loro interpretazioni i soprani Amelia Finto e Teresina Burchi nelle vesti della regale e appassionata Isotta; i tenori Raffaele Grani e Italo Cristalli che impersonarono il baldo Sigfrido; il baritono Arturo Pessina, un Hans Sachs di notevole rilievo; il basso Nazzareno De Angelis, commovente Re Marke; Elisa Petri, Brangania fervente e devota; e Gaetano Pini Corsi, impareggiabile Mime, arguto, maligno e perfido in ogni accento e gesto.
La complessità strumentale e sinfonica delle opere di Wagner poneva dei problemi nuovi, e richiedeva anche da parte dei direttori e concertatori d'orchestra un particolare studio che fece di molti di essi dei veri interpreti specialisti e degli apostoli del nuovo verbo, soprattutto dopo l'inaugurazione del teatro wagneriano di Bayreuth. Tali furono (a parte lo stesso Wagner) Hans Richter, Hans von Bùlow, Hermann Levi e Felix Mottl.
La prima opera di Wagner eseguita in Italia, e precisamente a Bologna nel 1871, fu il Lohengrin, che venne diretto dal notissimo Angelo Mariani. A leggere gli appunti presi da Verdi su lo spartito dell'opera durante una rappresentazione, si direbbe che non pochi fossero i difetti di esecuzione, e numerosi i tagli praticati, perfino nel preludio al 1° atto! Ben presto altri Maestri si aggiunsero al Mariani; a Milano, a Napoli e a Torino: Franco Faccio, Giuseppe Martucci, Luigi Mancinelli, Cleofonte Campanini, Rodolfo Ferrari, Eduardo Vitale, il sommo Arturo Toscanini, e il travolgente De Sabata.
Tutti i musicisti che scrissero opere nella seconda metà del secolo XIX furono sotto l'influenza di Wagner, tutti ad eccezione di Verdi (per quanto non si possa negare un'indiretta azione acceleratrice di quel processo di evoluzione che nel Bussetano era già in moto da tempo) difeso dalla potentissima sua personalità, e di Mussorgski, difeso dalla grande muraglia del folklorismo nazionale russo.
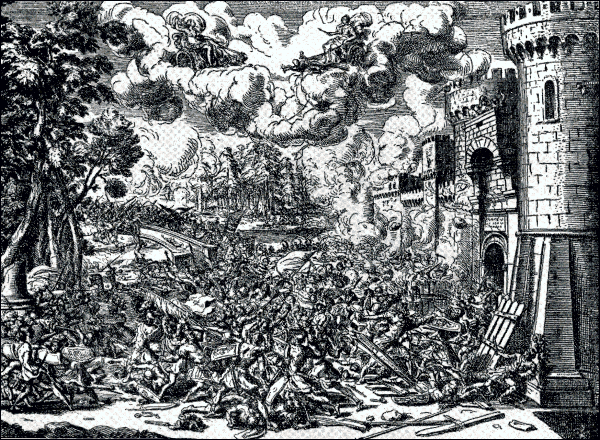
Figura 01: Scena per l'Ercole in Tebe di I. Meloni.

Figura 02: Costumi portati da G. B. Lulli.
Però l'azione della musica di Wagner sui maestri europei rimase allo stadio di assimilazione esteriore della tecnica armonico-strumentale e del meccanismo dei grund-motiv. Ma l'armonizzazione e l'orchestrazione wagneriane erano fatti troppo legati alla sensibilità personalissima del Lipsiano perchè altri potesse facilmente farla propria senza che si scorgesse l'imitazione. Peggio fu per l'uso dei grund-motiv. Senza l'incisività dei motivi wagneriani, senza neppure averne la profonda risonanza interiore, ridotti a saltuarie comparse le quali non costituiscono un tessuto sinfonico ininterrotto, e quindi incapaci di creare da soli il dramma nella sua essenza intima e nella sua atmosfera poetica, i motivi, come vennero usati dagli epigoni di Wagner, si ridussero a semplici echi di questa o di quella situazione, di questo o di quel personaggio; rimasero perciò un meccanismo di superficie. Discendono dall'altezza metafisica del grund-motiv per diventare solo dei temi-richiamo. Verdi, al solito, agendo da latino con mente sintetica e chiarificatrice originale, fece uso di pochissimi temi che adoprò con estrema parsimonia; ma in essi addensò le forze fatali del dramma facendone, come si disse, dei temi-cardini.
***
Perchè l'opera teatrale potesse riprendere il suo cammino occorreva uscire dallo splendido carcere wagneriano; occorreva opporre al suo sistema così personale un altro sistema. Occorreva, in una parola, ribellarsi al prepotente tiranno. Il nuovo grande ribelle fu Claudio Debussy. Questi compose una sola opera teatrale, il Pelléas et Mélisande (1902), ma fu anche l'opera che aprì al dramma musicale nuovi orizzonti all'infuori di quelli wagneriani, anzi in contrasto con quelli. Anzitutto Debussy scioglie ormai il canto in una specie di parlato che è quasi un ritorno a quello della Camerata fiorentina, poiché si appoggia tutto sulle inflessioni del linguaggio ordinario, appena un po' melodizzante nei momenti di maggior commozione. Ciò poteva significare l'annullamento della musica, ma non è tanto il senso logico della parola che interessa Debussy quanto l'emozione ch'essa racchiude e il suo valore musicale: emozione e valore musicale di cui il compositore coglie ogni più intima sfumatura. Inoltre Debussy attorno a questo canto-parlato crea con l'orchestra un'atmosfera sonora di carattere suggestivamente impressionistico.
Si proponeva l' impressionismo di fissare tutto ciò che rapido sfuma, che appena si percepisce, «quell'armonia della scena - come scrisse il Tommasini - che è al di là dei colori e delle linee». «La musica è fatta per l'inesprimibile», ha affermato Debussy, e questo «inesprimibile» è ciò che il musicista vuol realizzare nel canto melopèico, nelle trasognate armonie e nel luccichio ora vivido ora evanescente dei colori orchestrali.
A proposito del dramma musicale, Claudio Debussy fa questo ragionamento: «La musica possiede un ritmo proprio, i sentimenti dell'animo ne hanno un altro più istintivo e sottoposto agli avvenimenti. Da ciò non può risultare che un perenne conflitto. Perciò l'uso della forma sinfonica (Wagner) non solo non può giovare, ma anzi opprime e annienta la musica drammatica». Ragionamento molto discutibile, ma che condusse Debussy alla ricerca di un sistema di commento orchestrale che fosse agli antipodi di quello instaurato da Wagner. In Debussy infatti non esiste più il tessuto polifonico costruito sui temi fondamentali. Egli la uso tuttavia talvolta di alcuni motivi che ritornano ma che non hanno più il significato e la funzione dei grund-motiv wagneriani, ma piuttosto quella di temi-atmosfera. Essi non fanno che richiamare alla fantasia l'eco di particolari stati d'animo e di misteriose sensazioni determinate da avvenimenti che hanno una profonda e fatale risonanza drammatica. L'orchestra turgida e a tinte dense di Wagner, nell'opera di Debussy si fa trasparente e chiaroscurata. Essa non ha altro scopo che di rivestire di colori vaporosi, sfumati, leggermente impressionistici il dramma che il discorso dei personaggi e i loro gesti ci vengono man mano rivelando. Poesia delicata, tutta penombre, che di tanto in tanto vampate di passione più alta accendono di più vividi bagliori.
A tale impressione sottile, evanescente, piena di mistero e di sogno, contribuisce in gran parte l'armonizzazione disciolta e in gran parte basata su la strana emozione suscitata dalla successione di armonie preziose[4] la cui durezza si sfa in ondeggiamenti molli. I personaggi non sono più, come in Wagner, realizzazioni musicali e plastiche di forze naturali o sovrannaturali, ma specie di fantasmi a contorni imprecisi, immagini diafane di un mistero. La loro azione è il risultato di oscure energie di cui non si rendono conto, cosicché ogni gesto, ogni parola, ha la sua origine in qualcosa di fatale che sta oltre la loro esistenza reale e la loro volontà.
L'errore maggiore del sistema debussyano nei riguardi del teatro musicale è quello di aver creduto che il predominio dell'elemento musicale releghi in secondo piano la poesia e la soffochi nell'abbigliamento sonoro, mentre invece il prevalere della musica serve soltanto a rivelare più interamente la poesia con altri mezzi che non siano soltanto quelli verbali. La musica non soffoca, ma sublima e moltiplica l'espressione attraverso alla potenza di elementi di cui la poesia verbale da sola non dispone.
Altro preconcetto errato è quello esposto da Debussy a proposito del canto: «Al teatro di musica si canta troppo. Bisognerebbe cantare quando ne vale la pena e mettere da parte gli accenti patetici». Il pensiero debussyano parte da una verità per arrivare a una conclusione pratica altrettanto estrema. È vero che nelle opere del Settecento e del primo Ottocento si era abusato del canto melodico a proposito e a sproposito. In certe opere tutto veniva cantato con enfasi melodica o con sentimentalismo, perfino parole come, ad esempio, «passo per le valigie dall'albergo», e simili. Ma l'affermazione del compositore francese tende a negare, a torto, il valore espressivo lirico e drammatico del canto, o a limitarne la libera espansione, specialmente nelle effusioni patetiche, come se il sentimento patetico contrastasse con la poesia o col dramma. Oggi l'esagerazione di questo principio ha portato i compositori cosiddetti «oggettivisti» verso una musica disumana che rinnega ogni affettività.
E ancora, scrive Debussy; «Nulla deve rallentare lo svolgersi del dramma. Ogni sviluppo musicale non richiesto dalle parole è un errore»; e quindi ogni effusione musicale (arie, cori, intermezzi sinfonici, e simili) dev'essere abolita. Ed anche a questo proposito Debussy prende lo spunto da un reale abuso: le troppe arie e cabalette, le scene episodiche non necessarie, fatte a scopo descrittivo o per accrescere varietà, i cori riempitivi superflui, diluivano l'azione e ne intralciavano dannosamente lo svolgimento e il corso naturale. Ma l'applicazione rigorosa del principio affermato da Debussy limita il campo dell'espressione musicale, cosicché per non voler soffocare la poesia si soffoca la musica, per non intralciare il dramma s'imprigiona l'ispirazione sonora. D'altra parte Debussy sente il pericolo del predominio assoluto della poesia verbale su la musica, e vagheggia quindi un dramma che gli offra una trama mobile, ricca di suggerimenti e di suggestioni, in cui le parole «dicano le cose a metà». Solo così la musica può ancora salvarsi; e appunto dalla scelta di un poema di tal genere, come era quello di Maeterlink, venne la salvezza della musica di Pelléas et Mélisande.
Questi, dunque, i difetti più appariscenti della rivolta antiwagneriana di Debussy, difetti che, come quelli dell'opera di Wagner, si prolungano e talvolta vengono esagerati nelle opere dei successori, imitatori o deviazionisti, dell'arte debussyana.
[Torna all'indice]
Capitolo V.
I successori di Verdi e di Wagner
I compositori della seconda metà dell'ottocento furono tutti più o meno epigoni dei due colossi maggiori: Verdi e Wagner; allo stesso modo che quelli della prima metà avevan seguito le orme di Rossini e di Meyerbeer. Naturalmente fra gli epigoni ce ne furono molti forniti di robusto ingegno, capaci di spiccare anche qualche bel volo da soli, e di portare un proprio contributo allo sviluppo dell'arte, pure non avendo nessuna velleità di passare per ribelli innovatori. Essi composero unicamente per spontaneo e istintivo suggerimento della loro fantasia.
In Italia i compositori che successero a Verdi vengono generalmente riuniti sotto la denominazione di «giovane scuola italiana», o sotto l'altra di «scuola verista». Quest'ultima denominazione si deve al fatto che i musicisti di tale scuola si allontanarono dai soggetti di carattere romantico. Le passioni veementi prestate a esagitati personaggi di pura fantasia, quasi sempre ambientati in un torbido medioevo di maniera, moventesi tra avvenimenti e colpi di scena inverosimili, talora accompagnati all'elemento magico e demoniaco, non facevano più per loro. Essi preferirono personaggi presi dall'ambiente o popolare o borghese, animati da passioni (anche se violente) più prossime alle nostre, non fantasiosamente concepiti, anzi colti nella realtà e più ricchi di umanità.
C'è chi fa discendere la scuola verista dalla Carmen di Bizet ma in realtà la prima opera che apre il nuovo indirizzo è invece La Traviata di Verdi. È da notare poi che, dopo la Carmen la Cavalleria rusticana e i Pagliacci, la frase «opera verista» divenne sinonimo di opera a base di coltellate; ma questa interpretazione è un'esagerazione, ed anche musicalmente un errore. Ed è un errore perchè la musica, come s'è detto, arte essenzialmente trasfiguratrice, rifugge da ogni materialità veristica. Verismo sarebbe allora anche la pugnalata del Ballo in Maschera, opera invece nettamente romantica. Ma, per carità, non insistiamo troppo a voler catalogare le opere secondo dei cartellini da museo o da barattoli di farmacia. Già Verdi con il Rigoletto, col Don Carlo, con l'Aida, con l'Otello, ci aveva dato delle produzioni difficilmente catalogabili. Di veristico in Rigoletto c'è il colpo di spada di Sparafucile, come in Otello c'è lo strangolamento di Desdemona; ma la profonda umanità del gobbo, la tormentosa gelosia di Otello e la tortuosa suggestione di Jago, come in Don Carlo la tetra malinconia di Filippo II, e in Aida la complessa psicologia di Amneris, fanno già parte di un indirizzo nuovo che porta in primo piano il mondo segreto del cuore umano con le sue ansie e i suoi dubbi, le sue aspirazioni e i suoi conflitti, la sua sensibilità e le sue sfumature. E tutto questo vale ormai più del colpo di scena, dell'intreccio complicato e delle congiure.
Ma poi, non sempre i musicisti della giovane «scuola verista» furono fedeli ad un programma, che del resto non fu mai pubblicamente enunciato se non nel prologo dei Pagliacci.
Ma che cosa dice questo «programma verista» di Leoncavallo? Eccone le linee principali. Tonio, uscito a presentarsi come «Prologo», avverte che egli è venuto
«non per dirvi, come pria: le lagrime
che noi versiam son false!»
E qui c'è il primo equivoco, perchè se, effettivamente, molte lagrime delle opere che precedettero Pagliacci sono false, non si può dir così di tutte. Non sono false le lagrime di Desdemona, nè quelle di Violetta, nè quelle di Oroveso, nè quelle di Amina, e neppure, andando ancora più indietro nel tempo, quelle della Nina di Paisiello. Questo per non citare che alcuni esempi più noti, in cui si ravvisa come Paisiello, Bellini e Verdi ebbero pure per massima
«sol che l'artista è un uomo e che per gli uomini
«scrivere ei deve».
Le lagrime di questi personaggi sgorgarono da sentimenti che costituivano altrettanti casi di «verità» psicologica, non di «verismo». Perciò se Leoncavallo scrivendo Pagliacci «al vero ispiravasi», altrettanto può dirsi dei tre sopracitati suoi predecessori; e se
«ei con vere lagrime
«scrisse e i singhiozzi il tempo gli battevano»
anche gli altri non fecero diversamente. Perfino il rude Verdi confessava: «quando sono fra me e me alle prese con le mie note, allora il cuore palpita, le lagrime piovon dagli occhi». Le parole di Leoncavallo sembrano quasi parafrasate da queste di Verdi (che però Leoncavallo non conosceva).
Dov'è, dunque, il «verismo»? Forse dove Leoncavallo aggiunge:
«vedrete dell'odio
«i tristi frutti. Del dolor gli spasimi,
«urli di rabbia, udrete, e risa ciniche!»?
Ma in Rigoletto e in Otello c'è già tutto questo!
Il colpo di grazia al programma «verista» lo da poi Leoncavallo stesso quando, su la fine del Prologo, fa dire a Tonio:
«E voi, piuttosto che le nostre povere
«gabbane d'istrioni, le nostr'anime
«considerate, poiché noi siam uomini
«di carne e d'ossa»;
il che equivale a dire: non guardate alla verità esteriore delle nostre persone, cioè a quanto è materialità, «verismo», ma «le nostr'anime considerate», ossia la nostra intimità spirituale.
Ed è per questo, per essersi attenuto all'espressione più delle «anime» che delle «gabbane» che la musica dei Pagliacci vive ancora, come vivono tutte le opere che si ispirano non a elementi materialmente veristici, ma all'umanità spirituale.
Che i musicisti della «giovane scuola» non fossero sempre edeli a un indirizzo verista lo vediamo, ad esempio, da Mascagni, il quale passa dal «verismo» della Cavalleria all'idillio dell'Amico Fritz, allo pseudo-simbolismo delI'Iris, storicismo del Nerone; e da Puccini che abbandona l'ambiente veristico-borghese della Bohème per la beffa grottesca del Giorni Schicchi e per il mondo fiabesco di Turandot.
Pietro Mascagni balzò nel 1890 dall'oscurità della scuoletta e della banda di Cerignola alla luce della gloria con la rivelazione di Cavalleria rusticana; passò poi all'idillio campestre con l'Amico Fritz, al melodramma romantico col Guglielmo Ratcìiff, e ritornò all'opera veristica, anche se con un esteriore rivestimento simbolistico, con Iris. Nelle opere Le Maschere, Isabeau, Parisina. Il piccolo Maral, Nerone, e in altre minori, tentò altre vie o ricalcò quelle già provate ma con minor fortuna. La vena di Mascagni rivela già in Cavalleria tutti i suoi caratteri fondamentali: passionalità calda, sensuale, espansiva, sentimento idillico della natura, canorità accesa con predilezione per il registro acuto dei tenori, largo respiro melodico. Ma a fianco a queste qualità positive stanno pure le negative: esuberanze enfatiche, scarso senso strumentale, disuguale sensibilità drammatica, nessuna sensibilità comica, tendenza allo strambo nel vano sforzo di parere originale, mancanza di equilibrio e non chiaro senso del teatro. Nelle opere che vennero dopo Cavalleria Mascagni confermò pregi e difetti, senza dimostrare, neppure nelle ultime opere e dopo la più che quarantenne esperienza, alcuna capacità di evoluzione. Cosicché in tutte le opere di Mascagni, accanto a pagine superbe per l'infiammata melodia vocale (vocale e cantabile anche nei migliori squarci orchestrali, come gli intermezzi della Cavalleria, dell'Amico Fritz, la sinfonia de Le Maschere, e simili) se ne trovano altre fiacche e insignificanti.
Un'opera che si distacca dalle altre per una più forte drammaticità e per il suo fantasioso romanticismo è il Ratcliff, ma presenta anch'essa squilibri e prolissità non poche. Più equilibrato, anche se più tenue, è L'Amico Fritz nella sua atmosfera di poesia idillica, che se sfiora il sentimentalismo nella scena della zingaresca, tocca una intima e sentita commozione al primaverile «duetto delle ciliege». Più stilisticamente nuova è Iris (1898), ed è anche più ricca di una poesia che dalle sgargianti sonorità dell'« Inno del Sole» va sino alla finezza psicologica con cui è tratteggiato il personaggio della protagonista; dalla calda sensualità di Osaka giunge all'egoismo del vecchio cieco, e dalla pittoresca commedia dei burattini alla bieca scena dei cenciaioli. In quest'opera il Maestro prometteva, anche dal lato dello strumentale e dell'armonizzazione, più di quanto abbia poi in seguito saputo mantenere.
Quando si dice che Mascagni deriva da Verdi ciò va inteso nei riguardi soltanto della schietta e predominante vocalità della sua arte, che dal punto di vista drammatico ne siamo a grandissima distanza.
Insieme a Cavalleria rusticana trionfò, e trionfa tuttora, la migliore opera di Ruggero Leoncavallo: Pagliacci (1892), che, pur non avendo l'ala melodica di Mascagni, è tuttavia ricca di canti indovinati, armonizzati e strumentati con gusto signorile. Leoncavallo fu anche buon poeta e scrisse egli stesso i libretti delle proprie opere, mostrando abilità più che sufficiente di verseggiatore e di sceneggiatore, e senso pratico della teatralità. La sua ispirazione però è molto limitata, cosicché nessun'altra opera sua è riuscita vitale. Egli, più colto di Mascagni, ha subito l'influsso della musica da camera tedesca, e non infrequenti sono nelle sue opere i richiami a Schumann, a Mendelssohn, e perfino a Bach. Invano tentò di gareggiare ne La Bohème con l'omonima opera di Puccini. L'opera di questi offre più novità di idee, più eleganza e gusto strumentale ed anche più poesia e anima; mentre nell'opera di Leoncavallo predominano modi e frasi consuete e formule abusate. Non manca qualche pagina aggraziata, come la canzone di Musetta «Mimì Pinson la biondinetta», la gavotta di Schaunard «La macchina è soppressa», nel 1° atto; la scena dell'ammobigliamento a salotto del cortile, nel 2° atto. Ma è troppo poco per far vivere un'opera; mentre sono stucchevoli le scene in cui il musicista gonfia a vuoto pletoricamente la voce, e dove ripete sé stesso (ritmi tolti dal prologo dei Pagliacci) e rifà la voce di altri (il quartetto «Ed ora vengano» - atto 2° -, imitazione stretta del cicaleccio delle donne nel Falstaff verdiano).
Nè meglio si salva Zazà dove pure sono due pagine patetiche non svenevoli: l'aria del tenore «Mai più Zazà», e quella del baritono «Zazà, piccola zingara», mentre appaiono assolutamente false e bolse opere come I Medici, Rolando di Berlino, e le altre nelle quali alla pretensiosità del soggetto corrisponde una vera nullità dell'ispirazione.
Di ben altra statura è Giacomo Puccini; fine, sensitivo, fresco melodista, pronto a percepire le minime sfumature del sentimento e a tradurle in accenti delicatamente commossi e appropriati. Alla vena melodica egli aggiunge una preziosa e raffinata sensibilità armonica e un istinto coloristico che lo spinge ad usare gli strumenti dell'orchestra in funzione della poesia che essi possono esprimere. Si è detto e si ripete che Puccini è il poeta delle piccole cose, ed è vero: nello schizzare una figuretta anche secondaria, come ad esempio il Sagrestano della Tosca: nel caricaturare un organetto scordato, come nel Tabarro', nel dipingere l'uggia d'un mattino nevoso, come nel 3° atto de La Bohème; nell'esprimere le emozioni che attraversano l'anima di Mimì, di Butterfly e di Liù, egli è un grande signore. L'anima femminile in particolare non ha segreti per lui e gli ispira le pagine più sentite, più squisitamente intime e poetiche. Si dovrà affermare per questo ch'egli non sia grande musicista? Non diremmo. Grande è anche Pascoli in alcune delle sue «Miricae» le quali hanno contenuto ben tenue; poiché la grandezza non sta tanto nella scelta del soggetto più o meno solenne, quanto nella compiutezza della rappresentazione artistica. Molte cose vedute esteriormente sembrano piccole; ma, se si guarda attraverso il cuore, anche le piccole cose appaiono grandi, poiché nulla vi è di piccolo per il cuore.
Si è anche detto che Puccini è musicista modesto perchè il suo mondo è quello dei piccoli eroi borghesi. Ma anche qui si giucca, per ragioni polemiche e con precisa intenzione demolitrice, su una parola la quale non è altro che un cliché di origine politica. Ma che cosa vuol dire musica «borghese»? Se si vuol dire che la musica di Puccini solletica le forme inferiori della sensibilità del pubblico si è in errore, perchè nello stile del Maestro lucchese vi è troppa raffinatezza aristocratica, troppo amore per le armonie morbide, sì, ma dissuete e per i colori strumentali più ricercati perchè si possa parlare di gusti facili e banali. Questa ricerca del raffinato, del sottile, del prezioso, del coloristico, è andata crescendo di opera in opera, e culmina nella modernità di Turandot; tutto ciò senza che il pubblico si stacchi da lui. Il gusto del piacere raffinato è un gusto aristocratico e antiborghese; se fosse un gusto borghese, Debussy, tanto più raffinato e sensualmente voluttuoso e snervante di Puccini, dovrebbe essere anche più popolare; il che non è. Quanto alle vicende dei personaggi pucciniani, essi amano e soffrono come ogni creatura umana, borghese o no; le loro passioni sono sentite e il musicista le esprime con plasticità di rilievo e con vivezza di tinte, e soprattutto con un senso di musicalità che ha radici vaste e varie e che si imprime con prontezza nell'animo dell'ascoltatore e vi determina una specie di incantamento poetico, di rapimento lirico . Non vediamo perchè tutto ciò debba essere «borghese».
In Puccini l'amore per il canto espressivo, dalle linee eleganti e fluide, si accompagna con l'amore per le belle sonorità orchestrali, per la varietà dei timbri e per la ricchezza mutevole delle armonie. Mentre italiani sono in lui la chiarezza dei disegni e l'equilibrio delle proporzioni, da artisti stranieri egli deriva altri elementi: da Massenet la finezza elegiaca delle melodie, da Bizet la vivacità dei ritmi, da Debussy (con La Fanciulla del West) l'armonizzazione impressionista, e (in Turandot) da Strawinski e da Schonberg lo strumentale e la libertà tonale. Ma la personalità in Puccini è così forte che il lavoro di assimilazione quasi non si avverte. Egli prende soltanto ciò che gli serve e lo trasforma senza alterare la propria fisonomia, e sa imporsi dei limiti che non varca mai, e oltre i quali egli sente bene che l'assimilazione diventerebbe imitazione esteriore, e cioè non-arte. Lo sorregge inoltre un acuto senso del teatro; cosicché, a differenza di Mascagni che accetta qualunque libretto, qualunque situazione, e non taglia un verso, nè ha mai saputo correggere una propria opera, Puccini è incontentabile coi librettisti e con sé. Di ogni sua opera esistono diverse edizioni, e ciascuna porta ritocchi, tagli, aggiunte, e talora anche rifacimenti totali, come ad esempio nel finale del 1° atto di Manon Lescaut e in varie parti di Madama Butterfiy.
Detto questo, aggiungiamo che anche l'arte di Puccini non è esente da difetti. Per esempio, l'uso di caratterizzare i personaggi con dei leit-motiv, senza che questi abbiano la profondità nè la significazione dei grund-motiv wagneriani, incapaci di creare l'atmosfera sinfonico-drammatica wagneriana, leit-motiv che si ripetono quasi sempre uguali a sé stessi e sono come delle etichette su cui sembra scritto; Tosca, Mimì, Butterfly, Minnie ecc., cade nello stucchevole e nel puerile. Non entra in scena, ad esempio, Schaunard senza che si senta il suo motivo bravaccione e spensierato. Ora, alla fine, ci si domanda: la psicologia di queste persone è proprio così elementare, rudimentale, da poter essere contenuta tutta in un breve, per quanto efficace, motivo che lo accompagna come una fastidiosa fissazione?
Un altro difetto è nella tendenza alla femminilità sentimentale di vari motivi. Questa tendenza esiste realmente, ma anche su di essa si è molto esagerato a scopo polemico, mentre dal canto loro i cantanti, con la complice indulgenza di mediocri direttori d'orchestra, hanno trasformato in femmineo e sentimentale anche quello che non lo era, attraverso interpretazioni sdolcinatamente false.
E qui ci conviene riparlare dei virtuosi di canto, dei «divi» e delle «dive», i quali e le quali se non osano più spadroneggiare come nel settecento ai danni della musica, tuttavia non hanno ancora smesso (e siamo già a metà del novecento!) di prendersi licenze arbitrarie e antiestetiche con le quali deturpano senza scrupolo alcuno le maggiori creazioni del genio. Sono i cosidetti «Gigioni». Si tratta alle volte di artisti dotati di bellissime voci e di tecnica del canto perfezionatissima; doti alle quali non corrisponde in essi un'adeguata coscienza artistica e neppure quel tanto di rispetto per l'opera da essi eseguita che li convinca a non alterarne cervelloticamente il volto. È noto che una sera Rossini, dopo aver ascoltato la Patti cantare la cavatina del Barbiere infiorata da molti gorgheggi mai scritti nè pensati dal Pesarese, alla fine la complimentò molto per la sua abilità e poi le chiese con l'aria più ingenua di questo mondo: «Che cosa avete cantato?»- «È musica vostra...» - «Ah sì? - esclamò allora Rossini - ho proprio scritto della roba così brutta?». Si può immaginare come sarà rimasta la diva! Eppure era la Patti! Ma ecco altre celebri dive dalla gola usignolesca, seguaci di questo malcostume musicale, trasformare la scena della pazzia della Lucia di Donizetti in una gara sportiva di agilità col flauto. L'istrumento propone acrobazie, e la voce femminile lo scimmiotteg già raddoppiando; tutto ciò col risultato di far dimenticare al pubblico la musica di Donizetti e di suscitare quella sorta di meraviglia per l'inverosimile prodigio pirotecnico del virtuosistico gorgozzule che scatenerà i più clamorosi entusiastici applausi del pubblico. Ed ecco un tenorino pretensioso aggiungere uno svolazzo finale alla canzone del Rigoletto «La donna è mobile»; eccone un altro urlare un acuto stentoreo come chiusa della romanza del Mefistofele «Giunto sul passo estremo».
Il risultato è sempre il medesimo: il pubblico va in visibilio e non si rende conto dell'irriverente profanazione (se non fosse così fischierebbe di santa ragione!). E ormai, presa la via dell'arbitrio, ci sarà chi filerà note a sproposito, chi si permetterà «portamenti» ossia strascicamenti di voce sentimentaloni, chi terrà «corone» o vuol note prolungate su ogni acuto, chi singhiozzerà su ogni frasuccia la più insignificante, chi inframetterà al canto risatine beote. E siccome tutto ciò viene bevuto dal solito pubblico di cui sopra come il «non plus ultra» della più sublime interpretazione, o se anche non lo pensasse sono però tutte cose che solleticano la sua sensorialità, gli impresari vanno, naturalmente, alla ricerca di questi cantanti poiché sono essi che riempiono la «cassetta». E qualche casa grammofonica fissa queste bellezze sui dischi e le diffonde (e la radio si presta docile anche a questo). E i direttori d'orchestra, che sono i più diretti responsabili dell'interpretazione e dovrebbero quindi essere i maggiori difensori dell'integrità dell'opera d'arte, lasciano fare, quando pure non fanno anch'essi i «divi» dell'orchestra. Poiché ci sono anche i direttori che si piccano di dare all'opera un'interpretazione «personale», e allora tempi e coloriti vengono alterati in vista di «effetti» ai quali l'autore non ha mai pensato, talora anzi in opposizione alle di lui intenzioni.
Giuseppe Verdi in una lettera del 1871 a Giulio Ricordi si esprime molto chiaramente a proposito delle interpretazioni personali dei cantanti e della «divinazione dei Direttori... È la strada - scrive - che condusse al barocco e al falso l'arte musicale alla fine del secolo passato e nei primi anni di questo, quando i cantanti si permettevano di creare (come dicono ancora i francesi) - [il male dunque non è solo nostro] - le loro parti, e farvi in conseguenza ogni sorta di pasticci e controsensi. No: io voglio un solo creatore, e m'accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente quello che è scritto; il male sta che non si eseguisce mai quello che è scritto. Leggo sovente nei giornali di effetti non immaginati dall'autore; ma io per parte mia non li ho mai trovati... Io non ammetto nè nei cantanti nè nei Direttori la facoltà di creare, che, come dissi prima, è un principio che conduce all'abisso». E prosegue criticando un effetto di fortissimo degli ottoni ottenuto dal celebre direttore Angelo Mariani nella sinfonia della Forza del Destino, mentre egli aveva pensato a un effetto a mezza voce. Allo stesso modo, in altra lettera critica l'abitudine di affrettare i tempi propria così del Mariani come di Michele Costa, altro sommo direttore dell'ottocento.
Fino a che le orchestre erano formate di una ventina di suonatori, come nella prima metà del secolo XIX (al S. Carlo di Napoli raggiungevano eccezionalmente i quaranta!) il primo violino bastava a concertare la piccola compagine e a regolare l'esecuzione dell'opera che, salvo la sinfonia e qualche preludio si riduceva ad accompagnare i cantanti. Ma quando l'orchestra cominciò a farsi più numerosa e ad allargare i suoi compiti agli effetti coloristici descrittivi, e al commento drammatico, la maggior complessità e varietà della partitura orchestrale e l'accresciuta difficoltà della concertazione fra orchestra e palcoscenico resero necessario un Maestro che sovrintendesse all'uno e all'altra simultaneamente, assumendosi il carico e la responsabilità dell'interpretazione e dell'espressione battuta per battuta. Nacque allora un nuovo genere di divinità teatrale: il «concertatore e direttore d'orchestra». Questa specie di Giove, seduto un tempo su un alto scanno, oggi in piedi su un podio sopraelevato, domina le masse sonore e i cantanti e li trascina col gesto, e (alle prove) anche con la voce. Comunque si possano giudicare e criticare, noi ci inchiniamo rispettosi e ammirati innanzi ai nomi di Angelo Mariani, Michele Costa, Luigi Mancinelli, Giuseppe Martucci, Rodolfo Ferrari, Cleofonte Campanini, Franco Faccio, Leopoldo Mugnone, Edoardo Mascheroni, Ettore Panizza, Victor de Sabata, Tullio Serafin, Antonio Guarnieri, Vittorio Gui, Bernardino Molinari, Gino Marinuzzi, Franco Capuana, Fernando Previtali, Mario Rossi, Gianandrea Gavazzeni, Francesco Caracciolo, Guido Cantelli e Carlo Maria Giulini, agli stranieri Edoardo Colonne, Felice Mottl, Hans von Bùlow, Arturo Nikisch, Giuseppe Mengelberg, Felice Weingartner, Wilhelm Furtwàngler, Bruno Walter (il suo vero cognome è però Schlesinger), Sergio Kussevitzki, Leopoldo Stokowski, Issay Dobrowen, Igor Markevich, Artur Rodzinski, Jonel Perlea, Dimitri Mitropulos, e al più grande di tutti: Arturo Toscanini. Questo non è che un elenco dei nomi di maggior risonanza, ma ci sono anche i «divi», gli istrioni, che si danno delle arie da invasati, sbraitano, bestemmiano e lanciano contumelie volgari, e gesticolano come ossessi, e il loro sbracciarsi e saltabeccare esercita sul pubblico un fascino magnetico potente. Ora, sono proprio questi virtuosi della bacchetta i più pericolosi nemici dell'arte, sia che lascino strafare i cantanti, sia che si atteggino a creatori dando un'interpretazione che si allontana da ogni intenzione scritta dell'autore.
Anche fra i cantanti l'ottocento e il novecento vantano nomi illustri. Ai citati nei capitoli precedenti aggiungiamo ora quelli delle celebratissime Erminia Frezzolini e Adelaide Borghi Marno. Adelina Patti, che Verdi disse artista ancor più completa della Malibran, era assai colta e cantava in più lingue. Certamente fu artista sotto ogni rapporto eccezionale, ma anche altrettanto grande nei capricci, nella vanità e nell'avarizia. Ci allontaneremmo troppo dallo scopo di questo libro se volessimo parlare partitamente delle ammirabili, anche per bellezza, Gemma Bellincioni artista versatile, di grande rilievo scenico e vocale, e Carmen Melis (famosa Thaìs e Mimì); e di Amelita Galli Curci, di Giannina Russ, di Luisa Tetrazzini, una delle voci più limpide e uguali, una delle ugole più sicure, e soprattutto una delle sensibilità musicali più squisite dell'ottocento; e della colta e intelligentissima Claudia Muzio, di Fanny Toresella, di Emma Carelli, di Rosetta Pampanini, una delle più perfette interpreti della pucciniana Butterfly; di Rosina Storchio, di Esther Mazzoleni, di Gina Cigna, di Ebe Stignani musicista di alta classe, di Cioè Elmo, e di quell'incantevole usignolo che è Toti Dal Monte (nome d'arte assunto da Antonietta Meneghel), di Margherita Carosio, di Lina Pagliughi, di Maria Caniglia, di Renata Tebaldi, Fedora Barbieri, e Rosanna Carteri.
Straniere furono la viennese Antonietta Frietsche (cognome italianizzato in Fricci) la boema Teresina Stolz, che fu da Verdi prescelta come interprete dell'Aida, del Don Carlo e della Messa di Requiem a Milano; le tedesche Maria Waldmann, contralto, anch'essa prescelta da Verdi per la parte di Amneris nell'Aida e per la Messa; ed Enrichetta Sontag, prima interprete dell'.Euriante e del Freischùtz di Weber; e Jenny Lind soprannominata «l'usignuolo svedese». Romena fu Ericlea Darclée e francese Emma Calvé, mentre australiana era Nellie Melba (ma il suo vero nome era Elena Porter Armstrong). Spagnole erano Conchita Supervia e Fanny Anitua; irlandese Margherita Sheridan, d'origine greca è Maria Meneghini Callas.
Fra i tenori italiani i nomi più illustri sono quelli di Angelo Masini, ottimo attore e cantore di grande sensibilità, di voce eterea e di inimitabile grazia, insuperato interprete dell'Elisir d'amore e del Barbiere di Siviglia; Fernando De Lucia, anch'egli dotato di voce soavissima, per quanto scarsa. Possedeva, come forse nessun altro, l'arte di fare del canto un sospiro pieno di passione e di nostalgia. Roberto Stagno, primo interprete, insieme a Gemma Bellincioni, della Cavalleria Rusticana, ebbe voce non uguale, ma intelligenza viva, e grande abilità nello smussare i difetti vocali, di cui era consapevole. Poteva anche attaccare acuti in pianissimo e finirli infortissimo attraverso a un crescendo travolgente. Edoardo Garbin, che fu chiamato da Verdi a sostenere la parte di Fenton nel Falstaff; Alessandro Bonci, uno dei più ammirati tenori di grazia. Su tutti emerse per voce estesa, uguale, cristallina, e per gli acuti formidabili Francesco Tamagno, il primo famosissimo interprete dell'Otello verdiano. Possedeva anche figura atletica, ma nei primi tempi della sua carriera non aveva attitudini sceniche. Fu Verdi a dare a questo tenore un'anima e a farlo diventare anche attore. Francesco Marconi, la cui voce, di una soavità e purezza luminose e dagli acuti squillanti, si univa a un vivo sentimento espressivo, possedeva grazia e forza, ed aveva fiati così lunghi da poter cantare intere frasi legate senza dover riprendere il respiro. Dopo di lui il tenore più insigne per bellezza commovente di voce, estesa, anche se di timbro un po' baritonale fu Enrico Caruso. La commozione ch'egli destava cantando era tale che si rinnovò con lui quello che già era avvenuto nel '700 col Pacchierotti: durante un'esecuzione di Carmen al Colon di Buenos Aires, mentre cantava la romanza del fiore, l'orchestra non fu più capace di proseguire perchè le lacrime velavano gli occhi dei suonatori!
Gli ultimi tre grandi tenori del novecento sono stati: Beniamino Gigli, dalla voce calda e splendente, sensuale, ch'egli piega ad ogni più patetica espressione con una padronanza tecnica perfettissima; cuore generoso e buono. Tito Schipa, finissimo cesellatore dalla voce suadente. I suoi cavalli di battaglia furono l'Arlesiana di Cilèa, l'Elisir d'amore di Donizzetti e il Werther di Massenet. Aureliano Fertile, dalla voce ineguale se pure estesa e forte, ingegno versatile, capace di passare da Wagner a Verdi a Puccini con estrema aderenza allo spirito del personaggio sia dal punto di vista dell'interpretazione vocale, sia da quello dell'azione scenica sempre efficace. E ricordiamo pure con tutto il rispetto e l'ammirazione che meritano tre famosi interpreti del selvaggio Otello; Giovanni Zenatello, Francesco Merli e Renato Zanelli; ai quali è da aggiungere oggi il non meno vigoroso Ramon Vinay, mentre emergono in altri generi lirici Gino Penno, Ferruccio Tagliavini e Giacinto Prandelli.
Fra i tenori stranieri non dimentichiamo lo spagnolo Giuliano Gayarre, dalla voce di una dolcezza meravigliosa unita a una viva passionalità e a una efficace dizione. Le parole acquistavano dalle particolari flessioni del suo canto accenti di una potenza emotiva che letteralmente sconvolgeva. Quando, ad esempio, nei Puritani egli diceva ad Elvira: a Vieni fra queste braccia», la suggestione amorosa che usciva dal suo canto era tale che le madrilene esclamavano: «Que Dios te bendiga!». Aveva inoltre una tale facilità di modulazioni per cui passava attraverso ad esse senza alterare nè il registro vocale nè il fascino espressivo.
Nel ruolo dei baritoni basterà ricordare Antonio Cotogni, forse la più bella ed estesa voce baritonale. Era pure gran signore della scena, e aveva un modo tutto suo di interpretazione drammatica vocale che metteva i brividi. Giorgio Ronconi e Felice Varesi furono due fra i primi e maggiori interpreti di Verdi. Anche Giuseppe Kaschmann ebbe voce possente, con vibrazioni che facevano pensare all'arcata di un violoncello. Era colto, e cantava in più lingue. La sua potenza era tale che quando, ad esempio, nella Risurrezione di Lazzaro del Perosi intonava il «Lazare, veni foras», sembrava come uno squillo di molte trombe all'unisono, e si sarebbe potuto credere che quel grido avrebbe davvero risvegliato i morti nelle loro tombe, tale era la solennità augusta e l'imperiosità sovrumana di quella voce! Ma aveva anche espressioni di dolcezza inaudita. Un vero fenomeno poi, anche per il fatto di aver potuto cantare fino oltre i settant'anni, fu Mattia Battistini. Certamente fu il più grande baritono dell'ottocento dopo Cotogni. La sua voce era di timbro tenorile, e la dolcezza, la finezza delle sfumature così espressive, il suo canto così pieno di poesia che indussero Massenet a trasportare per lui la parte di Werther per sentirgliela cantare. Un altro fra i maggiori artisti lirici del secolo XIX è stato Titta Ruffo. Ruffo era... il nome del cane di suo padre! Strana affezione per la quale un padre impose tal nome al figlio, che... cane non fu! Fu invece un grande baritono, dalla voce un po' amara, ma robusta. Anch'egli compiuto attore, come furono pure Riccardo Stracciari e Carlo Galeffi, dalle voci baritonali estese e bellissime, e dalle interpretazioni versatili e avvincenti. E rimarrà pure indimenticabile Mariano Stabile per il profondo umorismo della sua interpretazione del personaggio di Falstaff.
Un baritono insigne straniero va pure ricordato, ed è il francese Victor Maurel, ammiratissimo primo interprete di Jago e di Falstaff, che però talvolta, come attore, tendeva a strafare.
Ai bassi Nazzareno De Angelis, Ezio Pinza e Tancredi Pasero, che ebbero bellissime voci e furono altresì buoni attori, va aggiunto quello che fu uno dei più suggestivi artisti d'ogni tempo, il russo Feodor Schaljapin, la più poderosa voce di basso che. si sia udita nel secolo scorso. In lui il cantante e l'attore si equivalevano: di qui un'efficacia scenica che raggiungeva vertici di indescrivibile intensità tragica. Anche quando taceva, l'espressione della sua fisonomia, la sua mimica, i suoi atteggiamenti scultorei, esercitavano un fascino irresistibile sull'uditorio. Va a lui anche il merito di averci fatto conoscere, in esecuzioni indimenticabili, il Boris Godunoff di Mussorgski. Oggi sono applauditi fra i bassi due interpreti mirabili per arte e voce: l'italiano Francesco Rossi Lemeni, e il russo Boris Cristoff.
Per fortuna l'invenzione del grammofono ci permette di sentire ancora le voci e le interpretazioni di parecchi di questi cantanti, la cui arte dovrebbe in molti casi far scuola, se, per ragioni commerciali, talvolta essi non avessero, di fronte alla macchina da presa, sentito il riprovevole bisogno di alterare ciò che l'autore aveva scritto, per tramandare effetti gigioneschi di loro invenzione!
La grand-opéra, con l'importanza data al ballo, fece fiorire un numero non indifferente di coreografi, di mimi, di ballerini e ballerine. Poi, a un certo momento, il ballo si staccò anche dal melodramma per acquistare una vita propria e indipendente, sia in forme ampie, sia nelle minori ma suggestive forme del «balletto». Tra i coreografi del secolo scorso va rinomato quel SalvatoreViganò che fu anche compositore. Egli sposò la bellissima quanto frivola ballerina Maria Medina (Josepha Maria Mayer), la quale usava danzare quasi nuda, atteggiandosi secondo figurazioni di bassorilievi antichi. Fu Viganò a portare per primo sulla scena Le creature di Prometeo di Beethoven. I suoi balli erano vere pantomime danzate e cadenzate, ed erano improntati a vivacità di movimenti ritmici di persone e di gruppi, e ad una mimica efficacemente espressiva. Non più, nei gruppi, lo stesso gesto per tutti, ma ogni individuo aveva gesti e atteggiamenti in rapporto alla propria personalità.
Altro coreografo che ebbe un periodo di grande fama fu Luigi Manzotti, autore, fra l'altro, del fantasmagorico ballo Excelsior, musicato da Romualdo Marenco, che ebbe in Italia e all'estero strepitosi successi. Fra le ballerine, talune sono rimaste famose per la loro bellezza, altre per la plasticità degli atteggiamenti, altre per la portentosa abilità del piroettare. La storia ricorda i nomi di Maria Taglioni, Carlotta Grisi, Fanny Eissier, Virginia Zucchi, Elena Cornalba, Fanny Cerito. Nel secolo attuale, la sfortunata Isadora Duncan, che rimase stranamente strozzata da un velo che aveva attorno al collo e che si impigliò in una ruota dell'automobile su cui viaggiava; l'intellettuale Jia Ruskaja, la stupenda Ida Rubinstein, prima interprete del Martirio di S. Sebastiano di D'Annunzio e Debussy; Anna Tatiana Paviova che rese celebre in una suggestiva interpretazione La morte del cigno di Saint-Saens, sono state al loro tempo celebratissime.
Poi la danza assunse nuovi atteggiamenti espressivi e poetici per opera di coreografi e danzatori moderni, fra i quali vanno ricordati Sergio Diaghiiew, il creatore del «balletto russo», dell'Uccello di fuoco e del Petruska di Strawinski; Bronislaw Nijinski, e Sergio Lifar che seppe infondere un veemente lirismo epico nella danza, seguiti dai moderni Aurel Millos, Leonida Massine e Giorgio Balanchine, e dalle ammiratissime ballerine Yvette Chauviré, Margot Fonteyn, Violette Elvin.
Naturalmente anche la scenografia, con le trasformazioni che il melodramma ha subito dal settecento ai giorni nostri, è andata modificandosi. Dalle macchinose scene del seicento, che puntavano soprattutto sulla meraviglia, si è passati all'impassibilità delle scene settecentesche, ammirevoli spesso per il senso architettonico, per le fughe di archi, colonne e scalee, ma distaccate dal dramma. Dalle scene di Lodovico Ottavio Burnacini e di Giacomo Torelli si è giunti a quelle architettonicamente fantasiose di Francesco e Giuseppe Bibiena. Nel primo ottocento Alessandro Sanquirico continua ancora lo stile a solenni prospettive architettoniche, non senza una certa rigidezza di linee. Ma già con Carlo Ferrano, con Carlo Parravicini, con Antonio Rovescalli, con Leonida Edel, e poi con Luigi Brilli, con Edoardo Marchierò, per quanto ancora fondamentalmente legati a concezioni veristiche e storiche, la scenografia si mette per vie nuove. Nella seconda metà del secolo XIX l'arte scenografica subisce l'influsso del romanticismo; le scene assumono aspetti più movimentati e drammatici, con forti contrasti di luci e d'ombre; l'ambiente e l'azione stringono fra loro sempre più intimi rapporti con Mario Vellani Marchi e con Nicola Benois. La scena, pur mantenendo e accentuando caratteri propri di poesia pittorica, pei quali può sfruttare ormai i più sorprendenti effetti di luci colorate di cui il progredire dell'illuminazione elettrica ha arricchito i teatri, si preoccupa di unire la propria suggestione a quella del dramma, della musica e della mimica per una più compiuta espressione dell'opera d'arte. Si arriva così alla scenografia modernissima,. che diremmo «essenzialista», in quanto il disegno schematico procede per accenni approssimativi, più suggerimenti di architettura e di paesaggio che vera e propria architettura e paesaggio. I tendaggi e i drappeggi sostituiscono i muri; l'accenno scheletrico di una finestra o di una porta su un fondo nero bastano a concentrare l'attenzione su le parti essenziali di una stanza, eliminando i particolari dispersivi. Siamo alle scene di G. Wunderwaids, Ludwig Sievert, Alfred Roller, Mario Cascella, Efisio Oppo, Savino Labò, Felice Casorati, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Mario Sironi ed Herta Bòhm.
Riprendiamo ora la rapida corsa attraverso ai Maestri della k giovane scuola». Ad essa appartiene anche Umberto Giordano il quale, specialmente in tre delle sue molte opere, cioè néll'Andrea Chénier (1896), nella Fedora (1898) e nella Siberia (1903) ha mostrato di saper fondere in unità di stile alla propria vena ricca di umano pathos elementi eterogenei assimilati da autori i più svariati. Infatti accanto a una vena canora spesso largamente espansiva e sinceramente commossa, non mancano coloriture orchestrali di natura wagneriana, o fraseggi che sembrano ispirati alla finezza della scuola francese. Ma anche Giordano è, come Puccini, se pure in grado minore, un buon assimilatore, e non dimentica di dare, in qualunque momento, la preminenza al canto vocale. Sempre aderente al testo, che interpreta con acuto senso di poesia ambientale, non manca all'occorrenza di accenti fortemente drammatici.
Liricamente più tenero e delicato, ma anche più scarso di drammaticità, è Francesco Ciléa, la cui migliore opera resta senza dubbio Adriana Lécouvreur (1902) per la fluida e calda vena melodica che la percorre da cima a fondo, ed anche per l'eleganza signorile dei ritmi e dell'orchestrazione.
Nelle opere di Alberto Franchetti affiora spesso l'orchestrale wagneriano e il melodizzare di Goldmark; ma il canto di Franchetti risulta un po' freddo e stentato, mentre l'elemento descrittivo e i grandi movimenti di masse corali trovano nella sua fantasia una sensibile ed efficace rispondenza. Tali doti emergono specialmente nell'Asrael (1888), nella Germania (1902), e soprattutto nel 2° atto del Cristo/oro Colombo (1892), opera che resta il suo capolavoro.
L'ultimo dei compositori della scuola cosidetta verista è Riccardo Zandonai che raggiunge la sua migliore espressione nella Francesco da Rimini (1914), composta su una riduzione della tragedia dannunziana. Il suo stile oscilla fra l'effusione lirica mascagnana e le preziosità orchestrali di Charpentier. Ma ha una propria sensibilità drammatica che si rivela nella forte dipintura del personaggio di Malatestino.
Nell'orbita wagneriana per l'amore alle leggende poetiche del Nord e per i disegni di taluni recitativi e il trattamento dell'orchestra è Alfredo Catalani, che peraltro non rinunzia all'ampia chiarezza del canto ch'egli deriva dall'arte italiana. Al canto appassionato, in cui vibrano accenti di profonda elegia, egli associa un descrittivismo poetico e fantastico orchestrale che trasporta personaggi e azione in un mondo irreale e sognante. Egli dunque, così in Edmea (1886) come in Loreley (1890), e meglio in Wally (1892) si palesa più legato alla scuola romantica che a quella verista. Tuttavia il modo di cantare dei suoi personaggi rivela in loro un'anima trepidamente umana e lontana dall'astrattismo proprio dei romantici puri.
Completamente wagneriano nella concezione operistica, nella struttura, nell'armonizzazione, se non nella melodia talora caldamente italiana, è invece Antonio Smareglia, il quale, anche dove meglio la fantasia lo sorregge, come nell' Oceano. (1902) e nelle Nozze Istriane (1895), non appare che un imitatore troppo spesso assorbito e accecato dalla luce del grande astro tedesco.
Un posto a sé occupa Ermanno Wolf-Ferrari, artista pieno di grazia e di arguzia elegante e signorile, che in forme moderne fa rivivere il sentimento della commedia goldoniana. Figlio di un tedesco e di un'italiana egli ha studiato in Germania, ma la sua anima di artista proviene unicamente dalla madre, ed è prettamente veneziana. Egli sa fondere con spontaneo innesto al canto moderno la canzone veneziana sentimentale. Baruffe e amori, sospiri e pettegolezzi, tutto il mondo e il colore della Venezia popolana, borghese e aristocratica del settecento rivive in una visione moderna per sapienza di mezzi e per gusto, antica per serenità e limpidezza di disegno. La satira divertita dei costumi e dei caratteri è espressa con una cantabilità fluente, ora pomposa ed ora leggera, ora pungente ed ironica, ora bonaria e umoristica, tra una lagrimuccia e un dispetto, tra un sorriso e un'impertinenza, con tinte chiare e trasparenti, profondamente umana e intensamente musicale. Specialmente ne I Quattro Rusteghi (1906) e nel Campiello (1936) lo spirito goldoniano della commedia di caratteri e d'ambiente si è trasfuso in musica come se lo stesso Goldoni fosse rinato musicista. Ma non c'è imitazione del settecento, nè di quello italiano nè di quello mozartiano. C'è solamente lo spirito del secolo ricreato entro un'atmosfera sonora totalmente moderna. E il fatto più mirabile si è che tra spirito antico e stile moderno non v'è contrasto, ma perfetta omogeneità per un processo di integrazione veramente unico e geniale.
Frattanto altri artisti fioriti all'estero nel secolo XIX sono da ricordare, oltre a quelli già citati nel capitolo III. Per esempio Camillo Saint Saëns, delle cui opere una sopravvive per la quadrata e robusta struttura, per l'impeto irruente di certi cori, per la sottile sensualità di alcune melodie amorose, pel colore di qualche danza e per la tersa lucentezza dello strumentale; ed è il Sansone e Dalila (1890). Un musicista noto specialmente per le sue operette è Giacomo Offenbach. Chi non conosce Orfeo all'Inferno, La bella Elena, La figlia del Tamburo Maggiore, ed altre opere comiche ed operette sue, dalla musica gaia e frizzante? Ma v'è un'opera, I racconti di Hoffmann, in cui lo stile del compositore si eleva e si nobilita per l'amato lirico inconsueto e personale, e per il garbo e la vivacità di talune scene tragicomiche, che lo rendono degno di maggior rispetto.
Sorvoleremo sul denso, dotto, ma appunto per ciò non sempre spontaneo, anzi troppo riflessivo, Vincenzo D'Indy, autore, fra l'altro, dell'opera Fervaal. La troppa riflessione e la molta dottrina congiurarono spesso insieme a tarpare l'ali della fantasia, che appare perciò spesso contenuta e fredda. Più liricamente spontaneo, anzi temperamento essenzialmente lirico e teatrale fu invece Giulio Massenet. La sua vena melodica è molto patetica, e talvolta perfino sentimentale, ma l'eleganza della forma, la delicatezza aristocratica dello strumentale, la poesia di varie sue ispirazioni, la dolcezza del suo canto, sono tutti pregi che fanno di lui un Maestro ricco di nobile fascino. Tali qualità emergono particolarmente in Werther (1892), in Thaìs (1894), e specialmente nella sempre freschissima Manon (1884); opere che imposero il suo stile come un modello che molti altri imitarono, o da cui per lo meno derivarono qualche elemento, in particolare la lineatura fine delle melodie e la morbida malìa del sentimento lirico. Peccato che la teatralità gli prenda talvolta la mano conducendolo alla ricerca di qualche effettaccio superficiale e banale.
Fra i compositori russi della seconda metà dell'ottocento uno dei più noti è Nicola Rimski-Korsakow. Nelle sue opere principali, La Pskovitana (1894), Sadko, Il gallo d'oro. Czar Saltan, e La leggenda della città invisibile di Kitesc (1907), egli appare il meno fedele al programma dei «cinque», il quale, come si disse, mirava a creare un teatro nazionale mediante lo sfruttamento del materiale folkloristico. Ma sovrasta di gran lunga i compagni per lo splendore della strumentazione che è di una ricchezza e varietà di coloriti abbagliante, e si stacca da quella di ogni altro contemporaneo, anche da quella di Wagner.
Completamente distinto dal gruppo dei cinque è invece Pietro Ciaicowski, il quale subì fortemente l'influsso dell'arte occidentale. La sua chiara vena melodica, sorretta da un elegante senso della forma e da una sicura sapienza tecnica, gli permise di raggiungere i risultati migliori specialmente in tre opere teatrali: Eugenio Oneghin (1879), La dama di picche (1890) e Volontà (1892).
In Germania Engelberto Humperdink applica le forme e la tecnica wagneriana, rinfrescata al soffio delle canzoni popolari, con ottimo risultato nella fiaba Hansel e Gretel (1893). Il connubio, per una volta tanto, è riuscito bene, che in altre opere, nei Figli di Re, per esempio, l'autore non si levò ad eguale perfezione per la debolezza intrinseca dell'ispirazione.
Completamente imbevuta di color locale, e tutta richiami ed echi di danze folkloristiche è La vida breve (1905) di Manuel de Falla, opera, peraltro, che appartiene già al secolo XX, non tanto per la data della sua composizione, quanto per lo spirito novecentista della fattura e dell'ispirazione che si accende alla canora fiamma della Spagna con espressione personale.
[Torna all'indice]
Capitolo VI.
Lo spericolato Novecento
Il primo grande compositore del secolo XX, Riccardo Strauss, è un prosecutore dell'arte wagneriana. Non certo per l'espressione eroica o mistica, che gli manca totalmente, ma per lo stile sinfonico strumentale. Ma il wagnerismo è portato da lui agli estremi limiti del parossismo e dall'esasperazione. L'architettura, già così complessa in Wagner, assume proporzioni colossali. Strumenti nuovi sono aggiunti, e i disegni più differenti sovrapposti in intrecci ardui e in complessi di poderose e nuove sonorità. I vari temi e le melodie sovrapposte si combinano con grande libertà nel movimento delle loro linee, originando spesso urti dissonanti che si dissolvono e si riformano come i cerchi nell'acqua al lancio di sassi. L'espressione è quanto mai sensuale e s'aggira tra gli scatti nevropatici di cui è quasi sempre intessuta la musica di Salomé (1905) e di Elettra, (1909), e la mollezza dei valzer, dei quali in qualche opera, come ad esempio nel Cavaliere della Rosa (1911), abusa in maniera stucchevole. Il predominio assoluto dell'orchestra sul canto rende minore il rilievo del carattere dei personaggi, mentre l'esasperazione di questi accomuna in un'unica espressione l'ebrea Salomé e la greca Elettra, e confonde i diversi ambienti in un'identica atmosfera turbinosamente esagitata. Ma noi siamo dominati comunque dalla prodigiosa forza che si sprigiona dall'orchestra sempre corrusca e sfolgorante di colori accesi, e dalla non meno sorprendente sapienza e grandiosità della costruzione.
Un wagneriano è, in fondo, anche Gustavo Charpentier. Nella sua Luisa (1900) il tematismo e l'orchestrale ricordano lo stile di Wagner, addolcito dall'eleganza francese. L'intenzione veristica è svelata non solo dal soggetto del romanzo che lo stesso Charpentier si è composto, ma dalla sua stesura in prosa. La musica dell'opera però, imbevuta com'è di intensa espressione lirica, contraddice di fatto l'intenzionale verismo dello Charpentier librettista. Anche le descrizioni ambientali, non ostante i richiami dei rivenditori di piazza e le canzoni dei bohèmiens, sono intinte di poesia; ed è precisamente questa interpretazione poetica che la musica fa del veristico soggetto, quella che salva l'opera e le conferisce una non effimera vitalità.
Charpentier è forse l'ultimo dei wagneriani, perchè dal 1902, anno della prima rappresentazione del Pelléas et Mélisande, incomincia a farsi sentire l'influenza dell'impressionismo debussyano. Tale influenza notiamo nell'Arianna e Barbableue (1907) di Paolo Dukas, il quale tuttavia cerca ancora una conciliazione dell'impressionismo con la tendenza sinfonistica classica e l'idealismo di Franck. Orchestratore smagliante, egli usa dare ai temi, più plastici di quelli debussyani, una gran varietà di espressioni trasmutandone il ritmo e i timbri strumentali. Per le intenzioni egli si allaccia al simbolismo maeterlinckiano al quale attinse anche Debussy.
Sotto l'influsso debussysta è pure l'unica opera composta da Ernesto Bloch: Macbeth. Musica allucinata e cupamente soffocante come i personaggi e l'atmosfera della tragedia di Shakespeare; musica che però talvolta soffre di una certa aridità scheletrica e uniformità ritmica e armonica. Bloch fa anche uso di motivi tematici, ma questi non hanno un forte rilievo plastico e sono piuttosto spunti impressionistici atti a creare atmosfere. Appaiono in successione senza che servano a costruire architetture sinfoniche. Il meglio dell'opera è dato dunque dalla drammaticità insita nel commento orchestrale, tetro e dissonante, ma adeguato ai personaggi e alle loro azioni, e da un certo modo di cantare che senza essere propriamente arcaico ha una patina antica che bene s'addice all'epoca remota in cui si svolge l'azione.
L'influenza dell'arte debussyana fu risentita anche da qualche compositore italiano. La fanciulla del West e una buona parte del Tabarro di Puccini riecheggiano infatti lo stile del grande «Claudio di Francia». Più mutevole e complessa l'arte di Franco Alfano che iniziò l'attività operistica seguendo l'indirizzo della «giovane scuola italiana», mostrando subito un temperamento lirico esuberante. L'opera più importante e riuscita di questo primo periodo è Risurrezione (1904). Ma successivamente, impressionismo e straussismo, e da ultimo altri indirizzi più moderni, si sovrapposero e si fusero alterando le linee essenziali della sua personalità. L'opera in cui le varie correnti risultano meglio assimilate al suo naturale sentimento poetico è La leggenda di Sakuntala (1921).
Tre sono i filoni maggiori dalla cui fusione deriva lo stile di Ottorino Respighi, quale ci appare ne La Fiamma (1934), che è l'opera sua più teatrale e musicalmente robusta: l'impressionismo, i canti gregoriani e il recitativo monteverdiano. Questo, s'intende, per il canto e per l'armonizzazione, che la strumentazione, coloritissima, è il risultato dell'essere stato egli allievo di Rimski-Korsakow.
L'amore di Respighi per Monteverdi e per il gregoriano fanno parte di quella tendenza all'arcaico e al primitivo di cui è permeata gran parte dell'arte musicale (e non solo musicale) novecentista. E questo primitivismo è a sua volta uno degli aspetti di quest'epoca ansiosamente sperimentale. Verdi, Wagner, Debussy, Berlioz, Mussorgski sembrano aver esaurita ogni possibilità di nuove creazioni. Non si aprono all'avvenire che due vie: o rinfrescare l'antico facendolo rivivere attraverso a tutta l'esperienza tecnica e spirituale accumulata dalla nostra generazione, o cercare nuovi indirizzi attraverso a un radicale rinnovamento della tecnica e soprattutto delle forme.
Respighi, si disse, cercò una via di equilibrio fra l'antico e il moderno, tentandone una fusione. Su questa via si trova anche Ildebrando Pizzetti. Egli si rifà alla recitazione uniforme della Camerata fiorentina che soltanto in qualche raro momento di maggior animazione o di abbandono lirico acquista andamento più melodico. Tale recitazione però egli avvolge in un'architettura polifonica orchestrale densa e tutta pervasa da som mistici e romantici. Non mancano i richiami a stilemi di carattere popolaresco, alle tonalità della chiesa antica, od anche alle scale greche. Qualunque sosta lirica che interrompa o anche solo rallenti lo svolgimento del dramma è abolito. Il coro vi è concepito esclusivamente come un personaggio attivo. Nelle sue principali opere, dalla Fedra (1915) alla Dèbora Jaéle (1922), a Lo Straniero (1930) all'Orseolo (1935), all'Oro (1947) e a Vanna. Lupa (1949) questi caratteri sono facilmente riconoscibili. Ma l'opera in cui dramma e musica ci sembrano compenetrarsi meglio e raggiungere più viva e commossa ispirazione in un maggiore equilibrio di forme, è il Fra Gherardo (1928).
Ancora più scheletrico, appare il recitativo nelle opere di Gian Francesco Malipiero (Giulio Cesare [1936], Antonio e Cleopatra [1938], Ecuba [1941], ecc.) che rivelano un grande amore del nostro Seicento. L'orchestra segue il dramma e lo commenta rinunziando ad ogni sviluppo tematico e sinfonico. La sensibilità musicale antiromantica del Malipiero compositore non è molto comunicativa, e questo spiega forse la debole risonanza che ha trovato nel pubblico. Forse le nuoce la scarsa espansività, l'estrema concisione, l'aspra durezza dei disegni vocali, e quel tormento ironico demolitore che quando non getta l'autore verso un repellente dissonantismo, ne ferma e inaridisce l'ispirazione avviandola incontro a quel cantilenare piatto e uniforme che apre la porta alla noia. Ma bisogna star molto attenti. Il pubblico non va a teatro per sentire cose repellenti. L'arte, e quindi anche il teatro, debbono creare un diletto (diciamo appositamente diletto e non divertimento); un diletto dello spirito. L'arte deve darci il «bello»; deve, in sostanza, trasportare l'animo nostro in una sfera ultrasensibile. Inutile pensare a un teatro per pochi snobisti, o per soli professionisti: il teatro è fatto per la folla che dev'essere elevata verso ideali di perfezione ma non cacciata nel ginepraio ispido di esperienze da laboratorio, dove tutto è per lei ermetico e ostile.
Scetticismo, ironia, sovversivismo della tecnica, erano già insite nell'opera di Ferruccio Busoni. Turandot (1906), Arlecchino (1920) e il Dottor Faust (1925) rivelano il suo spirito inquieto, in cui l'elemento cerebrale e l'ironia polemica contro il passato spesso sopraffanno l'artista. Anche Busoni fu un antiromantico, e fu lui a denominare neoclassicismo questo movimento ch'egli capitanò. Nella sua arte è un intimo dissidio fra tradizionalismo e avvenirismo che, del resto, è palese anche nei suoi scritti.
E le esperienze sono tutt'altro che finite, perchè oltre alle altre non classificate dai loro autori, oltre al neoclassicismo busoniano e dei suoi imitatori, c'è l'oggettivismo che ne è una derivazione diretta, e c'è l'atonalismo e il politonalismo; e ci fermiamo perchè in arte i nomi classificatori sono assurde etichette, che se prese sul serio dai compositori ne limitano il volo, e se non prese sul serio rimangono inutili e sterili nomenclature senza senso.
Sta di fatto che oggi anche Debussy sembra già lontano, e le nuove divinità si chiamano Strawinski, Schónberg, Hindemith e Milhaud. E qui siamo proprio ormai su la china più pericolosa. L' «oggettivismo» è l'assenza di ogni espressione affettiva. Per gli oggettivisti la musica non esprime e non deve sforzarsi di esprimere sentimenti. Gli elementi della musica non hanno di per sé stessi un carattere espressivo. Per dare un esempio: se dite a un oggettivista che la 5a con cui incomincia la Sinfonia Pastorale di Beethoven ci spalanca davanti una calma visione campestre perchè la 5"' è un accordo che da un senso di calma dilatata e serena, vi risponderanno con un facile capovolgimento che noi diamo tale interpretazione alla 5a unicamente perchè Beethoven l'ha usata a scopo pastorale, onde noi siamo tratti ad associarvi tale ricordo. Ma, di grazia, perchè Beethoven, o altri prima di lui, hanno pensato proprio a una 5a per esprimere la pace campestre e non piuttosto a una 7a o a una 11a? Ora, le alterazioni armoniche degli oggettivisti sono intese ad annullare continuamente i valori espressivi tradizionali, e ciò specialmente coll'infilare motivi che di per sé stessi non hanno senso e si trovano in disaccordo con gli altri elementi sovrapposti o sottoposti, successivi o precedenti della composizione, cioè con l'abolire ogni rapporto logico ed estetico.
L'oggettivismo abolendo il sentimento riduce la musica a un semplice problema di costruzione, a un gioco geometrico, a una pura ricerca di rapporti sensoriali fra valori ritmici, timbrici, di movimento, di volume e di forza. Questo vuol dire fare dell'edonismo materialistico, peggiore dell'edonismo sentimentale perchè di natura intellettualistica, e cioè antiartistica. Ma in coloro nei quali l'oggettivismo si accompagna con l'ironia per i valori del sentimento (quello che Verdi chiamava «il cuore») una espressione non manca, ma è un'espressione negativa, di natura cinica; nei casi migliori sardonica e beffarda.
L'assenza di tonalità dà un'impressione di incertezza e di disagio continuo, come se ci mettessimo a ballare su una corda senza trovare un sicuro equilibrio. L'associazione di più tonalità simultanee, crea senza ragione l'urto caratteristicamente odioso delle cose che non hanno a che fare insieme, come una bara nel mezzo d'una sala da ballo o la limatura di ferro sui maccheroni. Perchè, bisogna anche aggiungere, c'è chi va a cercare deliberatamente le associazioni più aspre e dissonanti. E siccome spesso non se ne vede la ragione lirica (quella logica è inutile cercaria perchè non ha a che vedere con l'arte) così si rimane sotto l'impressione di qualche cosa di sistematicamente voluto per dare pugni nello stomaco. E quando qualche cosa in arte è divenuto sistema, peggio quando questo sistema è voluto, e ancor più quando è imitato rinunziando alla propria personalità e alla sincerità, la poesia se ne rivola al suo cielo. Ma che valore ha l'imitazione in arte? Quando manca la scintilla personale, quando gli artisti, lavorando secondo lo stile e la tecnica di altri, rinunziano al proprio mondo, nessun'opera resiste per quanto ingegnosa essa appaia. E ciò che è ingegnoso non è detto che sia bello.
Ma nel campo delle «esperienze» c'è ancora dell'altro: motivi, per esempio, che si direbbero trascelti appositamente tra quelli che un tempo qualsiasi compositore (ammesso che gli fossero passati per la testa) avrebbe rifiutati come brutti e odiosi; motivi che sembrano fatti da uno che, non sapendo la musica, metta le mani a caso sulla tastiera. Poi c'è il «primitivismo» che, se può essere sincero in uomini venuti da razze le cui origini barbariche non sono molto remote nel tempo, e che quindi la barbarie hanno ancora come cosa viva nel sangue, è però una cosa completamente cerebrale e di maniera nei soliti imitatori. E fra i mezzi usati dal primitivismo c'è quello di voltar le spalle al canto e di rifugiarsi nei ritmi violenti; di non servirsi più degli istrumenti cantanti e di sfruttare largamente gli istrumenti a percussione. Il primitivismo fatto da uomini che primitivi non possono essere perchè discendenti da una lunga e grande civiltà (parlo in particolare degli Italiani) è del falso fatto coscientemente. E si sa bene che valore può avere in arte il falso.
Non diciamo che tutto questo non sia espressione del nostro tempo; anzi! Il nostro tempo si è svolto fra due guerre mondiali, una più feroce dell'altra; è il tempo del nazifascismo brutale, dei totalitarismi soffocanti e delle criminali persecuzioni razziste. È il tempo della violenza sistematica, pubblica e privata, materiale e di coscienza. È il tempo dei grandi appetiti ed egoismi imperialisti, e delle paci ingiuste. Ed è il tempo del disagio più aspro, del tormento più assillante sia economico che politico, sia intellettuale che morale. L'ansia rabbiosa con cui, seguitando a fucilare, ad impiccare, e a fabbricare bombe atomiche per una più vasta e orrenda strage, si cerca una formula che dia pace e serenità al mondo, va di pari passo con quella che affligge gli artisti alla ricerca di nuovi indirizzi. Non c'è da stupirsi se talvolta qualcuno perde il senso dell'equilibrio e si mette a denigrare ingiustamente coloro che sono venuti prima, coloro che usavano o usano altri sistemi, o che la pensavano o la pensano diversamente. Ci si provò a dir male di Verdi; ma si capì subito che a prendersela con il colosso c'era tutto da perdere. Il disprezzo si riversò allora sopra figure di secondo piano le "quali presentavano più facilmente il fianco alla critica: Boito, Mascagni, Ponchielli, Puccini e minori. Poi è venuto il momento in cui la polemica non si è più accontentata di servirsi della critica, ma ha costituito uno degli aspetti dell'arte medesima. Non è cosa nuova, e non diciamo che sia sempre un danno; I maestri Cantori di Wagner sono anch'essi, almeno alla base, opera polemica.
Tutto ciò è esperienza, e non tutta sarà nociva nè inutile. Soltanto occorre che l'arte non si riduca a una scuola scientifica. Anche l'arte ricerca, anche l'arte scopre: sta bene; ma le ricerche e scoperte debbono riguardare non la tecnica per se stessa, bensì lo spirito. Ora, il ridurre la musica a puro e semplice rovesciamento dei valori passati, al solo scopo di essere diversi, è demolire e non ancora creare.
Ciò spiega, almeno in parte, la scarsa aderenza del pubblico, che invano si cerca di mascherare con l'accusa di lentezza da parte di esso, a seguire i mutamenti dell'arte. E si citano le grandi catastrofi di capolavori (Barbiere di Siviglia, Norma, Traviata) determinate (si dice, ma non è del tutto vero) dall'incomprensione del pubblico, e l'ostilità prolungata contro le opere di Wagner. Ma va ricordato che gli insuccessi delle opere dianzi citate ebbero pronte rivincite, e che le opere di Wagner nello spazio di un decennio si imposero, mentre le manifestazioni dell'arte novecentista dopo quasi mezzo secolo sono ammirate solo da una ristretta cerchia di catecumeni. Inoltre il pubblico non rifiuta questa o quell'opera di questo o quell'autore, ma tutte in blocco le manifestazioni musicali di tutti i compositori atonalisti, politonalisti, oggettivisti e simili. Il che non vuol dire che non vi siano nelle loro opere cose degne di ammirazione anche da parte del pubblico, e che la tecnica novecentista non presenti aspetti meritevoli di fortuna. E la prova si è che quando un musicista geniale come Puccini, seppe conciliare le esperienze della tecnica novecentista con le esigenze del canto e del teatro, senza rinunciare alla propria personalità, com'egli fece in Turandot, ne nacque un'opera vitale (vitale, si noti, non ostante i difetti e gli squilibri del libretto) e subito accettata dal pubblico. E se espressioni esotiche, arcaiche, primitive siano opera non di un sistema cerebralmente studiato e applicato, ma sgorghino per geniale intuizione, come nell'Aida di Verdi o nella Sagra della Primavera di Strawinski, il pubblico non potrà non subirne il fascino.
Crediamo di non poter essere sospettati di conservatorismo e di passatismo, noi che non abbiamo mai tralasciata occasione per lodare l'audacia novatrice di tanti compositori del passato, quando l'audacia risponde non a formule prestabilite o a teoriche preconcette, ma a un sentito (sentito anche dal pubblico) bisogno spirituale. Tra questa esaltazione e le nostre critiche a taluni aspetti ed esperienze del novecento non c'è contraddizione. Ripetiamo che qualunque novità è lecita se risponde a un bisogno spirituale spontaneo e non a un congegno studiato e, soprattutto, se all'innovazione tecnica si accompagna l'ala, cioè quel certo quid indefinibile che ci trasporta in una specie di incantamento profondo che non ha nulla a che fare con l'ammirazione, anche entusiastica, per la trovata e pel sistema, ma che li supera e li assorbe in nome della poesia, ed è il segno della personalità artistica vera. Tutto è calcolato in una fuga di Bach, ma tutto è anche animato dall'altezza del volo lirico, dalla grandiosità della concezione e dalla bellezza melodica dei temi. Tutto questo s'è detto unicamente per chiarire il nostro punto di vista, che potrà anche non essere condiviso, ma che è scevro da preconcetti.
Nei riguardi del teatro, di cui ci stiamo occupando, i maggiori esponenti del movimento d'avanguardia, si tratti di Paolo Hindemith con Mathis der Maler (1935), o di Alban Berg con Wozzeck (1925), o di Dario Milhaud con Les malheurs d'Orphée (1926) o con Le pauvre matelo! (1927), o di Arturo Honegger con Giuditta (1925), o dello steso Igor Strawinski con Le Rossignol (1914) o con Mavra (1921), tutti espertissimi costruttori, sia che tentino di riallacciarsi a un Bach di cui non hanno sentito che la magistrale geometria architettonica, sia che marcino decisamente verso vie nuove e sovvertitrici, non hanno mai lasciato opere che vivano oltre la curiosità di un momento, specie per la loro consumata tecnica rivoluzionaria, ed hanno esercitato sul pubblico piuttosto una reazione di maggiore diffidenza verso ogni novità che un impulso a un accresciuto interesse.
Per accennare solamente ad alcune delle più importanti opere sopra ricordate, si è fatto, ad esempio, un gran parlare intorno al Mathis der Maler di Hindemith (1895), composto tra il 1934 e il '35, ed eseguito soltanto nel 1938 a Zurigo. Ebbene, è certo che l'uso di canti popolari e religiosi e il prevalente senso diatonico danno a quest'opera un aspetto generale di maggior distensione in confronto alle composizioni strumentali precedenti, ma è altrettanto certo che la dura angolosa legnosità con la quale il Maestro concepisce linee melodiche e armonie è sostanzialmente immutata. È una continua deformazione in cui l'architettura contrappuntistica, intesa come formula anti-sentimento, porta a sovrapposizioni di linee, più o meno contorte, di tonalità differente (il cui risultato è l'annullamento del senso tonale) oltre all'urto di dissonanze sconcertanti. Tutto è congegnato con scrupolosa esattezza secondo norme inflessibili, come le rotelle di una macchina perfetta ma senza cuore, dove il calcolo sostituisce il sentimento. Non basta una sinfonia ben costruita, a temi chiari (se non belli) e qualche altro buon frammento a fare un'opera bella.
Altro discorso va tenuto a proposito del tanto decantato Wozzeck di Alban Berg (1885-1935), composto fra il 1914 e il 1920, ed eseguito la prima volta nel 1925 a Berlino. Si tratta di un dramma in cui i personaggi non manifestano che una psicologia animalesca, che va dall'abbrutimento (Maria) alla cretineria (Capitano), dall'abulia vacuamente filosofeggiante (Wozzeck) al cinismo grottesco (Dottore), con uno sfondo di pervertiti e di alcoolizzati. Il protagonista, che è stato descritto come la vittima di una malvagia oppressione sociale imperante, in realtà è spinto all'assassinio e al suicidio solo dalla propria stupidità, e non desta perciò nessuna commiserazione. Manca ogni luce di idealità, si respira in un ambiente soffocante perchè privo di atmosfera spirituale, dominato da una follia allucinante. Suoni timbri e ritmi di questa... aiutatemi a dir musica, si aggirano in prevalenza per il buio carcere dodecafonico, attraverso a un dissonantismo dei più duri e urtanti, insistente fino alla nausea, e appaiono veristicamente coerenti col dramma e coi personaggi, cioè privi di idealità e di spiritualità. Ora, un dramma musicale siffatto potrà anche essere costruito con la più ammirevole abilità (e su questo non c'è dubbio), ma, privo com'è di ogni soffio spirituale, si può dire bello? I valori tecnici, il tritume dei motivi deformati, odiosamente alterati per la estrema sgradevolezza degli incontri armonici, quel cantilenare o parlottare a barlumi di motivi, a singhiozzi ritmici, a disarmonici salti, vaganti in maniera spettrale perennemente su uno sfondo atonale o politonale come un incubo ossessionante che non disorienta solo perchè fuori delle consuetudini, ma perchè contro natura e disumano, può costituire arte? E quando diciamo arte non pretendiamo, no, che essa diletti i sensi, ma che dia luce allo spirito, che sia umana, questo sì!
Arte deformante e disumana; anche quando l'autore riprende motivi da altri, come per esempio il 1° tema di fuga (atto 2°, dialogo fra Capitano Dottore e Wozzeck) il quale non è che una storpiatura del tema iniziale della «Pastorale» di Beethoven; o il motivo di valzer all'inizio della scena 4a dell'atto 2°, altra storpiatura del valzer del Cavaliere della rosa di Strauss. Tuttavia se la coerenza può avere qualche valore artistico, conveniamo che Berg è stato coerente: ci ha dato un mondo di nevropatici ripugnanti che trovano la loro giusta espressione in una musica altrettanto ripugnante e pazzesca. Tutto ciò è coerente, sì, ma è arte degradata e degradante. Musica, comunque, più funzionale che drammatica; abilità posta al servizio di un sovversivismo nichilista. Se Wozzeck e un capolavoro, la sua musica ci da la chiave per capire che cos'è la dodecafonia e a quale basso livello si arresta, nel caso migliore, il suo potere espressivo.
Uno dei lati dell'asserita originalità del Wozzeck sta in un equivoco assurdo, e cioè nell'associazione di forme strumentali da camera (1° atto, costruito come una Suite di stile antico; 2° atto come Sonata, Invenzione e Fuga; 3° atto, come Invenzioni) a quelle drammatiche. In questa contaminazione (nella quale è caduto in parte anche l'Hindemith), attuata anch'essa in maniera deformante e frammentaria, che cosa ci guadagni l'espressione del dramma non si vede. Che cos'abbiano a che fare fughe, invenzioni, variazioni, passacaglie con l'abbietto e tragico destino di Wozzeck, in verità non si capisce; come non si avverte il vantaggio del commentare quello che dice un personaggio con la grande orchestra, e quello che risponde l'altro con l'orchestra da camera. Tutte cose davanti alle quali certa critica che vuol passare per illuminata cade in ginocchio adorando e gridando al miracolo!
La chiusa dell'opera poi vorrebbe essere sentimentale, ma una rondine non fa primavera. Del resto le storture armoniche e l'odiosa imbecillità del bimbo che neppure cerca la madre, rendono antipatica anche la chiusa dell'opera.
Concludendo: si tratta di un'opera di eccezione che può interessare di conoscere; amarla... è un'altra cosa!
In tutti questi maestri il canto si risolve in una melopèa frammentaria e scarsamente incisiva. Ora, questa adesione stretta alla cadenza del linguaggio parlato è una forma di verismo materialistico, che può essere necessaria in determinati momenti, ma diventa antimusicale, antiartistica, se si trasforma in sistema. Anche Leo Janacek, del quale l'opera più famosa è Jenufa (1902) segue l'accento vocale e l'intonazione fonetica del linguaggio del contadino cèco, senza preoccuparsi del significato delle parole; ma tale accento gli suggerisce intonazioni melodiche nuove, per cui la sua opera reggerebbe male a una traduzione.
Sergio Prokofieff è un musicista che appartiene ad altro indirizzo. In lui la libertà del tessuto armonico e polifonico è potenziato da una vita ritmica e da un colore orchestrale che discende in prima linea da Igor Strawinski, e in particolare da quello spalancarsi improvviso di porte alla raffica violenta della barbarie primitiva che è costituito dal balletto La Sagra della Primavera. In fondo Prokofieff è ancora fedele alla tonalità, benché non manchino i balzi audaci a tonalità diverse e gli incontri fortemente dissonanti. L'elemento fiabesco, enigmatico e grottesco affiora in varie opere sue, anche nella trita musica dell'Amore delle tre melarance (1921).
In Italia al duro e angoloso Giorgio Federico Ghedini del Re Hassan (1939), ottimo costruttore ma di un'implacabile gravita monolitica, al rigidamente dodecafonico Luigi Dallapiccola, si contrappone il più vario e affettivo Lodovico Rocca del Dibuk (1934) e di altre opere, in cui al colore strumentale e alla ritmica marcata si associa un maggior rilievo del disegno melodico. Ancora più spiccata, per quanto risenta dell'influsso di varie correnti, da quelle strawinskiane ritmico-strumentali a quelle discendenti dalle teoriche atonali e politonali di Schònberg e di Hindemith, da quelle classiche della nostra opera buffa di Pergolesi e soprattutto di Rossini, all'impressionismo debussyano, è. l'arte di Alfredo Casella. Ne La donna serpente egli tentò, e in parte riuscì, a conciliare queste correnti, più o meno assimilate, in una forma di «melodramma» modernamente rivissuto.
Un altro filo si riallaccia all'opera comica di gusto goldoniano, con un misto di espressioni umoristiche e sentimentali, ed è quello offerto da Guido Farina. L'umorismo di Adriano Lualdi è invece più ironico e satirico, come nell'opera Il diavolo nel campanile (1925); ma la sua vena, che sfugge dagli atteggiamenti volutamente rivoluzionari, pur nella sua densa strumentalità coloristica, si ravviva al soffio della comicità, come nella Granicola e ne Le furie d'Arlecchino, ed anche ai fantasmi delle leggende esotiche, come ne La figlia del Re e ne La luna dei Caraibi (1953). Luigi Ferrari Trecate ha mostrato invece un gusto particolarmente indovinato ispirandosi agli arguti incantamenti delle fiabe infantili, specialmente in Ghirlino (1940) e in Buricchio (1948).
[Torna all'indice]
Opere famose e opere minori
[Torna all'indice]
Preambolo
Forse il miglior modo di seguire lo svolgimento della storia dell'opera in musica, di rendersi conto cioè dei vari indirizzi musicali, dei loro mutamenti e della loro entità, è quello di analizzare brevemente le opere principali nel loro ordine cronologico. È necessario precisare che per «opere principali» intendiamo non solo i capolavori gloriosi, che sono come i fari nel lungo cammino del melodramma da Monteverdi a noi, ma anche talune opere, fra quelle che interi capolavori non sono, significative di una tendenza, di un gusto, di un ambiente, di una società o di un'epoca. Opere molte volte dimenticate o quasi, spesso per la deficienza scenica del libretto, l'assurdità o la debolezza del dramma, o perchè legate alla moda di un momento, ma che avevano in sé germi di vita, raccolti da autori che successivamente li svilupparono.
Molte di queste opere, tuttavia, noi saremo costretti a trascurare affinchè la nostra trattazione non diventi troppo ponderosa, tanto più trattandosi di opere che solo per un caso eccezionale il pubblico può veder rappresentate o sentire trasmesse per radio. Trascureremo anche talune opere che ebbero successo per qualche tempo perchè più o meno ricalcavano forme in uso allorché apparvero, ma che non avevano in sé quel tanto di originalità e di intima forza che potesse conceder loro una lunga vita. La loro effimera fortuna è dovuta a contingenze particolari di luogo o di tempo, mutate le quali null'altro rimane di esse se non un gran vuoto sonoro. Sono le opere che dormono un sonno ben meritato, perchè i loro autori, privi di vero genio, non avevano nulla di personale da dire. È molto se di taluna di esse rimane ancor viva una romanza o una sinfonia.
Altre opere oggi non si rappresentano più, pur essendo ricche di bellezze, perchè mancano i cantanti capaci di eseguirle (e mancano purtroppo anche le scuole idonee a formare i cantanti). Di alcune di queste parleremo.
Parleremo pure di opere che a parer nostro soffrono di un immeritato oblìo, anche se il loro gusto non è più, necessariamente, il nostro; e parleremo di altre, le quali, pur essendo state scritte da compositori minori, hanno resistito al cambiamento dei gusti perchè rispecchiano qualche momento eccezionalmente geniale degli autori medesimi, o perchè realmente sono espressioni di una personalità, benché non grande, pure assai viva. Fra queste ultime ci sono opere care al pubblico, per quanto discusse dalla critica e discutibilissime. Anche l'espressione di un piccolo mondo, purché riuscito e in sé conchiuso,è arte ed ha diritto all'esistenza.
Il quadro storico che verremo così esponendo, ha non solo uno scopo informativo generico, ma anche quello pratico di orientare l'uditore, qualora gli capitasse di poter ascoltare un'esecuzione dell'opera in teatro o alla radio. Perciò, senza trascurare qualche grande capolavoro del passato, faremo posto soprattutto alle opere che più facilmente è dato oggi di poter ascoltare. E affinchè la chiarezza del commento risulti maggiore, crediamo utile far precedere i cenni illustrativi dal succinto riassunto del fatto, nelle sue linee essenziali, atto per atto.
Quello che ci accingiamo a fare è un po' differente da ciò che vien fatto di solito in una Storia della Musica, dove si espongono principalmente i concetti generali e lo sviluppo delle forme, soffermandosi appena sui caratteri più salienti delle opere, e più ampiamente solo su talune delle più importanti. Concetti generali e sviluppo delle forme abbiamo esposti in sintesi nei capitoli precedenti; ora ci tratterremo invece in modo più particolareggiato su le opere. Vale a dire che abbiamo preso a modello per questo libro le cosidette «guide» e i «cataloghi» delle gallerie e dei musei d'arte figurativa, dove appunto si studia la storia delle varie epoche e dei vari paesi passando in rassegna, sala per sala e quadro per quadro. Così noi ora passeremo in rassegna, come se fossimo, per così dire, in una galleria teatrale, secolo per secolo ed opera per opera, tenendoci, ripetiamo, a quelle più famose, o più popolari; od anche a quelle di qualche interesse e, a parer nostro, a torto dimenticate; e infine, perchè no?, a quelle che a noi sembrano avere qualche valore d'arte - anche se incompiuto - e che il pubblico, o la critica, non vogliono accettare.
Naturalmente non ci nascondiamo quella che, forse, è la difficoltà maggiore di una tale impresa, e che si può riassumere con le parole che il Chamberlain scrisse a proposito di Wagner:
«Un'opera d'arte non può venir descritta, ma deve venir vissuta». Cosicché ci rendiamo conto a priori che qualunque nostro chiarimento non può che restare ai margini dell'opera d'arte, della quale darà solo una pallida idea. Questo è anche il difetto delle guide e dei cataloghi. Ai lettori spetta di colmare la grave lacuna prendendo contatto diretto con l'opera per riviverla.
[Torna all'indice]
I.
Seicento e Settecento
CLAUDIO MONTEVERDI (Cremona 1567-Venezia 1643) - ORFEO: favola pastorale in un prologo e 5 atti. Prima rappresentazione nel Palazzo Ducale di Mantova il 24 febbraio 1607. Libretto di Alessandro Striggio junior.
Prologo - È una presentazione dell'opera fatta da un personaggio simbolico che raffigura la «Musica».
Atto 1° - Prato fresco ed ombroso. - Ninfe e Pastori festeggiano le nozze di Orfeo ed Euridice. Orfeo canta il fortunato amore suo e della sposa, che condivide la sua gioia. I Pastori e le Ninfe intrecciano danze in loro onore.
Atto 2° - Luogo solitario nel bosco, presso un ruscello. - Pastori e Pastorelle circondano Orfeo e lo invitano a cantare. Egli, presa la cetra, ricorda i suoi lamenti amorosi alle selve e la presente felicità. D'improvviso una Messaggera giunge trafelata e annunzio come Euridice, punta al piede da un serpe, sia morta. Alla ferale notizia Orfeo sembra impietrito. Poi, con sùbita decisione, afferma che scenderà all'Erebo, e tenterà di commuovere con la virtù del canto le divinità infernali affinchè gli concedano di riportare sulla Terra Euridice.
Atto 3° - Gola infernale presso la palude Stige. - Giunge Orfeo accompagnato dalla Speranza che lo lascia alla soglia del Regno dei Morti. Sopravviene Caronte che ammonisce Orfeo ad allontanarsi. Orfeo canta e prega Caronte di passarlo all'altra riva, dicendogli la cagione della sua infelicità e del suo viaggio. Alla dolcezza del suo canto Caronte si addormenta, e Orfeo ne approfitta per salire sulla barca e attraversare Stige.
Atto 4° - Lo speco di Plutone. - Proserpina, commossa al pianto d'Orfeo, prega Plutone di concedergli Euridice. Plutone acconsente a patto che Orfeo non si volga a guardare la sposa fino a che non sia fuori dell'Inferno. Orfeo intona un inno in gloria della sua cetra che vinse il Tartareo regno. Ma non sa resistere al desiderio di rivedere subito Euridice; avendo così contravvenuto all'ordine di Plutone, Euridice scompare. Un coro di spiriti espone e commenta la punizione inflitta ad Orfeo.
Atto 5° - Luogo ameno e fiorito. - Orfeo, dolente, lamenta la propria sorte. Eco risponde sconsolata alle sue parole. Apollo, sceso dal ciclo, lo conforta a deporre sdegno e dolore, e lo consiglia a seguirlo. Entrambi salgono al Cielo cantando.
Con quest'opera si può dire che nasce veramente il melodramma, anzi, a dir meglio, una forma tendente già al «dramma musicale», non essendo l'Euridice del Peri e quella del Caccini che tentativi imperfetti in cui il recitativo è ancora schematico e freddo, troppo legato com'è al suono del linguaggio naturale parlato più che all'emozione poetica espressa dalla parola. E non solo l'Orfeo di Monteverdi è il primo melodramma, ma è un grande capolavoro: il primo grande capolavoro del teatro musicale. Come si accennò nel I capitolo, gli istrumenti che debbono suonare sono segnati di volta in volta, ma non esistono le loro parti, le quali evidentemente venivano decise dall'autore durante le prove. Ma le indicazioni stesse lasciano intendere che il loro impiego mirava all'espressione drammacica. L'orchestra era invisibile al pubblico, dislocata, a seconda dell'opportunità, in diversi punti del palcoscenico, dietro le scene. Solo Orfeo canta le strofe affidategli accompagnandosi egli stesso con la cetra. Tuttavia questa orchestra doveva dare una sonorità dai timbri assai diversi da quelli ai quali oggi noi siamo abituati se si pensa che in prevalenza era formata di arpe, cembali, chitarroni, cetre, organi di legno, trombe e tromboni. Contro dieci viole che formavano la massa maggiore degli archi stanno solo quattro violini, e contro cinque tromboni quattro trombe sordine, e due cornetti stanno due soli flauti.
Per tutto il 1° atto e metà del 2°, e cioè dalla Toccata iniziale fino all'arrivo della Messaggera, la musica ha una freschezza campestre, una gioiosa serenità di idillio. Pastori e Ninfe sono concepiti in un alone di poesia che li trasfigura in creature di un remoto e favoloso mondo arcadico. Le melodie delle loro danze e delle loro canzoni si svolgono su ritmi leggeri ed agili e danno una emozione luminosa e primaverile. Ma già il secondo motivo della Toccata esprime una dolente malinconia e suona come un presagio di sventura. Questo motivo, che si ripete come un ritornello fra le strofe del canto durante il Prologo e ritorna poi come un grund-motiv alla fine del 2° atto, dopo l'annunzio della morte di Euridice, e alla fine del 4° atto dopo che Euridice è stata ripresa dal regno dei morti, diffonde un senso doloroso fatale, e sembra riassumere in sé la ragione profonda del dramma,
I ritornelli e le Sinfonie (qui sinfonia significa breve composizione strumentale) sono tutti di un'espressione intimamente legata all'azione e al momento drammatico. Va ricordata a questo proposito la sinfonia grave di tromboni cornetti e organo regale (specie di piccolo harmonium portatile) che apre il 3° atto e ci introduce nella severa e funerea atmosfera del regno dei morti. Anche questa sinfonia si ripete più volte come una specie di grund-motiv infernale nel corso dell'atto ed anche nel 5° atto alla fine del monologo disperato di Orfeo, prima della comparsa d'Apollo, ed è quindi un altro dei pilastri musicali del dramma.
Tutte queste sono novità che la Camerata fiorentina non aveva immaginato e neppure sospettato, e che verranno duecentoquarant'anni dopo riprese e sviluppate a sistema da Wagner.
Ma un'altra geniale novità monteverdiana, pregna anche questa di un grande avvenire, è la trasformazione del rigido recitativo fiorentino in un recitativo arioso, suscettibile di infiniti adattamenti melodici e delle più svariate espressioni liriche e drammatiche. Tale recitativo culmina nel racconto della Messaggera e nel pianto successivo di Orfeo. Il canto melodico della Messaggera con la sua varietà di ritmi e di movimenti segue passo passo gli avvenimenti narrati con una crescente ansia drammatica di stupenda forza evocatrice. In questo racconto, alla naturalezza del linguaggio parlato il Monteverdi ha saputo aggiungere la vigoria e la concitazione del linguaggio commosso. Dopo gli stupiti commenti dei Pastori, il lamento di Orfeo giunge anche più in alto. Disperata e virile, piena di una passione e di un pianto contenuto, la ribellione al suo crudele destino è energica; e sùbito nasce, ferma e calma ad un tempo, la decisione di scendere «ai più profondi abissi». La voce si sprofonda, e non è tanto un disegno descrittivo quanto l'evocazione della cupa abitazione dei morti. Ma al saluto «Addio Terra, addio Cielo, e Sole...», la voce si alza sempre più solenne con un crescendo che è pari al crescente sacrificio della rinunzia, per abbassarsi poi sconsolata e quasi nel pianto su l'ultima parola: «addio». Pietoso e pieno d'orrore il commento del coro; flebile e triste il compianto dei Pastori.
Nel 3° e 4° atto le parti vocali di Caronte e di Plutone sono stagliate in un recitativo duro e cupo per voci di basso. Il compositore sente dunque già fino da questa sua prima opera la necessità di caratterizzare i personaggi tanto attraverso alla lineatura del canto quanto attraverso alla scelta del timbro. Incerto è invece rimasto sul canto di Orfeo per commuovere Caronte e le divinità infernali. Infatti il Maestro ha tracciato due differenti disegni: uno gorgheggiante e virtuosistico, l'altro semplice e melico, lasciando libertà di scelta all'esecutore; ma nessuno dei due raggiunge una forza di commozione abbastanza intensa.
L'ultimo atto, brevissimo, è assai più stanco, e lo si direbbe scritto senza vera convinzione. Viene difatti a mancare in esso ogni interesse drammatico, ed è stato composto coll'intento evidente di dare una fine lieta alla vicenda.
L'INCORONAZIONE DI POPPEA: opera in un prologo e 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Grimano in Venezia nell'autunno del 1642. Libretto di Giovan Francesco Busenello.
Prologo - Nell'Olimpo. - Fortuna e Virtù contendono intorno a chi sia fra loro maggiore. Amore interviene dichiarando che l'una e l'altra oggi saranno sue schiave.
Atto 1° - Quadro 1° - Davanti alla casa di Poppea: è notte. - Ottone, innamorato di Poppea, vede a guardia della casa di lei due soldati di Nerone addormentati. Da ciò comprende che Poppea lo tradisce e se ne dispera. I due militi si svegliano e maledicono I''amore, Nerone, Poppea, la milizia e Roma per il servizio ch'essi debbono fare e che impedisce loro di dormire; ma si tacciono allorché vedono uscire Nerone con Poppea. Questa vorrebbe trattenere l'Imperatore; si fa promettere che tornerà. Poppea confida alla sua dama Arnalta le sue speranze. Frattanto Ottavia si strugge di dolore e di gelosia. Invano Seneca cerca di confortarla. Entrata Ottavia nel tempio per pregare, Pallade appare a Seneca e gli annunzio la sua prossima morte. Nerone poscia espone a Seneca la decisione di ripudiare Ottavia e di sposare Poppea. Seneca cerca di sconsigliarlo, ma Nerone si sdegna con lui e lo caccia da sé.
Quadro 2° - Una via di Roma. - Nerone conferma a Poppea la sua volontà di farla Imperatrice; ma Poppea insinua che Seneca si vanta che ogni atto dell'Imperatore dipende da lui. Nerone allora decide di farlo morire. Partito Nerone, Ottone s'incontra con Poppea e la rimprovera della sua infedeltà, ma Poppea lo respinge. Drusilla, innamorata di Ottone, cerca di volgere a sé il cuore di questi, e Ottone le promette di dimenticare Poppea e di amar lei.
Atto 2° - Quadro 1° - Giardino in casa di Seneca. - Un liberto annunzia a Seneca il comando di Nerone di svenarsi. I suoi famigliari non vorrebbero ch'egli si uccidesse, ma Seneca ordina che gli si prepari il bagno. A contrasto con questa scena cupa, la seguente ci presenta un Valletto il quale si fa insegnare da una damigella il bacio.
Quadro 2° - Giardino del palazzo imperiale. - Nerone invita Lucano a cantare amorose canzoni ora che il pedante Seneca è morto. Tutti i cortigiani di Nerone con lui bevono e cantano, poi Nerone canta le lodi di Poppea. Usciti tutti, ecco Ottone il quale pensa di uccidere Poppea, ma egli l'ama tuttora e non sa decidersi. Ottavia lo incoraggia all'azione; Drusilla gli presta le proprie vesti femminili perchè l'impresa riesca più sicuramente.
Quadro 3° - Giardino in casa di Poppea. - Poppea si adagia su un letto e si addormenta mentre Arnalta le canta una ninna-nanna. Allorché Ottone travestito da donna si prepara ad ucciderla. Amore glielo impedisce e Arnalta dà l'allarme.
Atto 3° - Quadro 1° - Lo stesso giardino in casa di Poppea. - Drusilla viene arrestata sotto l'accusa di avere attentato alla vita di Poppea. Essa nega, ma minacciata da Nerone di esser posta alla tortura, impaurita si confessa rea. Sopraggiunge Ottone che svela la verità, ma ora Drusilla insiste nel dirsi colpevole per salvarlo. Nerone condanna all'esilio Ottone, indi delibera il ripudio di Ottavia e il suo esilio da Roma, e promette a Poppea giubilante che in quel giorno medesimo sarà sua sposa.
Quadro 2° - Sala nel palazzo imperiale. - Ottavia dice addio a Roma e s'avvia verso l' esilio. Fra squilli di trombe e il plauso di Cortigiani Consoli e Tribuni, Poppea fa il suo ingresso nella reggia accanto a Nerone.
Delle tre opere rimasteci del Monteverdi, Orfeo, Il ritorno di Ulisse, L'incoronazione di Poppea (dell' Arianna non ci resta che il celebre «lamento»), L'incoronazione è la più perfetta, non ostante la riduzione dell'orchestra a pochi istruinenti e con prevalenza dei violini, per le condizioni dei teatri di Venezia. Tuttavia questa piccola orchestra ha fatto tesoro delle nuove trovate espressive già con successo sperimentate dal Monteverdi nei Madrigali guerrieri et amorosi, e segnatamente nel Combattimento di Clorinda e Tancredi. La sinfonia d'apertura è solenne, come solenni sono i ripetuti squilli nella scena finale dell'incoronazione. I ritornelli sono frequenti e sempre intonati al momento lirico o all'aria alla quale si innestano. Le parti corali sono poche: le sole necessarie all'azione. Abolite le danze, le canzoni a ballo e le altre forme corali riempitive. Fra i cori il più drammatico è quello dei famigliari di Seneca allorché insistono presso di lui perchè non si uccida. Gaio e spensierato invece è quello dei Cortigiani che inneggiano alla morte di Seneca; mentre il coro finale dei Tribuni e Consoli ha intonazione robustamente trionfale. Del resto, la discesa del Monteverdi dalla stratosfera mitologica all'ambiente umano della storia non è avvenuta senza ragione. Il suo genio lo guida non verso il fantastico, ma verso il cuore dell'uomo. Già nell'Orfeo, come s'è osservato, le pagine di più alta ispirazione, di più profonda poesia sono quelle in cui gli è dato scolpire e trasfigurare in suoni le passioni umane; e tanto più queste sono forti, tanto più la sua arte tocca il sublime. Anche nell'incoronazione di Poppea avviene il medesimo. Nerone, Poppea, Ottavia, Seneca, la Damigella e il Paggetto, Drusilla e Arnalta, i due soldati, hanno tutti una loro fisonomia musicale inconfondibile.
Monteverdi usa in quest'opera l'aria strofica e il recitativo, la canzonetta e il cantabile arioso, le forme sillabiche e quelle a vocalizzi con uguale interesse, a seconda che lo richieda la situazione. Ma il recitativo ha acquistato una semplicità, una verità psicologica, un'intensità drammatica che lo distacca moltissimo da quello dell'Orfeo. Mutevole di ritmi e di accenti, ora fluente ora spezzato, ora sospiroso ora grave, ora energico ora lieve, ora ansioso ora sereno, il recitativo monteverdiano dell''Incoronazione segue ogni moto dell'anima con quel sentimento vivo della realtà che la trasfigura in dramma e poesia. Gli interrogativi di Poppea, il sensualismo che emana da ogni suo gesto e parola, la sua ambizione sconfinata, tutto emerge dallo stile recitativo di Monteverdi con penetrazione e rilievo che in certi momenti si vorrebbe dire atroce tanta ne è la verità umana. Si capisce come Nerone sia totalmente soggiogato e diventi quasi un trastullo nelle mani di lei. La scena del 1° atto in cui ella si fa promettere da Nerone che ritornerà e ripudierà Ottavia, l'altra in cui accusa Seneca e senza parere fa sorgere in Nerone il desiderio di condannare a morte il filosofo, sono due momenti fra i più tipici di questo lapidario recitativo monteverdiano.
Nerone, preso nei lacci dell'astuta ambiziosa, sospira liriche di una deliziosa soavità («In un sospir») o parla a scatti, con una concitazione che dimostra in lui l'esasperazione dell'uomo sensuale e l'impulsività del violento. Seneca al contrario è sempre grave e calmo. La scena in cui comunica agli amici che è giunta l'ora della sua fine, è di un'austera grandezza veramente romana. Per rendere più profondamente il doloroso distacco di Ottavia da Roma, Monteverdi non esita ad usare anche tocchi veristici, facendole ripetere qualche vocale o qualche sillaba come chi abbia la parola rotta dal pianto.
Tra le scene patetiche e drammatiche si insinuano quelle comiche, poiché non altro è la vita che un mescolarsi di tragedia e commedia. Ed ecco i due soldati poltroni che messi a far la guardia alla casa di Poppea mentre Nerone sta dentro ad amoreggiare con la bella, imprecano, deridono, fanno della maldicenza finché nessuno li sente, e sono presi poi da una matta paura, allorché sentono che l'Imperatore sta per tornare. Altra pagina di una grazia squisita e di una leggerezza e leggiadria anticipatrici delle Nozze di Figaro di Mozart e del Falstaff di Verdi, è la scena tra la Damigella e il Paggio, intessuta di ritmi leggèri e di motivi languidetti e frizzanti insieme che ci danno intera l'emozione del gioco sensuale in un'atmosfera di giovanile freschezza.
Fra le pagine strofiche la più poetica è la ninna-nanna di Arnalta (atto 2°). La blanda melodia dalle lunghe note simili al calmo e lento respiro di chi dorme, il moto cullante del basso, la ripetizione tranquilla e un po' monotona di certi incisi: tutto spira un senso di pace e di riposo sereno. Ma la fantasia del vecchio Maestro è ancora fertile di trovate nuove. Una delle più efficaci è nell'ultima scena dell'opera. Dopo il trionfale ingresso di Poppea e Nerone nella reggia, tra fanfare di trombe squillanti e canti solenni, fra i due innamorati si svolge un dialogo dolcissimo, a brevi frasi passanti dall'uno all'altro per «imitazioni» con rapida alternativa, o intrecciantisi amorosamente fra loro, con un fervore e un senso di voluttà quale non sarà più dato di ascoltare se non due secoli dopo, ma con una sovreccitazione morbosa, nel duetto del 2° atto del Tristano e Isotta di Riccardo Wagner.
Con L'Incoronazione di Poppea il Maestro cremonese, a 75 anni di età, dimostrava di avere non solo conservata la forza d'ispirazione degli anni giovanili, ma di averla fino agli estremi giorni della sua vita alimentata di nuove e vigorose linfe, in un'introspezione del cuore umano sempre più profonda, in una visione di forme artistiche sempre più perfette e dense di alta poesia.
GIOVAN BATTISTA PERGOLESI (Jesi 1710 - Pozzuoli 1736) - LA SERVA PADRONA: due «intermezzi». Prima rappresentazione al Teatro San Bartolomeo di Napoli il 28 agosto 1733. Libretto di Gennarantonio Federico.
1° Intermezzo - Stanza in casa di Uberto. - Il vecchio (ma non troppo) brontola perchè si ritiene mal servito da Serpina. La chiama e la rimprovera, ma Serpina risponde con isolenza e gli dà su la voce gridando: «Serpina vuol cosi!». Uberto allora dichiara di non poterne più: prenderà moglie e la caccerà via. Serpina lo approva, e aggiunge: «sposerete me». Gli descrive i propri meriti e il proprio affetto. Uberto a questa uscita rimane imbarazzato, nè sa che dire.
2° Intermezzo - Serpina mette il servo Vespone (travestito da soldato) a parte del proprio progetto di sposare il padrone, e lo fa nascondere. Giunge Uberto che vorrebbe uscire; Serpina non glielo vieta: tanto fra poco egli prenderà moglie e anche lei si sposerà. Questa notizia incuriosisce Uberto, il quale vuol sapere chi sarà lo sposo. Ella lo informa di avere scelto un militare molto collerico e manesco: il Capitan Tempesta. Uberto si intenerisce, e sentendo che si tratta di un tipo violento si preoccupa per lei. Serpina approfitta di questo stato d'animo, gli raccomanda di pensare qualche volta a lei e perdonarle se fu talora impertinente, e lo lascia vivamente commosso. Uberto non sa più che fare, e s'accorge d'essere innamorato. Ora Serpina torna col finto fidanzato: Vespone travestito. Uberto lo interroga, ma quegli non risponde che a cenni. Serpina gli dice che il Capitano vuole che le assegni una dote di almeno quattromila scudi; se non vorrà dare la dote dovrà sposarla lui stesso. Poiché Uberto protesta, Vespone mette mano alla spada. Uberto allora si decide a sposare Serpina.
Tre personaggi in tutto, di cui uno, Vespone, è il consueto personaggio del «servo che non parla»; ma la breve vicenda, non ostante qualche inverosimiglianza assurda, fra cui quella della taciturnità del Capitano che non si fa intendere se non attraverso a Serpina, è spiritosissima e spigliata. La musica centuplica la vita dei personaggi e le loro azioni, cosicché questi «intermezzi» costituiscono la prima vera, se pur minuscola, «opera buffa», quale fu intesa fino a metà dell'ottocento.
La musica penetra nelle anime dei due protagonisti e ne pone in luce l'indole e le emozioni con un palpito di vita ignoto all'operistica precedente. Il carattere brontolone proprio dei vecchi, vissuti, come Uberto, troppo soli, usi ad essere sempre serviti a puntino e perciò viziati, è dipinto con bonario umorismo. Così ci appare il padrone di Serpina fino dalla scena d'introduzione in cui egli canta con un tono di malumore su cui l'orchestra getta il suo commento sorridente:
«Aspettare e non venire
«Stare a letto e non dormire,
«Ben servire e non gradire
«Son tre cose da morire».
Poiché abbiamo accennato all'orchestra, occorre subito aggiungere che si tratta di una minuscola orchestra d'archi (due trombe solo nel duetto finale), e il cembalo per i recitativi che sono del tipo «recitativo secco», cioè d'espressione scarsa e uniforme, piuttosto convenzionale. È una specie di «parlato» appena intonato vocalmente. L'accentuazione espressiva doveva esser data, evidentemente, solo dal modo come lo eseguivano i cantanti.
Serpina è schizzata con motivi spiritosi e maliziosi. Essa fa la prepotente, ma, in fondo, ha buon cuore e vuol sinceramente bene al vecchio. Il suo carattere furbo e pronto a difendere, con le moine o con le unghiette a seconda dei casi, il proprio interesse, a imporre e far trionfare la propria volontà, fa di lei la capostipite di una serie di figure tipiche dell'opera buffa italiana, fra le quali emergono la Rosina del Barbiere rossiniano e la Norina del Don Pasquale di Donizetti. Le baruffe di Serpina con Uberto sono tutte improntate a questa vivacità esuberante, a questo brio indiavolato, a questa astuzia donnesca che sa sfruttare così la minaccia come la civetteria, che sa approfittarsi della debolezza di Uberto, di cui ella conosce bene il cuore, per intenerirlo e ammansarlo con un'improvvisa finta umiltà e affettuosità. L'aria «A Serpina penserete» è un capolavoro di finezza psicologica tradotta in musica. La melodia lusingatrice si alterna con il gaio motivetto con cui la ragazza commenta fra sé l'effetto compiuto sull'animo di Uberto, creando uno sdoppiamento pieno di contrasto realistico vivacissimo.
La rete è stata tesa bene, e il vecchiotto ci casca, non senza aver lottato contro il nuovo sentimento che lo invade. Il recitativo «Ah quanto mi sa male» (l'unico strumentato) con quelle scorribande disperate dei violini, e la successiva aria «Son imbrogliato io già» ci rappresentano con efficacia questa lotta. La patetica e pensosa frase «Ho un certo che nel core», frase che lo spingerebbe verso l'amore, trova la resistenza dell'altra non meno pensosa, ma grave e lenta; «Uberto pensa a te!». Sono i due poli fra i quali si dibatte l'innamorato e pur diffidente e guardingo Uberto. La scena con Vespone finto Capitan Tempesta dà il tracollo alla bilancia, e l'ultimo duetto esprime la gioia della risoluzione felice. Finalmente Serpina si abbandona ad un sentimento sincero di amore che covava sotto la sua mariuoleria, e Uberto è lieto d'aver ceduto e di non essere più solo.
CRISTOFORO GLUCK (Erasbach [Palatinato superiore] 1714-Vienna 1787). - ORFEO ED EURIDICE: opera in 3 atti. Prima rappresentazione al teatro della Hofburg di Vienna il 5 ottobre 1762. Riformata e ripresentata all'Opera di Parigi il 2 agosto del 1774. Libretto di Raniero de' Calzabigi.
Atto 1° - Ameno boschetto di allori e cipressi che, ad arte diradato, racchiude in un piccolo piano la tomba di Euridice. - Pastori e Ninfe recano fiori su la tomba, piangono l'estinta ed intrecciano danze funebri. Anche Orfeo piange ed invoca la sposa estinta, e si propone di scendere all'Averne per rapirla. Gli appare Amore il quale promette di assisterlo. Però lo avverte che Giove gli vieta di guardare la sposa fino a che egli non sia fuori del regno di Plutone. Se disobbedisce la perderà di nuovo. Orfeo si propone di vincere la prova.
Atto 2° - Quadro 1° - Orrida caverna al di là del fiume Concito. - Furie e Spettri riddano. Orfeo si avanza suonando la cetra. Gli spiriti, stupiti, udendolo cessano la danza infernale e si chiedono chi possa aver varcato le soglie d'Averne. Orfeo vorrebbe passare e domanda alle Larve e alle Furie di placarsi; queste dapprima rispondono con violenza: «No!», poscia impietosite dal pianto del cantore gli cedono il passo.
Quadro 2° - Recesso delizioso nei Campi Elisi. - Gli spiriti beati contano e danzano: fra essi è Euridice la quale canta la serenità e la pace del luogo. Anche Orfeo penetrando in questo placido recesso è preso da commozione e da ammirazione. Pure egli è deciso a riprendere la sposa, che gli Spiriti gli rendono, vinti dall'esempio del suo amore e della sua fedeltà.
Atto 3° - Quadro 1° - Oscura spelonca. - Orfeo conduce per mano Euridice. Questa si lamenta ch'egli non la guardi. Invano Orfeo la sollecita a seguirlo, ma Euridice dolorosamente stupita pel suo contegno insiste perchè egli si volga. Orfeo non sa resistere alla preghiera e al dolore della sposa, ma nell'attimo stesso in cui la mira, Euridice cade a terra morta. Disperato, Orfeo vuole uccidersi per seguirla;ma interviene Amore il quale lo disarma e impietosito dal suo dolore e in premio della sua fedeltà resuscita Euridice e gliela rende.
Quadro 2° - Tempio dedicato ad Amore. - Eroi ed Eroine festeggiano il ritorno di Euridice e inneggiano alla potenza di Amore.
L'Orfeo ed Euridice di Gluck è la prima opera della riforma suggeritagli dal poeta Raniero de' Calzabigi. Tale riforma non muta sostanzialmente la struttura generale dell'opera, la quale resta costituita ancora da arie, duetti e cori intercalati da recitativi, come nelle opere italiane precedenti. Sotto questo punto di vista l'opera di Piccinni e quella di Gluck non presentano differenze sostanziali. Neppure molto grandi sono le differenze nei riguardi delle arie. Gluck tende a portare l'aria a una maggiore severità d'espressione, ma nei confronti con i compositori italiani egli si mostra inferiore a questi per pathos e per bellezza di melodia. Non v'ha dubbio che un'aria come quella celebre di Orfeo «Che farò senz'Euridice» (atto 3°) ha una linea di canto soave ed elegante, ma essa è ben lontana dall'esprimere la piena del dolore che grava in quel momento sul cuore di Orfeo. È un dolce lamento in cui le frasi «che farò?... dove andrò?» insistentemente ripetute come un dolente ritornello destano soltanto una sensazione di smarrimento e di malinconia. Il dolore affiora invece dal breve inciso (sei battute in tutto) che precede l'ultima ripresa della strofa iniziale, alle parole:
«...Ah non m'avanza
«più soccorso, più speranza
«nè dal mondo nè dal ciel!»
«Aria» è anche chiamato il canto di Orfeo ai Campi Elisi: «Che puro ciel» (atto 2°), ma non ha la struttura strofica consueta, propria delle arie. Si tratta di un recitativo cantabile che, preceduto da un'ampia e soave melodia dell'oboe, si svolge lento, a frasi staccate da lunghe pause, le quali conferiscono al canto un sentimento d'estasi meditativa, mentre l'orchestra è tutto un trillare e gorgheggiare d'uccelletti, uno scorrere queto d'acque, un tremolare di fronde: vita della natura tradotta in poesia musicale con un anticipo di circa mezzo secolo sul Guglielmo Tell di Rossini e di un secolo sul Sigfrido di Wagner. (L'orchestra di Gluck comprende già, - oltre agli archi, - flauti, oboi, fagotti, corni, trombe, tromboni e timpani).
Le differenze fra Gluck e gli italiani del suo tempo sono invece profonde se guardiamo alle forme dei recitativi e dei cori. I recitativi di Gluck sono tutti obbligati, cioè strumentati. L'aria «Che puro ciel» testé citata è, come s'è detto, un grande recitativo che l'orchestra commenta ed avvolge in un'atmosfera sonora di poesia della Natura. Ma anche i recitativi indicati come tali nella partitura non sono più i consueti «recitativi secchi», inespressivi, degli italiani, ma recitativi in cui la voce segue le inflessioni della recitazione commossa e drammatica, mentre l'orchestra intercala commenti appropriati. Fra questi recitativi, originalissimi quelli del 1° atto in cui l'orchestra risponde come eco ad Orfeo che chiama affannato e dolente la sposa estinta. Questo dell'eco è un vecchio gioco derivato dal madrigale cinquecentesco, e qui trasformato in voce della natura, o quasi dello stesso spirito d'Euridice che fievolmente risponda dall'al di là; ed è cosa di alta e poetica tragicità.
Quanto ai cori, quasi sempre omoritmici, essi non costituiscono solo uno sfondo, ma in un'opera nella quale i personaggi principali sono solo due (Orfeo ed Euridice), e solo un altro secondario (Amore), il coro, anche per l'efficacia espressiva della musica affidatagli, viene a prendere un posto di primo piano. L'ambientazione drammatica è spesso affidata al coro; ed è indimenticabile la profonda mestizia dei cori funebri dei Pastori e delle Ninfe nel 1° atto, la rude energia dei cori delle Furie e degli Spettri nel 2°, con quei durissimi «No!» coi quali essi tentano di respingere Orfeo, e quindi i successivi cori nei quali freme un sentimento di pietà delle Furie e degli Spettri per l'infelice cantore. Vengono poi i cori sereni e dolci degli Spiriti, degli Eroi e delle Eroine che fanno corona ad Euridice, e l'inno trionfale che chiude l'opera in lode d'Amore.
L'orchestra è pure assurta a un ruolo più importante non solo perchè, aumentata nel numero e nella varietà degli strumenti, commenta i recitativi con ricchezza di disegni, ma anche perchè crea atmosfere ambientali nei ritornelli, e quadri d'intenso colore nelle danze. Di queste ultime basterà ricordare le furiose danze infernali e quella aerea degli Spiriti beati in cui il flauto diffonde un canto tenero e malinconico insieme, ma di una tenerezza e di una malinconia celestiali.
L'opera ha lieto fine: dobbiamo riconoscere in ciò l'influenza decisiva del gusto del pubblico settecentesco, il quale non tollerava finali tragici. E tale gusto si impose ai compositori fino ai primi decenni dell'ottocento.
Quanto alle innovazioni di Gluck, specialmente a quelle che riguardano i recitativi strumentati, per la verità storica occorre tener presente che essi erano già comparsi numerosi nell'Olimpiade di Pergolesi (1735), ne La clemenza di Tito di Hasse (1738), nel Demofoonte di Jommelli (1764).
ALCESTE: Dramma lirico in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro della Hofburg di Vienna il 26 dicembre 1767. Riformato e ripresentato all'Opera di Parigi il 23 aprile 1776. Libretto di Raniero de' Calzabigi, tratto dall'omonima tragedia di Euripide.
Atto 1° - Quadro 1° - Piazza davanti al palazzo reale in Fera. - Il Re Admeto è morente; il popolo implora gli Dei che lo salvino. Anche la regina Alceste, disperata, invoca il soccorso dei Numi. Tutti s'avviano al Tempio.
Quadro 2° - Nel Tempio di Apollo. - L'oracolo profetissa che il Re morrà in quel medesimo giorno, se qualcuno non si sacrificherà per lui. Terrorizzati da questo funesto annunzio tutti fuggono. Rimasta sola, Alceste decide di sacrificarsi per salvare lo sposo. Il Sommo Sacerdote annunzio ad Alceste che il suo voto è stato accolto e che la Dea d'Averne ha già spiccato il volo per ghermirla.
Atto 2° - Salone nel palazzo reale. - Il popolo esulta per la guarigione del Re. Il Messaggero Evandro narra al Re il responso dell'Oracolo, ma non sa chi sia l'eroe sacrificatesi per lui. Admeto inorridisce al pensiero di dover la vita alla morte d'un altro. Nella gioia generale Alceste sola è triste perchè sa che dovrà abbandonare lo sposo. Della sua tristezza si meraviglia Admeto che non conosce il suo segreto; ne vuol sapere la causa, e tanto insiste che Alceste è costretta a confessargli ch'ella medesima si è sacrificata per lui. Questa notizia piomba Admeto nella più violenta disperazione; egli chiede ai Numi di morire. Un grave dolore pesa sul cuore di tutti.
Atto 3° - Quadro 1° - Piazza davanti al Palazzo reale. - Ercole tornando dall'aver compiuta una delle sue imprese si stupisce di trovare il popolo in pianto. Informato di quanto avvenne. Ercole si propone di salvare Alceste.
Quadro 2° - Luogo selvaggio innanzi all'ingresso d'Averno. - Alceste è pronta all'olocausto. Giunge Admeto, deciso a impedirle il sacrificio o a seguirla. Tanato, Dio della morte, viene a sollecitare Alceste affinchè compia il voto, altrimenti Admeto morrà. Sopravviene Ercole il quale minaccia con la clava Tanato e gli Spiriti infernali. Innanzi al valore di Ercole lo stuolo infernale abbandona la vittima e si dichiara vinto. Apollo stesso scende per dire ad Ercole l'ammirazione di Giove e di tutto l'Olimpo; mentre Admeto e Alceste gioiscono di ritrovarsi uniti su la Terra, e i figli e il popolo li festeggiano.
L'opera è piena di bellezze superbe sparse dovunque: nei cori, nelle arie, nei recitativi, nelle danze. Predominano le tinte fosche e quelle dolenti, ma non mancano le espressioni tenere ed anche quelle festose. Lo stile si scioglie e si libera dai vecchi convenzionalismi: la sinfonia non segue più la forma sonatistica ed è una sintesi del dramma al quale si riallaccia senza interruzione; le arie sono senza il consueto «da capo». La sinfonia (Gluck la chiama intrada) con quei suoi veementi baleni drammatici intercalati da accenti fatali e da sospiri dolenti, i cori e le arie del primo quadro, formano un blocco che sembra scolpito nel bronzo. In esso le espressioni del più grave dolore trapassano a quelle della più concitata disperazione; il più stupito smarrimento apre la via al pianto accorato e al terrore con una successione ininterrotta di immagini musicali di estrema semplicità concisione e forza, in cui il dolore di Alceste e quello del popolo si fondono in un quadro potente. E non certo a caso Alceste piange e invoca gli Dei con gli stessi accenti del coro.
Il 3° quadro, altrettanto compatto e bronzeo quanto il 1°, è la cosa più bella dell'opera. Alla Pantomima, che ha una espressione religiosa così elevata, seguono le preghiere in cui un inciso ripetuto con insistenza alternativamente dal Grande Sacerdote e dal coro dipinge l'intenso affanno che affligge Alceste e il popolo, e dona all'invocazione un più vivo senso di fervore. Viene poi il responso dell'oracolo con i suoi accordi pesanti, ritmati, fatali; e il senso di fatalità è dato anche dal colorito dello strumentale, misterioso e severo (violini con sordina, oboe, fagotto, corni e tromboni). Al funereo inesorabile annuncio, orchestra e cori esprimono un senso di stupore e poscia di raccapriccio e di spavento. Alceste è sola: in lei lottano l'amore per Admeto e l'amore per la vita. Il recitativo è scultorio. E l'atto si chiude, con alto slancio lirico e drammatico, col canto di Alceste «Fatal divinità», con cui la Regina decide il proprio sacrificio per salvare lo sposo.
Anche se gli altri due atti non si mantengono più all'altezza del 1°, contengono tuttavia pagine profonde. Se ritornano le arie col convenzionale «da capo» ve ne sono però di bellissime, quale ad esempio quella soavissima di Admeto «Perchè nutrir terror cotanto», di un soffio lirico così puro. E i recitativi interposti si fanno via via sempre più drammatici a mano a mano che l'ansia di Admeto per l'incomprensibile pianto di Alceste si acuisce e l'angoscia di lei cresce, fino ad esplodere nell'amarissimo canto di Admeto: «Crudele, senza te», gonfio di così intenso dolore e sconforto. Pagine poi fra le più sublimi della letteratura musicale d'ogni tempo, che possono solo paragonarsi ai primi cori funerei dell'Orfeo, sono: l'aria di Evandro «Troppo ahi non è» («aria» è detta, ma dell'aria non ha più le forme consuete, disciolta com'è in puro canto drammatico), e il successivo coro «Piangi, o Tessalia»: non cupo, non lugubre, ma solenne e pieno di fato. Pure di una drammaticità potente nella frattura dei ritmi, nella varietà dei disegni e dei movimenti, nella forza degli accenti, nei colori strumentali, è il recitativo di Alceste allorché si presenta alle porte d'Averne. Vi passa un alito freddo di morte con l'incubo di un terrore e di un orrore paurosi. Allo smarrimento di Alceste risponde, su uno svariare d'accordi gravi e lenti, il coro degli Spiriti infernali all'unisono; coro che insiste per ben quindici battute con espressione tetra su una sola nota: un fa. Il seguente duetto è percorso da un palpito nervoso, da una specie di vibrazione febbrile che culmina nell'aria di Admeto «Pel Dio, pe' Numi tuoi».
In conclusione, non ostante la staticità e la persistente tristezza del dramma, ciò che fu causa della cattiva accoglienza ottenuta dall'opera al suo primo apparire, la musica dell'Alceste, pure presentando un fascino minore di quella dell'Orfeo, si impone ancor oggi come una delle creazioni più vigorose di Gluck, e dà pienamente ragione al suo autore il quale profetizzava: «Alceste non deve piacere solo al presente, per la sua novità; non vi è tempo per quest'opera. Io affermo che essa piacerà ugualmente fra duecento anni». E non ha sbagliato.
IFIGENIA IN TAURIDE: opera in 4 atti. Prima rappresentazione all'Opera di Parigi il 18 maggio 1779. Libretto di Nicola Francesco Guillard, tratto dall'omonima tragedia di Euripide.
Atto 1° - Bosco sacro con l'entrata al Tempio di Diana. - Infuria un temporale violento che ha momenti di sosta e momenti di ripresa. Le Sacerdotesse di Diana e la Grande Sacerdotessa Ifigenia pregano gli Dei affinchè le salvino dalle folgori. Ifigenia è turbata da un sogno pieno di funesti presagi, ultimo dei quali l'apparizione del fratello Oreste ch'essa voleva abbracciare mentre una forza sovrannaturale la spingeva a ferirlo con una spada datale da Clitennestra. Toante, Re della T auride, giunge preoccupato e impaurilo: un oracolo gli ha predetta la morte s'egli non sacrificherà agli Dei un prigioniero. Frattanto uno stuolo di Sciti ha arrestato due giovani Greci. Uno di essi, narrano gli Sciti, è in preda ad oscuri rimorsi e invoca la morte. I due prigionieri (Oreste e Pilade) interrogati da Toante si rifiutano di svelare la ragione per cui si trovano nella Tauride. Il popolo Scita esprime in canti barbarici la propria gioia per l'offerta del sangue dei due prigionieri ch'essi si apprestano a fare agli Dei.
Atto 2° - Una parte interna del Tempio, destinata alle vittime. - Oreste è desolato per essere causa involontaria della morte dell'amico Pilade. Questi risponde che la morte non gli fa paura se gli è dato di morire accanto a lui. Un Ministro del Santuario e alcune guardie vengono a separare gli amici trascinando altrove Pilade. Ciò aumenta la disperazione di Oreste che esausto e accasciato si assopisce. Nel sonno gli appaiono le Eumenidi, e fra esse l'ombra di Clitennestra. All'entrare di Ifigenia la visione terrificante scompare e Oreste si risveglia. Interrogato da lei, Oreste le dice di essere di Micene, e l'informa che il Re Agamennone fu ucciso da sua moglie, e che il figlio vendicò la morte del padre. Le annunzio poi che Oreste è morto ed Elettra regna sola in Micene. Ifigenia fa accompagnare altrove il prigioniero e si appresta a compiere cerimonie funebri in onore di Oreste.
Atto 3° - La stanza di Ifigenia. - Le fattezze e l'età del prigioniero interrogato da Ifigenia le ricordano Oreste, al quale essa pensa con dolore. Si fa condurre innanzi i prigionieri, dice di essere di Argo, e propone di salvare uno di loro il quale rechi colà un suo scritto. Ma nessuno dei due vuol partire se ciò deve costare la morte dell'altro. Una nobile gara si manifesta fra i due per la reciproca salvezza. Oreste minaccia di uccidersi se Pilade sarà sacrificato. Ifìgenia sceglie allora Pilade quale messaggero, gli consegna uno scritto per Elettra, ma si rifiuta di dirgli quale legame esista fra loro. Per conto suo Pilade pensa di salvare Oreste.
Atto 4° - Interno del Tempio di Diana con la statua della Dea e l'ara dei sacrifici. - Ifigenia è presa da viva pietà per la vittima che deve morire. Oreste viene adornato per la cerimonia e poscia condotto presso I' ara fra i cantici delle Sacerdotesse. Allorché Ifigenia si avvicina armata per compiere il sacrificio, Oreste nomina Ifigenia ch'egli crede sia stata sacrificata in Aidide. La sua esclamazione lo fa riconoscere dalla sorella che gli narra d'essere stata salvata da Diana. Mentre fratello e sorella si abbracciano, giunge Toante, furente perchè ha saputo che uno dei prigionieri è fuggito. Egli ordina a Ifigenia di sacrificare all'istante l'altro prigioniero, ma essa lo informa che il prigioniero è suo fratello, il figlio del Re Agamennone. Sordo alle parole di Ifigenia, Toante ordina alle guardie di uccidere Oreste. Le Sacerdotesse circondano Oreste. Toante allora minaccia di uccidere Ifigenia, ma in questo istante, seguito da uno stuolo di Greci, giunge Pilade il quale uccide Toante. I Greci si gettano contro gli Sciti, che stanno per fuggire allorché compare Diana. Essa rimprovera gli Sciti per i loro costumi sanguinar! e li assoggetta ai Greci dei quali Oreste è Re.
La potente austera drammaticità di Gluck si afferma in quest'opera quasi ininterrottamente. Lo strumentale, più ricco e già tendente all'espressività ottocentesca, comprende 4 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 3 tromboni, 2 timpani, i tamburo, piatti e triangolo, oltre al quartetto d'archi (violini, viole, violoncelli e contrabassi): fino alla metà dell'ottocento non si andrà più in là.
Il dramma irrompe subito nell'introduzione con lo scatenarsi della tempesta, dopo l'illusoria idillica descrizione della calma. Le voci delle donne aggiungono una nota di sgomento alle voci dell'orchestra, mentre le brevi soste e le riprese del temporale accentuano l'orgasmo. Ottoni e flauti urlano e sibilano sinistramente sul tremolo degli archi e il rullo dei timpani. Ma appena cessata la bufera, ecco il racconto terrificante del sogno di Ifigenia, fatto con uno di quei recitativi che, malgrado la convenzionalità delle formole di cui Gluck abusa e che li fa assomigliare un po' tutti, non sono per questo meno efficaci per la semplicità nuda, la concisione e, quando occorra, la concitazione del fraseggio che l'orchestra con sobria descrittività commenta. Le Sacerdotesse esprimono la loro emozione con una delle ben note forme corali gluckiane, severe, a blocchi d'accordi che scendono lenti e gravi e fanno pensare a colonnati oscuri d'un tempio dorico. Un senso di smarrito stupore sembra pesare su le anime delle vergini sacre. A contrasto, ecco lo stupore e il terrore sciogliersi nella fidente preghiera di Ifigenia «O toi, qui prolongeas mes jours», piena di toccanti accenti. Ma le Sacerdotesse rinnovano la primitiva impressione di perplessità con un altro coro in cui una nota lungamente persistente del basso sembra aggiungere con la sua immobilità un senso di scoramento, quasi una risposta del destino alla loro domanda: «Quand verrons-nous tarir nos pleurs?». «Jamais», sembra rispondere il Fato con la sua staticità profonda.
Tutta questa prima scena è semplicemente monumentale. Nella scena successiva l'aria in cui Toante espone i presentimenti paurosi che lo assillano, è accompagnata da accordi misteriosi e duri; i bassi, i corni e i fagotti fanno udire ripetutamente un tema forte e minaccioso, ora ascendente ora discendente. Il terrore di Toante si fonde a quello di Ifigenia e delle Sacerdotesse creando un'atmosfera carica di nembi procellosi. Assistiamo qui ad un esempio di caratterizzazione di stupendo altorilievo. Segue poi l'arrivo degli Sciti, personificati essi pure da una marcia-coro, il cui spunto si giurerebbe che abbia suggerito a Mozart il tema della sua celebre marcia «Alla turca». Comunque il coro ha un certo impeto barbarico, e il successivo «Il nous fallait du sang», in cui Gluck fa uso pittorico di tutti gli istrumenti a percussione che accentuano ruvidamente il ritmo, è veramente espressione d'una gioia selvaggia che soltanto il «Guerra, guerra» della Norma supererà.
Se Orfeo e Alceste esaltavano l'amore coniugale (in Orfeo è lo sposo che salva la sua donna dalla morte, in Alceste è la donna che salva lo sposo), nell'Ifigenia in Tauride Gluck esalta l'amicizia nella sua espressione più nobile e devota. I due amici hanno diversa indole: nel 2° atto la musica si incarica di scolpire il carattere ardente, impetuoso di Oreste, distinguendolo nettamente dalla mansuetudine, non meno maschia e ferma nel desiderio di sacrificio, di Pilade. In relazione ai due caratteri sta la concezione dei due diversi timbri vocali: di baritono per Oreste, di tenore per Pilade, mentre Toante è un basso. Anche questa distinzione, allo scopo di caratterizzare i differenti personaggi, si può dire (dopo Monteverdi) nuova. In Italia pochissimi osavano farlo (Pergolesi, Marcelle, Traetta), ma in generale le parti simpatiche erano riservate a soprani o sopranisti, e quelle odiose ai bassi. I disegni vocali di Pilade sono morbidi, quelli di Oreste più scattanti e arditi. Tipiche sono a questo riguardo l'aria veemente d'Oreste «Dieux qui me poursuivez», tutta movimento nell'orchestra e impeto nel canto, e quella seguente di Pilade tenera e morbida, ma non molle, «Unis de la plus tendre enfance».
L'aria di Oreste «La calme rentre dans mon coeur» è una delle più belle pagine dell'opera. Il canto non ha più niente a che vedere con ciò che nell'opera italiana si chiamava «aria». È un recitativo che si muove su poche note con un senso di pace e di abbandono; ma nell'orchestra il ritmo sincopato e agitato delle viole ci dice che si tratta di una calma esteriore e che in realtà, nel suo fondo, l'animo di Oreste è sempre occupato da un'ansiosa agitazione. Il corpo di Oreste si assopisce, non l'anima sua ossessionata dal ricordo del matricidio. Ciò giustifica il successivo sogno con la terrificante apparizione delle Erinni e del sanguinoso spettro di Clitennestra. Scena da Mussorgski avanti lettera questa delle apparizioni: il basso è agitato, e i tromboni prima, gli oboi e clarinetti poi, scandiscono e martellano una minacciosa scala ascendente, mentre le larve avanzano con tetre intonazioni verso Oreste, e questi emette grida di terrore. Il giungere di Ifigenia tronca la scena su un accordo sospeso con nuova e ammirevole audacia.
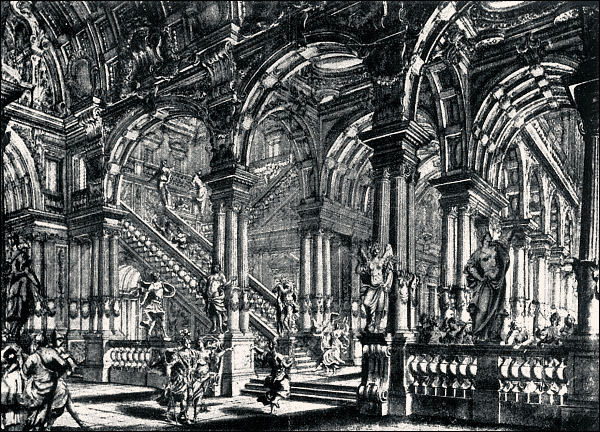
Figura 03: Atrio e scala: scena di Giuseppe Bibiena.

Figura 04: Eroe dell'Opera settecentesca.
Tutto il resto, anche se non raggiunge più l'altezza delle scene precedenti, è pure sempre nobilissimo; fra l'altro è da segnalare il delicato coro delle Sacerdotesse con cui si chiude il 2° atto. Il duetto del 3° atto fra Oreste e Pilade, anche se prolunga soverchiamente la gara di generosità fra i due amici rendendo troppo a lungo statica la situazione, è ricco di contrasti, di animazione e di frasi musicalmente drammatiche. Ma nessuno può dimenticare il sentimento vivo, lo slancio d'affetto dell'aria di Pilade:
«Ah, mon ami, j'implore ta pitie!», e, nell'ultimo atto il cantabile d'Oreste: «Que ces regrets touchants pour mon coeur ont de charmes!», e il successivo Inno delle Sacerdotesse, pieno di una religiosità solenne serena e casta, degna di ogni tempo e di ogni chiesa.
GIOVANNI PAISIELLO (Taranto 1740-Napoli 1816). - IL BARBIERE DI SIVIGLIA ovvero LA PRECAUZIONE INUTILE: dramma giocoso in 2 atti e 4 parti. Prima rappresentazione al Teatro Imperiale di Pietroburgo nel 1782. Libretto di Giuseppe Petrosellini, dalla commedia omonima di Pietro Beaumarchais.
Atto 1° - Parte 1a Strada: la casa di Don Bartolo da un lato. - Il Conte d'Almaviva è innamorato della pupilla del Dottor Bartolo, Resina. Giunge il Barbiere Figaro; il Conte lo conosce; mentre parlano, Rosina si affaccia alla finestra con Don Bartolo e lascia cadere in istrada ima carta che il Conte prontamente raccoglie. Don Bartolo, geloso, scende a cercarla; non trovandola rientra insospettito e fa ritirare dalla finestra la pupilla. Il Conte ora mette Figaro al corrente del suo amore, con lui si consiglia, e, uscito di casa Don Bartolo, canta, su l'aria della canzone gettatagli da Rosina, per dirle chi è; ma non le svela il suo nome vero, bensì le dice di essere uno studente di nome Lindoro. Poi con Figaro prende accordi per entrare in casa di Don Bartolo e avvicinare la ragazza.
Parte 2a - Camera di Rosina. - Rosina scrive una lettera al supposto Lindoro e la consegna a Figaro affinchè gliela rechi. Bartolo entra arrabbiato perchè Figaro ha rovinati i suoi servi «con narcotici sangue e starnutiglia». Entrano infatti due servi: lo Svegliato, il quale non fa che sbadigliare, e il Giovinetto che sternuta di continuo. Don Bartolo non riuscendo a intendersi con loro li caccia via molto irritato. Giunge il gesuita Don Basilio, maestro di musica di Rosina, il quale avverte Don Bartolo che è giunto in Siviglia il Conte d'Almaviva, colui che in Madrid faceva la corte a Resina, e lo consiglia a spargere calunnie sul conto suo; ma Don Bartolo vuol piuttosto sposar subito Resina, e incarica Don Basilio di fare i necessari preparativi affinchè il giorno dopo il matrimonio possa effettuarsi. Figaro che era dietro un uscio ha udito tutto e si propone di avvisarne il Conte. Intanto Don Bartolo rimbrotta Resina perchè le vede un dito inchiostrato e teme che abbia scritto al Conte', quando il Conte medesimo, travestito da soldato e fingendosi ubriaco, entra. Egli attacca briga con Don Bartolo, e di soppiatto allunga un biglietto a Resina. Partito il Conte, Don Bartolo vuole che Resina gli faccia vedere la carta datale dal soldato; ma Resina prontamente la cambia, cosicché Don Bartolo rimane scornato.
Atto 2° - Parte 3a - La stessa camera della Parte precedente, - Il Conte travestito da Baccelliere, sotto il finto nome di Don Alonso, viene a dar lezione di musica a Resina al posto di Don Basilio ch'egli dice ammalato. Per vincere la diffidenza di Don Bartolo è costretto a dargli la lettera che gli scrisse Rosina, dicendo di averla avuta dal Conte d'Almaviva. Rassicurato Don Bartolo chiama Rosina, la quale postasi al cembalo con Lindoro inizia la lezione. Anche Don Bartolo vuol cantare un'arietta dei suoi tempi, allorché giunge Figaro per fargli la barba. Costui si fa dar le chiavi per andare a prendere l'occorrente, ma appena uscito si ode un fracasso di oggetti infranti. Bartolo allarmato corre a vedere. Il Conte vorrebbe approfittare di questo istante per spiegare a Rosina il fatto della lettera consegnata a Don Bartolo, ma non fa in tempo, giacché tosto Don Bartolo e Figaro ritornano. Frattanto Figaro è riuscito a staccare dal mazzo delle chiavi quella del terrazzo; sta ora per accingersi a far la barba a Don Bartolo allorché giunge Don Basilio. Temendo ch'egli scopra a Don Bartolo l'inganno, il Conte gli da di soppiatto una borsa d'oro e lo persuade ad andar via. Figaro si rimette al lavoro, mentre il Conte riprende l'interrotta spiegazione con Rosina;ma Don Bartolo lo sente e monta in furore.
Parte 4a - La medesima scena. - Chiarito con Don Basilio l'equivoco della Parte precedente, Don Bartolo, convinto che Don Alonso fosse un emissario del Conte di Almaviva, fa vedere la lettera a Rosina e la persuade che è stata tradita. Al colmo della disperazione Rosina promette a Don Bartolo di sposarlo, e questi esce a disporre i preparativi per le nozze. Entrano frattanto dalla terrazza il Conte e Figaro. Rosina accusa il creduto Lindoro di averla ingannata per venderla al Conte d'Almaviva. Il Conte allora le si svela. Al giungere di Don Basilio con un notaio, il Conte fa stendere al proprio nome il contratto di nozze con Rosina, facendo tacere con una borsa d'oro gli scrupoli di Don Basilio. Quando Don Bartolo arriva è ormai troppo tardi e deve rassegnarsi.
La commedia del Beaumarchais è, nel libretto del Petrosellini, molto maltrattata, e perde gran parte del suo spirito. Figaro specialmente diventa una figura scialba, e gli altri personaggi diventano pure pupazzi convenzionali, poveri di naturalezza e di umanità. In questo modesto quadro, anche il musicista si aggira con modesto spirito comico e assai più sentimento.
Lo stile di Paisiello è quanto si può immaginare di perfettamente settecentesco per grazia, per eleganza, per delicatezza sentimentale. Più che burlesco o giocoso, Paisiello è spiritoso, ma la vena patetica predomina in lui, anche se la sua melodia sfiora alla superficie gli affetti senza penetrare in profondità. Spesso si nota anche un abuso di formule convenzionali, consacrate ma anche logorate dall'uso; stucchevole è pure l'uso dei «recitativi secchi» senza altro carattere espressivo se non quello che vien loro dall'intelligenza e dal gusto artistico di chi li recita. Pare però che gli attori dell'epoca paisielliana, come anche di quella rossiniana, fossero usi a calcare sulla recitazione in modo buffonesco, il che era una vecchia eredità della commedia dell'arte e dei più caricaturali «intermezzi».
Fra le scene di più vivace comicità è quella in cui Bartolo interroga, senza riuscire ad intendersi con loro, i servi Svegliato e Giovinetto, i quali, malconci come sono dalle droghe loro propinate da Figaro, rispondono a monosillabi e a frasi monche, fra uno sbadiglio e uno starnuto. Fra questi due storditi (musica lenta per l'uno, a scatti per l'altro) passa l'irritato dispetto di Don Bartolo.
Abbastanza viva è la scena in cui Rosina lascia cadere la canzone dalla finestra e Bartolo scende a cercarla invano. Il dialogo corre con scioltezza e il commento orchestrale è vario e spiritoso. In fondo, Bartolo è la figura meglio disegnata di tutta l'opera. Il vecchio brontolone uggioso c'è, soprattutto nell'aria «Veramente ho torto, è vero», ove alle fine le terzine e dei brevi dissonanti incontri di 23' accrescono il senso di irritazione fastidiosa. Umoristica e balorda è pure la Seghidiglia spagnola che Bartolo canta per vantare la musica dei suoi tempi. È infine da sottolineare la goffaggine pretensiosa del quintetto «Questo è un peso che fa dir di sì!», allorché Almaviva paga Don Basilio affinchè firmi il suo contratto di nozze come testimonio.
Ma le parti affettuose e sentimentali sono le meglio riuscite. Così l'aria di Rosina «Lode al ciel che alfin aperse l'Argo mio la gelosia» dal sereno e fresco respiro melodico; la cavatina del Conte «Saper bramate, bella, il mio nome» disegnata con molta semplicità e grazia canora; pure dolcemente ispirata è la cavatina di Resina «Giusto ciel che conoscete», e la sua canzone «Già riede Primavera», vaghissima di gentilezza anche nei delicati motivi orchestrali. La parte in minore di quest'aria, alle parole «Io piango afflitta e sola» è particolarmente sentita ed esprime una tenera malinconia tutta settecentesca, in cui tra flebili sospiri sembra tremare una lagrimuccia che però non si stacca dalle ciglia. Ancora più sentito è il breve recitativo strumentato di Resina: «Crudel, sappi, t'amavo», rotto da pause come di chi si sforzi di trattenere le lagrime, mentre i violini hanno leggeri pigolii lievemente affannosi. E pure settecentescamente languido e tenero è il duetto fra il Conte e Rosina; «Cara, sei tu il mio bene», che ha accenti di delicatezza cimarosiana.
WOLFANGO AMEDEO MOZART (Salisburgo 1756-Vienna 1791). - LE NOZZE DI FIGARO: opera comica in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro Italiano di Vienna il 1° maggio 1786. Libretto di Lorenzo da Ponte, tratto dall'omonima commedia di Beaumarchais.
Atto 1° - Camera non ammobigliata. - Figaro, cameriere del conte d'Almaviva, sta prendendo misure, ma quella stanza, che diventerà la stanza matrimoniale sua e di Susanna quando egli avrà sposata l'avvenente cameriera della Contessa, è troppo vicina a quella del Conte, che è un impenitente donnaiolo. Su ciò s'accende una disputa fra lui e Susanna, la quale lo informa pure che la dote assegnatale dal Conte dovrebbe servire ad ottenere le sue grazie, e che mezzano del Conte in questa faccenda è Don Basilio. Figaro si propone di «.far ballare» il Conte. Mar collina, governante del Dottor Bartolo fa sapere a questi ch'essa vuole impedire le nozze di Figaro per sposarlo lei. Don Bartolo promette d'aiutarla nell'intrigo, per vendicarsi del Conte che un giorno gli rapì la pupilla Rosina. Marcellina incomincia col provocare Susanna con la quale ha un bisticcio. Il paggio Cherubino si accosta a Susanna, rimasta sola, e si fa dare da lei un nastro della Contessa, della quale è innamorato; ma, in realtà, il giovinetto, che si apre ora alle prime esperienze della vita, è innamorato dell'amore e avido delle sue ignote delizie.
« Ogni donna cangiar di colore
«Ogni donna mi fa palpitar;
esclama. Ma sopraggiunge il Conte, il quale si mette a corteggiare Susanna. Cherubino si è nascosto dietro di lei. Sentendo venire Don Basilio, il Conte si nasconde pure dietro di lei mentre Cherubino prestamente passa davanti al sedile e Susanna lo ricopre con la vestaglia. Don Basilio espone a Susanna insinuazioni circa l'amore di Cherubino per la Contessa. Udendo ciò il Conte si mostra e ordina a Don Basilio di bandire il seduttore. Mentre parla scopre Cherubino sotto la vestaglia di Susanna sospetta ch'egli sia anche amante di Susanna e lo scaccia di casa. Giunge frattanto, condotto da Figaro, un corteo di contadini e contadine che vengono a ringraziare il Conte per avere abolito nei suoi feudi il «jus primae noctis». Cherubino chiede perdono al Conte, e questi mitiga la punizione ordinandogli di entrare subito come uffiziale nel suo reggimento.
Atto 2° - Camera ricca con alcova. - Susanna racconta alla Contessa come Almaviva abbia tentato di sedurla con denaro e come nell'istesso tempo sia geloso di sua moglie. Sopraggiunge Figaro il quale narra che il Conte vuol spedirlo via come corriere, per restare solo con Susanna. Ora Figaro ha preparata a propria difesa una trama. Gli farà recapitare per Don Basilio un biglietto in cui l'avverte che la Contessa ha un appuntamento con un suo amante. Consiglia poi a Susanna di dare al Conte un appuntamento in giardino, appuntamento al quale manderà, travestito da donna. Cherubino che Figaro ha trattenuto. La Contessa dovrà sorprenderlo, e cosi, smascherato, non potrà più apparsi alle nozze di Figaro con Susanna. Costei e la Contessa si accingono a vestire Cherubino da donna. Mentre,uscita Susanna, la Contessa sta attendendo al travestimento di Cherubino, giunge il Conte. Cherubino si rifugia in un gabinetto, dove rovescia con fragore un tavolino. La Contessa dice al marito che dentro c'è Susanna. Insospettito, il Conte ingiunge a Susanna di uscire, ma poiché questa non ubbidisce, va a prendere arnesi per forzare la porta, e per maggior sicurezza conduce seco Rosina. Frattanto Susanna, che non vista ha ascoltato, fa uscire Cherubino, lo fa fuggire dalla finestra, avendo il Conte chiuso a chiave tutte le porte, ed entra poi nel gabinetto. Torna il Conte con la moglie. Questa, vedendo ormai impossibile fingere, confessa che nel gabinetto sta rinchiuso Cherubino; ciò eccita vieppiù Vira del Conte, che impone a Cherubino di venir fuori, ma con grande stupore della Contessa e del Conte, compare Susanna. Almaviva chiede scusa a Resina;ed ecco che Figaro viene ad avvertire che tutto è pronto per le sue nozze. Il Conte lo ferma per aver schiarimenti sul foglio recapitategli da Don Basilio. Figaro fa lo gnorri. Frattanto giunge Antonio, il giardiniere, infuriato perchè un uomo saltando dalla finestra gli ha schiacciato un vaso di garofani. Figaro afferma di essere stato lui;Antonio invece ha creduto di ravvisare Cherubino in colui che saltò dalla finestra, e chiede a Figaro di chi sia la carta che nel saltare cadde dalle tasche del fuggente. Il Conte la prende, e vistala, domanda a Figaro di che si tratta. La Contessa e Susanna che hanno riconosciuta la patente del Paggio suggeriscono la risposta a Figaro. Sul più bello ecco giungere Marcellina con Don Bartolo e Don Basilio; essa dichiara che Figaro ha un impegno di nozze con lei, ciò che porta al colmo la confusione.
Atto 3° - Ricca sala con due troni, preparata per la festa nuziale. - Susanna, d'accordo con la Contessa, fissa con il Conte un ritrovo in giardino. Intanto da un segno al braccio e da altri particolari narrati da Figaro, Marcellina riconosce questi per un suo figlio rubatele in fasce, e gli indica in Don Bartolo suo padre. Mentre Figaro abbraccia sua madre giunge Susanna, la quale credendosi tradita gli da uno schiaffo; ma l'equivoco è presto chiarito. La Contessa informata di tutto da Susanna, le fa scrivere al Conte un biglietto in cui fissa l'appuntamento in giardino, sigillando il foglio con uno spillo che il Conte dovrà restituire. Giungono alcune fanciulle per fare omaggio di fiori alla Contessa. Fra esse è Cherubino travestito da donna, ma Antonio lo riconosce. Il Conte vuol punirlo, ma Barbarina, figlia di Antonio, lo chiede al Conte per isposo. Incominciano intanto le cerimonie per lo sposalizio di Figaro, durante le quali Susanna riesce a dare al Conte il biglietto con lo spillo.
Atto 4° - Quadro 1° - Gabinetto. - Barbarina dice a Figaro che ha perduto una spilla che il Conte le aveva dato da restituire a Susanna. Figaro perciò si crede tradito da Susanna.
Quadro 2° - Giardino con nicchie praticabili. - Figaro vuol sorprendere il Conte con Susanna, ma questa ha scambiato le vesti con la Contessa, la quale pure vuol smascherare lo sposo traendolo in inganno con tale travestimento. Ne nasce una serie di equivoci comici, dei quali fa le spese Figaro che riceve schiaffi prima dal Conte poi da Susanna. Quando infine il Conte vede Figaro ai piedi di Susanna che, a causa del vestito cambiato, egli crede la Contessa, vuol far nascere uno scandalo; se non che giunge la vera Contessa, alla vista della quale il Conte comprende il suo errore e le chiede perdono, che gli è accordato fra la gioia di tutti.
Nei riguardi della musica va osservato che su la fantasia musicale di Mozart influirono fortemente gli operisti italiani, e in particolare Paisiello col suo Barbiere di Siviglia, del quale si osservano qua e là alcuni spunti. I «recitativi secchi» che Mozart usa nelle sue opere seguendo una consuetudine che Gluck aveva tentato invano di spezzare, sono brevi e concisi. Ma le arie, i duetti, i concertati hanno uno spirito melodico, una forza di sentimento, e soprattutto un'intimità vera che, unita alla bellezza della forma, all'eleganza della linea, alla ricchezza dello strumentale, fanno di quest'opera un capolavoro di espressione e di grazia. In fondo, Mozart segue, come già Gluck, la struttura dell'opera italiana, ma vi apporta una sensibiltà approfondita, una garbata vis comica e una superba sapienza costruttiva. C'è ancora il settecento, con la sua grazia un po' languida, col suo brio frizzante ma non esuberante, con la sua signorilità elegante; c'è l'amore per le belle proporzioni, e per tutto ciò ch'è fine e ben educato. C'è anche la caricatura, ma abbozzata senza pesantezza e senza soverchia ironia. Accanto a questi caratteri fondamentali passano a quando a quando folate di sensibilità quasi romantica. Si sente che, pur senza guastare le forme e le proporzioni, senza creare squilibri, senza calcare nelle tinte, l'autore scava più profondamente nelle anime dei suoi personaggi. I quali non sono più le figure mitiche o eroicamente paludate e coturnate proprie della tragedia greca, ma sono uomini press'a poco del tempo di Mozart, nobili o plebei, con le passioni di tutti i giorni volte in sorriso, dove se qualche ventata di irritazione e di dispetto accumula nembi nel cielo, questo vien subito rasserenato; se una lagrima sta per scendere vien subito asciugata; se la fronte si corruga sotto lo stimolo di un dolore o di una minaccia, immediatamente si spiana in una sorridente calma.
I colori dell'orchestra accentuano caratteri e sentimenti, ma non li aggravano di tinte fosche; gli istrumenti conversano con le voci dei personaggi, ne commentano argutamente i discorsi, ne avviluppano i canti in armoniosi e delicati disegni; però tutto è essenziale e nulla superfluo, tutto è espressivo e nulla edonistico. Soprattutto non si può separare il canto dall'orchestra, nè questa da quello, formando essi un tutto organico inscindibile. Il piacere di chi ascolta nasce dalla perfezione dell'insieme, dalla bellezza della forma e dalla verità semplice e schietta del sentimento. Gli istrumenti giocano e ricamano con un gusto tutto leggiadria e spirito. Questo lo avvertiamo fino dalla sinfonia, piena di humor. Il primo motivo è sussurrato sottovoce misteriosamente, un secondo incomincia piano, ma porta a un fortissimo improvviso che è come uno scoppio di gioia. Poi il primo motivo ritorna misterioso e sottovoce nei bassi. Altri motivi e incisi appaiono in seguito creando nuovi contrasti espressivi e scattando dal piano al forte con subitanee accensioni, e mantenendo alacre e fervida la vita dinamica della sinfonia per tutta la sua durata.
Il Dent ha fatto giustamente notare come una delle cause principali della vitalità delle Nozze di Figaro sia da ricercare nel numero grande delle pagine d'assieme, il che toglie all'opera la monotonia propria delle opere settecentesche italiane in cui predominano le arie. Un altro lato della grandezza di quest'opera è dato dalla caratterizzazione dei tipi, di cui alcuni appena accennati (Barbarina, Bartolo, Marcellina, Don Basilio); uno (Antonio) schizzato fortemente in pochi tratti energici; gli altri (il Conte, la Contessa e Figaro) molto ben disegnati e coloriti; ma due inparticolare (Susanna e Cherubino) sbalzati in altorilievo ed anche ben finiti nei particolari, specialmente in quei particolari che permettono di giudicare dall'esterno l'interno. Tutti però si allontanano assai dalle figure del Beaumarchais, ma ci danno anche assai di più e di meglio (talora anzi qualcosa di diverso) di quanto risulta dal libretto del Dal Ponte. Il Conte d'Almaviva, ad esempio, non è dipinto dalla musica come un volgare donnaiolo, non ha la sensualità ripugnante del libidinoso, ma è semplicemente il signore che fa ciò che tutti i suoi simili fanno per inveterata consuetudine feudale (anche se a parole egli ha dichiarato la decadenza di certi diritti feudali), il signore un po' sazio della vita coniugale (però innamorato, e gelosissimo della moglie anche per spagnolesco senso dell'onore) e soprattutto un po' fatuo. Fatuità e gelosia sono i due elementi che la musica di Mozart mette più in evidenza nello schizzare il personaggio del Conte, insieme ai tratti di una signorile eleganza.
La contessa Resina ha la severa castità e la nostalgia malinconica delle mogli che sanno di non avere nulla a rimproverarsi e sentono di aver perduto il predominio assoluto sul cuore dello sposo. L'aria del 2° atto «Porgi, amor, qualche ristoro», e quella del 3° «Dove sono i bei momenti», sono piene di questo sentimento di contenuto dolore nel ricordo di un affetto di cui la fede la sforza a sognare possibile il ritorno.
Figaro è forse la figura più scialba; non ha più l'effervescente immaginativa e l'indiavolata attività che spiegò nel favorire le Nozze del Conte con la pupilla di Don Bartolo. Lo appesantisce il sospetto di essere ingannato dal Conte, la gelosia che questo sospetto alimenta, e una certa posa nobiliare per credersi nato di buona famiglia (conoscerà poi d'esser figlio del dottor Bartolo e della sua serva Marcellina). Alla sua gelosia si debbono le sue due arie migliori: l'ironico sfogo «Se vuol ballare, signor Contino», e l'altro canto pure ironico «Non più andrai, farfallone amoroso» in cui prende in giro in un ritmo marziale Cherubino divenuto Ufficiale. E c'è in quest'aria una specie di gioia liberatrice per il fatto di levarsi dai piedi anche il «farfallone amoroso», poiché alla sua gelosia anche questo intraprendente ragazzo da ombra.
Susanna è la creatura più vispa, furba, e onestamente equilibrata dell'opera. Pronta ad informare sinceramente il suo Figaro delle intenzioni del Conte su di lei, nelle prime scene dell'opera, ma pronta altresì con uguale spigliatezza ed arguzia a deridere la sua gelosia nell'ultima scena. Attiva nel menare pel naso il Conte e nell'ordire e condurre a termine l'intrico che dovrà liberarla dal suo assedio e permetterle di sposare Figaro. Astutissima e rapida sempre nel deliberare e risolvere nei momenti più difficili degli avvenimenti, ogni sua frase, ogni accento ha il profumo di una spontanea verità e di una fervida festività. Essa è l'anima musicale di tutta la commedia. Di una naturalezza che affascina, il quasi recitativo (Mozart dice «aria») «Venite, inginocchiatevi», sui garbati e un po' civettuoli disegni dell'orchestra. Ma l'aria dell'ultimo atto «Deh vieni, non tardar» (lo spunto è preso da una melodia di Sarti) con cui Susanna vuole provare Figaro, ha movenze così molli e piene di voluttuoso abbandono che ingannerebbe nonché Figaro, l'Universo. Eppure anche a questa lirica amorosa Mozart ha saputo dare un ingenuo candore che la allontana da ogni intenzione o desiderio materiale. È una pura, ardente aspirazione all'amore di un'anima che sogna; una specie di notturno poeticissimo.
La creazione più nuova dell'opera resta però Cherubino. Questo adolescente, innamorato della sua padrona, ma avido soprattutto di amore, desideroso di conoscerne i segreti, timido e sfacciatello insieme, irrequieto e inquietante, resta scolpito specialmente in due arie indimenticabili. Una è la confessione: «Non so più cosa son, cosa faccio» capolavoro di ingenua e inebriata trepidazione in attesa della rivelazione dell'amore. Un'aria che sembra uscire da un soffio di primavera tiepido e aulente, da un cuore alato, tutto pieno di fermenti e di palpiti. Eppure il motivo di quest'aria è tolto da un'opera dell'Umlauf, ma come rinverdito e sublimato! L'altra aria è quella del 2° atto «Voi che sapete che cos'è amor», più languente e sognante, ma anch'essa pervasa da un'ansia di mistero e da un intimo calore d'affetti, sconosciuti e intravvisti, come in un incantamento del cuore. Cherubino è una figurina che ha un suo lontano, ma a Mozart sconosciuto, parente nel paggetto dell' Incoronazione di Poppea di Monteverdi, e che darà un nuovo frutto nel paggio Isoliero del Conte Ory di Rossini. Susanna e Cherubino sono veramente umanità trasfigurata in poesia eterna.
DON GIOVANNI: dramma giocoso in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Italiano di Praga il 29 ottobre 1787. Libretto di Lorenzo da Ponte, tranne le ultime scene, dall'aria di Leporello «Ah! pietà, signori miei!», che furono scritte da Giacomo Casanova.
Atto 1° - Quadro 1° - Atrio nel palazzo del Commendatore. - Leporello, servo di Don Giovanni, lamenta la vita che è costretto a condurre presso un cavaliere licenzioso. Ed ecco uscire dal palazzo, fuggendo e coprendosi il viso per non essere conosciuto, Don Giovanni, inseguito da Donna Anna che si sforza di trattenerlo. Mentre essi contendono, giunge il Commendatore, padre di Anna, che lo sfida a duello, ma resta ucciso. Donna Anna corre in casa a chiamare aiuto, e frattanto Don Giovanni e Leporello fuggono. Torna Donna Anna col fidanzato Duca Ottano, il quale giura di vendicarla.
Quadro 2° - Recinto d'antico castello presso una locanda. - Donna Elvira sta cercando Don Giovanni da lei amato e dal quale fu abbandonata. Essa vuol vendicarsi ed ucciderlo. Don Giovanni udendo i suoi lamenti le si avvicina per consolarla, ma avendola riconosciuta lascia con lei Leporello. Costui le narra chi è l'uomo con cui ebbe a che fare, e le mostra la lista delle innumerevoli donne ch'egli amò e poi abbandonò.
Donna Elvira si allontana sconsolata, combattuta tra il desiderio di vendicarsi e l'amore che ancora prova per lui. Giungono Masetto e Zerlina con un gruppo di contadini che inneggiano alle loro nozze. Don Giovanni, di ritorno, ordina a Leporello di condurre Masetto e gli altri al suo palazzo per festeggiarli, e trattiene Zerlina. Don Giovanni le propone di sposarla, e la sempliciotta un po' vanerella gli crede. Mentre sta per partire con lei, arriva Donna Elvira la quale accusa Don Giovanni d'essere un seduttore. Don Giovanni fa credere a Zerlina che Donna Elvira sia pazza, ma costei riesce a trascinar via Zerlina. Giungono ora Ottavio e Donna Anna, i quali domandano a Don Giovanni il suo aiuto nella ricerca dell'ignoto assassino del Commendatore. Ma ritorna Donna Elvira la quale mette in guardia i due fidanzati contro la fellonia di Don Giovanni. Anche a loro però Don Giovanni dice che Donna Elvira è una povera pazza; ma donna Anna crede d'aver riconosciuto alla voce in Don Giovanni colui che attentò al suo onore e le uccise il padre, e ne avverte Ottavio. Intanto Don Giovanni si propone di andare a divertirsi con Zerlina.
Quadro 3° - Giardino e Casino di Don Giovanni. - Masetto rimprovera Zerlina per averlo abbandonato il giorno delle nozze. Udendo giungere Don Giovanni la lascia sola e si nasconde. Anche essa vorrebbe nascondersi, ma Don Giovanni li scopre entrambi e li conduce alla festa. Donna Elvira, Ottavio ed Anna, entrano mascherati.
Quadro 4° - Sala in casa di Don Giovanni. - Don Giovanni fa servire alle contadine e ai contadini dolci e rinfreschi. Entrano anche Don Ottavio Elvira ed Anna. Si incominciano le danze; Don Giovanni ballando con Zerlina la conduce in altra stanza. Ma a un tratto si odono le grida di lei che chiama aiuto. Don Giovanni esce trascinando Leporello ed accusandolo di aver tentato d'usar violenza a Zerlina, ma Ottavio pronto estrae una pistola e la punta contro Don Giovanni: Tutti si avventano contro il seduttore.
Atto 2° - Quadro 1° - Recinto d'antico castello, come nel 2° quadro del 1° atto. - Leporello vorrebbe abbandonare Don Giovanni, ma questi regalandogli dell'oro lo persuade a servirlo ancora. Ora Don Giovanni vorrebbe sedurre la serva di Donna Elvira, e per riuscire cambia di mantello e copricapo con Leporello. Poi, nascosto dietro Leporello, parla a Donna Elvira, che si è affacciata a una finestra, dicendosi pentito, e chiedendole perdono. Elvira scende e si incontra con Leporello che scambia per Don Giovanni, mentre questi si è nascosto e con un grido pauroso li fa fuggire. Rimasto solo. Don Giovanni canta una serenata alla servente di Donna Elvira. Ma giunge Masetto con alcuni contadini armati, e Don Giovanni, udito che cercano di lui per ucciderlo, spacciandosi per Leporello svia per diverse parti i contadini, trattenendo Masetto che copre di legnate lasciandolo tutto pesto. Alle sue grida accorre Zerlina alla quale Masetto racconta che fu cosi conciato da Leporello. Cercando di consolarlo col suo amore, Zerlina lo conduce via.
Quadro 2° - Atrio come nel 1° quadro dell'atto 1°. - Leporello riconduce Donna Elvira, ma intanto sopraggiungono Ottavio ed Anna, Masetto e Zerlina, i quali credendo di aver a che fare con Don Giovanni si scagliano contro Leporello. Questo vistosi a mal partito svela il vero esser suo. Allora Masetto, Zerlina e Donna Elvira si gettano di nuovo su di lui; i primi due per le bastonate che Masetto crede aver avute da lui, e Donna Elvira per averla ingannata fingendosi Don Giovanni; ma Leporello riesce a fuggire. Tanti imbrogli persuadono sempre più Ottavio che Don Giovanni sia l'assassino del Commendatore, Leporello poi ritorna e si incontra di nuovo con Zerlina, la quale minacciandolo con un rasoio lo lega a una sedia e lo percuote, abbandonandolo per andare a chiamare Donna Elvira; però quando ritorna con lei il mariuolo è fuggito con la sedia.
Quadro 3° - Recinto con statua del Commendatore. - Mentre Don Giovanni narra a Leporello la sua ultima avventura con una donna che Leporello riconosce per la propria moglie, la voce del Commendatore si fa udire minacciosa. Vista la statua, Don Giovanni ingiunge a Leporello di invitarla a cena. La statua china la testa in segno di assenso. Don Giovanni ripete l'invito; la statua con gran terrore di Leporello, risponde si».
Quadro 4° - Stanza in casa di Donna Anna. - Ottavio sollecita Donna Anna a sposarlo, ma essa lo prega di attendere perchè troppo recente e vivo è il suo dolore per la morte del padre.
Quadro 5° - Sala in casa di Don Giovanni. - La mensa è preparata: Don Giovanni si pone a tavola, Leporello lo serve e ingolla di nascosto grossi bocconi; i suonatori eseguiscono musiche gaie. Donna Rivira viene a fare un ultimo tentativo per trarre a sé Don Giovanni, ma questi la beffa trattandola con modi ironicamente galanti. Essa fa per partire, indignatissima, ma giunta su la soglia manda un urlo dispavento e fugge dalla parte opposta. Leporello va a vedere che cos'è stato, ma anch'egli getta un grido e torna annunciando tremante che è giunta la statua del Commendatore. Mentre Don Giovanni va incontro allo strano visitatore, Leporello si nasconde sotto la tavola. Il Commendatore, invitato a cena da Don Giovanni, lo invita a sua volta a cenare con lui. Don Giovanni accetta; allora la statua gli prende la mano e gli dice di pentirsi. Ai dinieghi di Don Giovanni s'apre una voragine di fuoco nella quale il Commendatore trascina il suo assassino, mentre di sotterra si leva minaccioso un coro di spettri. Allorché Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, Ottavio e Masetto giungono per vendicarsi, Leporello tremando di spavento narra loro l'accaduto.
È questo il capolavoro teatrale di Mozart. «Dramma giocoso» è detto nel libretto, ma in realtà, dopo la prima aria comica di Leporello «Notte e giorno faticar», in cui egli goffamente si lamenta del suo servizio di mezzano di un padrone eccezionalmente libertino, le scene volgono per qualche tempo al tragico. E tragico si mantiene il fondo dell'azione fino all'ultima scena, in cui il tragico si fonde con il fantastico, anche se qua e là Leporello porta la comicità delle sue paure, anche se ogni tanto gli equivoci portano a bastonature che destano il riso, come destano il riso le sventure domestiche di Masetto. Al tragico, al comico e al fantastico si alternano il lirico con l'amore di Ottavio e Donna Anna e con le oscillazioni d'odio e d'amore di Donna Elvira, e la gaiezza coi canti nuziali in onore di Masetto e di Zerlina e con la festa in casa di Don Giovanni.
Ma le imprese di Don Giovanni stendono quasi dovunque un'ombra e un incubo drammatico su tutte le situazioni. Diciamo «quasi» perchè questo personaggio non è poi sempre antipatico, ed anzi ha un momento in cui noi sentiamo che il suo difetto è un difetto di giovinezza e di vitalità prepotente. L'aria «Fin ch'han dal vino calda la testa» è un canto di gioia, un inno alla danza, al vino, all'amore, in un ritmo sfrenato, in un movimento slanciato che ci afferra e trascina, e in certo modo spiega i falli che da tale natura esuberante necessariamente derivano. Don Giovanni ci appare in questo istante una forza primitiva del mondo, una personificazione del desiderio di vivere e godere pienamente la vita in tutta la sua bellezza e ricchezza di aspetti.
L'intreccio di elementi così diversi ci offre un quadro di vita che la musica di Mozart riscalda, illumina e sublima. Questo misto di tragico e di comico, di sentimentale, di fantastico e di gaio, noi lo avvertiamo subito nella sinfonia, nella quale, dopo le prime battute in cui ci scuotono gli accenti che illustreranno l'arrivo della statua alla cena di Don Giovanni, la gaiezza leggera e le note affettive dell'Allegro successivo si alternano a un pesante e drammatico motivo discendente con un contrasto profondo. Si noti che la sinfonia non è un pezzo a sé, ma una vera e propria preparazione al dramma, e fa corpo con esso connettendosi con la prima scena, e cioè con le meditazioni tragicomiche di Leporello, le quali a lor volta sono interrotte dal drammatico irrompere di Donna Anna che insegue Don Giovanni. Allorché interviene il Commendatore gli accenti energici e vibrati mutano colore facendosi cupi e severi, fino al violento fulmineo duello che si conclude con la morte del padre di Donna Anna. È tutto un blocco musicale granitico, con un crescendo di tensione che ci porta dall'inizio quasi buffo in piena tragicità.
Questa tensione, questa foga drammatica si conserva per tutta l'opera, culminando in alcuni momenti più essenziali, e particolarmente nel finale dell'opera, senza che l'armoniosità, la proporzione, l'eleganza delle forme abbiano minimamente a soffrirne. Inoltre in questi blocchi, le arie, i recitativi, i duetti, i terzetti, i quadri polifonici, si inseriscono l'uno nell'altro con sciolta libertà di movenze e con piena adesione alla vita del dramma e alla sua continuità. Le arie sfociano nei dialoghi a due a tre a quattro, senza convenzionali arresti. Per tutta l'opera il sistema è sempre il medesimo: dialoghi di vari personaggi fra loro, ora isolati ora a gruppi di tre, cinque, sei, ora tutti insieme, con alterna vicenda, fino a che, con l'entrata del coro, si forma un vero e proprio concertato. Così Mozart procede fino a quell'ultima scena dell'opera nella quale è da notare la felice fusione del drammatico (spavalda ostinazione di Don Giovanni nella colpa) del fantastico (statua del Commendatore e coro di spettri) e del comico (paura di Leporello); mentre la chiusa è data da un movimento «fugato» del sestetto vocale e dell'orchestra.
Tutto questo è assolutamente nuovo e audace nel teatro d'opera, e si lascia ben da parte le convenzionali galanterie amorose e il falso eroico-cavalleresco dell'opera seria italiana del settecento. Il convenzionale e il falso hanno fatto posto al poetico e all'umano. Siamo alle soglie del romanticismo. Un altro fatto che ci allontana dal settecento, ma che è una conseguenza dello strumentalismo settecentesco, specialmente germanico, è lo sviluppo assunto dalla parte orchestrale, coi suoi commenti, il suo mutevole colorismo, il suo contrappuntismo, in cui affiorano anche forme proprie della musica da camera, le sue reazioni al canto, e specialmente la piena fusione delle forme sinfoniche a quelle vocali.
Nè in Mozart l'interesse per l'azione diminuisce quello per i singoli personaggi, i quali sono dipinti sempre coi colori più appropriati e vivi. Don Giovanni, con il suo canto pieno di baldanza sfrontata, e anche di galanteria raffinata («Là ci darem la mano») e la serenata: chi non cadrebbe a tanta dolcezza di seduzione?); Leporello con la sua anima pavida e la sua goffaggine non priva di malizia e di sarcasmo («Notte e giorno faticar», «Madonnina il catalogo è questo», scene col Commendatore); Zelina con la sua equivoca fedeltà amorosa («Batti, batti bel Masetto»); Donna Elvira con la sua passione irragionevole; Donna Anna col suo dolore che ha tratti drammaticissimi («Or sai chi l'onore») e tratti di un patetico imbevuto di un'intensa malinconia («Non mi dir, bell'idol mio»); Masetto con la sua buffa e disperata gelosia. Forse il meno rilevato dei personaggi, nella sua compita cavalleria e nel suo tenero e devoto affetto, è Ottavio, che però ha qualche effusione lirica bellissima («Dalla sua pace», «Il mio tesoro intanto»). Risoluto nella difesa della figlia, terribile nel suo fantomatico ritorno è invece il Commendatore (come Mozart sa raffigurarcelo nella pesantezza macabra dei suoi passi marmorei, nella solennità fatale del suo discorso e nel gelo funereo degli accordi che lo sostengono!), che nella scena finale si esprime con accenti musicali che sono già modi del recitativo wagneriano.
Non serve dilungarci di più, ma non dobbiamo tacere, sia pur soltanto di volo, la bellezza di tanti particolari, i quali prendono vita artistica dalla capacità del compositore di trasfigurar in musica ogni gesto, ogni atto, ogni parola. Non si tratta di pure imitazioni più o meno naturalistiche della realtà, ma di una vera e propria forma di sensibilità per cui tutto ciò che Mozart vede e sente si trasforma entro di lui in disegni sonori vocali o strumentali. Ne sono un esempio i gemiti, i sospiri, i tremiti, le sospensioni, i mancamenti di sonorità dell'orchestra allorchè Donna Anna vede il cadavere del padre e sviene. Nulla di veristico: solo musica, nel senso più normale del termine; ma musica che realizza parole e atti di questo momento scenico in un mondo puramente artistico. «Tanta è la sincerità con cui Mozart si esprime - scrive lo Schiedermair - che il quadro scenico diviene una pittura d'anime». Lo stesso dicasi per i brevi sospiri dei violini nell'aria di Ottavio «Dalla sua pace» allorchè esclama: «S'ella sospira, sospiro anch'io»; e per le lamentose scale cromatiche discendenti che traducono il piagnucolio di Leporello allorchè, bastonato, si raccomanda: «Perdon, perdono, Sgnori miei! ». E ancora per i movimenti che la statua del Commendatore fa abbassando il capo; settime discendenti che, più in là della descrizione realistica del movimento della statua, sembrano esprimere un mancamento di cuore di Leporello causato dal suo terrore. Anche se Mozart non ci ha espressamente pensato, non si può sfuggire a questa impressione.
In tutti questi casi è da osservare anche la semplicità dei mezzi usati dal compositore. Così è pure per le quattro note grevi e cupe che sottolineano i passi della statua. Note grevi e cupe non dicono in sé nulla di più di quello che significano i due aggettivi con cui le abbiamo indicate. Ma in quella data situazione esse suscitano per rinesso un senso di pauroso raccapriccio: l'effetto artistico è raggiunto in pieno, anche questa volta per le vie più semplici. E c'è in questa scena finale, in contrapposizione con l'esuberante forza di vita personificata in Don Giovanni, la ineluttabile potenza della morte e un senso arcano di orrore per l'ai di là. Ottoni e legni nelle note basse gettano la loro luce fredda e possente su la scena sinistra.
Ma v'è ben altro nella partitura del Don Giovanni. Eccoci al momento in cui Leporello vuol far ballare Masetto per distrarlo mentre Don Giovanni conduce via Zerlina. L'orchestra eseguisce il famoso delizioso minuetto (tempo 3/4) ma le parti sovrastanti sono nei seguenti tempi: Masetto in 3/8, Zerlina e Don Giovanni in 2/4. Sono poche battute, ma audacissime nel 1787, e che valgono a rappresentare un momento particolarmente agitato in cui i personaggi sono completamente distaccati da ciò che sta eseguendo l'orchestra, il cui motivo di danza rimane poi sospeso con un cambiamento di tono, di tempo e di movimento improvviso al grido di Zerlina: «Gente, aiuto!». E qui siamo quasi alle soglie del novecento. L'unico filo che ci riallaccia al settecento è la finezza del minuetto e la perfezione organica della forma. Perciò tanto più stridenti in quest'opera appaiono i «recitativi secchi» (mentre ve ne sono tanti di strumentali, efficacissimi); ma la bellezza complessiva dell'opera li sommerge e li fa presto dimenticare.
GIOVANNI PAISIELLO - NINA, ossia LA PAZZA PER AMORE: commedia in 2 atti. Prima rappresentazione nel Teatro del Reale Sito del Belvedere a Caserta nell'estate del 1789. Il libretto per la parte in versi è di Giambattista Lorenzi, e per quella in prosa è tradotta dalla omonima commedia francese di Joseph Marsollier de Vivetières.
Atto 1° - Giardino. - Contadini e contadine commentano la sventura della giovane Nina, figlia del Conte, la quale ha perduta la ragione. La governante, Susanna, racconta che Nina era stata promessa in isposa a Lindoro; i due s'amavano ed era già fissato il giorno delle nozze. Ma essendosi presentato un ricco partito, il padre di Nina ritirò la parola data a Lindoro. Questi, mentre s'avviava a dare l'ultimo saluto a Nina, si incontrò col rivale e ne venne ferito. Fu trasportato altrove, nè più se ne sentì parlare, cosicché fu creduto morto. Il padre intimò a Nina di riconoscere per suo sposo il presunto uccisore di Lindoro. Nina svenne, e allorché riprese i sensi era impazzita. Nella sua follia essa crede che Lindoro sia in viaggio, e ne attende continuamente il ritorno. Al Conte, che è torturato dal rimorso, il balio Giorgio cerca di recare conforto dicendosi certo che Nina guarirà. Intanto Nina si lagna perchè il suo Lindoro non ritorna. Alcune villanelle cercano di consolarla e le fanno cantare una canzone d'amore sul ritorno di Lindoro, ch'ella stessa ha composta e insegnata alle amiche. Non riconosce il padre, ma s'intenerisce al suono della zampogna di un pastore. Le amiche convincono Nina ad unirsi a loro per accompagnare al villaggio il pastore.
Atto 2° - La stessa scena. - Il Conte è desolato per le condizioni della figlia. Susanna cerca di confortarlo; quando ecco, Giorgio annunzio che Lindoro è vivo ed è giunto alla villa. Condotto innanzi al Conte, questi lo abbraccia e lo chiama «figlio». Lo mette al corrente dello stato mentale della figlia e insieme concertano il modo di risvegliare in lei il lume della ragione. Al ritorno di Nina, Lindoro e il padre le si presentano. Dopo qualche istante di smarrimento, essa finalmente riconosce una sottoveste da lei ricamata e donata a Lindoro. Questo'atto apre la via ai ricordi, al riconoscimento di Lindoro e del padre; e la ragione finalmente le ritorna, fra la gioia di tutti.
L'opera prende ad argomento la felice soluzione di un dramma domestico, e lascia da parte il dramma stesso, che viene soltanto raccontato nel 1° atto da Susanna. Ciò fu un vantaggio per Paisiello, pel quale il dramma avrebbe costituito un notevole intoppo, rifuggendo la sua musa dalle espressioni drammatiche. Ridotto così il libretto alla sola conclusione, che comprende le situazioni più patetiche, Paisiello si trovò a suo agio e potè espandervi i tesori della sua vena delicatamente e poeticamente sentimentale. L'intimo profondo dolore e il tenero nostalgico ricordo per un amore aspramente conteso e violentemente distrutto, quel continuo oscillare tra speranza e delusione circa il ritorno dell'amato, e il vano tormento di una mente smarrita, hanno trovato nella commossa sensibilità di Paisiello una piena rispondenza artistica che raggiunge il suo vertice nella celebre cavatina di Nina «Il mio ben quando verrà».
Siamo dunque con quest'opera nel genere che i Francesi dissero «comédie larmoyante», e la innamorata e delirante Nina è la progenitrice artistica di numerose altre creature simili, le più celebri delle quali sono l'Amina della Sonnambula, l'Elvira de I Puritani di Bellini, e la Lucia dell'omonima opera di Donizetti.
La Nina era un passo fuori dalla consueta opera buffa, dall'ancor più convenzionale e falsa opera eroico-mitologica; era un passo in una dirczione nuova e inesplorata, verso l'intimità di sentimenti umani nella forma dell'a idillio».
La cavatina «Il mio ben» si svolge su un movimento fluente ed uguale di terzine che creano un'atmosfera di trasognata calma apparente. Il flauto annunzia il motivo del canto aggiungendo il candore celestiale del suo timbro alla dolcezza mesta della melodia che l'oboe conclude con la sua voce languida e triste. La prima strofa del canto scorre intrisa di malinconia; ma, alle parole «ma nol vedo...» la frase si spezza con lunghi arresti stupiti; poi un inciso si ripete per tre volte con un'insistenza dolorosa per terminare ancora in tristezza. Ma nella seconda parte della seconda strofa l'accompagnamento presenta nelle terzine, ad accordi non più arpeggiati ma ribattuti, una maggior concitazione; e così nella terza strofa la quale presenta disegni più mossi come ad esprimere una accentuazione del delirio, e rompe infine in gemiti e in sospiri affannosi. Semplicità e verità di forma hanno qui raggiunto un altissimo vertice espressivo.
Se questa è la pagina più perfetta dell'opera, altre non sono meno degne di starle accanto. Fra le più sentite è la canzone «Lontan da te» che Nina ripete insegnando alle amiche una più intensa espressione del canto. Le note staccate, le varianti melodiche, le pause drammatiche da lei suggerite ne accrescono infatti il senso di smarrito dolore. Ma Paisiello fa di più: passa dal canto al delirio, dal delirio al recitativo drammatico con una potenza che superando ogni verismo materialistico e rimanendo nel campo della pura poesia, non s'era più ripetuta nelle opere italiane del settecento dopo l'Olimpiade di Pergolesi.
Ed altre pagine ancora meriterebbero di essere lungamente commentate. Senza scendere a troppi particolari, diciamo, in generale, tutte quelle in cui figura Nina, la cui musica è sempre animata da un soffio lirico commosso ed ombrato da un'intima tenera malinconia. Così questo personaggio presenta una grande coerenza stilistica e una intonazione elegiaca la quale la caratterizza con un rilievo indimenticabile. È una smemorata perchè colpita da una sventura orrenda: il ferimento del fidanzato e la crudeltà del padre; ma in lei è rimasta viva una dolce fissazione:
l'amore puro e immutabile per colui ch'ella ormai crede solamente partito e di cui attende, trepidante e smarrita per le continue delusioni, il ritorno. Così Paisiello ha data all'arte una creatura viva ed eterna.
I tratti pastorali creano con efficacia un'atmosfera delicata e stupita; in particolare la nenia della zampogna, col suo lungo pedale, con le sue villerecce alterazioni tonali; e la canzone del pastore, anch'essa piena di modi agresti. Sono momenti in cui ci si dimentica il teatro poiché abbiamo dinnanzi a noi, in una rappresentazione artistica perfettamente riuscita, la vita.
Di tratti ricchi di verità, del resto, sono ripiene anche le altre scene ed arie. Se, ad esempio, l'aria del Conte «È sì fiero il mio tormento», può apparire, non ostante la viva espressione di turbamento, di una concezione convenzionale, l'aria di Giorgio «Ah! eccellenza! cose belle!» ci offre invece uno stupendo esempio del senso realistico di Paisiello. Le parole spezzate a metà, riprese più volte, ripetute senza concludere, esprimono con schietta vigoria l'agitazione e l'affanno da cui è preso il personaggio sia pel fatto che ha gran novità da dire, vorrebbe dir tutto e non sa da che parte cominciare, sia perchè ha corso e non ha fiato per parlare. La sua agitazione interna, del resto, è descritta anche dal movimento oscillante continuo dei violini, con quello strano accento forte su la seconda quartina che è come un batticuore irregolare.
Un'altra pagina ricca di poesia è la scena di Lindoro «Questo è dunque il loco usato», in cui la rievocazione degli «augelli», del «prato», delle «aurette», permette a Paisiello di realizzare una serena atmosfera di idillio. Meglio ancora la scena in cui Nina riacquista la ragione, dove su un palpito di sincopati si svolge il dialogo rapido fra Lindoro e Nina, e questa non s'attenta a pronunciare il nome dell'amato, che le esce prima tronco e poi a monosillabi, come non credesse alla realtà. Qui Paisiello ha trovato nuovamente una commossa sincerità di ispirazione; e la chiusa dell'opera, che si svolge su una forma di «falso cànone», reca un'ondata di fresca gioia serena.
Aggiungiamo che la sinfonia, pur non essendo strettamente legata all'opera, ne è tuttavia una non sconveniente preparazione, per la delicata dolcezza, ora gaia ora malinconica, dei suoi motivi.
WOLFANGO AMEDEO MOZART - COSÌ FAN TUTTE, ossia LA SCUOLA DEGLI AMANTI: dramma giocoso in 2 atti e 8 quadri. Prima rappresentazione al Burgtheater di Vienna il 26 gennaio 1790. Libretto di.Lorenzo Da Ponte.
Atto 1° - Quadro 1° - Bottega di Caffè. - Ferrando e Guglielmo, giovani ufficiali, vantano la fedeltà delle loro rispettive innamorate, le sorelle Dorabella e Fiordiligi, a Don Alfonso, vecchio filosofo, che ha esposto su ciò qualche dubbio. Corre la scommessa di metterle alla prova.
Quadro 2° - Giardino in riva al mare. - Fiordiligi e Dorabella parlano del loro amore, allorché D. Alfonso viene ad annunciare che i loro innamorati debbono partire per la guerra. Essi stessi vengono a salutarle fingendo gran dolore, e si lasciano scambiandosi giuramenti di fedeltà.
Quadro 3° - Stanza. - D. Alfonso convince Despina, serva delle due sorelle, ad assecondare il suo piano di far entrare nelle buone grazie delle ragazze due nuovi giovinetti. Accordatesi, D. Alfonso fa entrare Ferrando e Gugliemo travestiti da Albanesi. Essi si dispongono a corteggiare ciascuno la fidanzata dell'altro. Ma le ragazze li respingono ed escono indignate. Gli uffìcialetti si credono già vittoriosi, ma D. Alfonso li avverte che è presto, e segretamente si accorda ancora con Despina.
Quadro 4° - Giardino. - Ferrando e Guglielmo fingono di avvelenarsi in presenza di Fiordiligi e Dorabella, a causa del loro rifiuto. Vistili cadere come morenti, le due giovani si spaventano, e D. Alfonso le consiglia ad usare loro, almeno in questi estremi istanti, un po' di compassione e a sorreggerli. Intanto D. Alfonso e Despina andranno in cerca di un medico. Ben presto infatti D. Alfonso ritorna col... medico, il quale altri non è che Despina travestita. Questa tocca con una calamità la fronte dei due finti avvelenati, i quali riprendono i sensi e implorano dalle due belle un bacio, che esse rifiutano sdegnate.
Atto 2° - Quadro 1° - Camera. - Despina convince le due padroncino a ricevere nuovamente i giovani Albanesi. D. Alfonso viene poscia a chiamarle perchè scendano in giardino a vedere uno «spettacolo brillante».
Quadro 2° - Giardino presso il mare: alla riva, una barca ornata di fiori, con suonatori e cantanti condotti da Guglielmo e Ferrando. D. Alfonso e Despina, avvicinati i giovani alle ragazze, li lasciano soli; anche la barca si allontana. A poco a poco Dorabella cede alle lusinghe di Guglielmo, ma Fiordiligi resiste a Ferrando. Quando questi apprende dall'amico che Dorabella gli ha dato il cuore, monta in furore e vuol fare vendetta. Ma D. Alfonso lo conforta, e invita Guglielmo a non cantar vittoria troppo presto. L'esperimento non è ancora finito.
Quadro 3° - Camera. - Fiordiligi confessa alla sorella e a Despina che si è innamorata dell'Albanese che la corteggia. Volendo tuttavia serbarsi fedele a Guglielmo, ordina a Despina di portarle l'abito militare del fidanzato: si travestirà e lo raggiungerà al campo. Ma Ferrando, che l'ha udita, torna ad assediarla, e alla fine anch'essa cede al nuovo affetto per il creduto Albanese. Guglielmo che, nascosto, ha udito, si dispera; ma D. Alfonso, con la sua vecchia filosofia, ripete: Non è vizio ma «necessità di cuore»,
«giacché giovani, vecchie, e belle e brutte,
«ripetete con me: Così fan tutte!
E promette di accomodare ogni cosa. Intanto Despina annunzio che le due dame sono disposte a sposarsi subito.
Quadro 4° - Sala illuminata. - Si preparano le nozze. Despina travestita da Notaio si dispone a stendere il contratto, allorché si odono canti militari. D. Alfonso, affacciatesi alla finestra grida alle donne: «Misericordia! Tornano i vostri fidanzati!». Egli fa nascondere in altra stanza gli «Albanesi» e il « Notaio». Ed ecco, Guglielmo e Ferrando rientrano nelle loro vesti di prima. Viene recato un baule, e ne esce Despina ancora vestita da Notaio, ma senza maschera. Guglielmo e Ferrando raccolgono e leggono il contratto di nozze lasciato cadere ad arte da D. Alfonso. I due uffiziali fingono meraviglia, e, andati a riprendere gli abiti da Albanesi, ritornano deridendo le donzelle, le quali, umiliate, chiedono perdono. E D. Alfonso intercede e riconcilia tutti.
Si direbbe che Mozart in quest'opera abbia mirato più allo spirito della commedia che al rilievo dei singoli personaggi. Questi, infatti, salvo il divertito D. Alfonso, e soprattutto l'indiavolata Despina, discendente diretta delle vispe e furbe servette e zingarelle del teatro italiano settecentesco, e progenitrice di Resina, Norina e compagne, appaiono caratterizzati dalla musica con minore intensità di quanto il maestro abbia fatto, per esempio, ne Le nozze di Figaro, nel Flauto magico e nel Don Giovanni. Ma, a parte Despina, che ci si presenta con accenti particolarmente vivi nell'aria del 2° atto: «Una donna a quindici anni», civettuola e maliziosa, nel resto la musica è però sempre di un'allegria fresca, di una scorrevolezza garbata e spiritosa, appena qua e là venata di malinconia, così da farci rivivere in una perenne sensazione di gioia la vicenda, un po' a tesi e un po' vera, un po' convenzionale e un po' umana, che la scena ci presenta nel suo spassoso svolgimento (anche talvolta paradossale). E tale gaiezza non si smentisce neppure nei momenti più burrascosi dell'azione, come, per esempio, alla scena del finto avvelenamento dei finti Albanesi (finale 1°), che anzi, come per farci ben persuasi che siamo in commedia, il brio della musica si fa più effervescente. Fiordiligi e Dorabella possono essere effettivamente spaventate, ma è soprattutto la farsa che domina e continua.
L'abbondanza delle idee ci offre l'immagine di una fonte copiosa, perenne e limpidissima. Nulla arresta questo fiotto, nulla l'intorbida. Su gli avvenimenti della commedia, che avrebbero potuto dare origine a un'amara espressione di scetticismo ironico, il musicista sorvola con ali leggere, con un sorriso pieno di piacevolezza, e non scevro da un fine umorismo che sfiora e non intacca, che appena ammicca e non corrode.
Poi vi è, forse più che in altre opere mozartiane, un evidente compiacimento che il musicista palesa nel trasfigurare le vicende dell'azione in una specie di sinfonia che si allieta della propria indipendente bellezza, e vive una propria vita musicale, alla quale partecipano le voci umane quasi come strumenti, pur conservando la spontanea e sciolta semplicità e schiettezza del dialogo. Questo senso sinfonico, che si mantiene sensibile dalla spigliata (per quanto forse un po' scolastica) ouverture, fino all'ultimo finale, accennando perfino alla costruzione di una fuga sul tema sentimentale che Fiordiligi intona durante il festeggiamento per le nozze coi presunti Albanesi alle parole: «E nel tuo, nel mio bicchiere», trae origine, oltre che dalla fluida e serena ispirazione melodica (che forse pecca solo per un eccesso di diatonicità e di monotonalismo), dalla sapienza di una costruzione perfetta che si rivela più schiettamente nelle scene a più voci, e nella leggiadria dello strumentale.
Forse in quest'opera Mozart ha ripiegato dalle posizioni nazionaliste del singspiel verso il modello dell'opera italiana cimarosiana, ma conservando quell'aerea spiritualità di ispirazione per cui personaggi ed azione sembrano contemplati come da un altro mondo dove il canto raggiunge una purità angelica, dove la vita diventa una visione di musicalità alata.
Fra le pagine più belle va ricordato il Terzettino: «Soave sia il vento», in cui la suadente amorosa melodia e il mormorio degli archi simile a una lieve brezza creano un'atmosfera di idillio sereno. L'aria di Dorabella: «Smanie implacabili», con i balzi vocali e il tempestoso accompagnamento, esprime con realismo lo stato agitatissimo dell'animo della ragazza. Ammirevole è pure la delicata aria di Ferrando: «Un'aura amorosa». Al 2° atto son da notare il duellino Dorabella-Fiordiligi: «Prenderò quel brunettino», e il successivo duetto Ferrando-Guglielmo: «Secondate, aurette amiche '), cui fa eco il coro, così teneri e pieni di grazia elegante; la vivace aria comica di Guglielmo: «Donne mie, la tate a tanti», e l'impetuosa aria di Ferrando: «Tradito, schernito».
Quando la tesi di D. Alfonso sulla facile infedeltà delle donne è dimostrata agli ingenui innamorati, e sta per scatenarsi un putiferio, è allora che la musica diventa più schiettamente gioconda, non proprio per bofonchiare cinicamente su la fragilità della natura femminile, ma per ridere serenamente dell'ingenuità di chi crede il mondo perfetto.
IL FLAUTO MAGICO: dramma eroicomico in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Italiano di Vienna il 30 settembre 1791. Libretto di Emanuele Schikaneder, tratto da una novella di Cristoforo Wieland.
Atto 1° - Quadro 1° - Paese montuoso con veduta di un tempio. - il principe Tamino è inseguito da un serpente a sta per esserne sopraffatto, allorché tre damigelle armate escono dal tempio e uccidono il rettile, quindi rientrano. Giunge l'uccellatore Papageno, essere tra l'uomo e l'uccello, con un gabbione d'uccelli, suonando un {strumento pastorale. Papageno lascia credere a Tonino d'essere stato lui l'uccisore del serpente; ma le damigelle ritornano e gli chiudono con un lucchetto la bocca in punizione della sua bugiarda vanteria. Indi informano Tamino che il serpente fu ucciso da loro per ordine della Regina della notte Astrifiammante, e gli danno il ritratto della di lei figlia. Gli raccontano poi che Pamina, la figlia della Regina, fu rapita da Sarastro, suo nemico. L'Astrifiammante glie la promette in isposa se egli la libererà.
Si apre improvvisamente la montagna, entro la quale, in una splendida sala appare la Regina, che riconferma a Tamino la promessa. Indi la montagna si richiude. Una damigella toglie il lucchetto a Papageno dicendogli che la Regina gli perdona; poscia consegna a Tamino un flauto d'oro il cui suono gli sarà di aiuto nelle imprese che sta per compiere. La Regina ha poi deliberato che Papageno segua il Principe nella lotta contro Sarastro, e gli dà un istrumento il cui suono promuove allegria.
Quadro 2° - Camera. - Il moro Monostato vuole incatenare Pamina perchè, ribellandosi ai suoi indegni desideri, cerco di fuggire. Papageno entra per la finestra: Monostato e Papageno hanno paura l'uno dell'altro, cosicché fuggono entrambi. Ma Papageno ritorna e dice a Pamina d'essere un messo dell'Astrifìammante, e che lo segue il Principe Tamino, inviato dalla madre di lei per liberarla. Pamina allora decide di fuggire e si affida a Papageno.
Quadro 3° - Boschetto. Un tempio maggiore nel mezzo su cui è scritto: «Tempio della Sapienza», congiunto a due templi laterali minori su uno dei quali è scritto «Tempio della Ragione», e sull'altro « Tempio della Natura». - Giunge Tamino guidato da tre Geni i quali gli impongono di osservare costanza, fede e silenzio se vuol riuscire nell'impresa. Un sacerdote uscito dal tempio centrale gli accenna vagamente che Sarastro non è colpevole com'egli crede. Monostato vuol riprendere e incatenare Pamina, ma al suono dell'istrumento di Papageno, egli e gli Schiavi sono presi da allegria e si mettono a ballare e cantare. Arriva anche Sarastro con un numeroso seguito. Pamina si inginocchia e invoca perdono per la tentata fuga. Monostato conduce Tamino. Come si vedono Pamina e Tamino corrono ad abbracciarsi. Sarastro fa condurre Papageno e Tamino nel «recinto delle prove».
Atto 2° - Quadro 1° - Atrio del tempio. - Sarastro dice ai Sacerdoti che egli rapì Pamina per ordine del Cielo, poiché sua madre è nemica dell'umanità e del progresso. Tamino sarà l'erede di Sarastro e il difensore del Tempio, e Pamina gli è destinata dagli Dei. L'Oratore degli Iniziati interroga Tamino, il quale si mostra risoluto, anche a costo della morte. Poscia un Sacerdote interroga Papageno, al quale viene promessa una Papagena purché egli sappia tacere. Anche Tamino rivedrà Pamina, ma non dovrà parlarle. Appaiono intanto le tre Damigelle che mettono in guardia Tamino: qui lo attende morte; la Regina si vendicherà. Tamino non risponde; fra lampi e tuoni le Damigelle sprofondano. L'Oratore e il Sacerdote conducono altrove Tamino e Papageno.
Quadro 2° - Giardino; da un lato gabinetto di fiori ove dorme Pamina. - Monostato vedendosi solo con lei vuole approfittarne, ma compare la Regina Astrifiammante, e Monostato si ritira in fretta. Pamina svegliandosi riconosce la madre e la informa che Tannino si è votato ad Iside. La madre allora consegna un pugnale a Pamina e le ingiunge di uccidere Sarastro e di togliergli il cerchio d'oro di cui si fregia e in cui sta racchiuso il suo potere. Solo a questa condizionepotrà sposare Tamino. Monostato, che nascosto ha ascoltato, partita la Regina si appressa a Pamina, le toglie di mano il pugnale e la minaccia di morte se non cede al suo amore, ma giunge Sarastro il quale scaccia Monostato.
Quadro 3° - Atrio del tempio. - Tamino e Papageno debbono persistere nel silenzio; ma Papageno ha sete: una Vecchia gli reca dell'acqua e si dice sua amante. Papageno ne rabbrividisce. I tre Geni recano una tavola imbandita. Mentre Papageno mangia, compare Pamina che si rivolge a Tamino con trasporto, ma egli non le risponde. Pamina si allontana disperata credendo che non l'ami più. Suonano trombe funebri: Tamino deve andare per una via prima indicatagli. Papageno stenta ad abbandonare la mensa, ma compaiono due leoni. Tamino suona il flauto e i leoni si ritirano.
Quadro 4° - Sotterraneo. - L'ultima prova per Tamino: egli deve dire addio a Pamina. Giunge poi Papageno, e la Vecchia gli corre incontro amorosa. Papageno, minacciato, giura d'amarla; la Vecchia allora si trasforma: è Papagena, che gli fu promessa in isposa. L'Oratore interviene per separali, ma poiché Papageno non vorrebbe, vien fatto sprofondare.
Quadro 5° - Giardino. - Pamina vuole uccidersi, ma i tre Geni glielo impediscono e la consolano dicendole che Tamino l'adora.
Quadro 6° - Orrido monte con profonda grotta: nel fondo di questa un cancello; al di là si alzano vortici di fiamme fino alla cima, dalla quale scende lava ardente. Da un iato una piramide su cui a lettere d'oro è scritto che chi cerca la pace e la virtù deve affrontare il fuoco e il gelo. - Tamino è deciso ad affrontare il pericolo, ma giunge Pamina, e i due giovani possono finalmente abbracciarsi. Tamino passa attraverso alle fiamme con Pamina suonando il flauto.
Quadro 7° - Un alto monte da cui scende un impetuoso torrente. - Tamino, sempre suonando il flauto, affronta e attraversa con Pamina l'impetuosa corrente che si alza per sommergerli. Il monte infine si spalanca, e appare un tempietto illuminato: Tamino e Pamina vi entrano e si inginocchiano.
Quadro 8° - Giardino come nel quadro 5°. - Papageno non trovando più Papagena vuole impiccarsi. I Geni lo trattengono. Egli si rammenta dello strumento magico e lo suona: compare allora Papagena con la quale si allontana felice. L'Astrifiammante giunge con le tre Damigelle guidata da Monostato, al quale la Regina promette la figlia in isposa se l'aiuterà a rapirla. Ma s'ode un orribile schianto di tuoni, e tutti sprofondano.
Quadro 9° - Il tempio del sole. - Sarastro è seduto in trono. Tamino e Pamina gli stanno innanzi ormai congiunti nell'amore.
La complicatissima e faragginosa vicenda, i simboli più o meno oscuri, le allegorie massoniche, la lotta fra illuminismo e oscurantismo, fra le forze del Cielo concentrate in Sarastro e quelle dell'Inferno impersonate in Astrifiammante non rendono un buon servizio all'arte in quest'opera; e neppure i fantasmagorici e cataclisma;ici colpi di scena e i mutamenti a vista. Ma Mozart vi trionfa ugualmente per virtù del suo genio. Il Flauto magico, scritto su testo tedesco, doveva servire a riprendere l'iniziativa, già tentata con Il ratto del Serraglio, di porre le fondamenta del melodramma nazionale germanico; ma in realtà Mozart palesa in quest'opera lo stesso stile ed usa le stesse forme proprie del melodramma italiano già esperimentati nelle opere precedenti. Soltanto abolisce i «recitativi secchi» che sostituisce con la semplice recitazione; e dato che egli non sentiva come si potesse creare un'atmosfera musicale anche per i dialoghi più comuni (restano i «recitativi strumentali» per i momenti di maggior concitazione) il meglio che si potesse fare era appunto quello di lasciar parlare i personaggi abolendo l'inutile quanto inespressivo formulario convenzionale dei «recitativi secchi».
La pagina più bella dell'opera è la sinfonia, che non ha stretto rapporto di temi con la commedia, ma che però con la sua brillante dinamica prepara ugualmente bene l'animo alla vita della musica mozartiana e al soggetto «eroicomico». Dopo alcuni accordi maestosi di preparazione segue un breve movimento Adagio, insieme severo e leggermente ansioso. Quindi con l'Allegro viene attaccato un movimento di fuga su un «soggetto» giocoso, il cui spunto Mozart prese da una Sonata per piano di Muzio Clementi. Ammiriamo la geniale capacità di trasfigurazione di un motivo non suo di cui Mozart ha dato prova: Clementi non avrebbe mai sospettato che fosse possibile una tale divinizzazione di un suo tema. Questa fuga non ha uno sviluppo regolare; a metà circa si interrompe, e si ripetono gli accordi maestosi introduttivi; quindi la fuga viene ripresa e conclusa mantenendo costantemente un fervore di animazione gioiosa pieno di vita; ma di una vita che appare più cosmica che terrestre.
Il libretto dell'opera presenta molti momenti a carattere descrittivo: tuoni, fulmini, montagne che si aprono e si chiudono, voragini che inghiottono, fiamme, lave incandescenti, torrenti impetuosi, sortilegi e magie. Il musicista quasi non se ne accorge, lasciando fare alle macchine sceniche, per concentrare tutta la sua forza creativa intorno al carattere dei personaggi e alle loro emozioni. E su tutto distende la sua prodigiosa sensibilità melodica piena di grazia, di arguzia, di serenità, a quando a quando anche di vigore e di slancio.
In quest'opera elementi comici, drammatici, sentimentali, fantastici e religiosi si alternano e spesso nei pezzi a più voci si fondono mantenendo separate le singole espressioni pur nell'unità della forma. E, come di consueto, al canto si uniscono le voci dell'orchestra, non come accompagnamento, ma come elemento di cui il canto stesso non è che una delle parti. La drammaticità non si fa sentire che in penombra, poiché il musicista non è disposto a dar soverchio peso ai momenti più emozionanti della vicenda scenica. Questo ci appare fino dalla prima scena. Quando Tamino entra fuggendo e urlando perchè inseguito da un mostruoso serpente, e sviene dallo spavento (curioso modo di presentare l'eroe del dramma!), la musica si mantiene vivace e agitata, sì, ma nè il serpente ci è descritto da motivi o da suoni particolari, nè la paura di Tamino è in qualsiasi modo rilevata e accentuata dal canto o dall'orchestra. In complesso è musica che non vuol scomporsi per così poco, anzi si direbbe che ci tiene a farci ben capire che si tratta di una favola e che perciò non conviene esagerare le tinte.
Anche nella scena in cui Monostato minaccia di morte Pamina se non si arrende ai suoi desideri amorosi, la musica scorre senza appesantire la minaccia. Anzi le parole di Monostato: «Colomba mia venite qua!» sono cantate su lo stesso motivo con cui Pamina esclama: «Che mostro rio! Che crudeltà!». Allorché nel 2° atto Pamina e Tamino saranno separati, con la prospettiva di non vedersi più, come quando Pamina pensa di suicidarsi, la musica mozartiana sfiora appena le situazioni dolorose con una elegante malinconia che solo qua e là prorompe in qualche accento più vivo. Evidentemente si tratta solo di una tendenza settecentesca in generale e mozartiana in particolare ad attutire e smussare tutto ciò ch'è drammaticamente troppo acceso. Si è visto nel Don Giovanni che quando volle, Mozart seppe essere fortemente ed anche aspramente tragico. Questo ammorbidire e aggraziare nel Flauto magico ogni situazione più tesa deve dunque essere stato fatto di proposito per non uscire dal tono leggero della commedia. Tale senso di levità fiabesca e di commedia, Mozart lo mantiene per tutta l'opera.
Non si lascia invece sfuggire le tinte patetiche. Ed eccone un esempio stupendo all'aria di Tamino «Oh! cara immagine», allorché gli vien presentato il ritratto di Pamina, ed egli ne è di colpo innamorato come per incantamento. La melodia vocale è tutta piena di questo senso di incantesimo e di sognante poesia, mentre i violini sospirano e, nella parte centrale dell'aria, dolcemente ansimano e si arrestano bruscamente come sotto l'urto di un'emozione troppo forte, però mantenuta in una sfera di purità celestiale. Anche Pamina, musicalmente tratteggiata con fine dolcezza e delicata femminilità, si abbandona ad un momento di patetica nostalgia nell'aria «Ah! lo so, più non m'avanza."; è un lamento squisitamente femminile in cui il dolore si scioglie in una soavità melodica di paradiso.
Tutt'altro rilievo musicale ha Papageno, natura semplice e primitiva, personaggio comico senza furberia per la stessa ingenuità dei suoi istinti, delle sue paure e della sua golosità. Egli si esprime con motivi popolareschi festosi, accompagnandosi con la siringa di Pane, o con Io strumento magico dategli dalle Donzelle, il che da una espressione ancor più burlesca a ciò che canta. L'aria «Gente, è qui l'uccellatore» con cui si presenta al 1° atto, e quella:
«Colomba o tortorella» del 2°, sono due fra le espressioni più tipiche di questa figura nuovissima e rimasta unica nella storia del melodramma, alla quale Mozart seppe dare un'impronta così originale. Quando le Donzelle gli chiudono con un lucchetto la bocca, le sue espressioni a bocca chiusa conservano il medesimo gustoso sapore faceto-popolaresco.
Dell'amore di Mozart, per la grazia elegante, anche l'odioso Monostato subisce il felice influsso, che si rivela nell'aria «Regna amore in ogni loco», la quale col suo brio frizzante lo rende per un momento simpatico. Altra espressione ancora Mozart ha u?ata per Astrifiammante, in generale impetuosa ed aspra. Non che anch'essa non abbia il suo momento patetico, se pur breve. La sua aria del 1° atto, «Infelice, sconsolata», ci apre il segreto più intimo del suo cuore: la pietà e l'affetto della madre. Ma negli altri momenti essa conserva un modo costantemente violento ed anche virtuosistico di canto che la distingue in mezzo a tutti gli altri personaggi. Il virtuosismo non si limita ai vocalizzi difficilissimi, ma spinge la voce a note ultracute, come, ad esempio, il fa sopra il rigo; il che accresce impeto e veemenza al suo canto, ed anche agli stessi gorgheggi che sono concepiti (si veda in proposito l'iraconda aria «Gli angui d'inferno») in funzione della sua personalità magica e demoniaca.
Poiché il soggetto dell'opera mira a una mèta morale e religiosa, è naturale che faccia largo posto all'espressione dei sentimenti inerenti a questa mèta. Tra la Marcia sacra, tenuta misticamente «sottovoce», con cui si apre il 2° atto, il duettino del Sacerdote e dell'Oratore «Fuggite, o voi, beltà fallace», così sereno, il «fugato» pensoso (Mozart aveva scoperto da poco Bach e Hàndel) che commenta la lettura dell'iscrizione morale incisa su la piramide, si muove e sovrasta la figura austera e mite di Sarastro, i cui canti sono sempre improntati a serena grandezza. Questa imbeve di sé specialmente l'aria del 2° atto «Qui sdegno non s'accende», e ancor più l'aria «Possenti Numi», in antifona con i cori, che non vuol avere nessun carattere di esotismo, ma la cui bellezza riposa interamente nella nobiltà solenne del sentimento religioso da cui è sgorgata.
Se nel libretto ci sono assurdità, stravaganze e sconnessioni, «La musique - secondo ciò che della potenza di quest'arte scriveva Mozart medesimo, e ciò che in particolare si può ripetere della musica sua-règne en souveraine, et fait oublier tout le reste».
Due mesi appena dopo la prima rappresentazione del Flauto Magico, stremato dal lavoro, Mozart moriva.
DOMENICO CIMAROSA (Aversa 1749-Venezia 1801) - IL MATRIMONIO SEGRETO: melodramma giocoso in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Nazionale di Vienna il 7 febbraio 1792. Libretto di Giovanni Bertati.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala in casa di Geronimo, ricco negoziante. - Paolino, giovane di negozio di Geronimo, sta rassicurando Carolina, sua moglie segreta e figlia minore di Geronimo, nei riguardi di una prossima e felice soluzione della loro anormale situazione. Geronimo desiderava dare in moglie la propria figlia maggiore Elisetta e un nobile. Paolino è riuscito a convincere il suo protettore Conte Robinson a chiederla in moglie, e pensa che l'esserseli obbligati entrambi renderà più facile la soluzione del loro caso. Geronimo dà l'annunzio delle prossime nobili nozze alle figlie e a sua sorella Fidalma. Elisetta monta in boria e rimprovera Carolina per l'invidia che le sembra che mostri verso di lei; e le due sorelle si bisticciano. La matura Fidalma confida poi ad Elisetta che spera di potersi sposar presto anche lei, e quasi le scappa detto di essere innamorata di Paolino. Giunge intanto il Conte Robinson, il quale alla vista di Carolina se ne invaghisce, e ci resta male quando gli indicano come fidanzata Elisetta.
Quadro 2° - Gabinetto. - Carolina confida a Paolino che il padre vuol darle per marito un Cavaliere. Paolino le dice che pregherà il Conte di intercedere presso il di lei padre. Ma il Conte Robinson, prima ancora che Paolino possa parlargli del caso suo, gli confessa che si è innamorato di Carolina e lo incarica di proporre a Geronimo il cambio della fidanzata. Intanto il Conte incontrandosi con Carolina le propone di sposarlo, ma essa garbatamente rifiuta. Elisetta li sorprende a colloquio, e immaginando che Carolina voglia astutamente sottrarle il fidanzato, fa ai due una scena di gelosia. Sopravviene Geronimo: ciascuno cerca di spiegargli a modo proprio l'accaduto, e naturalmente ne nasce una grandissima confusione.
Atto 2° - Quadro 1° - Gabinetto come nel quadro precedente. - Il Conte Robinson avverte Geronimo che non intende sposare Elisetta, e domanda di sposare Carolina dietro compenso di cinquantamila scudi. Fatti i suoi conti Geronimo accetta, e il Conte dice poi a Paolino di avvertire Carolina. Paolino spera nell'aiuto di Fidalma; se non che costei fraintende credendo ch'egli voglia confessarle il proprio amore. Quando Paolino capisce d'esser stato frainteso se ne accora tanto che sviene. Ai richiami di Fidalma accorre Carolina, alla quale la zia racconta che Paolino è svenuto per l'emozione provata nel dichiararle il suo amore. Carolina rimasta poi sola con Paolino gli rinfaccia sdegnata il suo tradimento; ma Paolino le spiega l'equivoco e soggiunge che per la loro salvezza non resta ormai che un mezzo solo: la fuga.
Quadro 2° - Camera. - Il Conte cerca di persuadere Elisetta che un matrimonio fra loro è impossibile. Elisetta, sempre persuasa che la causa di ciò sia la civetteria di Carolina, si allea a Fidalma, la quale, per parte sua, sospetta che Carolina ami Paolino; e insieme convincono Geronimo a mandare Carolina in un ritiro. Geronimo annuisce e dà egli stesso la notizia a Carolina. Questa fa allora un ultimo tentativo presso il Conte, ma mentre sta per svelargli il suo segreto, Geronimo, Elisetta e Fidalma li sorprendono. Non resta dunque altro che fuggire. Ma mentre Paolino e Carolina stanno per attuare il loro progetto, odono rumore e si rinchiudono nella stanza di lei. È'la sospettosa Elisetta che ha sentito parlare. Ode un bisbiglio nella stanza di Carolina, sospetta che ci sia il Conte con lei e sveglia tutta la casa. Ma il Conte esce invece dalla propria stanza, mentre i due colpevoli escono dall'altra e confessano il loro matrimonio segreto. Il Conte intercede per loro e dichiara che sposerà Elisetta; e il perdono è concesso.
[A questo punto esiste nella partitura dell'opera un'altra scena, che viene sempre saltata, in cui il Conte dichiara ad Elisetta che non la sposerà].
Il grazioso, divertente e ben congegnato libretto è certamente un elemento importante del successo costante ottenuto dall'opera, che però vanta una musica geniale. Questi due fatti cospiranti permettono di considerare Il matrimonio segreto come l'autentico capolavoro dell'opera buffa settecentesca. La commedia si vale dei soliti intrecci e colpi di scena comuni al teatro del secolo XVIII, ma scorre fluida e piacente, lasciando da parte personaggi e situazioni abusate; scorre con naturalezza, sorridendo gaia e festevole con grazia, tracciando caratteri comicamente divertenti o pateticamente interessanti, senza appesantimenti caricaturali né sdilinquimenti sentimentali. La musica di Cimarosa vi si adatta con tale aderenza spirituale che le figure di commedia diventano creature vive, e le loro parole e le loro azioni motivi eterni di poesia. Tutto è semplice, schietto, vero, di una verità intima e superiore, senza enfasi, senza gonfiature di voce (l'artista che lo facesse sviserebbe il carattere di questa musica), di una raffinatezza di gusto e di elaborazione che si lascia dietro ogni vieta convenzione.
Geronimo, con la sua ambizione nobiliare da marcante arricchito, con la sua leggera sordità che gli fa prendere granchi sui discorsi degli altri, con la facilità al brontolamento propria dei vecchi, costituisce un tipo che la musica stacca bene da tutti i suoi simili di opere buffe precedenti per farne piuttosto un modello di quelle future. La sua gioia esuberante e pomposa allorché annunzia alle figlie il prossimo aristocratico parentado fissa quella forma bonaria di macchietta alla quale Rossini ripenserà varie volte nelle sue opere buffe. La figura del mercante grandeggia nel duetto col Conte Robinson, allorché questi gli propone di sostituire come sposa Carolina ad Elisetta. Certe parole sono ripetute nel canto con cocciuta ostinazione, da una parte, con biliosa irritazione dall'altra, e l'orchestra a sua volta le sottolinea deridendo con gusto sapido. Poi Geronimo fa i conti del guadagno, borbottando in fretta sottovoce alla maniera monotona dei vecchi avidi e calcolatori, mentre i violini snocciolano un gaio commento burlevole. Tutto ciò con garbato e signorile umorismo.
Non meno stupendamente scolpito è il personaggio di Robinson, chiacchierone chiassoso, affabile con degnazione, ma anche, al momento opportuno, e cioè quando Elisetta Io accusa di star nascosto con Carolina, sdegnoso con nerezza. Altrettanto vive sono musicalmente le figure di Elisetta, fatuamente superba e dispettosa, e dell'inciprignita e sentimentale Fidalma; mentre Carolina e Paolino, presi dal loro amore e dalla loro ansia, recano la noia della tenerezza e della malinconia: tenerezza e malinconia fatte di carezze e di sospiri, di accenti affettuosi e di languidi lamenti. Due sono nel libretto i momenti culminanti del loro dramma sentimentale, e il Cimarosa non se li è lasciati sfuggire, ma ne ha fatto le due pagine più belle dell'opera. Una è la prima scena: profumo di deliziosa intimità, in cui la melodia scorre tra un sospiro e un sorriso con senso di idillio patetico un po' settencentescamente languido ma non sdolcinato. Le parole «caro», «cara», tante volte ripetute, si stendono come carezze soavi. Nell'annunciare all'amata che «presto avrà fin la pena», Paolino si lascia sfuggire dei vaghi melismi di gioia. Alla frase «Se amor si gode in pace non v'è maggior contento», i violini emettono anch'essi dei rapidi gruppetti giubilanti. Si respira in ogni momento un'atmosfera leggera e trasparente, tutta colori delicati e sfumati, senza arcadiche pastorellerie, ma ricca di un'affettuosità veramente toccante e trasfigurata in grazia.
L'altra pagina è la famosa aria di Paolino (che «aria» - secondo il vecchio stampo convenzionale - non è per il disegno vario e fluttuante): «Pria che spunti in ciel l'aurora», bella non tanto per la descrizione dei «cavalli di galoppo», ma per la sognante poesia di cui è imbevuta la frase melodica proposta prima che dalla voce umana da quella più vagamente remota del clarinetto. I gruppetti e gli incisi con cui i violini commentano, aggiungono delicati palpiti e brividi al racconto della prossima fuga. Le insistenze di Paolino debbono vincere l'onesta titubanza di Carolina, e lo fanno con carezzosa soavità di seduzione. Non un accento che riveli l'ansia del pericolo; tutto è dipinto di roseo ottimismo: è il sogno della loro felicità futura. Quest'aria è completata dalla scena in cui Paolino e Carolina stanno per uscire e per attuare il loro progetto di fuga. Anche qui le tinte musicali sono estremamente lievi, trepidanti e misteriore: brevi gruppetti e gorgheggi, interruzioni e silenzi che esprimono la cautela dei due sposi segreti: dolcezza e spasimo sottile di un gesto decisivo che deve coronare il loro amore.
Numerosi sono poi i momenti in cui la vena leggermente elegiaca o finemente ironica del musicista crea, da inezie di particolari, la vita. Ci basti citare le frasi di Paolino durante il duetto col Conte. Il contrasto tra la frenesia e l'insofferenza del Conte («Non posso più resistere, mi sento incenerir») e il dolore sconsolato di Paolino che vede crollare le sue speranze in un aiuto da parte del Conte («Ah sento proprio il core che in sen mi va a languir») è dei più artisticamente riusciti.
Altro momento patetico, di tinta prebelliniana, è nelle parole di Carolina «Cielo! deh! tu m'addita il consiglio miglior», sostenute da una malinconica frase dei violini, allorché essa viene a sapere che vogliono chiuderla in un ritiro. Qui canto e orchestra si sciolgono dalle forme convenzionali per assumere una schiettezza di linguaggio nuovo nella storia del melodramma.
Vivacissima è infine la pittura della scena in cui Fidalma ed Elisetta persuadono Geronimo a mandare via Carolina. E poiché Geronimo è un po' sordo, le due donne gli strillano a perdifiato nelle orecchie con irritante insistenza «in un ritiro, la Carolina, la Carolina, in un ritiro» fino a sopraffarne la sordità e la volontà.
I recitativi sono quelli «secchi» consueti dell'opera italiana; tuttavia qua e là, raramente, qualche inflessione melodica, qualche movenza cromatica ne ravviva il sentimento.
La sinfonia, nella sua aggraziata espressione tra il misterioso e il sentimentale, tra l'arguto e il patetico, si intona bene all'azione, anche se non ha pretese concertanti, ed anche se non è strettamente legata ad essa da un proposito di sintesi della commedia o da richiami tematici. L'orchestra di quest'opera comprende: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 2 timpani, violini viole, violoncelli e contrabassi; e l'autore fu accusato di essere troppo rumoroso! Eppure questa è anche l'orchestra di Mozart.
Com'è noto, il successo del Matrimonio segreto fu tale che, per desiderio dell'Imperatore Leopoldo II, l'opera venne ripetuta per intero la sera stessa, dopo un breve intervallo per riposare e rifocillare gli artisti.
LUIGI CHERUBINI (Firenze 1760 - Parigi 1842) - MEDEA: tragedia in 3 atti. Prima rappresentazione al teatro Feydeau di Parigi il 13 marzo 1797 (23 ventoso dell'anno V). Libretto di Francesco Benedetto Hoffmann.
Atto 1° - A Corinto, presso la reggia di Creonte, in vista al mare. - Glauce, figlia del Re Creonte, promessa sposa a Giasone, condottiero degli Argonauti, ha tristi presagi; pure si conforta nella fiducia che la maga Medea non potrà spezzare i nuovi legami d'amore che stringono Giasone a lei. Creonte assicura Giasone che proteggerà i due figli ch'egli ebbe da Medea contro il popolo che, non potendo aver nelle mani la madre, vorrebbe far giustizia su di essi. Giunge poi Medea, e pronuncia atroci minacce contro Glauce se sposerà Giasone. Essa tenta di attrarre ancora a sé Giasone, ma questi la respinge; Medea allora giura di vendicarsi.
Atto 2° - Un'ala della reggia di Creonte; dall'altro lato il Tempio di Giunone. - Creonte ingiunge a Medea di abbandonare il proprio regno se vuole aver salva la vita: tutto il popolo vuole il suo sangue per i delitti da lei compiuti. Ma Medea astutamente ottiene dal Re di restare ancora un giorno. Prega poscia Giasone che laici ancora presso di lei i figli in questo ultimo giorno, e manda a Glauce in dono un diadema e un peplo dotati di infernale magia. Frattanto il corteo nuziale di Giasone e Glauce entra nel Tempio. Medea gioisce della vendetta che ha preparato.
Atto 3° - Luogo montuoso, coperto da alberi; un tempio nel fondo, da un lato la reggia. - Neris, ancella di Medea, conduce presso di lei i suoi piccini. Medea leva un pugnale per ucciderli, ma vinta da pietà materna lo lascia cadere e li abbraccia; quindi li affida a Neris che entra con loro nel Tempio. Dalla reggia intanto giungono grida d'orrore e di dolore: Glauce sta morendo per la magia del diadema e della veste denotale da Medea. Questa nell'udire le grida gioisce selvaggiamente e si rinchiude nel tempio. Mentre il popolo si riversa fuori della reggia a cercare Medea per vendicare la morte di Glauce, dal tempio esce Neris, la quale racconta che Medea uccise i figli. Medea stessa si presenta su la soglia del tempio che ha incendiato gridando a Giasone: «l'ombra mia t'aspetta presso Stige»; e fugge fra l'orrore e la costernazione di tutti.
Cherubini tentò di riportare il melodramma alla severa altezza di Gluck, ma gli mancò spesso il calore dell'ispirazione. La scienza talora sopraffà l'arte, e un'ombra grigia opprime la fantasia del compositore. «Il suo carattere prudente e calcolatore - com'ebbe a scrivere il Saponaro - spesso condensa in ghiaccioli il caldo respiro iniziale». La Medea, eseguita nel 1797, fu ampiamente rimaneggiata dall'autore nel 1809, allorché fu riprodotta a Vienna. I recitativi furono aggiunti dal Maestro Francesco Lachner (1803-1890). In Medea, malgrado che la preoccupazione costruttiva e stilistica domini e talora freni l'ispirazione, circola un'inconsueta libertà di linee e di spiriti, un'abbondante e robusta linfa volontariamente controllata e arginata affinchè non sboccasse in espressioni apertamente romantiche, dalle quali Cherubini rifuggiva con un forte senso di repulsione che lo condusse ad opporsi all'arte di Berlioz. Ma là dove la vena si scioglie, ivi sgorgano le. melodie di largo palpito e di grande vigore drammatico che gli procacciarono l'ammirazione di Beethoven. Tra gli squilibri d'ispirazione che si notano nelle pagine di Medea c'è però diffuso un senso tragico e una nervosità ritmica che precorrono la sensibilità nuova da cui uscirà La Vestale di Spontini e, in più sublime sfera, la Norma di Bellini.
Fra le parti più robuste di Medea va ricordata anzitutto la Sinfonia, vibrante di foschi riverberi strumentali, che dominano tutta l'opera da cima a fondo, e di un impeto tragico che la apparenta all'Egmont beethoveniano. Non si spiega perciò, poveri come siamo di musica sinfonica, il perchè non venga qualche volta eseguita nei concerti, se non pensando a deplorevoli lacune culturali di enti e di direttori.
Un carattere saliente della musica di Medea è la sua classica compostezza che, tanto nella sinfonia, quanto nelle scene animate da più fiera angoscia e da più spaventosa crudeltà, pur nella varietà degli elementi tematici e dei movimenti ritmici, pure nel vigore potente degli accenti che la percorrono, non viene mai meno. Non ci soffermeremo su le prime scene dell'opera, che sono inadeguatamente deboli e convenzionali, e neppure su l'aria di Creonte «Qui tremar devi tu», sul concertato del 2° atto «Date almen per pietà un asilo», e sul duetto fra Medea e Giasone «Figli miei», che ha tuttavia un basso stupendamente mosso con viva espressione di tormento. Forse l'aver voluto dare all'opera un carattere prevalentemente sinfonico, carattere che meglio si manifesta, oltre che nella sinfonia, nei drammatici preludi del 2° e 3° atto (di cui l'ultimo accentra con rara potenza espressiva nella descrizione d'un temporale il tumulto tempestoso che si agita nell'anima della protagonista e il tragico fato che incombe) ha fatto sì che il Cherubini mantenga il canto quasi sempre nella forma del declamato. Si avverte perciò in molti momenti in cui la piena del sentimento più liricamente prorompe, la mancanza di quella profonda forza di liberazione, di superamento, che è la melodia.
Alla melodia aperta, ampia, di intensa commozione e di largo respiro, si arriva solamente con l'aria di Neris (atto 2°) «Solo un pianto». Qui la vena del Maestro ha rotto ogni impaccio convenzionale e teorico e si spande in un fiotto di dolore melodioso, cui il contraccanto del violoncello aggiunge spasimo e passione.
Poniamo accanto a questa, che è forse la lirica più perfetta dell'opera, alcune altre patetiche arie; quella di Giasone «Or che più non vedrò», così toccante nella sua duplice espressione di dolente amarezza e di sospirosa speranza; e, per purezza di canto, quella di Medea «Dei tuoi figli la madre», piena di insinuante nostalgica dolcezza, in cui la frase «Splendea la notte in sogni buoni» sembra precorrere il linguaggio musicale più alto di Wagner. Nè dimentichiamo che nel duetto finale del 1° atto, anche se qua e là la mano sembra raffreddarsi in formule usate, predomina una concitazione irruente che afferma il robusto senso drammatico di Cherubini. Qualche cosa di prewagneriano è anche nell'alta serenità del terzetto e coro «Pronube Dive», preghiera di largo e solenne afflato, che per contrasto rende anche più drammatico l'improvviso irrompere di Medea.
All'opera di Cherubini donano anche dignità le vigorose architetture dei cori e dei concertati, per la prima volta nel teatro musicale italiano a tessitura riccamente polifonica; architetture alle quali partecipano con pari interesse le voci e gli strumenti, e perciò più dense di contrasti e più ricche di ombre, di luci e di chiaroscuri.
IL PORTATORE D'ACQUA, o LE DUE GIORNATE: opera in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Feydeau di Parigi il 16 gennaio 1800. Libretto di Gian Nicola Bouilly.
Atto 1° - Una stanza con letto in casa del portatore d'acqua Micheli a Parigi. - Antonio e Marcellina, figli di Micheli, e il loro nonno Daniele sono lieti: Antonio dovrà recarsi l'indomani a Gonesse per sposare la figlia di un ricco fattore. Frattanto egli canta una canzone da lui composta, «la canzone del Savojardo», che rievoca un avvenimento importante della sua vita, quando fu salvato dalla fame e dall'assideramento per l'intervento generoso di un ignoto. Arrivato il padre Micheli, Antonio e sua sorella, accompagnati dal nonno, si recano al Commissariato a far vistare il passaporto per Gonesse. Micheli, che ha salvato dall'arresto il Presidente del Parlamento Conte Armand e sua moglie Costanza condannati a morte dal Cardinal Mazarino, espone loro un piano per fuggire da Parigi: il Conte accompagnerà il figlio Antonio, e Costanza si fingerà sua sorella. Frattanto un capitano con alcuni soldati entra per una perquisizione. Micheli fa prontamente entrare nel letto il Conte con una berretta tirata sugli occhi, come se fosse il suo vecchio padre, e gli pone accanto Costanza a vegliarlo. Mentre si svolge la perquisizione ritorna Antonio. Partiti i soldati e il capitano, e alzatesi il Conte, Antonio riconosce in lui l'ignoto che un giorno a Berna lo salvò.
Atto 2° - Una barriera di Parigi. - Un tenente e vari soldati fanno la guardia alla barriera: sperano di catturare il Conte Armand sul quale pesa una taglia di seimila scudi. Giungono Antonio e Costanza, ma i connotati di lei non corrispondono a quelli segnati sul passaporto, perciò il tenente la arresta. Ne nasce una vivace disputa con Antonio. Attratto dalle grida esce dal corpo di guardia il Capitano che, avendola vista la sera prima in casa di Micheli durante la perquisizione, la riconosce. Giunge anche Micheli con una botte d'acqua su un carretto. Dopo breve discussione, Antonio e Costanza sono lasciati passare, Il tenente interroga Micheli circa il conte Armand che si dice nascosto nel quartiere ov'egli abita. Micheli dice di aver visto nascondersi appunto in una casa della sua contrada un uomo i cui connotati corrispondono a quelli del Conte, e propone di condurli egli stesso alla ricerca. Mentre il tenente e il Capitano sono rientrati al Corpo di guardia a scegliere i soldati per la cattura del Conte, Micheli apre rapidamente la botte dalla quale esce il Conte che oltrepassa svelto la barriera e si dilegua.
Atto 3° - Ridente contrada nel villaggio di Gonesse; nel centro un albero cavo; a destra la casa del ricco fattore Semos; a sinistra un'alta rupe con cespugli. - Semos e sua figlia Angelica attendono Antonio, e sono in pensiero per il ritardo. Frattanto le ragazze del villaggio recano doni alla sposa; ma giungono soldati in paese, e tutte si precipitano a vedere. Antonio, assicuratesi che non c'è più nessuno, scende dalla rupe seguito da Costanza e da Armand, il quale vien celato dentro Inalbero. Ritornano con gli invitati Semos e Angelica, i quali si rallegrano nel trovare Antonio e quella ch'essi credono sua sorella. Giunge anche il Capitano con alcuni soldati. Due di questi si pongono dietro l'albero a bere. Costanza si accosta all'albero per porgere alcune vivande al marito, ma i due soldati l'afferrano ed essa sviene per lo spavento. Per difenderla Armand esce dall'albero. Ritornando in sé e vedendo lo sposo. Costanza pronuncia involontariamente il suo nome, scoprendo chi egli è; per tal modo si vieti pure a sapere che Costanza è la sposa di Annona e non la figlia di Micheli. Armand viene arrestato e si sta per trascinarlo via, allorché giunge Micheli con l'ordine di liberazione di Armand firmato dal Re.
L'opera è composta nella forma del singspiel tedesco e dell'opéra comique francese, cioè con i recitativi parlati. E questi recitativi sono numerosi e lunghi, cosicché la parti musicali si riducono a quattordici pezzi più la sinfonia, ma in essi si concentra tanta vita e spirito da fare dell'opera un gioiello. Nel gioiello la sinfonia è la pietra preziosa più pura. Cherubini fa uso del cosiddetto melodram, cioè dell'azione parlata e intercalata da commenti strumentali, che appaiono sollevati a maggior dignità espressiva che non pel consueto. Nè mancano esempi di recitativo strumentato di un'efficacia drammatica assolutamente nuova, sia per la concisione nervosa della parte vocale, sia per la vivezza del commento orchestrale, che non si limita ad accordi e strappate, ma aggiunge all'energia del canto l'energia dei disegni e colori propri. Uno dei più begli esempi di questi dialoghi recitativi è quello animatissimo del 2° atto allorché viene arrestata Costanza, che rimane interrotto su un accordo di settima.
Fu notato, anche in un'apparizione recente de Le due giornate, che questa musica manca in generale di abbandono espansivo e di impeto drammatico, raffrenati, come già in Medea e nelle opere minori, dal controllo che il compositore esercitava su la levigatezza dello stile e l'armonioso equilibrio della costruzione. Questi valori infatti sono, anche ne Le due giornate, notevolmente preminenti su quelli puramente espressivi.
Il successo riportato dall'opera allorché apparve (200 rappresentazioni consecutive!) è dovuto in parte alla nobiltà dello stile cherubiniano e alla sapienza della fattura; sapienza che non è semplicemente bravura tecnica, ma spontaneità geniale, tantè l'assimilazione di essa da parte della fantasia è completa, cosicché tutto sembra scorrere con estrema facilità. Il male incomincia appunto là dove questa grande facilità tecnica, divenuta abitudine mentale, vuol controllare e arginare la fantasia tarpandole talvolta la libertà del volo. Ma un'altra causa del successo è certamente da ricercare in certe situazioni patetiche del libretto, abilmente intrecciato e condotto, tendenti al genere di commedia detta e larmoyante», tanto diffusa su la fine del settecento, e di cui la Nina di Paisiello fu uno degli esempi più perfetti e acclamati.
Un altro lato seducente della musica de Le due giornate è quell'aspirazione verso un'espressione romantica latente e in qualche momento anche prorompente, ma sùbito frenata, che dà a quest'opera un sottile afflato che la distacca nettamente non solo dalla Nina, ma da tutta l'operistica settecentesca. Se non che questo freno lascia perplessi e disillusi anche se prova che spiriti nuovi stanno penetrando nell'arte musicale, e se con la sua dottrina geniale il Cherubini affina taluni dei mezzi necessari a un'adeguata espressione di essi.
Un fatto pure importante è che il musicista non si sia sentito legato dalle più antidrammatiche consuetudini a inserire nell'opera un numero di arie corrispondenti al numero e all'importanza dei personaggi. Così l'azione non viene turbata, e i convenzionalismi e le velleità virtuosistiche dei cantanti sono bellamente evitate. Musica e azione corrono liscie e senza intralcio alla loro mèta.
Si è già detto, e ripetiamo, che la sinfonia è la gemma più preziosa del gioiello. Con quel suo preambolo pensoso, in cui sembrano addensarsi nubi tragiche, e lo slancio spigliato e rasserenante dell'Allegro successivo, essa preludia in modo mirabile alla commedia. Ma diremo anche che essa non è indegna di stare accanto alle ouvertures di Beethoven, alle quali l'apparentano la sostanza delle idee musicali e l'elevatezza e genialità degli sviluppi.
Pagine deliziose, anche se qua e là l'ispirazione sembra discendere da Paisiello, da Cimarosa o da Mozart, sono sparse un po' dovunque. Eccone una, piena di una schietta limpidezza di canto popolaresco: la canzone di Antonio: «Un pauvre petit Savoyard», e la serena e quasi religiosa invocazione di Micheli «Guide mes pas, o Provvidence!» in forma di lied. Ricco di energica passione è poi il duetto fra Costanza e Armand: «Me séparer de mon époux?», ed è qui soprattutto che si avverte qualche bagliore romantico. Da segnalare poi la descrizione dell'alba nel preludio al 2° atto; e la marcia, di una pomposità lievemente umoristica, che, al 3° atto, accompagna l'arrivo dei soldati nel villaggio. Infine la fervida festività dei finali, specialmente del 1° e del 3° atto, l'ultimo dei quali sfrutta come un tema fondamentale il ritornello della canzone di Antonio nell'atto 1°.
[Torna all'indice]
II.
Ottocento (1801-1850)
BEETHOVEN (VAN) LUDWIG (Bonn 1770 - Vienna 1827) - FIDELIO: dramma lirico in 2 atti. Prima rappresentazione in 3 atti al Teatro «An der Wien» di Vienna il 20 novembre 1805;2a versione in 2 atti allo stesso teatro il 21 maggio 1814. Il libretto, tratto da un dramma di Giovan Nicola Bouilly, è di Giuseppe Sonnleithner, il quale peraltro non fece che rielaborare grossolanamente un altro libretto già esistente di Pierre Paveaux, dal titolo «L'amour coniugal». Nel 1814 il libretto del Fidelio fu ampiamente rimaneggiato da Giorgio Federico Treitschke.
Atto 1° - La corte di una prigione di Stato presso Siviglia. - Giaquino, portinaio della prigione, assedia la figlia del carceriere, Marcellina, ma questa è invece presa d'amore per Fidelio, un giovane impiegato da poco assunto dal padre. In realtà Fidelio non è altri che Leonora, moglie del prigioniero Fernando Florestano, che, travestitasi da uomo, sì è fatta accettare come aiuto dal carceriere nella speranza di riuscire a liberare lo sposo. Rocco, il carceriere, che ha un buon concetto di Fidelio, gli propone di sposare la figlia. Fidelio annuisce, ma espone a Rocco il desiderio di aiutarlo nelle sue mansioni presso i carcerati. Giunge poscia il Governatore della prigione, Pizzarro. Fra la corrispondenza che Rocco gli consegna vi è una lettera nella quale è detto essere a conoscenza del Ministro ch'egli ha fatto incarcerare, con potere arbitrario, alcuni innocenti. Fra questi, da due anni, si trova, per odio personale di Pizzarro, Fernando Florestano, che ha poi fatto credere morto. Ora egli ordina a Rocco di ucciderlo, e poichè Rocco si rifiuta, Pizzarro lo incarica di scavare la fossa, aggiungendo che il prigioniero lo ucciderà egli stesso. Leonora ha udito il dialogo, e confida di potere sventare il piano criminale di Pizzarro. Comincia intanto col chiedere a Rocco che lasci uscire in giardino i prigionieri a prender aria, e Rocco acconsente. I prigionieri si avviano lentamente verso il giardino. Leonora chiede poi a Rocco di poterlo aiutare a scavare la fossa per Fernando. Pizzarro rimprovera Rocco per avere lasciato uscire dalle, celle i prigionieri, che fa rientrare.
Atto 2° - Prigione oscura e sotterranea. - Fernando lamenta la sua triste sorte, e in una strana visione crede di vedere Leonora che viene a liberarlo. L'emozione che prova è tale che sviene. In tale stato lo trovano Rocco e Leonora, i quali si pongono a scavare la fossa. Pizzarro giunge, ed estrae il pugnale per uccidere Fernando, ma Leonora con un balzo si frappone e punta una pistola contro Pizzarro svelandogli chi sia essa. In questo istante squillano le trombe delle scolte e Giaquino annunzia l'arrivo del Ministro. Pizzarro si allontana, Fernando e Leonora si abbracciano felici.
A questo punto, in generale, si fa finire il 2° atto trasformandone il 2° quadro in 3° atto, non ostante che Beethoven medesimo nell'ultima revisione dell'opera l'abbia divisa in due atti soli. L'azione di quest'ultimo quadro, o atto, è la seguente.
Il Ministro fa liberare i prigionieri innocenti. Rocco gli racconta le infamie perpetrate da Pizzarro, la sua intenzione di uccidere Fernando e l'eroica azione di Leonora. Il Ministro allora ordina a Leonora stessa di togliere le catene che legavano lo sposo. Tutti inneggiano al trionfo dell'amore.
La critica, tenuta in rispetto dal nome eccelso di Beethoven, è stata sempre guardinga e ossequiosa verso la musica del Fidelio. Eppure, se c'è opera che dimostri le scarse attitudini al teatro del suo autore, è questa. Già è noto, e lo attestano i lunghi ripetuti abbozzi e rifacimenti, e il tempo impiegato a creare l'opera, che Fidelio fu pel genio beethoveniano una conquista assai più faticosa di qualunque vasta composizione sinfonica. Malgrado che l'alta sua fantasia illumini di potenti bagliori alcune scene, malgrado che la scrittura mostri sempre la sapienza tipica del sommo sinfonista, malgrado la indiscutibile nobiltà dell'intera opera, si avverte che l'ispirazione è un po' legata dalla mediocrità del testo, un po' dalla catena delle parole, e un po' anche dall'istinto scarsamente vocalistico e robustamente sinfonistico dell'autore.
Beethoven accetta lo schema dell'opera a pezzi staccati e recitativi quale esisteva al suo tempo; però preferisce che i recitativi siano, nella maggior parte dei casi, soltanto parlati anzichè musicati, e quando si induce ad intercalarvi brevi commenti strumentali, come avviene in talune scene del 2° atto (mélodram) questi non aggiungono nulla. Lo stile oscilla spesso fra quello di Cherubini e di Mozart, non escludendo neppure Rossini, del quale accetta per il Quartetto del 1° atto la forma a «falso cànone», in cui la stessa melodia passa successivamente dall'uno all'altro dei quattro personaggi, contrappuntata dalle voci e dall'orchestra. Le quali voci umane, non solo nel quartetto, ma quasi in ogni altro momento dell'opera sono trattate come strumenti. Ne risulta un'espressione generale più sinfonica e quartettistica che operistica, troppo genericamente drammatica per poter aderire alla vicenda umana che forma il soggetto dell'opera. Beethoven anzi è spesso più tragico nelle sue composizioni strumentali che non nelle pagine di Fidelio.
Ma quando l'impeto tragico del musicista si scatena, esso manifesta un carattere trascendentale che trasporta il dramma in una sfera superiore a quella della vita terrena. Questa elevazione sembra talvolta perfino contrastare con la modestia dei personaggi (a parte la coraggiosa e astuta Leonora) e con gli avvenimenti prettamente terrestri e contingenti, soffocati da un'atmosfera di crudeltà disumana di cui non ci si rende ragione. Anche la comparsa di spunti musicali che appaiono in altre composizioni puramente strumentali di Beethoven accentua a volte la scarsa aderenza della sua fantasia al testo. Alla medesima causa si deve attribuire la scarsa caratterizzazione dei personaggi. Ma nel grave coro dei prigionieri al 1° atto, e specialmente nelle scene del 2° atto, ove il dramma più stringe i suoi nodi, ivi il creatore musicale sale più in alto. Già il preludio del 2° atto esprime fortemente lo stato d'animo di Fernando, e l'aria successiva «Della vita in su l'aurora» è uno dei grandi mirabili adagi ai quali Beethoven ci ha abituati anche nelle composizioni strumentali. È la melodia il cui spunto si trova anche nelle tre ouvertures che portano il titolo di Leonora.
Dopo il mélodram, la seconda parte del dialogo tra Rocco e Leonora è cantata, e sostenuta da un movimento dell'orchestra agitato, cupo e febbrile di efficacia intensamente drammatica. Il coro finale, non ostante qualche formula cadenzale consueta, reca una vivace luce di gioia. I personaggi, le contingenze del dramma, scompaiono: finalmente il musicista può esprimere in una vasta composizione sinfonico-corale il suo amore per la gioia e per la libertà. Ed è ancora una volta il sinfonista, ma non l'operista, che trionfa.
Ma le due pagine più alte sono la ouverture dell'opera, e specialmente la 3a ouverture «Leonora» che i direttori intercalano solitamente all'inizio dell'ultimo quadro del 2° atto. In questa ouverture il dramma è espresso in una sintesi sinfonica così densa e potente da rendere quasi superfluo tutto il resto dell'opera. Il che ci riporta al punto di partenza: Beethoven è soprattutto un sinfonista e non uomo di teatro. Naturalmente, non diamo alla frase «uomo di teatro» il significato banale di uomo che cerca di cattivarsi il pubblico con effetti grossolani, ma vogliano dire che manca di quell'incisività vocale e sinfonica insieme per cui il dramma si manifesta e afferra con sùbita forza l'animo dell'uditore. Questa forza, che c'è sempre nella sinfonia beethoveniana, difetta spesso nel canto.
GASPARE SPONTINI (Majolati [Jesi] 1774 - ivi 1851). - LA VESTALE: melodramma in 3 atti. Prima rappresentazione all'Opera di Parigi il 15 dicembre 1807. Libretto di Stefano De Jouy.
Atto 1° - Foro in Roma; a destra l'atrio del tempio di Vesta. - Licinio, generale Romano vincitore dei Galli, confessa all'amico Cima di amare la Vestale Giulia, un giorno promessagli in isposa dalla madre, e poscia costretta dal padre moribondo a farsi sacerdotessa. Egli sa di essere riamato, e vuol strappare Giulia all'altare. La Gran Vestale sospetta dal contegno malinconico e pensieroso di Giulia ch'essa celi una fiamma amorosa, e la pone in guardia contro tale pericolo. Durante la funzione sacra per il trionfo di Licinio, mentre Giulia gli pone sul capo la corona, egli sottovoce t'avverte che nella notte verrà a rapirla.
Atto 2° - Interno del tempio di Vesta, presso l'altare su cui arde il fuoco sacro. - Giulia è turbata dal pensiero che Licinio sta per giungere, ma vinta dalla forza dell'amore gli apre la porta del tempio. Mentre i due amanti parlano, la fiamma su l'ara si spegne. Intanto Cinna accorre avvisando che sono stati scoperti. Giulia costringe Licinio a fuggire da solo. I Sacerdoti che entrano trovano soltanto Giulia svenuta accanto all'ara il cui fuoco si è estinto.
Atto 3° - Campo scellerato; si vedono tre piramidi: due in cui sono sepolte due Vestali che tradirono il giuramento; la terza, aperta, destinata a Giulia. - Cinna avverte Licinio che ha radunato uno stuolo di armati, pronti ai suoi ordini. Licinio chiede al Sommo Sacerdote grazia per la vittima; al suo rifiuto si allontana giurando di strapparla con la forza alla morte. Giulia è accompagnata al supplizio. A terra viene deposta un'ara spenta sulla quale è appeso un velo. Mentre è condotta alla piramide in cui dovrà essere sepolta viva, Licinio irrompe con armati. Egli si dichiara il solo colpevole e vuol trafiggersi; trattenuto, fa appello ai suoi amici perchè lo aiutino a liberare Giulia. Frattanto si scatena un temporale, ed un fulmine cade su l'ara, ne incenerisce il velo ed accende la fiamma. Il portento è interpretato come un segno di perdono e di consenso della Dea alle nozze di Giulia. Fra il giubilo generale Giulia vien tratta dalla piramide e si slancia fra le braccia di Licinio.
La Vestale segna una tappa importante del melodramma verso le espressioni romantiche. Essa non raggiunge la sublime altezza di una Norma: si muove ancora tra strutture consacrate dal tempo, che ogni tanto però dilata e rompe. Il musicista tende ad un'espressione più intensa dei sentimenti, che in varie scene raggiunge anche vigorosamente, senza abbandonare la classica compostezza delle linee. Armonizza gli elementi passionali in un'architettura solenne che mira al grandioso. Inni sacri e marce trionfali, processioni e cortei, colpi di scena spettacolari e danze, aprono nettamente le porte al fasto della grand-opéra. Tutto ciò insieme all'ispirazione che sorregge alcune parti, procurò all'opera un successo clamoroso che ebbe lunga durata; e molte cose appaiono tuttora stupende.
I recitativi, tutti strumentati, hanno talora un periodare ridondante; ma in molti casi il discorso presenta un maschio vigore drammatico, mentre l'orchestra segue e commenta con un'aderenza e un rilievo che ci portano lontano dal settecento e oltre Gluck.
La drammaticità vigorosa si afferma nella bella sinfonia, che con la varietà dei suoi elementi, con la grave pensosità del suo inizio, la fremente agitazione dell'Allegro, le progressioni trascinanti, gli accenti eroici prorompenti di quando in quando, prepara ed ambienta suggestivamente il dramma.
Il 1° atto ha il suo fuoco nella religiosità dell' «Inno Mattutino», al quale quasi di certo ha pensato Bellini scrivendo l'introduzione della Norma. È una preghiera di trasparente serenità che racchiude una dolce malinconia. Fra le molte cose decorative e convenzionali del 1° atto spiccano ogni tanto tratti di forte espressività. Tali la frase della Gran Sacerdotessa: «Il tuo cor si perde, o figlia», e il nobile e solenne invito corale: «Della Dea pura seguace».
Se gli elementi spettacolari decorativi e le forme consuete prevalgono nel 1° atto, non ostante la continua e nuova densità strumentale, non così è nel 2°, tutto vibrante di un'intensa ansia drammatica. Esso raggiunge la massima potenza nell'aria di Giulia, dopo il veramente ombrato e vespertino «Inno della sera». Quest'aria è la cosa più bella dell'opera; è una preghiera percorsa da un fremito di orrore e d'angoscia, in cui la voce oscilla con tormento ed ha improvvisi crolli come se l'anima fosse presa da sùbiti spaventi. La perorazione orchestrale che si smorza nel pianissimo resta a un tratto interrotta per l'apparire di un più profondo turbamento dell'animo che informa di sè il recitativo seguente:«Su questo sacro altare... fremendo io porto la sacrilega mano». I bassi ascendono con un tema violento e minaccioso più volte ripetuto in tonalità diverse. L'agitazione aumenta d'intensità: brividi e sussulti continui scattano dai bassi agli acuti. Un serpeggiare di accordi cromatici fra lunghe pause indica il balenare di un nuovo pensiero e lo stato di incertezza della volontà. Poi su un tema agitatissimo, balzante, che esprime in modo perfetto lo sconvolgimento e diremmo quasi il tremendo batticuore di Giulia, questa con irresistibile decisione apre il tempio a Licinio. Il richiamo fatale dell'amante sarà ricordato da Wagner nel «tema del destino » al 2° atto de La Walkiria; e non è solo questo che Wagner imparerà o assimilerà da Spontini.
Il duetto successivo anche se non raggiunge più quest'altezza, conserva una forte drammaticità. Affettuosamente animato e virile il canto di Licinio: «Avran pietà gli Dei», che alle parole: «Figlia del ciel, idolo del cor mio! arbitra te vogl'io della mia vita» si leva in uno slancio di passione che raggiunge la sublimità belliniana. Affannate sono le risposte di Giulia. Affiorano modi e disegni sconosciuti al secolo XVIII: è tutto un linguaggio espressivo nuovo che si affaccia e palpita in quast'opera, e specialmente in quest'atto, e che apre veramente la via al linguaggio ottocentesco che di lì a poco Rossini e Bellini perfezioneranno e amplieranno, e Verdi porterà all'espressione tragica più profonda. Si passa dal recitativo quasi secco, all'arioso, da questo al recitativo strumentato; accenti lirici appassionati si alternano con accenti drammatici; frasi pensose in movimento lento passano tra dialoghi concitati; i tempi mutano con estrema frequenza e prontezza; l'orchestra è sempre eloquente, percorsa da disegni originali, ispirati a un senso di agitazione affannosa. Una verità drammatica, superiore a quella espressa da Gluck, si fa strada in queste pagine e spalanca orizzonti nuovi.
L'invocazione di Giulia «O Nume tutelar» è un'altra pagina di bellissima purezza melodica e di patetica espressività. Il finale, su un turbinoso movimento orchestrale, è di una drammaticità irruente e fa pensare a qualche finale di Verdi. L'influsso dell'arte settecentista, alla quale Spontini pure soggiacque nelle prime sue opere, qui è completamente dimenticata e superata.
Nel 3° atto ci troviamo di fronte a non minori bellezze, ancor oggi vive e ammirevoli. Ecco, anzitutto, il preludio, dapprima funereo poi violentemente agitato, che descrive il «campo scellelerato», e che si fonde col disperato monologo di Licinio, precursore in tal momento dell'Edgardo donizettiano. Lo stile è anche qui ormai quello che sarà usato fino verso la metà dell'ottocento, quello che lo stesso Spontini approfondirà e consoliderà, anche se con minor ala, nelle opere successive, specialmente nel Fernando Cortesi e nella stupenda sinfonia dell'Olimpia.
Poi viene la «Marcia funebre» in cui i gemiti e gli accenti rotti del coro e dell'orchestra esprimono una mestizia tanto profonda quanto solenne. E poichè accenniamo ai cori, aggiungiamo che in quest'opera essi hanno una parte importante e di primo piano. Intervengono con la loro voce potente o sommessa nei momenti più significativi del dramma, con movimenti spesso densi di polifonia, e con vigore sconosciuto ai compositori del secolo precedente. Anche per questo lo Spontini merita il titolo di fondatore del linguaggio ottocentesco.
Un gioiello di tenerezza sospirosa è pure il duettino tra Giulia e la Gran Vestale. Dopo l'impetuoso temporale in cui ruggono i bassi e sibilano le scale cromatiche discendenti dei violini, il sereno è portato dal ricomparire, in orchestra soltanto, dell' «Inno della sera» che apre il 2° atto. La delicatezza crepuscolare di questa melodia e la violenza della scena precedente creano un constrato da pastorale beethoveniana. E non è questa la sola volta che Beethoven viene a mente, poichè ci sono atteggiamenti drammatici, movimenti orchestrali e disegni vocali che spesso ne richiamano alla memoria il respiro austero.
Dopo di che Spontini ebbe torto di musicare e di far eseguire un finale con danze e cori di ispirazione e fattura piuttosto fiacche e scipite; ed aveva ragione Wagner che voleva sopprimerlo nell'esecuzione che della Vestale si fece nel 1844 a Dresda, diretta dall'autore.
GIOACCHINO ROSSINI (Pesaro 1792 - Passy [Parigi] 1868). - L'ITALIANA IN ALGERI: dramma giocoso in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro S. Benedetto a Venezia il 22 maggio 1813. Libretto di Angelo Anelli.
Atto 1° - Quadro 1° - Piccola sala comune agli appartamenti del Bey e a quelli di sua moglie. - Elvira, la moglie del Bey Mustafà, lamenta che il marito voglia ripudiarla, invano consolata dalla schiava Zulma e dagli Eunuchi; ma Mustafà le conferma che non vuol più saperne di lei; vuol darla in moglie al suo schiavo italiano Lindoro. Inoltre dà ordine al Capitano dei Corsari Haly di trovargli una moglie italiana. Lindoro sospira il giorno in cui potrà tornare in Italia, ove ha lasciato una donna che ama, e invano cerca di convincere Mustafà a non dargli moglie.
Quadro 2° - Spiaggia di mare. In distanza un vascello infranto ad uno scoglio contro il quale lo spinse la burrasca. - I corsari hanno fatto bottino; fra gli schiavi presi c'è una bellissima italiana. Isabella, e un suo compagno, Taddeo, innamorato di lei. Isabella s'era posta in mare per ricercare il suo fidanzato Lindoro, del quale non aveva più notizie da quando era partito molti mesi prima dall'Italia. Ora ella suggerisce a Taddeo di dire che le è zio.
Quadro 3° - Sala magnifica. - Isabella vien condotta innanzi a Mustafà che ne è incantato, ma Isabella pensa già a menarlo pel naso. Entra Lindoro e i due amanti si riconoscono. Intanto Isabella, avendo saputo che il Bey ha ripudiato la moglie e vuol darla in isposa a Lindoro, lo rimprovera indignata e fra lo sbalordimento generale gli ordina di tenersi Elvira e dichiara proprio schiavo Lindoro.
Atto 2° - Quadro 1° - Sala come al 1° atto. - Lindoro e Isabella si accordano per fuggire insieme. Frattanto Mustafà per ingraziarsi Isabella nomina Kaimakan Taddeo.
Quadro 2° - Appartamento sontuoso a pian terreno con loggia in vista del mare. - Isabella si abbiglia per ricevere il Bey. Questi vorrebbe restar solo con lei e sternuta più volte (segnale convenuto affinchè Taddeo si allontani). Ma Taddeo fa il sordo, e Isabella chiama anzi Elvira a prendere il caffè con loro, a nome di Mustafà. Questi si arrabbia di ciò e se ne va.
Quadro 3° - Sala come al 1° quadro. - Lindoro comunica a Mustafà che la bella Italiana per ricambiargli l'onore fatto a suo zio Taddeo nominandolo Kaimakan, lo insignisce del titolo di Pappataci. E gli vien spiegato che l'onorificenza di Pappataci importa l'obbligo di mangiare, bere, dormire e tacere. Mustafà ne è beato.
Quadro 4° - Appartamento sontuoso come al 2° quadro. - Isabella porta con sè tutti gli schiavi italiani, che vuol liberare, e s'accinge a ordire l'ultima beffa al Bey. A costui vien detto che si prepara la cerimonia per insignirlo del grado di Pappataci. Intanto Taddeo gli fa giurare di osservare le norme della cerimonia:
«Di vedere e non veder,
«di sentir e non sentir
«per mangiare e per goder
«di lasciare fare e dir
«io qui giuro e poi scongiuro
«Pappataci Mustafà.
E Mustafà ripete e giura. Indi si pone a tavola con Taddeo. Isabella abbraccia in sua presenza Lindoro. Il Bey fa per levarsi, ma Taddeo gli ricorda il giuramento, ed egli si ripone a sedere e mangia. Si accosta quindi alla loggia un vascello sul quale Isabella, Lindoro e gli schiavi Italiani salgono. Taddeo si accorge allora di essere stato egli pure burlato; sollecita energicamente il Bey ad intervenire, ma questi, fedelissimo ormai al giuramento, non se ne cura; e la nave parte. Quando finalmente s'avvede del tiro giocatogli, è troppo tardi. Egli si rivolge pentito ad Elvira protestando che le resterà fedele, e dichiara: «Non più italiane».
L'Italiana in Algeri è la decima opera di Rossini; se con le precedenti si era acquistata larga fama, con questa la fama si consolida in modo definitivo. Il carattere di Mustafà può sembrare estremamente balordo, e tutta la trama inverosimilmente assurda, ma occorre tener presente che, dato il temperamento di Rossini, più la burla era enorme e paradossale, più il suo spirito si sentiva eccitato. La musica di quest'opera è folle come il soggetto: una follia geniale in cui dove più gli avvenimenti diventano sesquipedali, più la fantasia del compositore si solleva a volo, dando all'irrealtà materiale il crisma di una realtà superiore nella sfera dell'arte. La risata musicale di certe scene è così matta e rumorosa da far tremare il teatro; è di un'esuberanza travolgente; al suo contatto il reale e il falso non si distinguono più, ma si trasfigurano entrambi in una gioia che varca il tempo e lo spazio. «Chi non ride - scrive il Bacchelli - e resta freddo e riservato, sarà una seria e degnissima persona, ma da compiangere».
Il nucleo della farsa si concentra intorno a due caratteri: la babbuaggine di Mustafà e la furberia di Isabella. Mustafà, tronfio, goffo, fatuo e stupido, tutto carname sensuale e niente cervello, è il bersaglio principale delle più grasse risate musicali di Rossini. Gorgheggi da vanesio, tanto più comici in una voce di basso che sembra la più buffa caricatura dell'usignolo in amore, servono di presentazione. I modi burberi o svenevoli trovano nella musica aderenza piena negli accenti vocali e nei commenti ridarelli o addirittura ridanciani dell'orchestra. La stupidità piramidale emerge specialmente nel meraviglioso terzetto del 2° atto: «Pappataci! che mai sento!» dove i tre personaggi di Mustafà, Taddeo e Lindoro, così ben caratterizzati, alternano o fondono i loro canti con volubile e giocondissima allegria. L'altro momento culminante che completa la personalità beotissima del Bey è la scena finale dell'opera, con quelle scalette ironizzanti dei violini, ora rapidamente ascendenti ora discendenti, e la placida calma dell'eroe Pappataci mentre si compie la beffa che ha già allarmato il povero Taddeo.
Il coro fa eco a tanta dabbenaggine cantando su un ritmo eroico e marziale: «Viva, viva il flagel delle donne». Il coro nell'opera non ha molto da fare, ed è più che altro una variante riempitiva, ma in questo momento la sua funzione ironica diviene colossale, specie per le frequenti ripetizioni del nome «Mustafà» marcato in modo così grottescamente solenne.
Isabella è la più prossima parente di Rosina, ed anche più astuta della pupilla di Don Bartolo, ed è una lontana discendente della Serpina pergolesiana. Rossini si era già provato in un carattere simile nello stesso anno scrivendo la parte di Sofia nel Signor Bruschino. Subito appena caduta in mano dei Corsari, Isabella canta quel «Già so per pratica qual sia l'effetto» che è tutto un programma musicale di future mariuolerie. E così agile, mobile, furbesca, si mantiene in tutta l'opera, salvo nell'aria «Per lui che adoro», destinata col suo finto sentimentalismo a trarre vieppiù in inganno Mustafà. I suoi atteggiamenti più energici e il finto furore (sfuriate di gorgheggi e cicloni di terzine nel finale 1°) sono invece destinati a domare lo stolto Bey . Manco a dirlo, i modi dell'Italiana dànno origine a uno di quegli stati di confusione generale su cui si impernia il finale del 1° atto. Le tre donne sentono nella testa un campanello che fa din din, Lindoro e Haly odono un martello che fa tac ta, Taddeo una cornacchia che fa cra cra, Mustafà un cannone che fa bum bum. Ma dall'alternanza e dalla sovrapposizione di questi monosillabi Rossini ricava una babele musicale che il crescendo ingigantisce e fa proiettare come un'enorme allegra girandola pirotecnica.
Lindoro è il consueto tenore di grazia, al quale Rossini ha affidata una delle più languide e felici sue romanze d'amore:«Languir per una bella», preceduta da un preludio patetico del corno. Il pavido Taddeo è il consueto «buffo», ma la sua figura, appunto perchè non nuova nel teatro musicale, ha stimolato l'estro di Rossini meno che non gli altri due personaggi principali che rappresentavano una novità. Elvira pigola, povero uccello smarrito, tutta compresa del suo amore fedele per quel grosso babbuino di Mustafà. Scolorita è invece la figura di Haly.
C'è poi l'orchestra che ormai giuoca insieme ai cantanti una parte di primo piano, con ogni sorta di lazzi, di piroette, di sberleffi, di tiri umoristici, di sonorità chiassose, di motivetti spassosi, di ironie argute, a getto continuo e instancabile, con una originalità di ideazione, un calore fantastico, una briosità estrosa, quale la storia dell'opera buffa non aveva mai conosciuto. Il Matrimonio segreto di Cimarosa, 77 Barbiere di Siviglia di Paisiello, appaiono appena delle opere comiche: l'opera buffa, accennata già da Rossini specialmente ne La cambiale di matrimonio e nel Signor Bruschino, nasce veramente ora con L'Italiana in Algeri.
L'orchestra di Rossini è tutta un fermentare di trovate burlesche: corni che gorgheggiano; violini che saltellano, trillano, cantano, volano; flauti che ridono; fagotti che sbofonchiano;trombe e tromboni che sghignazzano; clarinetti e oboi che gettano note di malinconia o cachinni sarcastici: tutto serve per ridere in maniera clamorosa. E la prima stupenda risata è nella sinfonia che, dopo la introduzione patetica, scatta improvvisa e beffarda con giuochi strumentali parodistici scintillanti, con fresche oasi canore, e con un fervore gioioso che, secondo un sistema caro a Rossini, raggiunge la più esilarante ebbrezza nel triplice «crescendo» che prese appunto il nome di crescendo rossiniano.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA: melodramma buffo in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Argentina in Roma il 5 febbraio 1816. Libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima di Beaumarchais.
Atto 1° - Quadro 1° - Piazza in Siviglia: da un lato la casa del dottor Bartolo. - Il Conte d'Almaviva, accompagnato da suonatori di chitarra, canta una serenata a Rosina, pupilla del Dottore. Dopo la serenata, Almaviva paga lautamente i suonatori, ma costoro per ringraziarlo della sua munificenza fanno un chiasso tale che Almaviva è costretto a cacciarli. Giunge Figaro cantando, ed è riconosciuto dal Conte, il quale gli dice di essere innamorato di Rosina. Figaro allora gli narra che egli è barbiere e speziale in casa del Dottore, e aggiunge che questi vuole sposare oggi stesso la pupilla. Rosina intanto si è affacciata e ha lasciato cadere un biglietto, nel quale chiede al suo amatore di dirle cantando il suo nome. Il Conte allora canta una romanza in cui dichiara di essere uno studente di nome Lindoro; ma la canzone è bruscamente interrotta dall'intervento di Don Bartolo che fa chiudere la finestra. Ora Almaviva domanda a Figaro di introdurlo nella casa del Dottore per parlare a Rosina. Figaro gli consiglia di travestirsi da soldato e di fingersi ubbriaco;egli penserà al resto.
Quadro 2° - Camera in casa di Don Bartolo. - Rosina, decisa a far trionfare il suo amore per il creduto Lindoro è pronta a far « giocare cento trappole», e prepara un biglietto che affida a Figaro per lui. Don Basilio, maestro di musica di Rosina, viene poi ad avvertire Don Bartolo che è giunto a Siviglia il Conte d'Almaviva, segreto amante di Rosina, e gli consiglia di spargere contro di lui calunnie; ma Don Bartolo risponde che preferisce affrettare le proprie nozze con la pupilla. Figaro, ch'era nascosto, ha udito tutto, ed ora ne avvisa Rosina. Ritorna Don Bartolo e da vari indizi sospetta che Rosina abbia scritto una lettera; brontola e tempesta per sapere a chi ha scritto, ma Rosina nega. Giunge intanto il Conte travestito da soldato e fingendosi ubbriaco. Chiede alloggio a Don Bartolo; questi gli presenta un brevetto d'esenzione, ma il Conte glielo butta all'aria. Ciò provoca un putiferio tale che interviene la polizia; ma al capo di essa il Conte si dà a conoscere ricevendone segni di alto rispetto. Al colpo inaspettato Don Bartolo rimane come di stucco; poi chiede spiegazioni che gli son rifiutate, cosicchè ne nasce una gran confusione.
Atto 2° - Quadro 1° - Camera ad uso di studio con pianoforte in casa di Don Bartolo. - Una nuova visita: Don Alonso (e sempre il Conte travestito) viene per dar lezione a Rosina in luogo di Don Basilio, che dice ammalato. Per vincere la diffidenza di Don Bartolo, il Conte gli mostra il biglietto scrittogli da Rosina e inventa una frottola qualunque che persuade il Dottore a chiamare la pupilla. Appena giunta, essa riconosce nel finto D. Alonso il suo Lindoro, e subito incomincia la lezione. Intanto Figaro viene per far la barba a Don Bartolo. Fattosi consegnare le chiavi per andare a prendere l'occorrente, rovescia delle terraglie. Al fracasso Don Bartolo accorre; ne approfitta il Conte che vorrebbe spiegare a Rosina l'incidente del biglietto, ma non fa in tempo perchè Don Bartolo e Figaro tornano subito. Mentre Figaro si prepara a radere Don Bartolo ecco giungere Don Basilio. Prontamente il Conte persuade Don Bartolo a man-
darlo via affinchè non guasti il piano ch'egli dice di star ordendo contro il Conte per mezzo del biglietto di Rosina. E tutti d'accordo trattano Don Basilio da ammalato e lo mandano a casa. Questi esce, non senza aver prima nascostamente ricevuta una borsa dal Conte. Figaro riprende il suo lavoro, ma don Bartolo udendo Rosina e Don Alonso parlare sottovoce si avvicina a loro di soppiatto e scopre l'inganno: strepito infernale.
Quadro 2° - La stessa scena. - La vecchia serva Berta deride questa casa di matti. È certo effetto d'amore; poverina, anch'essa ne sente il prurito! Don Basilio entra poi con Don Borialo e gli dice che Don Alonso era il Conte medesimo. Don Bartolo allarmato lo incarica di condurre un notaio affinchè in serata egli possa sposare Rosina. Consegna poi a Rosina il biglietto datogli da Don Alonso, cosicchè Rosina finisce per credere che Lindoro sia un emissario del Conte incaricato di venderla a lui. Nel colmo del dispetto chiede a Don Bartolo di sposarla e lo avverte che fra poco Lindoro verrà per rapirla. Don Bartolo esce in cerca della polizia mentre Rosina si ritira nelle sue stanze. Si scatena un temporale, verso la fine del quale Figaro e il Conte entrano da una finestra. Rosina respinge indignata il Conte; ma allorchè questi ne conosce la causa le si rivela apertamente per Almaviva. Ora i due amanti felici si scambiano languide parole d'amore; ma non c'e tempo per ciò. Figaro avverte che è stata portata via la scala dal balcone ed ha visto da basso due persone. Quand'ecco giungere Don Basilio col Notaio. Il Conte ne approfitta per fargli stendere il contratto di nozze con Rosina. Un'altra borsa e la minaccia di una pistola persuadono Don Basilio a firmare come testimonio, insieme a Figaro. Quando Bartolo giunge con la polizia è troppo tardi, e vedendosi innanzi il Conte in persona si rassegna.
È questa la più perfetta opera buffa che sia stata scritta. Il protagonista ci è rappresentato fin dal suo primo apparire con una forza espressiva che lo scolpisce profondamente in ogni aspetto della sua psicologia: uomo gaio, «pronto a far tutto la notte e il giorno», anche il mediatore amoroso, gaudente, chiacchierone, avido di guadagno, furbacchione matricolato, confidenziale anche con i grandi di Spagna com'è il Conte d'Almaviva, gran fanfarone ma di ottimo cuore.
La sua presentazione musicale chiassosa e piena di vulcanica vivacità è da sola un capolavoro, e la larga frase così piena di sensuale soddisfazione «Ah che bel vivere, che bel piacere» ha l'impeto e lo spirito di una incomparabile sincerità. Il fervore dinamico del suo estro scatta «all'idea di quel metallo» in un fuoco d'artificio di gorgheggi, e scoppia di gioia entusiasta allorchè, ammirato del proprio genio, esclama: «che invenzione prelibata», ripetendo più volte come fuor di sè: «bella, bella, bella, bella, bella bella in verità!». Il chiacchierone interminabile salta fuori specialmente là dove Figaro dà al Conte il proprio indirizzo: «Numero quindici a mano manca». Tutto è cantato su una nota sola: il cosiddetto «parlato» di cui Rossini fu un uso frequente e comicissimo, mentre l'orchestra commenta con un motivo di un'effervescente gaiezza, seguìto da un ebbro «crescendo». Il furbo ritorna ad affiorare nella scena con Rosina, ma qui ha trovato chi è più furbo e fino di lui!; il faccendiere, praticamente padrone di casa, appare nelle scene con Don Bartolo. Tutto ciò sempre tra un recitativo e un arioso, tra una frasetta arguta e un cantabile, con una naturalezza perfetta e una vivacità esuberante di salute e di giocondità che straripa da ogni nota, tanto sua quanto degli istrumenti che ne commentano il canto. Ma c'è anche una scena, l'ultima dell'opera, ove Rossini ci svela il lato finemente malizioso di Figaro, là dove questi rifà il verso ai due innamorati, ormai sposi, e il Figaro moraleggiante con bonaria fatuità, che chiude gaiamente la commedia e «smorza la lanterna».
Rosina, sorella maggiore di Sofia e di Isabella, scopre le sue unghiette di micina nella cavatina fintamente mansueta ma piena di vispi arabeschi vocali, solo in apparenza fatui e spensierati. Essa si diverte al proprio giuoco e ne gode tutta la voluttà. Nella scena con Figaro dispiega un brio indiavolato, e quando gorgheggia «Ah tu solo, amor, tu sei che mi devi consolar» nel canto passa un'onda di fresca felicità quasi fanciulllesca. Ma non è una ingenua, e Figaro deve arrendersi alla furberia di questa «volpe sopraffina». È un trillante augelletto, pronto a trasformarsi in una piccola viperetta, ora astuta, ora briosa, e tale si conserva per tutta l'opera; solo un po' sentimentale nelle ultime scene allorchè è sicura del proprio trionfo.
Accanto a Rosina è Don Bartolo, che la musica mantiene in un brontolio continuo da vecchio bisbetico e sospettoso, con grande coerenza stilistica. Egli raggiunge i più tipici momenti oltre che nelle scene col Conte travestito, principalmente nell'aria «A un dottor della mia sorte» che fonde la boria all'irritazione e alla ironia con passaggi pieni di spiritoso umorismo. Purtroppo talvolta questa stupenda aria viene sostituita, per uno stolido capriccio di cantanti, che usavano far questo ancora vivente Rossini, e che ancora per deplorevole consuetudine si ripete, con un'aria di Pietro Romani («Manca un foglio») piuttosto settecentescamente melensa (per quanto il Romani sia contemporaneo del Pesarese).
Al gesuita ipocrita Don Basilio basta pure un'aria sola, quella della «Calunnia», per rivelare attraverso subdoli melismi e un travolgente «crescendo» la potenza della sua arma preferita. Perfino una figuretta di ultimo piano come la serva Berta, riceve dall'arietta arzilla «Il vecchiotto cerca moglie» il suo caricaturale profilo di vecchia ringalluzzita e compassionevolmente grottesca.
Almaviva, salvo nelle scene in cui imita con arguzia caricaturale il soldato bravaccio e ubbriaco e il prete untuoso, è sempre il consueto tenore di grazia delle opere comico-sentimentali settecentesche, con due belle arie fiorite di soavi e leggiadri melismi (la serenata «Ecco ridente in cielo», e la dichiarazione «Se volete sapere il mio nome») e con molli altri passi sentimentali e melismatici sparsi dovunque. Spigliato diventa solo nel dialogo con Figaro, in cui per altro si limita a chiedere e ad approvare con fervido entusiasmo o a giubilare con lo scorrevole e limpido canto «Ah che d'amore la fiamma io sento», dove i melismi stessi diventano melodia. A proposito di questo e di altri duetti, viene fatto di segnalare come Rossini, con sistema nuovissimo, che però è uno sviluppo di una maniera mozartiana, fonde canti e recitativi, accompagnamenti e commenti strumentali con una sciolta fluidità mai prima, nonchè vista, sospettata.
Numerosi sono poi i tratti umoristici e satirici sparsi dappertutto. Subito nel 1° atto abbiamo, nel coro dei suonatori che ringraziano Almaviva, la satira dei seccatori importuni che non la smettono mai; e alla fine dell'atto medesimo, nei modi burberi di cantare, la satira della polizia. Sono questi gli unici due momenti in cui il coro ha parte. Satira dei complimenti interminabili e noiosissimi sono tanto i « Pace e gioia» insistenti di Don Alonso, che i reiterati «Buona sera» di Don Basilio e degli altri personaggi. E c'è anche, diremmo, la satira dell'opera buffa nel terzetto «Zitti zitti, piano piano» che prolunga una situazione statica in contrasto col «presto andiamo via di qua» proclamato da Figaro Almaviva e Rosina. E ricordiano infine la colossale satira di coloro che, per spiegare ad alcuno una cosa parlano tutti insieme, nella scena in cui Don Bartolo e gli altri vogliono spiegare all'Ufficiale della polizia l'insolente contegno del soldato. Iniziando con le parole di Bartolo «Quella bestia di soldato» Rossini costruisce una delle sue più babeliche architetture sonore in un ritmo pettegolo vivacissimo, in cui fa da bordone un insistente ripetuto sol di Don Basilio. Per colmo di ironia l'Ufficiale risponde flemmatico «Ho inteso!». Ma in fatto di concertati babelici questo non è il solo; e successivamente, dopo il «Freddo ed immobile» in forma di «falso cànone», tutto sottovoce, cui sovrasta il fragoroso grido di Figaro «Guarda Don Bartolo, sembra una statua», ecco il turbinoso «Mi par d'esser con la testa in un'orrida fucina», in cui voci e orchestra fanno dell'impressionismo sonoro, non imitando ma rievocando il mulinello delle macchine e lo stridore dei meccanismi: «Fonderie d'acciaio» avanti lettera, ma con minore verismo. Analogo, ma meno turbinoso, è l'altro concertato «La testa vi gira, ma zitto, Dottore» allorchè Don Bartolo scopre l'inganno del falso Don Alonso.
Non solo nei concertati, ma anche nelle arie e nei pezzi a più voci l'orchestra assume un'importanza commentatrice pittorica la quale non è che lo sviluppo dell'orchestra mozartiana, però con uno spirito umoristico e contrasti di tinte frequenti e rapidi quali Mozart non usò mai. La sinfonia, trasportata nel Barbiere dall'Elisabetta regina d'Inghilterra, che a sua volta l'aveva ricevuta dall'Aureliano in Palmira, sembra nata ad un parto col Barbiere. Dalla solenne apertura, attraverso a motivi patetici dell'oboe e dei violini si giunge a un «Allegro» che dal tema riceve un'espressione non priva di una certa malinconia poetica, per esplodere in gioia rumorosa nel «crescendo». Essa è un efficace preambolo a questa commedia, e sembra schiuderci il velo su l'intima tristezza che è sempre al fondo della vita anche quando essa appare spensieratamente gaia.
Un episodio orchestrale bellissimo è il temporale del 2° atto: niente di pauroso e di drammatico, soltanto un grosso acquazzone estivo con un po' di vento e di elettricità, quanto basta per dare una nota più romantica al progettato ratto di Rosina. Una pagina evocativa rapida e succosa.
Com'è noto l'opera cadde clamorosamente la prima sera, soprattutto perchè si era formato un partito paisiellano il quale considerava l'audacia del giovane compositore (Rossini quando scrisse il Barbiere aveva appena ventiquattro anni!) nel musicare lo stesso soggetto usato dal Tarantino come una mancanza di riguardo a quest'ultimo. Ma l'opera di Rossini si lasciava a gran distanza quella di Paisiello; e alla seconda rappresentazione andò alle stelle!
LA CENERENTOLA: melodramma giocoso in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Valle di Roma il 25 gennaio 1817. Jacopo Ferretti ne trasse il libretto con molta libertà e numerose modificazioni dalla nota fiaba di Carlo Perrault.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala nel Castello del Barone Don Magnifico. - Angelina detta Cenerentola, figliastra di Don Magnifico, canta mestamente accanto al focolare mentre le sorellastre Clorinda e Tisbe stanno pavoneggiandosi; quando entra Alidoro, precettore del principe Don Ramiro, travestitosi da mendicante. Egli chiede la carità: Tisbe e Clorinda lo scacciano, ma Cenerentola gli versa una tazza di caffè e gli offre del pane. Le due sorelle rimproverano e percuotono Cenerentola, ma Alidore la difende e le dice che prima di sera il Cielo la ricompenserà. Giungono poi dei Cavalieri i quali invitano le ragazze a un ballo di Corte durante il quale il principe si sceglierà la sposa. Tisbe e Clorinda informano dell'avvenimento il padre e corrono nelle loro stanze a prepararsi. Dalla porta rimasta aperta entra il Principe travestito da scudiero: si incontra a caso con Cenerentola, e subito s'accende fra i due una viva simpatia. Viene poi Don Magnifico, al quale il finto scudiero annunzia che presto il Principe in persona verrà a prendere lui e le figlie per condurli alla festa; ed ecco infatti che arriva, travestito da Principe, il suo cameriere, Dandini. Tisbe, Clorinda e Don Magnifico si affrettano a fargli onore, mentre egli finge di essere affascinato dalla grazia delle ragazze. Invano Cenerentola prega il padrigno di condurre a Corte anche lei; questi la respinge sgarbatamente. Sopraggiunge Alidoro, non più in vesti da mendico, il quale afferma che le sorelle sono tre, ma Don Magnifico risponde che una morì. Quando tutti sono partiti. Alidoro conduce con sè Cenerentola dicendole che le darà abiti e gemme e carrozza per andare a Corte.
Quadro 2° - Gabinetto nel palazzo di Don Ramiro. - Dandini, sempre travestito da Principe, nomina Don Magnifico suo Gran Cantiniere. Tisbe e Clorinda si fanno in quattro per piacergli dicendo male l'una dell'altra.
Quadro 3° - Salotto nel palazzo del Principe. - Don Ramiro chiede informazioni su le figlie di Don Magnifico a Dandini, ma questi gli risponde che sono «un misto di insolenza di capricci e vanità». Intanto è annunziato l'arrivo a Corte di uma bella incognita:è Cenerentola riccamente abbigliata. Don Magnifico, le figlie e lo stesso Don Ramiro rimangono confusi e stupiti per la somiglianza con Angelina.
Atto 2° - Quadro 1° - Gabinetto come al quadro 2° dell'atto precedente. - Don Magnifico e le figlie commentano la somiglianza dell'incognita con Cenerentola, ma restano persuasi che non può essere lei. Tisbe e Clorinda narrano poi con enfasi i loro successi presso il Principe, e ciascuna di esse si dice sicura di sposarlo. Intanto Cenerentola, seccata della corte che le fa il finto Principe, gli dice sinceramente ch'essa ama il suo scudiere. Chiede poi a Don Ramiro di lasciarla partire senza seguirla e gli consegna per riconoscimento uno dei suoi braccialetti. Partita Cenerentola, Don Magnifico viene a chiedere al presunto Principe si sollecitare la scelta della sposa, ma questi gli svela di non essere il Principe ma solo il suo cameriere. Don Magnifico, vedendosi burlato, va in furia e dichiara che chiederà conto della beffa al vero Principe.
Quadro 2° - Sala in casa di Don Magnifico, come al 1° quadro del 1° atto. - Cenerentola è presso il focolare, vestita dei suoi stracci. Ritornano Don Magnifico e le figlie, ancora stralunati per la somiglianza di Cenerentola con l'ignota e per il tiro di Dandini. Intanto fuori si scatena un temporale. Dandini e Don Ramiro entrano per ripararsi dalla pioggia, ma Don Ramiro vede al polso di Cenerentola l'altro braccialetto e la riconosce. Don Magnifico e le figlie dopo un momento di stupore si scagliano contro Cenerentola; sdegnato il Principe la dichiara sua sposa e la conduce seco. Alidoro consiglia Don Magnifico e le figlie di recarsi a Corte a chiedere perdono.
Quadro 3° - Sala del trono. - Cenerentola, in abito sfarzoso, accanto al Principe, è felice e commossa per l'improvviso cambiamento del suo stato. Don Magnifico e le figlie si prostrano al Principe implorando perdono. Intercede per loro Cenerentola, e il perdono è accordato.
Ogni elemento fiabesco è stato volutamente omesso dal librettista, d'accordo col musicista, temendo ch'esso non fosse bene accetto al pubblico romano, ed anche per quel senso realistico che domina tutta l'arte di Rossini. Anche così la commedia è piacevole, specie per gli equivoci cui danno luogo i travestimenti del Principe e di Dandini. Una delle scene più belle, infatti, per gli elementi comici che ne nascono è quella del 2° atto in cui Dandini svela il vero essere suo a Don Magnifico. La musica si fa scorrevole e spiritosa, passa dal fastoso all'ironico e scanzonato; il canto si riduce a un «parlato» su una nota sola mentre i violini ridono della burla riuscita; fino a che si scatena l'ira buffa e impotente di Don Magnifico con una variante allegrissima del motivo d'apertura con cui Dandini avvertiva misteriosamente il Barone di avere da comunicargli «un segreto d'importanza». E questa metamorfosi musicale dà ancor più gusto alla scena. Dandini, anche nelle scene con Tisbe e Clorinda, come in quelle col Principe, è la figura meglio scolpita. In lui passa un riflesso bonario della ciarlataneria di Figaro.
Pettegole, litigiose, invidiose ed ambiziose, Tisbe e Clorinda sono pure vivacemente schizzate dall'arte rossiniana, la quale continua a dare la medesima importanza al canto e all'orchestra; anzi talvolta, come nei «parlati», all'orchestra più che al canto. Orchestra, come nel Barbiere e nell'Italiana in Algeri, sempre doviziosa di trapassi e di contrasti timbrici ora comici ora sentimentali. Un gioiello di brio e di leggerezza è, in tal senso, la sinfonia, che Rossini trasportò in quest'opera da La Gazzetta, opera ch'egli sentiva ben morta, benché recentissima. Lo schema è sempre il consueto: un'introduzione maestosa con qualche accento patetico, cui segue un Allegro pieno di una forza ritmica sbalorditiva, dove però presentano un alto interesse anche i giuochi burlevoli di proposte e risposte rapidamente palleggiate tra flauto e violini o tra flauto e fagotti, che conducono al consueto «crescendo» di immancabile effetto trascinante.
Don Magnifico è un po' come tutti i bassi comici delle opere buffe, e risente dello stile settecentesco. Egli, infatti, non è che una figliazione diretta del Geronimo cimarosiano, con delle tinte più caricate e una più ricca effervescenza ritmica. Don Ramiro è pure il tenore di grazia consueto; ma nella scena con Cenerentola al 1° atto, il delicato fascino che si stabilisce, misterioso e subitaneo, fra i due giovani, ha toccato il cuore sensibile e giovanile di Rossini dettandogli pagine piene di sentimento e di poesia. Anche di Angelina, Rossini coglie in questa scena la vera intimità di fanciulla dall'anima profondamente buona e affettuosa; mentre la canzone che essa intona presso il focolare, «Una volta c'era un re», la circonda di un velo di malinconia. Questo carattere malinconico e l'intenso e naturale desiderio di godere, come le sorellastre, un po' di svago, si fondono in un'espressione che ci è ancora rivelata nella passione con cui ella domanda al padrigno di essere portata «in casa di quel principe». In altri momenti, come quando si presenta a Corte, i vocalizzi che nell'intenzione di Rossini dovrebbero creare attorno a lei un'aureola di radiosa superiorità regale, non mancano di qualche intonazione rettorica che ne diminuisce un po' il prestigio. L'ultimo rondò, «Non più mesta accanto al fuoco », Rossini lo portò qui dal finale del Barbiere di Siviglia, dove in verità era superfluo.
È un pezzo di bravura che rientra nelle consuetudini teatrali del primo ottocento; però, balzante di gioia com'è, non disdice nel momento della felice conclusione degli affanni di Angelina. Paganini se ne servì per creare un pezzo di bravura violinistico su la 4a corda.
I cori non hanno alcuna importanza, e servono solo a portare qualche varietà interrompendo la serie delle arie e dei pezzi d'assieme, o fondendosi in essi. Il temporalino del 2° atto è un po' più vario di quello del Barbiere ma non più minaccioso, e termina invece con un senso di pace pastorale poeticissima su un lungo calmo pedale del basso, e con una vaga espressione beethoveniana.
La fretta con cui l'opera dovette essere condotta a termine costrinse Rossini ad affidare al Maestro Luca Agolini un'aria di Alidoro nel 1° atto, ed una di Clorinda nel 2°: ne sono uscite due pagine assai modeste, in cui l'Agolini si è sforzato di imitare il Pesarese restandone troppo al di sotto. Ma sono due arie di nessuna importanza per lo svolgimento dell'azione, e che si possono togliere con sicuro vantaggio.
L'opera fece fiasco alla prima rappresentazione quasi come il Barbiere. Ne fu colpa l'impreparazione degli artisti, i quali avevano dovuto impararla troppo in fretta. In seguito si risollevò, ottenendo poi sempre e dovunque grandi successi.
CARLO MARIA WEBER (Eutin [Oldenburg] 1786 - Londra 1826). - DER FREISCHÜTZ (IL FRANCO CACCIATORE): opera romantica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Reale di Berlino il 18 giugno 1821. Libretto di Friedrich Kind tratto da una novella di Giovanni Augusto Apel.
Atto 1° - Piazzetta con osteria alla quale è seduto Max. - Kilian colpisce con la carabina un bersaglio, e Max viene deriso perchè non sa tirare. Gasparo consiglia a Max di recarsi nella foresta a compiervi uno scongiuro per ottenere l'aiuto del demonio. Kuno, il Guardiacaccia, lo avverte che non potrà sposare sua figlia Agata se non sarà l'indomani vincitore alla caccia. Così vuole una vecchia tradizione: la figlia del Guardiacaccia non potrà trasmettere in eredità questo grado ed ufficio a chi non sia vincitore alla caccia. Già il suo avo ebbe questo ufficio vincendo, ma una leggenda vuole che il piombo da lui usato fosse stato fuso dal Demonio. Delle palle stregate - narra la leggenda - sei vanno giuste, ma la settima è del Diavolo. Max è avvilito perchè teme di non riuscire vincitore e di perdere la sposa. Il Demonio Samiel compare e ne paralizza la volontà. Gasparo lo convince a recarsi nella foresta per avere il piombo infallibile. Gli carica il fucile con una palla incantata; con essa Max atterra un'aquila. Sempre più ossessionato. Max promette di recarsi nella foresta «alla gola del lupo». Gasparo, partito Max, dà in uno scoppio di gioia infernale.
Atto 2° - Quadro 1° - Stanza in casa di Kuno. - Agata è in attesa di Max e in pensiero per il suo ritardo. Egli giunge alfine, ma con un pretesto la lascia ben presto.
Quadro 2° - Orrido burrone in mezzo al bosco. - Si odono voci di spiriti invisibili. Suona la mezzanotte; compare Gasparo il quale chiama Samiel: «domani - egli dice - dovrò pagare il fio della mia empietà; prolunga la mia vita: ho pronta un'altra vittima». «Ebbene - risponde Samiel - domani, egli o tu». Max arriva e, aiutato da Gasparo s'accinge alla fusione del piombo incantato: due temporali s'incontrano con estrema violenza. Alla fusione della settima palla Max e Gasparo sono lanciati a terra.
Atto 3° - Quadro 1° - Stanza di Agata. - Agata, in abito di nozze, è sgomenta pei sogni orrendi fatti nella notte. L'amica Annetta deride le sue paure e la incoraggia; poi, con uno stuolo di Damigelle, s'avviano.
Quadro 2° - Parco. - Il Principe Ottokaro invita i cacciatori alla gara. Max spara a una colomba: nello stesso istante Gasparo cade colpito a morte ed Agata sviene. Il Principe vuole che Max sveli questo mistero, e Max confessa di essere stato sedotto da Gasparo che lo attirò alla «Gola del lupo». Ottokaro si adira contro di lui e lo manda in esilio; ma Kuno, Agata e i cacciatori lo difendono. Anche un eremita intercede per lui e ottiene che se fra un anno col suo rimorso avrà scontata la colpa, sia felice sposo di Agata. Il Principe acconsente. Tutti si inginocchiano ringraziando Iddio.
La creazione di un'opera nazionale germanica è ormai col Freischütz di Weber un fatto compiuto, per quanto dal lato della sensibilità melodica essa risenta ancora l'influenza del teatro italiano. L'atmosfera di leggenda che vi domina e l'elemento satanico (personificato da Samiel e da Gasparo) che determina gli avvenimenti e che culmina nella scena della fusione del piombo, in contrasto con l'azione mistica dell'Eremita che porta alla felice conclusione (e che però non ha avuto dalla musica un rilievo sufficiente), corrispondono al gusto della poesia romantica nordica, e sospingono l'ispirazione del musicista verso espressioni aderenti allo spirito dell'arte tedesca. Portato naturalmente dalla sua cultura e dal suo genio verso il fantastico, Weber trovò nel soggetto del Freischütz, al quale lavorò tre anni, quanto poteva eccitarne le facoltà creative. Prescelse inoltre la forma tutta germanica del «Singspiel», in cui il recitativo non è mai cantato. Nell'edizione italiana dell'opera, in aderenza allo spirito nostro, i recitativi furono musicati da Franco Faccio; e in quella francese con analogo intendimento, da Ettore Berlioz. In seguito anche in Germania le riproduzioni del Freischütz furono fatte con i recitativi musicati, il che ha il vantaggio di rendere meno duro e arbitrario il distacco fra recitazione e canto.
In quest'ambientazione romantica, la prima pagina superba di bellezza è la sinfonia, coi suoi ritmi tempestosamente concitati, che un'oasi di mistico fervore attraversa con il puro «a solo» di clarinetto. Formata con i motivi dell'opera che esprimono la disperazione di Max, l'infernale gioia di Gasparo, il cozzo dei temporali nell'ora della tregenda, e l'allegrezza innocente di Agata nel rivedere il fidanzato, essa ha ricevuto una tale unità e una tale perfezione formale che sembra piuttosto un poemetto sinfonico che una sinfonia d'opera.
I cori hanno un impeto e un vigore che superano quanto in fatto di cori era stato composto fino allora. Sono cori che acquistano animazione anche dai movimenti a imitazioni e dagli intrecci polifonici e contrappuntistici delle parti: cori di gente rude (cacciatori), che trovano nei disegni energici e ardenti dei motivi musicali una potente espressione. Particolarmente celebre per la sua vigoria ritmica e il fiero colorito strumentale è rimasto il coro del 3° atto «Che supera al mondo di caccia il piacer?».
Accanto alla parte corale v'è l'elemento soprannaturale diabolico, ampiamente sviluppato, specialmente nel finale del 2° atto (scena della fusione delle palle). Samiel, che avrebbe potuto diventare il motore centrale del dranma, si limita invece a comparire silenzioso di quando in quando a o dire brevi frasi puramente recitate, specialmente all'inizio dell'ultima scena del 2° atto in cui il dialogo fra Gasparo e Samiel si svolge tutto in forma di recitazione alternata a brevi commenti strumentali, quella forma che si è già vista usata da Cherubini e da Beethoven, e che i tedeschi chiamarono melodram. Ma la forza demoniaca di Samiel si manifesta attraverso a Gasparo, i cui disegni vocali sono tutti improntati a spavalderia ironica, o, come nel drammatico finale del 1° atto, a perversa diabolica gioia.
L'espressione del fantastico-diabolico raggiunge il suo culmine nel 2° quadro del 2° atto. Questo quadro, così vario di motivi e di ritmi, ha una tinta sinistra e cupa, I lamenti remoti degli Spiriti, i gemiti dei legni, i fremiti degli archi, i ritmi ansimanti, la varietà dei movimenti, la glacialità funerea e bieca delle pennellate orchestrali (eppure è la medesima orchestra di Mozart), gli accenti e l'agitazione febbrile di alcuni episodi, le voci misteriose della natura interpretata nei suoi aspetti leggendari, le macabre voci degli Spettri che insistono su una sola nota, l'eco che ripete in modo soprannaturale la voce di Gasparo che numera i proiettili fusi, lo stesso alternare canto e recitazione in una forma quasi incoerente di melodram, le strida di animali selvaggi, i crepitii del fuoco, l'ululo del vento, i rombi del tuono, i rintocchi di campane lontane, lo scoppio del temporale, tutto ciò crea un'atmosfera di orrore e di incubo, di tregenda spaventosa quale la musica non aveva ancora conosciuto. Ci troviamo di fronte a un mondo espressivo completamente nuovo e già perfettamente raggiunto.
Altre pagine vivamente sentite e fortemente espresse, rompendo anche gli stampi melodrammatici abituali per una concezione più libera e mobile, sono la scena del 1° atto allorchè Max è preso dalla disperazione e dal terrore per la forza ignota che s'impossessa di lui; la scena del 2° atto quando Agata attende il fidanzato, scena in cui all'ansia per il ritardo si alterna la casta preghiera, seguita dallo slancio di gioia al suo arrivo; e il terzetto successivo pieno di così veemente concitazione. È da notare però che spesso modi strumentali entrano nel trattamento delle voci non solo per ciò che riguarda la loro architettura polifonica e il loro allacciamento con l'orchestra, ma per il genere dei disegni a loro affidati, il che conferisce ai motivi un'espressione più astratta.
Le ultime scene dell'opera interessano per un altro aspetto, e cioè per certi accenti vocali e certe modulazioni a cui si riallaccerà il Wagner delle prime opere.
GIOACCHINO ROSSINI - MOSÈ: melodramma sacro in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro S. Carlo di Napoli il 5 marzo 1818. Libretto di Leone Tottola. - Rifatto e presentato all'Opera di Parigi il 26 marzo 1827. Il libretto della nuova versione è di Stefano de Jouy.
Atto 1° - Campo dei Madianiti. - Gli Ebrei e i Madianiti pregano Iddio che li sottragga alla dominazione del crudele Faraone. Mosè infonde loro nuova fiducia nell'aiuto divino. Il ritorno di Elisero, fratello di Mosè, con la sorella Maria e la di lei figlia Anaide, rinnovella la speranza di poter abbandonare l'Egitto e ritornare in patria. Un grande arcobaleno conferma a tutti la certezza nell'invocato aiuto del Cielo. Ma una voce misteriosa chiama Mosè affinchè vada a ricevere le leggi di Dio, e avverte il popolo che deve attendersi altre persecuzioni da Faraone. Invitati da Mosè, tutti si inginocchiano e giurano di osservare le leggi divine; poscia si compiono riti religiosi propiziatori. Il figlio di Faraone, Amenofi, che si è innamorato di Anaide, vorrebbe indurla a restare con lui, ma Anaide resiste. Amenofi, adirato, ottiene da Faraone la revoca della concessione di partire, già fatta agli Ebrei. Mosè allora fa oscurare il sole.
Atto 2° - Galleria interna nella Reggia di Faraone. - Perdura la più profonda oscurità. Gli Egiziani implorano pietà dal Dio d'Israello. Faraone fa chiamare Mosè e gli promette, di lasciar partire gli Ebrei se farà ritornare la luce. Mosè prega Jehova: la luce ritorna. Faraone comunica poi ad Amenofi di aver combinato il suo matrimonio con una principessa Egiziana. Amenofi se ne dispera e pensa di impedire nuovamente la partenza degli Ebrei.
Atto 3° - Portico del Tempio d'Iside. - Stanno svolgendosi cerimonie sacre allorchè Mosè viene a reclamare da Faraone l'osservanza della promessa. Il sacerdote Osiride vorrebbe che prima gli Ebrei si inchinassero ai Numi egiziani. Mosè rifiuta ed anzi invita Faraone a piegarsi a Jehova finchè è ancora in tempo. Agli insulti e alle minacce degli Egiziani Mosè risponde con un prodigio: tutti i fuochi si spengono. Faraone sobillato dal Sacerdote ordina che tutti gli Ebrei ritornino in schiavitù. Ma gli Ebrei decidono di seguire Mosè.
Atto 4° - Deserto in vista del Mar Rosso. - Amenofi chiede ad Anaide di abbandonare gli Ebrei e di seguirlo; egli farà liberare gli Ebrei. Benchè innamorata di lui, Anaide rifiuta: resterà con gli Ebrei, qualunque sia la loro sorte. Al colmo del furore Amenofi parte minacciando la strage di tutti gli Ebrei. Dopo avere invocato l'aiuto di Jehova, Mosè entra coi suoi nel Mar Rosso, il quale si apre per lasciarli passare. Giungono schiere di armati Egizi guidati da Faraone e da Amenofi, ma il mare si rinchiude sopra di essi e li travolge.
Nel rifare l'opera per presentarla a Parigi, Rossini dovette tener conto del diverso gusto e della diversa coltura del pubblico di una città che da Lulli in poi era divenuta il centro mondiale della musica. Questo non tanto per ragioni d'opportunità, quanto perchè egli stesso sentiva l'influenza del mutamento d'ambiente e la necessità di una più libera espressione. Da ciò non soltanto il miglioramento del libretto del buon Tòttola, ma il rifacimento di vari pezzi, l'aggiunta di nuovi, i ritocchi allo strumentale e una approfondita espressione dei recitativi. Rimangono alcune parti più deboli, che sono soprattutto quelle che riguardano l'amore di Amenofi e di Anaide. Non ostante alcune belle ispirazioni, sono queste le parti più convenzionali, perchè non offrivano alcuno stimolo nuovo alla fantasia del musicista.
Rossini sentì che il dramma vero, il dramma «sacro», si accentrava attorno a Mosè e alla sua lotta contro Faraone per la liberazione dei fratelli Ebrei. E dedicò a Mosè le maggiori cure, facendo di lui una creazione possente per vigorìa di accenti musicali. I suoi recitativi sono di un'austera e nobile bellezza, degni veramente di colui che parla e agisce in nome di Jehova. Particolarmente solenne è l'invocazione alla luce nel 2° atto: recitativo che fa già passaggio all'arioso. Alcune delle preghiere più piene di afflato religioso sono intonate per primo da Mosè. Così, nel 2° atto, dopo il ritorno della luce, la meditazione «Celeste man placata», la cui melodia passa poi in forma di «falso cànone» alle altre parti del quintetto; e la preghiera del 4° «Dal tuo stellato soglio», che unisce nella forma a cànone dei solisti l'intervento alterno del coro. Questo intervento dà al sublime cantico un èmpito lirico più forte, che si trasforma in un'onda luminosa splendente, allorchè alla fine si passa dal minore al maggiore, e pare allora che si spalanchi innanzi a noi la visione dell'Empireo e che noi siamo sollevati in alto fino ai piedi del trono divino. Questa preghiera, com'è noto, non esisteva allorchè il Mosè fu eseguito a Napoli la prima volta nel 1818, e comparve solo allorchè l'opera fu riprodotta nella quaresima dell'anno successivo.
Accanto a Mosè è il popolo che piange, impreca, prega, inneggia e spera, con le incertezze e le istintive diffidenze proprie di chi stenta a credere al miracolo per l'avvilimento in cui lo ha gettato la schiavitù, e per la piccolezza della propria mente, ma anche con gli slanci di una fede profonda ed invitta. Il coro diventa dunque in quest'opera un personaggio di primo piano, di gran lunga il più importante dopo Mosè, o meglio a fianco di Mosè. È il popolo ebraico che apre l'opera con l'impeto corale dell'«Ah! dell'empio al potere feroce tu ci togli gran Dio di bontà», espressione che ci getta di colpo in pieno dramma. Da questo primo slancio passa all'accorato «Ma chi pegno è alla speme tuttora?», accorato anche per il commento ritmico ostinato dei violini, che mentre sembra un semplice contrappunto ha invece una espressione così insistentemente dolente. È un canto che nella sua nobiltà fa presentire il Verdi del Nabucco che però non apparirà che ventiquattro anni dopo. Il canto della speranza si leva poco dopo sul ritmo di una danza leggera ed elegante alle parole «La dolce aurora che il ciel colora». Viene poi il canto di esultanza: «All'etra, al ciel, lieto Israel», in cui il coro alterna e fonde la sua voce a quella dei solisti con impeto gioioso. E non stiamo a citare tutti i casi in cui il coro interviene, poichè, avendo Rossini considerato il coro alla stregua di un vero e proprio personaggio, la sua voce si associa a quella degli altri personaggi, o le si avvicenda anche per brevi frasi o per semplici esclamazioni. È una concezione nuova del coro che spezza le vecchie forme corali chiuse per una maggiore e più mutevole mobilità di espressione, e gli dà la possibilità di partecipare con accenti concisi o con lirismo ampiamente spiegato a tutti gli avvenimenti essenziali del dramma, e anche la possibilità di rinforzare con la propria voce quella delle parti soliste molto spesso riunite in concertato, variandone la intensità espressiva con effetti di grande potenza dinamica. Questo impiego del coro e delle voci in concertato, che fa pensare talvolta all'avvicendarsi del «concertino a e del «tutti» nella forma strumentale del «Concerto grosso», inaugura anche nelle voci sulla scena una tecnica che diremo «a volumi sonori» che avrebbe meritato un più largo sviluppo.
L'orchestra (ottavino, flauto, clarinetto, 4 corni, trombe, tromboni, fagotto, serpentone, arpa, timpani e cassa, oltre al quartetto degli archi) è usata con intenti marcati di pittura, non solo per effetti di contrasti timbrici e di sonorità, ma per effetti descrittivi di cui i più importanti sono l'apparire dell'arcobaleno nel 1° atto (arpeggi ascendenti e leggeri dell'arpa), la solennità della voc di Jehova («Voce misteriosa»; accordi piani e forti degli ottoni), il ritorno della luce nel 2° atto (crescendo di tutta l'orchestra con arpeggi ascendenti dei violini), l'arrivo della cavalleria egiziana, l'aprirsi e rinchiudersi delle onde del Mar Rosso, lo sconvolgimento delle acque su l'esercito travolto, e finalmente quella luce serena, perlacea, che dal canto dei violini e dei clarinetti sorge come un'alba di promessa sul popolo Ebreo in salvo al di là del mare, e che conclude così celestialmente quest'ultima scena del poema Mosaico.
Ma la pagina descrittiva più potente è quella delle tenebre all'inizio del 2° atto. Non è solo un brano orchestrale, poichè all'espressione concorrono anche le voci dei solisti e del coro con esclamazioni, gemiti, dissonanze, accenti di terrore, a cui s'alternano grida d'implorazione, su un movimento affannoso dei violini in sordina, che creano il senso smarrito e oppressivo di un incubo atroce. Non c'è nulla di simile in tutta la storia precedente del melodramma, se non in qualche quadro dell'Israel in Egitto di Händel.
IL CONTE ORY: melodramma giocoso in 2 atti. Prima rappresentazione all'Opera di Parigi il 20 agosto 1828. Libretto di Eugenio Scribe e Delestre Poirson, i quali trassero il soggetto da una ballata popolare piccarda omonima.
Atto 1° - Un paesaggio: nel fondo il castello di Formoutier; a destra un romitaggio. - Il giovane Conte Ory, innamorato della Contessa di Formoutier, il cui fratello è partito per una Crociata, si è travestito da Eremita, ed aiutato del suo gentiluomo ed amico Roberto, procura di avvicinarla. Tutto il villaggio accorre per udire la parola del saggio Eremita. Giunge al villaggio anche l'Aio del Conte, inviato dal padre a ricercare il figliolo, fuggito da casa senza il consenso paterno. Accompagna l'Aio il paggio Isoliero, anch'egli innamorato della Contessa. Isoliero confida all'Eremita il suo amore e gli dice che, travestito da pellegrino, egli spera di poter entrare nel Castello. Ory loda la sua astuzia, ma fra sè pensa a farne tesoro per proprio conto. Anche la Contessa viene a chiedere consiglio all'Eremita su la tristezza che l'affligge. Ory la consiglia ad amare e già la Contessa si dispone ed accogliere l'affetto del Paggio, quando l'Aio riconosce il suo pupillo. Nell'esplosione di orrore e di indignazione generale, giunge un messo con un foglio per la Contessa, nel quale si annunzia il prossimo ritorno del fratello. Ma Ory si propone di vendicare lo scorno, e Isoliero che comprende il suo proposito, pensa di stare all'erta per proteggere la Contessa.
Atto 2° - Camera da letto della Contessa. - È notte. Si scatena un violento temporale, durante il quale delle Pellegrine invocano ospitalità e si dicono perseguitate dal Conte Ory. La Contessa, ancora sotto l'impressione del pericolo passato, prova pietà per esse e fa loro aprire il Castello. Una di esse chiede di poter ringraziare personalmente, la Contessa: è il Conte Ory, il quale, fatto suo il progetto del Paggio, è riuscito a penetrare nel Castello con tutti i suoi amici travestiti da Pellegrine. La Contessa dà ordine che siano rifocillate con latte e frutta, ma Roberto è riuscito a scovare del vino, e le «Pellegrine», in un momento di assenza della Contessa, si dànno a un'orgia bacchica. Tornata la Contessa, le «Pellegrine» si ritirano nelle stanze loro assegnate. Giunge il Paggio Isoliero con l'annunzio che a mezzanotte i Crociati, e con essi il fratello della Contessa, saranno di ritorno; ma udito che nel castello si sono introdotte delle Pellegrine, avverte che esse non sono che cavalieri travestiti, e che con loro è lo stesso Conte Ory. Questa notizia sgomenta la Contessa. Spento il lume, ecco appressarsi il Conte Ory, il quale spera di trovare la Contessa addormentata. Essa finge di destarsi: Ory le si avvicina, ma il Paggio si sostituisce a lei e intanto ne approfitta per baciare la mano alla Contessa, mentre lascia stringere la propria dal Conte. La situazione equivoca è interrotta da un suono di trombe che s'avvicina: sono i Crociati di ritorno. La Contessa si ritira; il Paggio si fa riconoscere dal Conte che dapprima si sdegna per l'inganno patito, ma di fronte al pericolo imminente ne accetta l'aiuto per uscire nascostamente, egli e i suoi amici, dal castello prima dell'arrivo del Conte di Formoutier.
L'allegria esuberante dell'Italiana in Algeri e del Barbiere di Siviglia fa raramente capolino nella musica del Conte Ory. Essa, pur senza aver perduto nulla della burlesca ironia di Rossini, si è fatta più fine ed elegante. In ciò, ed in ciò solo, è da riconoscere l'influenza dell'ambiente francese coi suoi gusti signorili. Il riso si è fatto sottile e garbato, la marioleria si è tinta di arguzie, e un filo di delicata e sentimentale sensualità si è infiltrato fra le pieghe di questa giocosità aristocratica e leggera. Solo nell'orgia del 2° atto, di fronte alle finte Pellegrine, le quali trincano e danzano spensieratamente, il Maestro si lascia andare a comporre un canto pieno di bacchica allegria.
Il Conte Ory ha molti dei modi rossiniani consueti ma la sua figura esce dai suoi canti con un senso di balda furberia che ce lo rende simpatico malgrado le sue imprese audacemente libertine. La sua fatuità si esprime negli agili arabeschi dei melismi vocali, in cui si avverte una specie di godimento sensoriale che forma veramente lo spirito di questo personaggio.
Ma nell'opera vi è un'altra figura disegnata pure con finezza leggiadra: quella del paggio Isoliero; figura che richiama alla mente per analogia quella del Cherubino mozartiano. Ma Cherubino è più audace e inciprignito; Isoliero è solo il giovinetto alle prime esperienze, che non cambia di colore alla vista di qualsiasi donna, come Cherubino, ma ha preso una cotta per la sua bella cugina Contessa di Formoutier. Egli sfrutta la situazione favorevole nel 3° atto, allorchè il Conte Ory travestito si introduce nella camera della Contessa, e nel buio della stanza, lasciando credere a questa di essere il Conte Ory, le stringe e porta al cuore e bacia la bella mano, mormorandole parole d'amore con un nodo di emozione alla gola. È una scena in cui la musica sorride appena dolcemente e velatamente, tutta presa nella descrizione psicologica della complessa situazione e della trepidazione dei tre cuori. Lievi tocchi di violini e flauti, qualche gorgheggio voluttuoso, dei sottili brividi, un senso di abbandono nelle frasi cantanti commosse, tutto un insieme di elementi musicali che creano un'atmosfera di mistero e di fascino tra l'umoristico e il sensuale, ricca di intima poesia malgrado la scabrosa situazione della Contessa. E tutto questo in una forma regolare perfetta, senza smancerie, senza enfasi, e senza cadere in svenevolezze (il che era facilissimo). Lo stesso difficile e arcigno Berlioz dovette inchinarsi davanti a una pagina simile gridando al «capolavoro»!
I due personaggi del Conte e di Isobero sono incorniciati entro un tessuto musicale brillante e festoso con tratti a volte di fine umorismo, a volte di comicità farsesca, fra cui si insinuano ondate di sensuale languore. Ma anche quest'ultimo carattere ci si presenta mescolato a elementi ironici o burleschi, di modo che ne esce un'espressione più densa, di cui si subisce l'emozione senza poterla analizzare. L'ansia della Contessa, la sua malcelata attrazione verso Isoliero, la trepidazione nella notte tempestosa, la paura del Conte Ory, si mescolano in un tutto inimitabile per l'intimità psicologica della musica che afferra ed esprime i movimenti anche fuggevoli e minori dello spirito con malia avvincente.
L'arte del Maestro, la sua ritmica marcatissima, il suo gusto per i contrasti strumentali, sembrano, a un primo sguardo, non aver subito modificazioni; ma se si osserva attentamente si vedrà che un mutamento abbastanza profondo c'è: l'arte di Rossini da soggiogante e travolgente si è fatta maliziosa e insinuante. È un Rossini spumeggiante e iridescente che ha saputo piegare i propri mezzi a un'espressione più aggraziata e analitica. È sempre l'artista che sa mettere in luce la turlupinatura e ci gode, ma ha imparato a farlo con dilettoso buon garbo. Anche il temporale, che si annunzia con una dissonanza la quale basta da sola a dare qualche brivido di paura alle due donne (la Contessa e la sua ancella) già in apprensione, con le sue riprese e i suoi arresti, le sue raffiche e i suoi rombi, cui sovrastano gli strilli femminili, è concepito in un sentimento di burlevole gioco.
GUGLIELMO TELL: melodramma tragico in 4 atti. Prima rappresentazione all'Opera di Parigi il 3 agosto 1829. Libretto di Stefano De Jouy e Ippolito Bis, dalla tragedia omonima di Federico Schiller.
Atto 1° - Villaggio alpestre; a destra un torrente. - Il popolo si appresta a compiere i riti religiosi e festivi per le nozze dei pastori;un pescatore nella sua barca sul torrente canta apprestando le reti. Solo Guglielmo Tell, in disparte, è triste e pensoso poichè la Svizzera è oppressa dal tirannico governatore tedesco Gessler. Il vecchio pastore Melchthal intanto inizia il rito invitando i pastori a cantare. Melchthal chiede al figlio Arnoldo quando potrà celebrare anche le sue nozze. Arnoldo è agitato dalle parole del padre: egli ama segretamente la principessa Matilde di Hasbourg, ch'egli ha salvato da morte. Guglielmo però ha indovinato il suo segreto, lo rimprovera e lo incita ad aiutarlo nell'azione ch'egli sta per intraprendere contro gli oppressori. Melchthal benedice tre coppie di sposi, e si iniziano le danze. Alle gare di tiro a segno con la freccia Jemmy, figlio di Guglielmo Tell, riesce vincitore. Quand'ecco giunge trafelato il pastore Leutoldo: un ministro di Gessler tentava di rapirgli la figlia ed egli lo uccise. Ora è inseguito dagli sgherri del tiranno e chiede soccorso. Nessuno osa; Guglielmo Tell allora scende con Leutoldo nel battello e vogando vigorosamente si allontana. Rodolfo, con uno stuolo di armati viene per catturare Leutoldo. Avendo Melchthal risposto con disprezzo alle sue richieste, lo fa arrestare e ordina di incendiare il villaggio. Invano i pastori tentano di opporsi.
Atto 2° - Valle profonda presso il lago dei Quattro Cantoni.- Matilde si incontra con Arnoldo e gli confessa che ricambia il suo amore. Se la distanza che li separa è grande, Arnoldo non disperi:combattendo nelle file dell'esercito tedesco da valoroso potrà un giorno chiedere la sua mano. Udendo venire alcuno, Matilde parte. Giungono infatti Guglielmo Tell e Gualtiero Farst. Essi gli recano la notizia che Gessler ha fatto uccidere suo padre, e lo rimproverano di voler combattere per l'oppressore. Inorridito e disperato Arnoldo giura di vendicare il padre. Arrivano i rappresentanti degli altri tre Cantoni svizzeri, i quali giurano solennemente di unirsi per la salvezza della patria.
Atto 3° - Quadro 1° - Campagna amena e remota. - Arnoldo confida a Matilde il suo proposito di vendetta. Il fato li divide; essi dovranno separarsi per sempre.
Quadro 2° - Piazza in Altdorf. - Gessler ha fatto bandire una festa per esaltare la dominazione germanica. Su un palo è un trofeo al quale tutti debbono inchinarsi; ma Guglielmo Tell vi si rifiuta, e poichè Rodolfo lo denunzia per colui che trasse in salvo Leutoldo, Gessler lo fa arrestare, e gli ordina di colpire con l'arco una mela posta sul capo di suo figlio Jemmy. Rincorato dal figlio medesimo, Guglielmo colpisce nel segno, ma subito per l'emozione provata quasi sviene e gli cade a terra una freccia che aveva nascosta. Gessler gli chiede perchè l'avesse conservata. «Per te s'egli era spento» gli risponde Guglielmo. Gessler allora ordina ch'egli sia incatenato; invano Matilde intercede per lui, e solo riesce a salvare il figlio, che Gessler vorrebbe pure incatenato. «Anatema a Gessler» grida Tell, e tutto il popolo risponde con lo stesso grido.
Atto 4° - Quadro 1° - Stanza in casa di Melchthal. - Arnoldo ripensa con dolore al padre estinto, allorchè gli viene annunziato l'arresto di Guglielmo Tell. Egli allora corre con i suoi a liberarlo.
Quadro 2° - Il lago dei Quattro Cantoni. - Matilde restituisce Jemmy a sua madre e dichiara che resterà con loro come ostaggio per la liberazione di Guglielmo. Intanto Jemmy incendia la casa di Guglielmo come segnale convenuto per l'insurrezione popolare. Mentre l'incendio divampa, sul lago si scatena un violento uragano. Guglielmo, tratto da Gessler pel lago verso il carcere di Kusmac, è stato invitato dal tiranno a guidare il naviglio nella tempesta. Ma egli balza rapidamente a riva e scocca un dardo contro Gessler che muore. In questo istante giunge Arnoldo il quale annunzia che è entrato vittorioso in Altdorf con i ribelli. Il cielo si rasserena: passa nei cuori un'onda di giubilo.
Dalla mirabile sinfonia all'estrema nota dell'ultimo atto passa per la musica di quest'opera un soffio epico potente. Benché i librettisti abbiano fatto di tutto per rovinare la tragedia di Schiller, la novità del soggetto, la grandezza dei caratteri, l'aver ridotto le scene d'amore a un puro episodio portando in primo piano la lotta eroica di un popolo per la sua libertà (argomento questo che già aveva commosso e ispirato il musicista nel comporre L' Assedio di Corinto e il Mosè), hanno indirizzato la fantasia creatrice di Rossini verso una mèta ben alta e nuova, che egli seppe pienamente raggiungere. L'opera è veramente «colossale», non tanto per la sua mole (dura complessivamente oltre cinque ore, e il primo atto da solo un'ora e tre quarti!), ma per la grandiosità della concezione.
La sinfonia è un poema che compendia l'azione del dramma. Essa consta di quattro tempi: il 1° (Andante) è costituito da un canto dolente di cinque violoncelli non privo di un fondo di calma fidente. Senza interruzione segue un temporale impetuoso (Allegro), indi un Andante in cui il corno inglese canta un motivo campestre di «ranz des vaches» mentre il contrappunto acuto del flauto sembra un garrulo arabesco d'usignolo. Ma degli squilli improvvisi di trombe annunziano la vittoria (Allegro vivace): un ritmo veloce di cavalcata marziale, un cicaleccio animato, grida di esultanza narrano con uno slancio travolgente il trionfale esito della lotta per la liberazione. Inutile ridire la bellezza superba di questa sinfonia, tanto giustamente popolare.
I caratteri dei personaggi sono delineati con magistrale rilievo. Specialmente quello fiero e ardente di Guglielmo Tell, i cui recitativi e i cui ariosi hanno lampeggiamenti d'acciaio, tremiti di sdegno sacro, impeti di ribellione o d'entusiasmo, e mai un grido di enfasi, mai una frase rettorica. È un personaggio scolpito in un bronzo durissimo, dalla sagomatura angolosa e rude, ma che possiede pure un lato, un unico lato, patetico. È il suo amore di padre, che lo fa palpitare e piangere per la sorte del figlioletto e gli fa sgorgare dal profondo un canto tenerissimo prima di lanciare la freccia che trapasserà sul suo capo la mela postavi dal crudele Gessler. È la preghiera «Resta immobile»: l'unica aria affidata a questo personaggio, ma un'aria dalla forma totalmente sciolta, piena d'una commozione intima intensissima, alla quale il lamento continuo del violoncello che serve d'accompagnamento conferisce un'angoscia di pianto indicibile. Nulla di svenevole: commozione umanissima, lacrime di un padre che teme di colpire il proprio innocente fanciullo, dolore in cui trema il terrore attraverso a note di una tenerezza virile.
Se Tell è un uomo tutto d'un pezzo, non così ci appare Arnoldo, combattuto fra l'amore di Matilde e quello per la Patria. I suoi canti, di forme ampie e spiegate, che salgono agli acuti taglienti con un continuo balenìo ritmico marcato, ce lo dipingono come una natura giovanile, ardente, generosa ma impulsiva. Sono, questi canti, l'appassionato «Ah Matilde, io t'amo», il tenero «Cari, onesti e dolci accenti», nei quali si esprime il suo amore per la principessa, e l'amaro «Oh muto asil del pianto» in cui si espande il suo dolore per la morte del padre. Ma Arnoldo non manca di fierezza virile, che si manifesta in alcune altre espressioni di un vigore marziale, come il «Ciel, tu sai se Matilde m'è cara» del 1° atto, le risposte vibrate alle accuse di Guglielmo («Desio di gloria mi invita all'armi»: atto 2°), e l'impetuoso «Corriam, voliamo» dell'atto 4° (padre della cabaletta «Di quella pira» del verdiano Trovatore).
Più pallida, perchè meno attiva nel dramma, la figura di Matilde, ma ha anch'essa un'oasi che ci permette di vederne l'intimità spirituale attraverso all'espressione di un vivo sentimento poetico della Natura nella romanza del 2° atto «Selva opaca», così imbevuta di sognante estasi. Innanzi a questa pagina Berlioz ammirato fu tratto ad esclamare: «Ecco della poesia, ecco della musica, ecco dell'arte, bella, nobile, pura». Anche Edwige (la moglie di Guglielmo) e Melchthal nelle loro brevi parti sono delineati con rapida efficacia di tratti; meno bene Gessler che è riuscito alquanto goffo e truculento; assai bene invece Jemmy che nei suoi recitativi o nelle sue partecipazioni ai concertati ha sempre accenti giovanilmente freschi e leggiadri. Perfino il Pescatore, che pure alla fine del 1° atto riesce antipatico per il pusillanime rifiuto a portare in salvo Leutoldo, ha una romanza («Il picciol legno ascendi») così estrosa e gioiosa da renderlo di primo acchito simpaticissimo e da farci supporre ch'egli sia per avere nella vicenda una parte di ben maggiore importanza.
Ma accanto a Guglielmo e ad Arnoldo vi è un altro personaggio che di quando in quando, specialmente nel 1° atto, assume un rilievo imponente: il popolo svizzero. Questo popolo noi lo vediamo dipinto nel 1° e nel 3° atto nei suoi costumi pastorali, nei suoi ritmi religiosi, nelle sue danze e nelle sue canzoni popolari. Nel 2° atto scendiamo nei suoi sentimenti patriottici, nella sua fierezza dignitosa, nel suo amore della libertà, nei suoi impulsi generosi e audaci. Nella musica che lo caratterizza passa la soave fragranza dei pascoli, la svettante solitudine alpestre e il fragore dei torrenti che costituiscono il paesaggio in cui vive. Nel 1° atto, in cui l'azione drammatica è appena accennata in qualche frase di Guglielmo e nel dialogo suo con Arnoldo, il popolo tiene il primo posto con i suoi solenni cori religiosi, con i suoi canti pastorali irruenti o estatici, con le sue danze corali elegantissime. È un mondo nuovo, di cui la grande sinfonia ci aveva già dato il preannuncio, e che qui si spalanca con una larghezza stupenda di intuizione musicale. L'elemento pastorale oltre che dalla sinfonia e dai cori del 1° atto, acquista vita anche dalle danze-coro, pure oltremodo eleganti, del 3° atto, specialmente dall'indovinatissima «tirolese»: «Quell'agil piè ch'ugual non ha».

Figura 05: Figurini di Sievert per Le nozze di Figaro di Mozart.

Figura 06: Scena di Parravicini per il Matrimonio Segreto di Cimarosa.
Ma nel 2° atto il popolo svizzero ci è dipinto sotto l'aspetto eroico. Dopo i rimproveri di Guglielmo e Gualtiero ad Arnoldo per quel suo amore principesco e teutonico che rischia di portarlo a combattere per l'oppressore (quale drammatico contrasto fra l'austero e amaro canto di Guglielmo e le tracotanti risposte di Arnoldo!), dopo la rivelazione della morte di Melchthal e il disperato pianto di Arnoldo («Troncar suoi dì quell'empio ardiva»), oppresso dal tremendo rimorso (quale intensità di disperazione nel grido lacerante: «Il padre, ahimé, mi malediva, ed io la patria allor tradiva»), entrano in scena i rappresentanti dei tre Cantoni e si svolge quella scena della congiura che è nuovissima nella storia del teatro musicale e darà luogo a svariate imitazioni da parte di altri compositori, primo fra i quali il contemporaneo Meyerbeer negli Ugonotti. Dai primi sommessi accenti febbrili («Guglielmo, sol per te») si passa al solenne giuramento sostenuto dai robusti squilli dei corni e delle trombe e dalle impetuose scale simili a raffiche di tempesta e dai trilli violenti dei bassi, dove non c'è più niente di teatrale ma canta la volontà e la maestà di un popolo in armi per la difesa del proprio diritto. Tutto ciò, sostenuto con un ritmo ferreo, con una granitica compattezza vocale e strumentale, fino all'incontenibile esplosione del grido: «All'armi!» che con un turbinoso movimento dell'orchestra chiude l'atto.
L'orchestra di Rossini in quest'opera ha superato quanto era stato fatto fino allora da lui stesso e dagli altri. È un'orchestra dai ritmi sempre dinamicamente vivi, ricca di colori, varia e densa nei disegni, e sempre imbevuta di quelli che sono i due fondamentali caratteri dell'opera: il pastorale e l'eroico. Il sentimento della Natura, già così poeticamente e profondamente espresso nella sinfonia, sèguita a sorreggere di colori freschi ed ariosi i cori pastorali e religiosi, originando anche descrizioni particolari, come quelle che evocano lo spirito dei tre diversi popoli di Untervalden, Schwitz e Uri allorchè giungono al convegno, nel 2° atto. I colori dell'orchestra rossiniana s'incupiscono nel temporale furioso dell'ultimo atto, per rischiararsi in una luminosità iridata di arcobaleno prewagneriano nel finale catartico dell'opera, in cui uno stesso motivo passando da un istrumento all'altro, animandosi nel ritmo, salendo verso le note sovracute, trascina con un possente soffio di vita in una sfera lirica che uscendo dal puramente umano si aderge a un'altezza contemplativa universale.
DANIELE AUBER (Caen 1782 - Parigi 1871) - FRA DIAVOLO: opera comica in 3 atti. Prima rappresentazione all'Opéra-Comique di Parigi il 28 gennaio 1830. Libretto di Eugenio Scribe.
Atto 1° - Vestibolo d'un albergo aperto nel fondo, in un villaggio presso Terracina. - Un temuto brigante soprannominato Fra Diavolo infesta la regione. Una taglia di seimila scudi è stata posta su di lui, e il brigadiere dei carabinieri Lorenzo spera di guadagnarla. Ma egli è preoccupato perchè la figlia dell'oste Matteo, la bella Zerlina, che egli ama e che lo ama, l'indomani dovrà sposarsi per volere del padre con un ricco fittaiolo. D'improvviso un turista inglese, Lord Rocburg, e sua moglie Pamela, irrompono gridando al soccorso. Essi raccontano di essere stati aggrediti e derubati di uno scrigno pieno di gemme da briganti armati. Lorenzo parte con i suoi carabinieri alla caccia dei banditi. Frattanto giunge una carrozza da cui smonta un tale che da due giorni segue i due inglesi facendo la corte a Milady. Egli si è loro qualificato per il Marchese di San Marco, ma non è altri che Fra Diavolo travestito. Giungono anche, poco dopo, due individui che chiedano la carità: sono due compagni di Fra Diavolo: Giacomo e Beppo. Il «Marchese» intercede per loro presso l'oste dicendo che pagherà loro da cena e da dormire. Essi confidano poi al loro capo che fra il bottino tolto agli inglesi non furono trovati i cinquecentomila franchi di cui Pamela aveva parlato allo stesso Fra Diavolo, e questi si propone di indagare su ciò. Fra Diavolo riprende a corteggiare Milady; le stacca dal collo un medaglione d'oro col suo ritratto e dichiara di volerlo conservare per amar suo. Abilmente interrogandola viene poi a sapere che i cinquecentomila franchi sono cuciti nel suo mantello. Ed ecco frattanto ritornare Lorenzo con i suoi soldati. Essi hanno sorpreso e distrutto il grosso della banda di Fra Diavolo, e ritrovato lo scrigno con le gemme di Pamela, la quale consegna a Zerlina una dote di diecimila franchi affinchè possa sposare Lorenzo.
Atto 2° - Camera d'albergo. - Zerlina canta lieta poichè l'indomani potrà sposare Lorenzo anzichè il fittaiolo che suo padre voleva darle. Indi accompagna i due inglesi nella loro stanza. Entra Fra Diavolo e si mette a cantare alla finestra accompagnandosi col mandolino: è il segnale di richiamo convenuto per i due compari Beppo e Giacomo; ma udendo venir Zerlina si nascondono tutti e tre in uno stanzino. Zerlina si sveste, si ammira nello specchio con fare civettuolo, e si corica. Mentre Fra Diavolo e i suoi due uomini si accingono ad uccidere Zerlina per entrare poi nella stanza degli inglesi, si ode bussare alla porta di strada. Zerlina si risveglia, e i tre briganti si nascondono di nuovo. È Lorenzo di ritorno coi suoi: un contadino che conosce Fra Diavolo perchè fu suo prigioniero, ha detto loro di averlo visto nei pressi dell'albergo. Esce anche Milord per vedere chi è giunto. Mentre sta parlando con Lorenzo si ode il rumore di una sedia rovesciata nello stanzino accanto. Ne esce Fra Diavolo il quale, interrogato da Lorenzo come si trovasse colà, risponde che è un segreto d'amore, lasciandogli sospettare di essersi nascosto colà per Zerlina. A Milord fa credere invece che fosse colà per Pamela della quale mostra a Milord il medaglione che afferma gli sia stato dato da lei. Lorenzo e Milord, presi da geloso furore lo sfidano.
Atto 3° - Paesaggio montuoso; da un lato l'entrata dell'osteria; in alto un eremitaggio con campanile. - Il Marchese getta nel cavo di un albero uno scritto che Beppo e Giacomo poco dopo raccolgono. In esso sono fissati i particolari dell'insidia tesa da Fra Diavolo per uccidere Lorenzo e derubare gli inglesi. Il segnale convenuto per l'azione sarà il suono della campana del romitaggio. Zerlina cerca di convincere Lorenzo della propria innocenza, quando alcune parole sfuggite a Beppo e a Giacomo la persuadono della loro presenza nella stanza durante la notte, e ciò chiarisce l'equivoco in cui è caduto Lorenzo. Questi arresta e perquisisce i due banditi, e trova così il biglietto di Fra Diavolo. Tutti si celano, i carabinieri vengono appostati nelle gole del monte, e Giacomo è condotto a suonare la campana. Compare allora sul sentiero del colle Fra Diavolo. Il contadino che fu suo prigioniero lo riconosce ed esso viene catturato.
Rossini chiudeva la sua carriera operistica col Guglielmo Tell a trentasette anni nel 1829. In quest'anno Gounod contava solamente undici anni; Berlioz, giovane di ventisei anni, aveva appena iniziata da tre anni la sua combattutissima attività artistica: Saint-Saëns e Bizet nascevano rispettivamente sei e nove anni dopo. Dei compositori francesi più noti, Halévy, Boïeldieu, Hérold, Adam, Auber, il più originale fu quest'ultimo. Egli però risente indubbiamente dello stile rossiniano, di cui peraltro seppe bene assimilare lo spirito senza divenirne un imitatore pedissequo. La grazia e l'eleganza francese, innestate nella ritmica rossiniana, formano il fulcro dell'arte di Auber. Cosicchè nella Muta di Portici, rappresentata un anno prima del Guglielmo Tell, le parti in cui eleganza e ritmo appaiono più fini e scintillanti, sono quelle che esercitano ancora qualche fascino, come ad esempio la sinfonia. Eppure nella Muta, il personaggio non parlante, i cui sentimenti e pensieri perciò dovevano necessariamente essere espressi dall'orchestra, oltrechè dalla mimica, portavano su la scena un elemento abbastanza nuovo (se non nuovissimo) che avrebbe dovuto condurre a un approfondimento dell'espressione strumentale. Ma la fantasia del compositore si mostrò troppo impari al compito, cosicchè il successo di quest'opera non potè essere durevole.
Più felice che nel sentimentale, Auber fu nel comico, e perciò Fra Diavolo si regge ancora. Naturalmente siamo ben lontani dalla vita ritmica e melodica sgargiante di un Rossini, tuttavia in molte pagine del Fra Diavolo si osserva una serena e dilettevole arguzia di linguaggio musicale unita a fresca, se non profonda, vena di melodia, facile da afferrare e da ritenere, di impronta popolare. Questo carattere popolaresco non è mai sguaiato e volgare; tutt'al più sarà sciatto e scialbo, ma è sempre nobilitato da quel senso dell'eleganza signorile e dell'equilibrio che sono tipicamente francesi. Però dell'arte francese la musica di Auber ha spesso il superficiale edonismo, mira al piacere per il piacere senza nessuna intenzione interiore. Talvolta non manca di poesia, ma è la poesia dei sentimenti più comuni. Non sa elevare le piccole cose in un'atmosfera di grande poesia, ma le lascia nella lor piccolezza sfiorandole col suo canto morbido, con le sue armonie semplici, con la forma accurata e sapiente ma senza grandi ambizioni e pretese. Semplice e conversevole è anche il recitativo, senza la pedanteria del vecchio recitativo secco, ma anche senza soverchia energia.
La musica del Fra Diavolo presenta questi caratteri nella forma migliore; è musica scorrevole, leggera, di ottima fattura, piena di ritmi di ballabili balzanti, con un dialogo vocale agile e disinvolto. La sinfonia ha già questa vivace bellezza, più esteriore che intima, di melodie e di ritmi spigliati e spiritosi. Nel corso dell'opera il protagonista, bandito dall'aria cavalleresca, che unisce all'arte del seduttore audace quella del capo autoritario e senza scrupoli, ci è presentato in modo romantico nella ballata di Zerlina «Quell'uom dal fiero aspetto» (divenuta popolarissima); ma con aspetti più realistici è delineato dal compositore nei canti e nei recitativi affidatigli. Nulla però di violento o di drammatico salvo qualche breve tratto. Uditelo, com'è galante dei duetti con Pamela, e nella canzone «Agnese la zitella». Nei dialoghi coi due compari Beppo e Giacomo (questi sono schizzati con buon gusto umoristico dal loro primo apparire come finti mendicanti fino alla scimmiottatura gustosissima delle civetterie di Zerlina allo specchio), Fra Diavolo ha qualche accento imperativo energico, ma nel complesso il musicista non prende troppo sul serio l'aspètto criminale del suo personaggio e si guarda bene dal drammatizzarlo, anzi non si dimentica mai che sta componendo un' «opera comica». Zerlina e Lorenzo sono i consueti innamorati d'opera e le parti liriche loro affidate hanno pregi di sentimento e di grazia. Di Zerlina poi è dipinta bene specialmente la innocente vanità femminile nell'aria «Grazie al ciel, per una serva».
Anche i due inglesi, avaro e geloso lui, fatua e un po' civetta lei, sono sobriamente pupazzettati. E tutta l'opera, insomma, respira quest'aria di gaia farsa divertente che la fa ritornare di quando in quando in vita.
VINCENZO BELLINI (Catania 1801 - Parigi 1835) - LA SONNAMBULA: melodramma in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Carcano in Milano il 6 marzo 1831. Libretto di Felice Romani.
Atto 1° - Quadro 1° - Il mulino di Teresa presso un villaggio svizzero: un torrente ne fa girare la ruota. - Gli abitanti dei villaggio festeggiano Amina, orfanella raccolta da Teresa, per le sue nozze imminenti con il ricco possidente Elvino. Amina è felice; al contrario Lisa, ostessa, innamorata di Elvino, cerca nascondere il proprio dolore e respinge le attenzione del contadino Alessio che l'ama. Venuto il Notaio, Elvino dà ad Amina l'anello e un mazzolino di viole; e si firma il contratto. Giunge intanto un forestiero: è il Conte Rodolfo, signore del villaggio; assente dalla fanciullezza, nessuno lo riconosce, nè egli si dà a conoscere. Complimenta con galanteria la sposa facendo nascere una leggera gelosia in Elvino, che lo interroga. Lo sconosciuto risponde che reca al castello notizie del figlio dell'estinto Conte, scomparso da giovinetto, ma tuttora vivo. Vien sera: la gente si ritira per timore del fantasma che ogni notte appare e di cui perfino i cani hanno terrore. Entrato il Conte nell'albergo, Elvino confessa ad Amina la propria gelosia.
Quadro 2° - Stanza nell'osteria. - Lisa è venuta a ossequiare il Conte (che ormai è stato riconosciuto) e si trattiene con lui a civettare. Sentendo venir gente, fugge e perde un fazzoletto. Si spalanca la finestra ed entra Amina in istato di sonnambulismo. Lisa che l'ha vista entrare corre a denunziare il supposto tradimento ad Elvino, Questi giunge con Teresa ed altri villegianti. Destatasi Amina, Elvino la respinge rimproverandole l'inganno. Invano Amina si proclama innocente: l'averla scoperta nella stanza del Conte di notte è prova troppo grave contro di lei, ed Elvino dichiara che non la sposerà più.
Atto 2° - Quadro 1° - Boscaglia. - Amina s'incontra con Elvino e cerca di persuaderlo della propria innocenza, ma Elvino non le crede e le strappa dalla mano l'anello che le aveva donato.
Quadro 2° - Villaggio come nel 1° quadro dell'atto 1°. - Elmo per dispetto ha promesso a Lisa di sposarla, il che fa disperare Alessio. Il Conte afferma su l'onor suo ad Elvino che Amina è innocente, e che entrò nella sua stanza in istato di sonnambulismo. La discussione fra i due diventa vivace, cosicchè Teresa esce di casa e li prega di parlare sottovoce: l'infelice Amina, affranta, ha potuto alfine prender sonno. Saputo poi del fidanzamento di Elvino con Lisa mostra il fazzoletto di Lisa trovato nella camera del Conte. Ciò produce in tutti un forte turbamento; quand'ecco apparire Amina. Essa parla in sonno del proprio amore per Elvino e del, dolore procuratole dal suo abbandono. Leva dal seno i fiori che le aveva donati: appassiti, durati anch'essi un giorno solo come l'amore; e sogna il suo ritorno. Il Conte dice ad Elvino, ormai convinto e preso dal rimorso, di rimetterle in dito l'anello, poi la risveglia. Al primo moto di smarrimento succede ben presto la gioia per l'amóre riconquistato.
A due anni di distanza dal Guglielmo Tell ecco un altro stupendo capolavoro del teatro italiano. La drammatica vicenda della Sonnambula coi suoi elementi pastorali e patetici, è una derivazione del teatro «larmoyant» a cui appartiene la Nina di Paisiello. Essa seppe commuovere la fantasia sensibilissima di Bellini, il quale per realizzarla musicalmente trovò accenti toccanti e melodie di una bellezza ineffabile. L'ambientazione pastorale è data specialmente dai cori freschi e pieni di campestre serenità. In quest'ambientazione, attuata con felice intuizione, si muovono i personaggi, figure semplici attorno ad una vicenda che la musica solleva da fatto pietoso di cronaca a potenza eterna di poesia. Il libretto conteneva dei germi che la musica del Catanese ha fatto fermentare; essa soltanto crea dall'episodio modesto e dall'equivoco banale l'«idillio drammatico». E l'idillio incomincia con la cavatina di Amina «Come per me sereno oggi rinacque il dì!», melodia di angelicata a casta purezza; continua con la balzante cabaletta «Sovra il sen la man mi posa» piena di un giubilo così innocente, e con il dolcissimo «Prendi, l'anel ti dono» di Elvino in cui è tanto sentimento d'affetto.
Ma con il coro «A fosco cielo, a notte bruna», dal ritmo misterioso e dall'andamento di leggenda fatata paurosa, si entra già nel dramma, che si annunzia con più acceso ardore nel duetto tra Elvino e Amina «Son geloso del zeffiro errante», dove anche i vocalizzi hanno carattere espressivo, e divampa violento nel finale dell'atto, alle parole di Amina «D'un pensiero e d'un accento rea non sono», dov'è tanta amarezza di pianto. Ma ecco, miracolo che solo la grande musica e i grandi musicisti sanno compiere, che passando lo stesso motivo ad Elvino con le parole «Voglia il ciel che il duol ch'io sento tu provar non debba mai» l'amarezza diventa spasimo e il pianto diviene disperazione. E l'ardore cresce con lo sviluppo del pezzo, con il movimento contrappuntistico delle parti, che fonde in unità le differenti espressioni dei diversi personaggi, con il passaggio del canto all'orchestra che aumenta la tensione, con le pause che rompono angosciosamente i disegni vocali del coro, e infine con l'animazione tempestosa della chiusa «Non più nozze. Sconoscente, io t'abbandono». Il dolore, l'acuto tormentoso dolore belliniano carico di sconforto, di amarezza e di strazio, è nell'istesso tempo catartica liberazione di sè stesso nell'ampia distensione di una purezza melodica assoluta. La melodia è sempre liberatrice, ma questa del Bellini è fenomeno unico in quanto parte dall'espressione più intima e realistica del dolore per negarlo e superarlo nell'atto stesso che lo riconosce. Forse da Monteverdi in poi nessuno era riuscito a darci questa complessa emozione artistica con tanta immediatezza e tanto rapimento.
Nel 2° atto de La Sonnambula la tensione di questo dolore non si esaurisce, ma sale ancora nello sconsolato canto di Elvino «Tutto è sciolto», seguìto dall'amarissima frase «Pasci il guardo e appaga l'alma dell'eccesso de' miei mali», per esplodere nel grido «Ah! perchè non posso odiarti» in cui l'amore rivela ancora le sue fiamme accese attraverso all'ira impotente. Ancora una volta le più complesse emozioni sono espresse con la più semplice linearità di immagini sonore. E fra un canto e l'altro, preludi orchestrali che, per la forza espressiva dei motivi come per la scelta degli istrumenti, creano con rapidissima azione, in un giro di poche note, l'atmosfera voluta. Spesso non sono altro che il preannuncio del motivo del canto, ma che ripreso dalla voce trova già l'animo ambientato e predisposto a penetrarlo e a lasciarsene penetrare.
Di canto in canto, con un crescendo mai affievolito di tensione drammatica, con un'altezza di ispirazione melodica senza uguali, si giunge a quell'ultima melodia che è il vero canto risolutivo del dramma: «Ah! non credea mirarti sì presto estinto, o fiore». È tutto un fiato, senza ripetizioni convenzionali, con uno svariare continuo di emozioni estatiche e nostalgiche di profonda intensità, di indicibile sublimità; tutt'un fiato melodico di un'ampiezza inusitata. Dopo di che, quando si crederebbe che la fantasia non possa salire di più, la voce di Elvino prorompe nello straziante «Più non reggo a tanto duolo» che è la trasfigurazione musicale di un pianto liberatore, l'incontenibile, sfogo benefico delle lacrime, che per suggestione fisica inevitabile ne richiama altre vere dagli occhi dell'ascoltatore. Sappiamo bene che la commozione fisica non ha niente a che fare con l'emozione estetica, ma qui le lacrime materiali non sono che un'adesione di tutta la nostra anima all'emozione estetica creata dal canto belliniano, alla quale neanche l'organismo fisico può sottrarsi. «Chi non piange e resta freddo e riservato - diremo parafrasando quanto il Bacchelli scriveva a proposito del riso rossiniano dell'Italiana in Algeri - sarà una seria e degnissima persona, ma da compiangere».
L'ultimo rondò, «Ah! non giunge uman pensiero al contento ond'io son piena» sostituisce l'abituale pezzo di bravura con un pezzo pieno di slancio gioioso che parte dal cuore, e dov'è quella piccola frase balzante «ah m'abbraccia!» (un salto di Ioa, dal sol sopra il rigo al mi nella, prima riga) che la Malibran diceva con tale impeto d'amore da far scattare il pubblico e lo stesso autore per l'entusiasmo.
Ma ne La Sonnambula non c'è solo la melodia; c'è anche il recitativo: un recitativo flessibile, aderente, di un'espressione intensa e profonda quale neppur Rossini aveva immaginato, e che è forse la novità maggiore dell'arte belliniana. Uno dei più begli esempi è il lungo recitativo che precede l'aria «Ah! non credea mirarti», di una bellezza inaudita per la varietà degli atteggiamenti e per la finezza di penetrazione psicologica.
NORMA: tragedia lirica in 2 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 26 dicembre 1831. Libretto di Felice Romani tratto da una tragedia di Alessandro Soumet.
Atto 1° - Quadro 1° - Bosco sacro presso il tempio d'Irminsul nelle Gallie. - Pollione, Proconsole di Roma, che ebbe con la Druidessa Norma una relazione amorosa dalla quale nacquero due figli, ora ama la giovane sacerdotessa Adalgisa. Egli racconta all'amico Flavio un sogno pieno di paurosi presagi. La luna intanto s'è alzata: i guerrieri Galli attendono impazienti che Norma, interprete della volontà divina, dia loro l'ordine di distruggere le schiere romane; ma essa afferma che l'ora non è ancora suonata. Intìma pace, miete il sacro vischio e leva una preghiera alla Luna. Sgombrata la selva, Adalgisa si ritrova con Pollione; questi le annunzia che all'alba farà ritorno a Roma; l'invita a fuggire con lui, ed essa glie ne fa promessa.
Quadro 2° - Stanza di Nonna nell'interno del tempio. - Adalgisa, presa da rimorso, confida a Norma di amare. Norma, che sa di essere anch'essa colpevole, la scioglie dai voti e le permette di unirsi alla persona amata; ma come Adalgisa le rivela che l'uomo amato è Pollione, e questi entra in quello stesso istante. Norma lo investe ricordandogli il suo amore per lei e i figli. Ma Pollione non l'ascolta e tenta invano di trarre con sè Adalgisa.
Atto 2° - Quadro 1° - La stanza ove dormono i bimbi di Norma. - Essa pensa di ucciderli nel sonno; ma nell'atto di colpirli, il suo amore di madre le arresta la mano. Fa chiamare Adalgisa, alla quale pensa di affidare i figli affinchè li conduca con sè a Roma; poscia si ucciderà. Ma Adalgisa si rifiuta di partire e vuol tentare di ricondurre ancora Pollione a Norma.
Quadro 2° - Luogo solitario presso il bosco dei Druidi. - I guerrieri attendono sempre invano che Norma dia loro un cenno per attaccare i Romani, ma Norma fa dire loro dal padre suo Oroveso di pazientare ancora, e i guerrieri si disperdono.
Quadro 3° - Interno del Tempio d'Irminsul presso l'ara del Dio. - Norma apprende che Adalgisa non è riuscita a convincere Pollione e che questi s'appresta a rapire la giovinetta. Sdegnata, percuote tre volte lo scudo d'Irminsul. Al richiamo i guerrieri accorrono, e Norma dà loro l'ordine di sterminare i Romani. L'inno di guerra prorompe selvaggio. Mentre Norma, invitata da Oroveso a designare la vittima, sta per offrire sè stessa, giungono alcune guardie le quali hanno tratto in arresto Pollione, scoperto dentro il recinto delle vergini. Norma pensa di sacrificarlo, ma non ne ha il coraggio. Allontana i guerrieri sotto pretesto d'interrogare il prigioniero, e fa un ultimo tentativo per indurre Pollione ad abbandonare Adalgisa. Riuscita vana ogni preghiera e ogni minaccia. Norma richiama i guerrieri e le sacerdotesse, e innanzi a tutti accusa sè stessa. Il suo gesto generoso per salvare Adalgisa fa conoscere troppo tardi a Pollione quel grande cuore e risveglia in lui col rimorso l'amore. Norma quindi raccomanda a Oroveso i figli, e s'avvia con Pollione al rogo.
A distanza di circa nove mesi e mezzo dalla Sonnambula, Bellini dà al mondo con la Norma un altro superbo capolavoro, e di tutt'altro genere: drammatico-idillico il primo, tragico-eroico il secondo. Nella Norma la fantasia di Bellini crea un mondo scomparso che, se deriva dal lato librettistico da quello che ispirò a Spontini La Vestale, è peraltro approfondito dalle maggiori facoltà drammatiche del poeta Romani, e rivissuto con potenza lirica e tragica altissima dal musicista nei suoi tre aspetti principali: il sentimento sacro che domina gli avvenimenti, lo spirito bellicoso barbarico dei guerrieri Galli, e il romanzo d'amore dei tre protagonisti: Norma, Pollione e Adalgisa. Il sentimento sacro si afferma subito nel motivo dolcemente austero e grave con cui si apre l'opera, derivazione dell'Inno mattutino» della Vestale, ma al quale Bellini ha saputo conferire un respiro di una solenne ampiezza che lo rinnova e lo trasfigura. L'elemento sacro trova poi nella celebre invocazione alla «Casta diva» la più compiuta ed alta realizzazione. Il flauto annuncia il motivo portandolo con la sua voce aerea verso il cielo: serenità perfetta nel motivo e nel timbro; trasparenza dell' aria, limpidezza argentina della luna, serena dolcezza dei cuori. La voce di Norma riprende ed amplia quest'espressione: quattordici battute di canto continuo di una tersa bellezza che infonde un sènso di pace soavissima. È «la melodia che vince ogni parola!», come ebbe a scrivere Gabriele d'Annunzio della melodia belliniana. «Inargenta» l'anima, la quale rimane, come la luna nel cielo, «senza nube e senza vel». Le molli risposte del coro sottovoce, quasi temesse di rompere l'incanto, su cui si snodano i floridi vocalizzi di Norma, concepiti con un senso di felice abbandono, completano il quadro mantenendo l'emozione (e poteva sembrare impossibile) alla medesima altezza. Magia di genio! Una simile visione era ed è rimasta unica nella storia della musica.
I cori guerrieri sono tutti improntati a nobiltà e grandezza; imbevuti anch'essi di un sentimento panico sacro, talvolta con accenti che richiamano alla mente Beethoven, come, ad esempio, il coro «Non partì?», anche per il ritmo del tema e l'accompagnamento a terzine che sembrano derivati dal primo tempo della Sonata per piano detta «Au clair de lune». Sotto questa austerità non si direbbe che si celi un popolo barbaro; il coro «Dell'aura tua profetica») dal ritmo così marcato, è la voce di un popolo fiero e bellicoso, ma non selvaggio. Ma all'esplosione del grido «Guerra, guerra» il fondo barbarico si palesa con una violenza paurosa. Importante è poi la partecipazione attiva al dramma delle masse corali, le quali dialogano fra loro, con Oroveso e con Norma. La concezione del coro come riempitivo e variante è qui completamente superata e sostituita da una concezione nuova, del coro-personaggio.
Il romanzo d'amore offre al compositore il modo di scolpire i caratteri dei personaggi con un'efficacia monumentale, e non solo per mezzo di canti strofici, ma per mezzo di recitativi in cui la parola nelle sue risonanze interiori più profonde trova una rispondenza musicale che ha la forza di una rivelazione. Le strutture dell'aria del duetto del terzetto e del concertato appaiono rinnovate in forme sciolte, snodate, sensibili, facili ai rapidi trapassi da una emozione all'altra come alle sùbite accensioni, alle estasi e ai rapimenti.
Pollionè già fino dai primi recitativi ci si palesa appassionato e impetuoso. Il racconto del suo sogno, specialmente nella parte centrale in cui il canto si muove su un basso misteriosamente cupo e fremente, attinge una grande forza drammatica; e allorché Pollione ripete la minaccia: «Norma così fa scempio», un audacissimo accordo di tredicesima sembra spalancare un abisso di terrore. L'indole impetuosa è riconfermata dalla cabaletta tutta slancio gagliardo: «Me protegge, me difende», mentre la passionalità, anche pieghevole ad accenti teneri, appare nei dialoghi con Adalgisa, nel «Va crudele» dall'agitato commento dei violini, nel trepidante «Vieni in Roma», nel supplichevole «Ah! t'appaghi il mio terrore».
Adalgisa è una creatura femminilmente e perdutamente innamorata, che nell'amore non ha smarrita la propria innocenza e gli impulsi generosi del cuore, che trema del proprio fallo e non sa difendersi. Un turbamento angoscioso è nella sua preghiera; specialmente efficace nel vaneggiamento vocale alle parole «O Dio, proteggimi: perduta io son». Il suo amore manda luci di cielo nel canto estatico «Sola, furtiva, al tempio»; la sua femminilità che immagina la dolcezza d'esser madre si discioglie nella supplichevole e affettuosa melodia: «Mira, o Norma, a' tuoi ginocchi questi cari pargoletti».
Norma, levatane la celestiale preghiera alla «Casta diva», ha un rilievo pieno di vigore, sia che invochi «Ah! bello a me ritorna» in un ritmo ch'è tutto un palpito ardente di vita, con la risoluta e veemente affermazione «e contro al mondo intero difesa a te sarò», sia che con la voce mozzata da intimo sdegno esclami «Oh! di qual sei tu vittima», o che tremante d'affanno (i ii violini accompagnano il canto con terzine prive della prima nota sopra quartine dei 2i) gridi a Pollione: «Vanne, sì, mi lascia, indegno»; sia che fremente d'ira, ma con altera nobiltà d'accenti, minacci: «In mia mano alfin tu sei».
Ma anche nei recitativi passa il dramma in cui si dibatte il suo cuore; recitativi che nulla hanno più di schematico, recitativi che diventano canto, pregnanti in ogni lor minima inflessione; recitativi accompagnati da un più alacre movimento degli archi e da disegni e ritmi impetuosi e vibrati. Recitativi che hanno bagliori e slanci di fuoco; chiaroscuri mirabili di sottintesi o di meditazione interiore, dolcezze femminee sensuali e scatti di belva ferita. Fra tutti stupendo per aderenza espressiva, per mutevolezza di atteggiamenti che riflettono l'instabile tumulto dei pensieri e delle emozioni, è quello in cui Norma pensa di uccidere i figli per colpire in loro 1'amante che la tradì, e che sgorga nel pianto appassionato: «Teneri figli», così gonfio di materno abbandono e di malinconia. La sublime malinconia belliniana gli detta melodie che per la perfezione formale e per l'intimo fervore che le anima non sembrano cosa di questo mondo. «E se a codesto punto - scrive Ildebrando Pizzetti - uno non si sente gli occhi pieni di lagrime, egli è un disgraziato e un miserabile».
Fin qui Norma è amante, è madre, è sacerdotessa: un contrasto umano d'affetti passa attraverso ai canti con cui Bellini l'ha raffigurata e ci commuove. Ma nell'ultima scena Norma è eroina: salva Adalgisa, trascende sè stessa, purifica l'altare e in uno santifica l'amore con la propria morte; e la musica di Bellini ora non la raffigura ma la trasfigura. La coscienza della propria nobiltà passa nel contenuto ardore del canto «Qual cor tradisti». Un pensiero improvviso le balena: i figli! Che sarà di loro quando i genitori saranno estinti?: l'orchestra è tutta un ansimare di gemiti. Ora essa implora Oroveso con un'invocazione alla quale un padre non può rimanere sordo: «Deh! non volerli vittime» (i violini sono un reiterato lamento d'angoscia mortale); «pensa che son tuo sangue»: Bellini fa cadere quest'osservazione dall'alto. E il richiamo al vincolo di sangue non è invano; Oroveso che finora partecipava solamente dei sentimenti patriottici e guerrieri del popolo, ora si stacca da essi, piange. Popolo e guerrieri sono dei barbari;, non comprendono e, con accenti staccati che sembrano pugnalate, seguitano a chiedersi «Piange! Prega! Che mai spera?... vanne al rogo... maledetta estinta ancor». Ma il pianto e il perdono d'Oroveso hanno liberato il cuore di Norma da un tremendo peso. Incomincia di qui il canto di liberazione, di trasfigurazione, che sale e ci distacca da questo mondo con una forza vertiginosa, con una luminosità che è il riflesso di un mondo superiore ove ogni dolore è superato. A questo finale Wagner attinse lo spunto per il finale del Tristano e Isotta.
Fu detto che la strumentazione e armonizzazione della Norma è povera. Lo stesso amico di Bellini, Francesco Florimo, pare che lo avesse consigliato a modificarle; ma Bellini gli rispondeva che ciò gli era «impossibile per la natura piana e corsiva delle cantilene che non ammettono altra natura d'istrumentazione che quella che vi è». Anzi Bellini scrivendo l'opera si era lasciato trasportare in alcuni punti verso una densità orchestrale che egli stesso alleggerì prima che l'opera andasse in scena, persuaso che «gli artifizi, musicali ammazzano l'effetto delle situazioni».
È una orchestrazione a linee semplici che lascia emergere il canto nel quale principalmente si concentra la forza espressiva, e che tuttavia non manca di tocchi efficaci, come si può osservare nel vigore della sinfonia, nell'introduzione al 1° atto, nel racconto del sogno di Pollione, nell'uso del flauto preludiante alla «Casta diva», nell'uso marziale delle trombe in vari momenti epici del dramma, nell'impiego dei violini e dei violoncelli per esprimere i singulti e infine il prorompere del pianto doloroso di Norma nel preludio al 2° atto, nel poetico e qui ancora malinconico uso di flauto, oboe e clarinetti nel preludio al coro «Non partì?», nel selvaggio coro «Guerra, guerra», e nel fluttuare «quasi oceanico» - scrive il Pizzetti - di arpeggi nell'ultima scena dell'opera. Del resto l'orchestra della Norma comprende gli archi, un flauto, un ottavino, due oboi, due clarinetti, due fagotti, quattro corni, due trombe, tre tromboni, un trombone basso, arpa, timpani, cassa, piatti, più, in alcune scene, la banda sul palcoscenico.
Com'è noto la Norma fece fiasco la prima sera; tuttavia Bellini aveva coscienza del valore della propria musica, e all'amico Florimo scriveva: «Sarei felice di poterne fare di simile in tutta la mia vita artistica». Ma l'opera si andò risollevando nelle sere successive fino a trionfare completamente, ed ebbe un seguito di ben quaranta rappresentazioni consecutive!
GAETANO DONIZETTI (Bergamo 1797 - ivi 1848). - L'ELISIR D'AMORE: melodramma in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro della Canobbiana a Milano il 12 maggio 1832. Libretto di Felice Romani, tratto dalla commedia Le philtre di Eugenio Scribe.
Atto 1° - Ingresso d'una fattoria. - È un momento di sosta nel lavoro dei campi. Adina, ricca proprietaria, legge; Nemorino che vorrebbe farsi amare da lei, la contempla e sospira. Essa legge del filtro d'amore che legò Isotta a Tristano, e vorrebbe possederne la ricetta. Anche Nemorino lo vorrebbe. Intanto giunge il sergente Belcore alla testa di un drappello di soldati. Egli tosto si mette a fare il galante con Adina e le offre dei fiorì, con gran dispetto di Memorino. Approfittando di un momento in cui è rimasta sola, Nemorino le rinnova le sue profferte d'amore, ma ne è respinto. Quand'ecco giunge su la piazza il ciarlatano Dottor Dulcamara. Egli ha medicine per ogni male. Nemorino gli chiede se ha l'Elisir d'amore della Regina Isotta, e Dulcamara gli vende per tale una bottiglia di Bordeaux. Gli raccomanda però il silenzio: l'effetto sarà sorprendente e rapido. Andatosene il dottore, Nemorino beve, e un po' per effetto del vino, un po' per la sicurezza di farsi amare da Adina, balla e canta. Adina sopravviene e si stupisce del suo cambiamento. Nemorino per ischerzo le dice che spera di guarire dal suo amore, e ciò ferisce la vanità femminile di Adina, tanto che quando Belcore poco dopo le offre di sposarla subito, accetta per fare un dispetto a Nemorino; il quale, infatti, si dispera e prega invano Adina. di attendere un giorno ancora. Non ottiene altro effetto che di irritare Belcore e far ridere Adina e tutti gli astanti.
Atto 2° - Interno della fattoria. - Banchetto di fidanzamento al quale partecipa anche Dulcamara, che canta con Adina un'allegra barcarola. Nemorino è assente, e ciò toglie molto del divertimento che Adina si riprometteva. Giunge poco dopo, e vorrebbe un'altra bottiglia di Elisir, ma non ha denaro. Se ne lamenta con Belcore e questi gli offre venti scudi subito se si fa soldato. Nemorino accetta, e corre da Dulcamara a prendere un'altra bottiglia. Intanto si è sparsa la voce di una sua grossa eredità, e tutte le ragazze lo corteggiano; cosicche Nemorino, che dell' eredità non sa nulla, comincia a credere all effetto dell'Elisir, Adina che non sa neppur lei dell'eredità e lo vede contento e vezzeggiato da tutte le giovani, mentre credeva di trovarlo solo a piangere, ne resta mortificata e prova per lui un sentimento nuovo di affètto. Ancor più essa si commuove allorchè sente da Dulcamara che Nemorino comperò da lui l'Elisir della Regina Isotta e che per acquistarlo vendette la propria libertà facendosi soldato. Adina allora si propone di rapirlo alle altre ragazze. Ma anche Nemorino ha veduta una lacrima spuntare su gli occhi di Adina e sente che ormai essa l'ama. Quando Adina ritorna e gli restituisce il contratto ch'egli ha firmato con Belcore e che essa ha ricomprato, Nemorino lo respinge: se essa non l'ama egli andrà soldato a cercare la morte. A tale prova d'amore Adina alfine si confessa vinta. A Belcore non resta che presentare le armi al rivale, ciò che egli fa con soldatesca cavalleria, mentre Dulcamara rivela a Nemorino la notizia della sua nuova ricchezza: tutto effetto dell' Elisir!
A cinque mesi dalla Norma e a poco più di un anno dalla Sonnambula di Bellini, e a meno di tre anni dal Guglielmo Tell di Rossini, il teatro italiano si arricchisce di un altro capolavoro con L'Elisir d'amore di Donizetti. Anche se il libretto dice «melodramma», in realtà si tratta di un'opera comico-sentimentale. Trentaseiesima opera di un maestro trentacinquenne ma già celebre, L'Elisir d'amore è però il primo vero compiuto capolavoro donizettiano, la prima opera sua capace di resistere al tempo, al cambiamento dei gusti e degli stili; opera che dopo oltre un secolo dalla sua prima apparizione, conserva tuttora la primitiva freschezza. E (cosa stupefacente) questa meraviglia fu composta in soli quattordici giorni!
Pure derivando da Rossini, il brio e la comicità dell'Elisir d'amore hanno un'intonazione più delicata. Soltanto Dulcamara arieggia a Figaro, ma anch'egli ha una coloritura sua propria che lo distingue da ogni altra caricatura del «buffo» operistico. S'egli sa vendere la sua merce con altisonante briosità e con inesauribile parlantina (l'orchestra sotto il suo parlato è di una verve inesprimibile!), sa anche cantare con eleganza aggraziata le galanti strofette «Io son ricco e tu sei bella». In altri termini, è un fanfarone con delle arie signorili senza posa, anzi con molta naturalezza. Nei dialoghi con Nemorino e con Adina, egli conferma questi caratteri senza mai un accento enfatico o una pesantezza caricaturale, con una coerenza di stile perfetta.
Ma il personaggio musicalmente nuovo e impagabile di quest'opera, pel quale si può parlare di vera e propria creazione, è Nemorino. Non è un'aquila, d'accordo, ed è analfabeta, ma non è un cretino. È un ingenuo che l'amore ha rincitrullito: è uno «Sciocco per amore», definizione che potrebbe essere il sottotitolo dell'opera. La musica di Donizetti lo coglie nel vivo con simpatia briosa ma senza malizia. Innamorato estatico ce lo presenta subito nella cavatina «Quanto è bella quanto è cara», dalla melodia che si svolge tutta fra una carezza tenera e un sospiro di malinconia. È un canto che esprime pienamente il fascino amoroso da cui è vinta l'anima di Nemorino; fascino ribadito nel duetto con Adina, fascino che scorre nelle frasi e nei cantabili soavi e civettuoli di Adina, che, sulle labbra di Nemorino, senza cambiare una nota, acquistano un sapore patetico ed elegiaco. Come mai? Mistero dell'arte, che può dare alla medesima immagine espressioni diverse, perchè solo una sfumatura impercettibile divide l'una dall'altra.
A tutto il dialogo (e così sarà sempre in quest'opera in cui il semplice recitativo è ridotto al minimo) partecipa con una vita alacre l'orchestra, sia unendosi al canto, sia contrappuntandolo di commenti festevoli o sentimentali a seconda dei casi. Effervescente sotto questo aspetto è il dialogo tra Nemorino e Dulcamara: l'orchestra ride sotto la promessa del Dottore; esulta con trasporto, ma sempre conservando il tono di gaia commedia, sotto i ringraziamenti del giovane allocco. La certezza di possedere il toccasana dà ai ritmi di Nemorino nelle scene successive una disinvolta allegrezza campagnola, non priva di furberia. Ma come teme che sul più bello la preda gli sia tolta dall'intraprendente sergente, uditelo come rapidamente passa dall'entusiastico: «Esulti pur la barbara» all'implorante «Adina credimi, te ne scongiuro!». E allorchè crede che il farmaco incominci a volgere verso di lui il cuore di Adina, uditelo con che gioia gongolante mormora fra sè «Io già m'immagino che cosa brami». Però, come sorprende una lacrima sul ciglio dell'amata, è preso da una profonda commozione. La voce patetica del fagotto, su l'accompagnamento ondulato dell'arpa, ce ne dà l'annunzio. Al pensiero dell'amore conquistato egli è sopraffatto da un'intima tenerezza che esplode in un grido di rapimento e di effusione lirica solo alle parole «m'ama, sì m'ama, lo vedo!». Lirica di una purezza gemmea che il flauto e il fagotto chiudono col loro breve commento carezzevole.
Confessiamo che,la gioia di Nemorino è giusta:Adina non è una preda facile. È una ragazza che la musica donizettiana ci dipinge spigliata, spiritosa, e nell'elegante «Per guarir di tal pazzia», anche parecchio civetta: non tanto per le parole, quanto proprio per la volubilità leggèra della melodia, che Nemorino riprende (secondo l'usanza dei duetti melodrammatici del primo ottocento) ma volge in tono appassionato: è sempre questione di sfumature nell'interpretazione. Ma il filo sottile della malinconia entra anche in lei allorchè vede Nemorino festeggiato e vagheggiato dalle ragazze: Nella frase «Credea trovarlo a piangere» non c'è solo dispetto, ma anche un accento patetico nuovo in quanto s'accorge ora che, in fondo, gli vuol più bene di quanto avesse voluto confessare a sè stessa. Ed ecco questo nuovo sentimento risolversi nelle frasi ansiose e tenere insieme del dialogo con Dulcamara: «Quanto amore! ed io spietata!». Ma il suo spirito civettuolo non è scomparso, e sprizza ancora vivide scintille nel canto birichinissimo: «Una tenera occhiatina», che completa la fisionomia di quest'arguta ragazza. Ora si noti bene che la grandezza dell'Elisir d'amore non proviene soltanto dalla limpida bellezza dell'ispirazione melodica, ma da questo misto di gaiezza e di malinconia, di riso e di furtive lacrime, di superstizione e di realtà, di spensieratezza apparente e di intima affettività, che è rappresentazione della stessa vita.
C'è poi infine la spassosa macchietta del miles gloriosus in Belcore, che si presenta coi suoi soldati al suono di una marcetta che è la caricatura bonaria della marzialità; come nel suo complimento ad Adina, «Come Paride Vezzoso» c'è la caricatura della galanteria soldatesca, pettoruta e bonacciona. Non è disposto a lasciarsi prendere in giro, e scatta con comica irritazione contro Nemorino: «Che cosa trova a ridere cotesto scimunito», salvo a ingaggiarlo soldato, a stendergli da buon commilitone la mano, e a ridere poi fra sè con un disegno rossiniano a terzine dello strano avvenimento: «Ho ingaggiato il mio rivale: anche questa è da contar». Ma non se ne offende, quando alla fine il rivale gli porta via la promessa sposa, consolandosi col dire con un'ultima smargiassata: «Pieno di donne è il mondo, e mille e mille ne otterrà Belcore». Però non la perdona a Dulcamara, al quale, mentre parte, grida dietro «Ciarlatano maledetto! che tu possa ribaltar!».
VINCENZO BELLINI - I PURITANI: melodramma serio in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Italiano di Parigi il 24 gennaio 1835. Libretto del conte Carlo Popoli.
Atto 1° - Quadro 1° - Terrapieno in una fortezza dei Puritani presso Plymouth. - È l'alba: le milizie si destano, si accingono a nuovi combattimenti, pregano, mentre castellani e castellane festeggiano le imminenti nozze di Lord Arturo Talbo Cavaliere con Elvira, figlia di Lord Gualtiero Valton generale Puritano. Queste nozze addolorano il Colonnello Puritano Sir Riccardo Forth che di Elvira è innamorato. Essa gli era stata promessa dal padre, il quale però, conosciuto l'affetto della figlia per Arturo, non ebbe cuore di apparsi al suo sentimento.
Quadro 2° - Stanza d'Elvira. - La giovinetta teme che il padre voglia forzarla a sposare. Riccardo, ma lo zio Giorgio le comunica che il padre, pregatone da lui, ha acconsentito alle sue nozze con Arturo, e che fra foco il Cavaliere giungerà per compiere il rito. S'ode infatti venire dal campo l'annunzio che Arturo Talbo entra nella fortezza, Elvira si getta con lagrime di gioia e di riconoscenza nelle braccia dello zio.
Quadro 3° - Sala d'arme. - Arturo s'incontra con Elvira. Lord Valton consegna ad Arturo un salvacondotto affinché egli e la sposa abbiano libero il passo fino al tempio. Valton frattanto accompagnerà dinanzi al Parlamento una nobile prigioniera ritenuta spia degli Stuardi.
La Dama, rimasta casualmente sola con Arturo, gli svela di essere Enrichetta di Francia, vedova di Carlo I Stuart. Per salvarla da certa morte Arturo le cela il volto sotto il velo nuziale che con ingenuo atto Elvira le aveva posto sul capo, e fa per uscire con lei, ma Riccardo appare e sfida Arturo come rivale in amore. Nell'intromettersi fra loro Enrichetta si scopre. Riconosciuta la prigioniera, Riccardo lascia che Arturo parta con lei. Quando Elvira ritorna, apprende la fuga del fidanzato con la prigioniera e pel dolore impazzisce.
Atto 2° - Sala. - Mentre Giorgio racconta i particolari su la demenza di Elvira ai castellani, giunge Riccardo con la notizia che il Parlamento ha condannato a morte Arturo. Giorgio e Riccardo assistono piangendo ai vaneggiamenti di Elvira, e Giorgio convince Riccardo a tentare di salvare Arturo per amore di Elvira. Però all'alba i Cavalieri assaliranno i Puritani. Se Arturo sarà con loro perirà.
Atto 3° - Loggia su un boschetto presso la casa d'Elvira. - Mentre infuria un violento temporale, Arturo giunge rapidamente: ode Elvira che intona la canzone che egli era solito cantare allorchè veniva a trovarla. Anche egli la ripete; Elvira viene al noto richiamo e riconosce con gioia Arturo. Questi le spiega la ragione della sua fuga. Elvira sembra comprendere, ma poi è ripresa dal delirio. Mentre parlano vengono sorpresi: la folla irata ricorda ad Arturo che egli fu condannato a morte. A tale parola Elvira riacquista la ragione, e dichiara che se egli morrà anch'essa morirà con lui. Ma un messo reca una lettera in cui è annunziata la vittoria dei Puritani sugli Stuardi e la grazia concessa ai loro partigiani. La notizia rida a tutti la gioia.
Quest'opera segna un indirizzo nuovo nell'arte di Bellini, indirizzo che avrebbe potuto avere profonde conseguenze su la sua arte in particolare e su lo sviluppo del melodramma in generale. Se non che, Vincenzo Bellini moriva quasi improvvisamente otto mesi dopo la prima rappresentazione.
In quest'opera lo strumentale appare non solo arricchito ma avviato a ricerche espressive intentate. Ne è prova subito all'inizio dell'opera l'introduzione orchestrale, in cui il musicista ha saputo creare un'atmosfera d'ambiente poeticissima appoggiandosi a due elementi: il sorgere del sole e i richiami delle trombe che risvegliano le soldatesche. Ne sono prova anche il breve ma irruente temporale, su cui passano frasi drammaticamente gementi ed ansiose, e i preludi alle varie scene, tutti intonati alle situazioni liriche o drammatiche dei singoli momenti. I disegni melodici cercano fogge differenti dalle usate, e sono tali da richiamare spontaneamente una più ampia collaborazione da parte dell'orchestra, collaborazione la quale si manifesta lungo tutta l'opera, e in particolare nei pezzi d'assieme e nei concertati.
Fra questi ve ne sono poi taluni che hanno un robusto piglio drammatico; ad esempio, il tempestoso e insieme patetico finale 1°, dalle parole di Elvira «Dov'è Arturo?» alla chiusa. Il cupo e tragico squarcio: «Quaggiù, nel mal che questa valle serra» (atto 2°, dopo il racconto di Giorgio, e il «Credeasi, misera, da me tradita» (atto 3°), dalla frase larga e desolata che alla fine si scioglie in un canto che supera con più alto respiro il dolore, sono altre pagine di grande potenza e novità musicale e di ricca espressività orchestrale.
Non che per questo egli abbia abbandonata l'antica larga vena melodica che riassumeva in sè ogni vita lirica o drammatica escludendo quasi interamente la necessità di una intensa attività dell'orchestra e riducendola a sfondo armonico o ritmico. Eccone anzi subito un esempio nel x° atto, nell'aria di Arturo «A te, o cara». Il canto fluisce pieno di una tenerezza lievemente immalinconita dal ricordo degli affanni passati, sopra un semplice oscillare di terzine arpeggiate. Abbandono lirico che sembra interiormente illuminarsi di una luce astrale; uno di quei disegni flessibili e commossi come solo Bellini seppe fare, dal respiro lungo, completato da un motivo cullante e armonioso (che arieggia quello intercalato alla «Casta Diva») eseguito da Valton e da Giorgio in unione all'orchestra. L'effetto è pure analogo al coretto della Norma: una gran distensione di pace inonda il cuore con la forza di un incantesimo, mentre il coro procede sottovoce, a sillabe ampiamente pausate, come se temesse di turbare con la sua voce la serena dolcessa dell'ora. Che importa se così non si parla mai? Persone che nella vita comune parlassero a sillabe staccate farebbero ridere; ma la vita della musica ha tutt'altre leggi. Quei coristi potrebbero anche non dir nulla ed eseguire solo le note scritte; l'effetto sarebbe perfettamente il medesimo: un gran senso di stupore trasognato che si aggiunge al molle ondeggiare del canto e alle esclamazioni rapite di Arturo e di Elvira. Le singole espressioni fondendosi insieme determinano un'emozione simultanea complessa, quale solo la musica può dare, e solo in parte la pittura e la scultura. Questa è la ragione dei quartetti e dei concertati, ragione puramente artistica e in netta opposizione ad ogni verismo materialistico.
La classica purezza melodica belliniana riaffiora superbamente nella grande «scena della pazzia» nel 2° atto, nell'aria «Qui la voce sua soave». Calma e mesta ad un tempo, con un senso trasognato che ci porta alle soglie del mistero là dove l'umano diventa divino e il divino umano, la melodia si dispiega, completa nella parte strumentale, rotta dall'ansia e dalla follia nella voce umana, come un profondo sospiro dell'anima, lasciando in chi l'ascolta un rapimento celeste e una trepida commozione come di smarrimento. Ma alle parole «Ah! rendetemi la speme o lasciatemi morir» un languore disperato sale dal canto al cuore e lo avvolge come in una vampa struggitrice. Poi il pensiero della demente ricorre al passato: ritornano motivi festosi del 1° atto; quand'ecco ella s'accorge che Riccardo piange: una frase in ottave è attaccata fortissima su la prima nota, come per l'emozione della visione inattesa, ma subito alla seconda nota è già al pianissimo con tre p, quasi che all'improvviso sussulto sia subentrato un senso di ignoto spavento. «Forse amò...», pensa la fanciulla, e i violini commentano con movimenti pieni d'un delicato affanno. Dopo una ripresa della melodia, l'ansia cresce e precipita per fermarsi su misteriosi dolci accordi di corni. Ma a questo punto il teatro riprende il suo arbitrio tirannico imponendo un'aria di bravura: bella, slanciata, i cui vocalizzi potrebbero anche giustificarsi con la demenza di Elvira, ma per ciò non meno «aria di bravura», che richiede l'arte di una Giulia Grisi, la quale fu la prima interprete di quest'opera, per non diventare tediosa; bravura, e cioè più teatro che vita.
E di teatro, di effetto anche un po' banale, sa la cabaletta finale del 2° atto: «Suoni la tromba», pure ricca d'impeto e di forza. Tutto il duetto che precede il «Suoni la tromba» se non contiene ispirazioni particolarmente alte è però da segnalare per l'arte di fondere le frasi del dialogo fra Riccardo e Giorgio in un'unica linea melodica; arte di cui Bellini ci aveva dati altri esempi insigni, in ispecie nell'ultimo duetto della Norma fra la protagonista e Pollione.
Ci siamo soffermati su le due più ispirate effusioni liriche, ma di tali effusioni l'opera è piena, e sarebbe troppo lungo analizzarle tutte. Segnaliamo la dolce ed elevata preghiera del 1° atto «La luna, il sol, le stelle», l'appassionato «Non parlar di lei che adoro», la romanza «A una fonte afflitto e solo così poetica ed elegante ravvivata su la fine da uno slancio doloroso al quale partecipa anche l'orchestra con elegiaco abbandono. Segnaliamo pure la strofa «Nel mirarti un solo istante» che ci riporta ai più teneri canti de La Sonnambula, e l'impeto amoroso del «Vieni fra queste braccia», traboccante di incontenibile ardore, ma che richiede un tenore com'era Giovan Battista Rubini, capace di salire al re e al fa sopra il rigo! E questa è una delle ragioni, insieme al virtuosismo della donna, per cui quest'opera non può essere eseguita oggi, o se lo è ci lascia inevitabilmente scontenti. Per poter mantenere in vita i nostri capolavori del primo ottocento (e avremmo il dovere di farlo!) occorre riprendere i metodi di preparazione dei cantanti che allora si usavano; diversamente uno dei più gloriosi patrimoni della nostra storia artistica sarà perduto per sempre. Ma quando si potrà farlo? E perchè, se ci preoccupiamo tanto, e giustamente, della scomparsa del «Cenacolo» di Leonardo non dovremmo preoccuparci per la scomparsa delle opere di Rossini e di Bellini? Si dirà che di esse ci restano le partiture. Ma che cos'è una partitura se non può venire eseguita? Meno di un quadro per gli occhi di un cieco!
I cori non hanno in quest'opera, specialmente per colpa del libretto, la funzione di primo piano che avevano assunto già un po' nella Sonnambula e soprattutto nella Norma, Sono riempitivi per rinforzare, e nei concertati per accrescere varietà alla tavolozza sonora.
GAETANO DONIZETTI - LUCIA DI LAMMERMOOR: dramma tragico in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro S. Carlo di Napoli il 26 settembre 1835. Libretto di Salvatore Cammarano, tratto dal romanzo La sposa di Lammermoor di Walter Scott.
Parte 1a - atto unico - Quadro 1° - Giardino nel Castello di Ravenswood nella Scozia. - Lord Enrico Asthon, tornato da poco al castello per la morte della madre, mene a conoscere che la propria sorella Lucia è innamorata del suo mortale nemico Sir Edgardo di Ravenswood, che la salvò un giorno dalla furia di un toro. Nell'apprendere ciò Enrico avvampa di furore e giura di spegnere nel sangue l'onta, invano dissuaso da Raimondo educatore e confidente di Lucia.
Quadro 2° - Parco presso il Castello, - Il ritorno del fratello preoccupa Lucia, la quale conosce il suo odio per Edgardo. Inoltre un orribile sogno l'ha atterrita. Ed ecco giungere Edgardo: egli deve partire, e prima di allontanarsi vorrebbe rappacificarsi con Enrico, ma Lucia lo sconsiglia. Edgardo allora vuole che ella almeno gli giuri fedeltà eterna; e si scambiano in pegno un anello.
Parte 2a - atto 1° - Quadro 1° - Stanza nell'appartamento di Lord Asthon. - Enrico domanda a Lucia di spegnere nel suo cuore l'affetto per Edgardo; ella dovrà sposare Lord Arturo Buklaw. E poichè Lucia dichiara di aver giurato fedeltà ad Edgardo, Enrico le mostra un foglio, ad arte preparato, in cui è detto che Edgardo si è dato ad altra donna. Il dolore di Lucia è tremendo, pure essa non vorrebbe tradire la fede giurata; ma il fratello la sforza a cedere con le minacce. Anche Raimondo, che ha tentato inutilmente di aver notizie di Edgardo, pensa che il suo silenzio sia la prova del suo abbandono, e la consiglia a cedere al fratello.
Quadro 2° - Sala nel Castello. - Arturo promette ad Enrico il proprio aiuto per risollevare il suo partito. Intorno si levano voci festanti per le imminenti nozze di Arturo con Lucia. Questa appare nel massimo abbattimento, ma Enrico ha prevenuto Arturo dicendogli che la sorella è tuttora immersa nel dolore per la recente morte della madre. Lucia ha appena firmato, tremante, il contratto nuziale, quando entra Edgardo. Fuor di sè questi le rende l'anello, riprende il suo, e maledice al loro amore.
Atto 2° - Quadro 1° - Salone terreno nella torre di Wolferag, dimora di Edgardo. - È notte; infuria un temporale. Portato dal suo odio per Edgardo, Enrico viene a dargli la notizia che Lucia è già sposa, poscia lo sfida a duello, all'alba, fra le tombe dei Ravenswood.
Quadro 3° - Sala come nel 2° quadro dell'atto precedente. - Vi si aggira una folla festante per le nozze di Arturo e Lucia, quando entra Raimondo il quale narra come Lucia perduta la ragione, abbia trucidato Arturo. Essa infatti sopraggiunge chiamando Edgardo e delirando.
Quadro 3° - Esterno del Castel di Wolferag, presso le tombe dei Ravenswood. - Edgardo pensa di gettarsi su la spada di Enrico per morire. Mentre sta cosi meditando si ode un suono di campana a morto. Raimondo e vari cavalieri lo informano che Lucia, tratta di ragione dal dolore per le nozze impostele con inganno da Enrico, è poscia morta. A tale notizia Edgardo si ferisce e spira invocando Lucia.
Due giorni dopo la morte di Vincenzo Bellini, quasi ad affermare la perenne vitalità del genio musicale italiano, la Lucia di Donizetti trionfava a Napoli. La lotta sanguinosa fra gli Asthon e i Ravenswood determina in quest'opera, come nella tragedia shakespeariana di Giulietta e Romeo la lotta fra la casa dei Capuleti e quella dei Montecchi, un'atmosfera tempestosa di odio in cui rimangono travolti due giovani amanti appartenenti alle famiglie avverse. Quest'atmosfera rovente e procellosa Gaetano Donizetti ha saputo esprimere con forza nei ritmi veementi e nei canti infocati che caratterizzano il personaggio di Enrico e, in vari momenti, anche quello di Edgardo. Perchè, a differenza del Montecchi, Edgardo non impreca alle lotte domestiche, ma vi partecipa con un odio profondo. Solo per un istante lo udiamo dire a Lucia che vorrebbe stendere la mano in segno di pace all'avversario; ma egli aveva giurata alla famiglia degli Asthon «eterna guerra» (gli accenti donizettiani sono di una energia ferrea) su la tomba del padre uccisogli da Enrico. Soltanto l'amore improvviso e fatale per Lucia lo placa: «Ma ti vidi e l'ira tacque» (la melodia si placa anch'essa in una linea sospirosamente carezzevole e tenera).
In Asthon invece l'odio domina rabbiosamente ed esplode in ogni canto contro il rivale («Cruda funesta smania»), e contro la sorella («La pietade in suo favore»). E perciò non gli si può credere quando, per vincere l'ostilità di Lucia alle nozze con Arturo, le dice «Spenta è l'ira nel mio petto, spegni tu l'insano amor»: il turbinoso movimento dei violini nega quanto le sue parole affermano su un canto ancora troppo concitato. Di repressa ira è ansante il canto «Se tradirmi tu potrai»; ira che sentiamo ancora a stento contenuta, tanto in Edgardo, quanto in Enrico, all'inizio del concertato «Chi mi frena in tal momento», dove però per un momento un sentimento di fraterno amore e di rimorso risveglia in Enrico l'onda patetica di una melodia più ricca di abbandono e di umanità alle parole «Ah! è mio sangue, l'ho tradita». Se nella prima parte del concertato vi era qualcosa di melodrammatico, a questo punto il teatro è superato e ci troviamo faccia a faccia con la vita in un'espressione che trasfigura l'intimo dramma in canto. Il coro segna accordi e ritmo a sillabe staccate da lunghe pause, secondo un modo espressivo già caro a Bellini, e che produce un'impressione di stupito smarrimento.
Per conto suo Edgardo crede d'aver trovata la causa del Supposto tradimento di Lucia nel fatto ch'ella è dello stesso sangue dell'odiato Enrico, appartiene alla stessa «stirpe iniqua, abbominata), alla quale, più che a Lucia medesima, va la sua furente maledizione. Dei bagliori di questo lampeggiante turbine si illumina foscamente anche il duetto tra Enrico ed Edgardo che forma il 1° quadro dell'ultimo atto, e al quale sembra partecipare la Natura istessa nel breve preludio descrittivo dell'uragano.
L'amore tenero e ardente di Lucia e di Edgardo resta come isolato in questo ambiente torbido e arroventato, dal quale non può naturalmente germinare che follia e morte. Esso lo illumina e lo rischiara con le sue effusioni liriche, su cui la tragedia incombente stende un velo di intensa malinconia, che soltanto nel 2° quadro della ia parte si rischiara nel sentimento di una felicità fidente. La beatitudine estatica di questo amore audacemente ribelle e teneramente segreto splende nel timbro etereo dell'arpa che preludia all'incontro dei due giovani, e palpita nella gioia balzante di Lucia allorchè confessa alla confidente Alisa che «Quando rapito in estasi» Edgardo le «giura eterna fe'», essa dimentica ogni affanno e «gioia diviene il pianto»; e a questo punto l'inflessione della melodia trasfigura le lacrime in canto, il dolore superato si fa musica con solo un'eco poetica di dolce tristezza. E nel momento dell'addio la piena dell'affetto si riversa in quell'onda di fuoco purificatore che è la melodia «Verranno a te su l'aure». Nell'ultima ripresa i violini incielano il canto con la loro voce serafica,
Anche l'orchestra di quest'opera apporta nuovi splendori di luci e colori espressivi. L'orchestra di Donizetti è sempre ricca e varia. I timbri dolenti e cupi del preludio quel succedersi di rulli dei timpani, di armonie gravi dei corni, di accorati accenti dell'oboe, i tre improvvisi urli di tutta l'orchestra, i ritmi misteriosi e insistenti dei bassi su gli accordi dissonanti superiori, creano già il presentimento della tragedia con sintesi efficacissima.
Nel tumulto degli eventi drammatici fra cui si dibattono Edgardo e Lucia, nel naufragio di ogni loro speranza e felicità, l'amore dilata ancora le sue ali nel canto della demente. Lucia è la sorella di Nina, di Amina e di Elvira, e la malinconia infinita della sua anima ha qualcosa di diafano e di aereo, come nelle frasi ch'ella mormora trepidante e trasognata sopra la melodia del flauto. Certi cromatismi sono sospiri di dolore che si alternano a vocalizzi rapidi come vertigini della mente errante. La tragica violenza di taluni recitativi, come allorchè Lucia crede di vedere ergersi il fantasma dell'ucciso Arturo, cede ai dolenti ripetuti lagni dei violini in una frase che svaria dal maggiore al minore con un senso di desolata tristezza. Poi l'anima si apre all'estasi nel penetrante abbandono dell' «Alfin son tua».
I recitativi melodiosi di questa scena sono tutti improntati a questa trasumanata espressione di un delirio amoroso. Ma, per le convenzioni di cui viveva il teatro ottocentesco, occorreva che alla scena grave seguisse l'aria gaia, magari «di bravura». A questa convenzione obbedisce il successivo rondò «Spargi d'amaro pianto», la cui bellezza melodica peraltro lo salva. Purtroppo, però, le «dive» aggiungono a questa scena, di una verità così alta e toccante, la pirotecnica sgargiante delle gare di velocità col flauto, e tutta una serie di altre scemenze virtuosistiche, alle quali naturalmente Donizetti era ben lontano dal pensare, che fanno a pugni con l'arte e col buon senso, e di cui i pubblici di scarsa sensibilità artistica vanno fanatici. Ma la maggior colpa di queste brutture e profanazioni è di quei direttori che le permettono.
Dopo la follia, la morte solleva ancora fuori dal turbine delle vicende umane l'amore verso le regioni più pure dello spirito nella celebre aria di Edgardo: «Tu che a Dio spiegasti l'ali». Tre lunghe note di corno piene di un trasognato stupore, quasi remoti richiami dell'al di la, segnano il trapasso dall'annunzio della morte di Lucia al nuovo sentimento che investe Edgardo. Poi il flauto annunzia la nuova melodia angelicale che sorge dal profondo dell'anima commossa di Edgardo, e la voce tenorile la porta alla luce. È una purissima elegia, un pianto in cui amore e morte sono sollevati in un'aspirazione religiosa. Lo strazio umano, ed anche lo stesso verismo delle frasi monche nella ripresa dopo il suicidio, che vorrebbero dare l'impressione dello stentato parlare di chi ormai è prossimo a spegnersi, mentre il canto per disteso è passato alla voce piangente d'un violoncello, sono superati da un senso di pace ultraterrena, da una visione di cielo dove le anime amanti saranno eternamente congiunte e beate.
Che valore hanno alcune poche pagine convenzionali e caduche, alcuni passi tronfi di enfasi rettorica, di fronte a tante bellezze? E fra le cose convenzionali poniamo anche i cori, i quali hanno funzione puramente narrativa o di commento statico, ma non partecipano al dramma che come sfondo sonoro, solo in qualche momento ravvivato da più accentuata espressione. Sono i punti morti sui quali si può facilmente sorvolare in quanto la tragedia musicale non vive di essi, ma dei fremiti d'ira di Enrico, dei vaneggiamenti di quella fragile e appassionata creatura femminile che è Lucia, e del disperato amore di Edgardo. Questi tre elementi bastano a spiegare la vitalità dell'opera donizettiana e ad assicurarle l'immortalità.
GIACOMO MEYERBEER (Berlino 1791 -Parigi 1864).- GLI UGONOTTI: opera in 5 atti. Prima rappresentazione all'Opera di Parigi il 29 febbraio 1836. Libretto di Eugenio Scribe ed Emilio Deschamps. - L'azione accade nell'agosto del 1572.
Atto 1° - Sala nel castello del Conte di Nevers in Turenna, Al di là delle grandi vetrate del fondo, un giardino e un oratorio. -Il gentiluomo protestante Raul de Nangis è atteso dal Conte di Nevers e da un gruppo di giovani signori, che con lui si pongono poi lietamente a mensa. Durante il pranzo Raul racconta d'aver salvato da uno stuolo di prepotenti una bellissima ignota giovane, della quale si è fortemente innamorato. Un vecchio servo di Raul, Marcello, fiero luterano, fa ridere coi suoi modi e i suoi canti i convitati.
Frattanto una dama velata è entrata nell'oratorio ed ha chiesto di parlare a Nevers, I giovani vanno a vedere di nascosto chi è, e Raul riconosce nella donzella la giovane da lui salvata. Essa è la figlia del Conte di Saint-Bris, Valentina, la quale è venuta a chiedere a Nevers di essere sciolta dal fidanzamento al quale la costringeva il padre. Un paggio reca un foglio a Raul, nel quale lo si invita a salire sul cocchio che verrà a prenderlo e a lasciarsi condurre bendato. Non è detto nè dove, nè da chi, ma gli amici riconoscono lo stemma e il sigillo della Regina di Navarra; però non ne fanno parola con lui.
Atto 2° Il castello e i giardini di Chenonceaux in Turenna. - Valentina, dama della Regina Margherita, la informa che il Conte di Nevers rinunzia alla sua mano, e le confessa di amare Raul. Questi viene condotto bendato innanzi alla Regina, la quale gli fa togliere la benda, e gli dice di volerlo stringere a illustri nozze. Il Re vuole la pace coi protestanti, e perciò il Conte di Saint-Bris è disposto a concedergli in isposa la figlia. Giungono poscia Nevers e Saint-Bris con altri cavalieri, ai quali la Regina fa giurare la pace con i protestanti. Ma come Raul vede che la fidanzata promessagli è Valentina, ch'egli aveva sorpresa in apparente intimo colloquio con Nevers, la rifiuta. Ciò provoca lo sdegno di Saint-Bris, della Regina e di tutti i cavalieri, i quali si propongono di punire Raul per tale affronto.
Atto 3° - Pré aux Clercs a Parigi. A destra un'osteria; nel fondo una cappella. - Soldati ugonotti da un lato, studenti carlisti dall'altro, bevono e cantano insieme a donne. Passa il corteo nuziale di Nevers con Valentina, la quale rimane in chiesa a pregare. Marcello reca un biglietto di sfida di Raul a Saint-Bris, ma il confidente di questi, Maurevert, persuade Saint-Bris a cercare altra via per eliminare Raul. Per ordire il complotto entrano nella cappella, dove Valentina non vista li ascolta. Ora essa informa Marcello della congiura. Giungono poco dopo Raul e Saint-Bris coi testimoni, ma quando il duello sta per iniziarsi arrivano uomini armati. Marcello, che è all'erta, chiama al soccorso, ed ha luogo, ma violenta zuffa tra cattolici e ugonotti. L'arrivo della Regina fa cessare la lotta. Essa rivela a Raul la ragione della visita di Valentina a Nevers; ma già Nevers accompagnato da nobile corteggio viene a prendere la sposa,
Atto 4° - Sala in casa del Conte di Nevers. - Raul è venuto per parlare a Valentina e discolparsi; ma Valentina, udendo avvicinarsi il padre e lo sposo, lo fa celare dietro una tenda per evitare a lui la morte, a sè il disonore. Dal nascondiglio Raul può assistere alla congiura che si svolge per ordine della Regina Caterina di Francia allo scopo di sterminare gli Ugonotti in quella stessa notte. Nevers si rifiuta di assalire a tradimento gli Ugonotti disarmati, e Saint-Bris lo fa arrestare. Tre frati vengono a benedire le spade dei congiurati, indi tutti si allontanano. Raul vuol correre ad avvertire i fratelli; Valentina cerca di trattenerlo per salvarlo dalla strage, e gli confessa il suo amore. Tale rivelazione ferma per un attimo Raul; ma come ode suonare la campana a martello, segnale dell'inizio della strage, si distacca da lei e fugge.
Atto 5°- Quadro 1° - Sala nel palazzo di Sens. - Si sta svolgendo una festa da ballo fra dame e signori Ugonotti, allorchè Raul si precipita fra loro avvisandoli del pericolo che incombe. Tutti escono per difendersi.
Quadro 2° - Chiostro in fondo al quale è un tempio ugonotto. - Mentre Raul parla con Marcello ferito, Valentina lo raggiunge recando una sciarpa bianca, distintivo dei carlisti, con cui egli potrà porsi m salvo presso la Regina Margherita, e gli comunica che Nevers è stato ucciso e che essa può alfine amarlo senza essere colpevole. Ma Raul rifiuta di salvarsi mentre tutti i suoi correligionari periscono. Allora Valentina dichiara di convertirsi alla sua religione, e il vecchio Marcello, prima di morire, benedice le loro nozze. Frattanto si avanza un gruppo di soldati guidati da Saint-Bris. Egli chiede ai tre chi sono, e alla risposta: «Ugonotti», ordina il fuoco. Con orrore si accorge troppo tardi di aver fatto fucilare sua figlia.
L'opera Gli Ugonotti rappresenta l'esemplare più insigne della grand-opéra, creazione che discende per ipertrofia dalla Vestale di Spontini e dal Guglielmo Tell di Rossini. È l'opera-ballo di proporzioni colossali (5 atti) che aduna in sè tutto quanto la fantasia può immaginare di spettacolare: processioni, congiure, trionfi, incendi, battaglie, festeggiamenti principeschi o popolari, in sale dorate o nelle piazze, con orchestrine o bande sul palco, sbandieramenti, colpi di scena romanzeschi, avvenimenti meravigliosi, vasti movimenti di masse, danze numerose e sfarzose, scenografia grandiosa. Ma Gli Ugonotti, undicesima opera di Meyerbeer, rappresenta anche il capolavoro del compositore berlinese. Tutti i maggiori pregi, ed anche tutti i maggiori difetti della sua arte vi si riscontrano.
Difetto principale di questa, come delle altre opere minori di Meyerbeer, è la tendenza a ingrandire gli episodi a scapito della concisione drammatica. Appartengono a questo sistema tutta la prima scena dell'opera, mentre si attende Raul, e gran parte della scena del banchetto, la canzone di Marcello «Dispersa sen vada la fiera masnada» nel 1° atto; l'aria di Margherita «O lieto suol della Turenna» e i coretti che le fanno eco, il coro «Al rezzo amico», il rondò del Paggio «No, no, giammai da giovin paggio» nel 2° atto; il «rataplan», la ronda degli zingari e relativi ballabili, il lungo settimino della disfida e l'altrettanto prolisso corteo nuziale del 3° atto; l'ampiezza e la spettacolosità data alla scena della congiura e della benedizione delle spade (derivazione dell'analoga scena della benedizione delle bandiere nell'Assedio di Corinto di Rossini) nel 4° atto. È certo tuttavia che taluni di questi episodi, anche superflui e prolissi, hanno una loro bellezza, eleganza e vigorìa di forme. Tali, ad esempio, il «rataplan», la seconda parte del settimino, alle parole «Per vendicar l'offesa», molti passi della congiura (specie nella prima parte) e la benedizione delle spade.
Difetto è pure una certa superficialità edonistica della melodia a danno della profondità espressiva, la rettorica ridondanza sonora a detrimento della poesia, la predilezione per gli episodi realistici di cui il particolare esteriore interessa il musicista più della psicologia, e il rilievo dato alla pomposità vistosa al posto di un'asciutta ma veramente vigorosa grandezza.
Non è da meravigliare se in questa ricerca dell'elegante, del piacevole e dello spettacoloso, se in questo disperdersi attorno ad episodi minori, in questa deficienza di senso psicologico, i caratteri dei personaggi riescono piuttosto incerti, specialmente quelli dei due protagonisti. Raul ha tuttavia alcuni buoni momenti di estasi poetica nel racconto del 1° atto «Bianca al par di neve alpina» col soave accompagnamento della viola d'amore, e nella presentazione del 2° atto a colei ch'egli non sa ancora essere la Regina: «Oh beltade che rallegri». Meglio scolpito, nella durezza fiera dei suoi canti, è Saint-Bris; e più ancora Marcello, macchietta ed eroe insieme, tipo nuovo nel teatro. Dall'aspetto puramente macchiettistico, che gli viene dai suoi atteggiamenti di comico orrore per coloro che non sono Ugonotti e per le donne, e dalla sua canzonetta (che vorrebbe essere feroce ed è soltanto caricaturale), lo salva il sentimento religioso veramente vivo che si esprime attraverso ai corali luterani. Uno dei più importanti è 1' «Ein fest burg» che, mirabilmente svolto e contrappuntato, forma la base del preludio con cui si apre l'opera, alla quale conferisce tosto un'impronta sacra e severa. L'innesto dei corali nei pezzi d'assieme crea spesso efficacissimi contrasti drammatici.
Si deve poi rilevare che Meyerbeer fa largo uso di espressioni collettive, sollevando l'uso, convenzionale del coro e del concertato a funzione drammatica. E non si può negare in tal senso una grande efficacia al «rataplan», alla disputa fra cattolici e ugonotti nel finale del 3° atto, e alla scena della congiura e della benedizione delle armi. A ciò s'aggiunga che negli Ugonotti l'orchestra, già molto varia e ricca anche nelle opere precedenti, specialmente nel Roberto il Diavolo, qui assume un più grande interesse artistico. L'orchestra degli Ugonotti, anche se più pittorica che poetica, pure reca una notevole varietà di colori di cui si avvantaggia il dramma. Talvolta impasta timbri diversi o similari per ottenere tinte più intense. Nulla, ad esempio, di più tetro di quella fanfara barbarica affidata a trombe e tromboni sotto il coro «Rei settari, abiurar». Un effetto tragico di contrasto Meyerbeer ottiene invece nel finale del 4° atto allorchè alterna il suono funereo e lontano della campana, sostenuto da clarinetti e fagotti in pianissimo, con accordi accentati di tromboni, corni e fagotti; facendo poi scorrere poco dopo il brivido di raccapriccio delle rapide scale cromatiche discendenti dei legni sul grido di Raul «Oh ricordo fatal! Del massacro dei fratelli è il terribil segnal!».
Altre volte, come nell'accompagnamento della romanza di Raul «Bianca al par», affidato alla sola viola d'amore, o come all'inizio del giuramento di pace nel 2° atto a cui preludiano i soli timpani (Meyerbeer è il primo a trattare i timpani come istrumento cantante), o come nell'ultimo atto allorchè la voce grave e solenne del clarinetto basso commenta le tragiche nozze di Raul e Valentina, gli basta la voce di un singolo istrumento per creare l'atmosfera voluta. Nell'uso degli istrumenti, sia dal punto di vista della pura varietà timbrica come da quello della espressione, egli va oltre Weber e si può dire inauguri un'epoca nuova della musica teatrale. Si sente che c'è stato di mezzo Beethoven, ma, si può anche affermare che Berlioz e Wagner si riallacciano, oltre che a Weber, anche a lui.
Una grande densificazione espressiva è poi raggiunta con il più largo uso di procedimenti polifonici e contrappuntistici, così in orchestra come nelle voci. Tale maggior movimento delle parti e i loro contrasti intensificano fortemente l'espressione drammatica, e ciò specialmente nel finale 2° nel tumulto che si scatena allorché Raul rifiuta di sposare Valentina, e nella disputa del 3° atto. Non v'ha dubbio che questi sono due potenti affreschi sonori.
Ma il nucleo vitale dell'opera è il grande duetto del 4° atto fra Raul e Valentina. L'ampia melodia «Stringe il periglio, l'amore oblìo» è finalmente della poesia: amore e dolore vi lottano con una contenuta disperazione che si accentua nella successione ansiosa delle implorazioni reciproche: «Abbi pietà del mio martire!» - «Mi lascia, o Ciel! di qua partire!», su le sincopi dell'orchestra, per precipitare in frasi rotte (non più di due sillabe) sempre affannosamente alternate. La rivelazione dell'amore di Valentina porta una sosta in questo doloroso contrasto. Ora l'affanno è amoroso. «Come un balen, qui nel mio cor, detto suonò che mi consola». Le frasi escono ancora spezzate, ma per una trepida dolcezza che sbocca in un canto della più intensa ed estatica ebbrezza, un canto che sale e scende come un'ondata di passione, imitato dal violoncello, su un fremente tremolo degli archi: «Dillo ancor, che m'ami dì». L'ebbrezza cresce, diviene ben presto entusiasmo lirico in Raul, mentre Valentina è presa dal terrore per la propria involontaria confessione. La campana a stormo, segnale della strage, interrompe l'incantamento. Un tumulto, un ritmo precipitato che dal canto si propaga alternativamente, battuta per battuta, all'orchestra, sembra soffocare il cuore; Valentina sviene, e il turbamento prodotto da questo fatto sembra arrestare ogni moto. Ma la campana insiste implacabile, atroce, e su una ripresa del tumulto orchestrale Raul si stacca da lei e fugge per salvare i fratelli. Meyerbeer non era mai salito così alto, ne vi salirà mai più.
GAETANO DONIZETTI - IL CAMPANELLO: melodramma giocoso in un atto. Prima rappresentazione al Teatro Nuovo di Napoli il 7 giugno 1836. Parole e musica di G. Donizetti.
Atto unico. - Camera attigua a una farmacia, a Forìa, sobborgo di Napoli. Si festeggiano le nozze dello speziale Annibale Pistacchio con Serafina. Il giovane Enrico, cugino di Serafina, che l'ha amata, la rimprovera del suo abbandono. Serafina risponde per le rime ricordandogli le sue infedeltà. Mentre Enrico è implorante ai piedi di Serafina, rientra Annibale, al quale Enrico dà ad intendere che provavano insieme una scena di commedia. Frattanto suona mezzanotte. Annibale, che di buon mattino deve partire, dopo un ultimo brindisi accomiata gli invitati. Enrico però ha deciso di impedire ad Annibale di passare la notte con la sposa. Ed ecco, appena partiti gli invitati, ed entrati gli sposi nella stanza nuziale, si ode una scampanellata alla porta della spezieria. È Enrico che, travestito da damerino francese, viene a chiedere medicinali per un male al ventre. Mentre Annibale è uscito per prendere qualcosa, Enrico sposta i mobili, mette un biglietto nella serratura della stanza nuziale, spegne il lume e se ne va. Annibale tornando al buio urta nel tavolo e rovescia la terraglia che vi stava sopra; crede andare verso la porta della stanza da letto ed apre invece l'armadio. Non si (menta, chiama il servo, e intanto trova dei fiammiferi e riaccende il lume, ma resta trasecolato per lo spostamento dei mobili. Mentre si accinge a rimetterli a posto il campanello torna a suonare. È ancora Enrico sotto nuovo travestimento. Finge di essere un cantante che ha perduta la voce, e chiede un rimedio tirando in lungo le spiegazioni. Annibale gli dà una scatola di pillole; Enrico le ingoia tutte e comincia a gorgheggiare e a trillare, poscia intona una barcarola. D'improvviso ritorna rauco; Annibale gli da un'altra scatola di pillole. Enrico riprende a gorgheggiare giare, fino a che Annibale, spazientito, lo caccia fuori. Annibale fa per entrare nella camera da letto e trova nella serratura il biglietto contenente minaccie. Mentre col servo pensa a un modo per difendersi, suona di nuovo il campanello. È un vecchio (sempre Enrico travestito) che viene a raccontare gli innumerevoli mali della moglie e a chiedere che Annibale gli spedisca una lunghissima ricetta che non finisce più di leggere. Quando finalmente il finto vecchio se ne va, giungono tutti gli amici e i parenti per salutare Annibale prima della partenza, coll' augurio: «bella al par di questa notte sia la vita ognor per te!».
L'operina, composta per togliere dal pericolo di fallimento un impresario e dalla fame una compagnia di canto, è un gioiello di brio e di freschezza melodica. Il soggetto gli fu ispirato dal «vaudeville» Sonnette de nuit «che il Maestro aveva ascoltato in Francia. Tutto il libretto (per certo non inferiore a quelli di tanti altri librettisti del tempo) indica la facile spigliata vena e il gusto comico effervescente del Donizetti. L'abbondanza dei motivi, ora gai, ora umoristici, ora caricaturali, ora burleschi, non ha riscontro che nel Don Pasquale e nell'Elisir d'amore.
Dopo le musiche festose del banchetto nuziale, ecco il duetto fra Enrico e Serafina, in parte di un comico furore caricaturale (l'autore ha segnato: «con caricatura» anche per le brevi cadenze vocali alla fine della strofa di Enrico; e su i gorgheggi coi quali risponde Serafina: «con molta ironia») e in parte affettuoso. È da notare che il giovane innamorato non è un tenore; Donizetti ha qui rotta la consuetudine melodrammatica facendone un baritono. Tenore è invece il servo Spiridione.
Per amore di comicità, allorchè Enrico racconta ad Annibale il soggetto della scena che stava provando con Serafina, Donizetti non esita a contaminare l'aria «Assisa a piè d'un salice» dell'Otello di Rossini con le parole seguenti:
«Assisa a piè d'un gelso
«immersa nel dolore
«gemea trafitta Zanze
«dal più crudele amore!
Fra le pagine più piacevolmente ispirate è il vivace brindisi «Mesci, mesci e sperda il vento». Il dialogo col finto francese si svolge tutto sul consueto recitativo secco e non acquista interesse se non nella recitazione e nella mimica degli attori. La commedia non riprende nella musica se non col racconto del finto cantante: «Ho una bella», e prosegue con un fare leggermente turlupinatorio, con la sola parentesi della elegante barcarola: «Or che in ciel alta è la notte» e la scherzosa chiusa «la la la la», che con la sua felice cantabilità aumenta l'irritazione dell'infelice speziale.
L'ultimo colloquio col fìnto vecchio si svolge su un parlato sillabico uniforme, mentre l'orchestra sciorina un motivo elegante e gioioso, tipicamente donizettiano per la sua finezza; uno di quei motivi che per il loro contrasto con il rapido parlato inespressivo creano un'atmosfera di gustoso umorismo ironico.
Col ritorno dei parenti e degli amici la divertente farsa musicale si chiude con un tono di lieta festosità un tantino canzonatoria.
MICHELE GLINKA (Novospaskoje [Smolensk] 1804 - Berlino 1857). - LA VITA PER LO CZAR: melodramma in 5 atti. Prima rappresentazione al Teatro Imperiale di Pietroburgo il 9 dicembre 1836. Libretto del Barone Andrea di Rosen. - Epoca dell'azione 1613.
Atto 1° - Campagna sul fiume Sciaccia nel Domnino. -La popolzione è festante per la vittoria contro i Polacchi, figlia del contadino Ivan Sussanin, sogna il ritorno del fidanzato Bogdan Sobinin. Ma il padre la rimprovera: non è il momento di pensare all'amore mentre corre voce che i Polacchi marcino di nuovo su Mosca. Giunge frattanto in battello Sobinin il quale conferma che Mosca è salva; ma Sussanin non è ancora tranquillo e vuol differire le nozze della figlia a quando la notizia della vittoria sia certa.
Atto 2° - Sala nel palazzo occupato dal capo dell'esercito Polacco. - Ufficiali, Nobili e Dame polacchi danzano ed esultano fidenti nella vittoria finale; ma un messo reca la notizia che i Polacchi sono stati scacciati da Mosca. Ad un primo impeto dì dolore succede una vivace reazione, e i guerrieri giurano di vendicare la sconfitta.
Atto 3° - Nella capanna di Sussanin. - Perdura la gioia per la vittoria russa. Wania, orfanello raccolto e educato da Sussanin, si propone di servire e, dove occorra, di morire per la patria. Anche Antonida e Sobinin sono lieti per le ormai prossime nozze. Ma d'inprovviso irrompono nella capanna dei soldati polacchi, i quali chiedono a Sussanin che li guidi al castello dello Czar Michele. Sussanin indovina che essi vogliono rapirlo e cerca di sottrarsi a quest'incombenza ma minacciato finge di acconsentire, e di nascosto dice a Wania di correre ad avvisare lo Czar mentre egli condurrà i Polacchi nel folto della foresta. Antonida tenta invano di distogliere il padre dall'impresa e non riuscendovi sviene. Giunge frattanto il corteo nuziale; ma appreso l'accaduto, gli uomini si propongono di ritogliere Sussanin ai Polacchi.
Atto 4° - Quadro 1° - Il Castello dello Czar. - Wania giunge trafelato ed avverte le guardie del castello del pericolo che incombe su lo Czar.
Quadro 2° - Tetra foresta. - Mentre i Polacchi dormono stanchi, Sussanin, presago della propria fine prega Dio e pensa alla famiglia che resterà priva di lui. I Polacchi risvegliandosi temono di essere stati tratti fuor di strada da Sussanin, e lo interrogano su ciò. Egli risponde tergiversando; ma come vede sorgere l'alba gli sfugge il pensiero che a quell'ora lo Czar sarà già in salvo. A questa rivelazione i Polacchi si gettano furenti contro Sussanin e lo uccidono.
Atto 5° - Quadro 1° - Strada che conduce al Kremlino a Mosca. - Una folla di popolo esultante assiste alla sfilata del Corteo imperiale. Wania narra a un folto gruppo di cittadini l'impresa eroica in cui Sussanin perdè la vita per lo Czar.
Quadro 2° - Piazza del Kremlino. - Da destra avanza il corteo imperiale, seguito da gran turba di popolo. Alcuni cittadini dicono ai famigliar! di Sussanin che non piangano: il suo eroismo lo rende immortale. Frattanto giunge fra alte acclamazioni lo Czar.
La vita per lo Czar è l'opera con la quale nasce il teatro nazionale russo. Essa ha il suo fondamento nei canti popolari russi, nell'esaltazione delle gesta del popolo e nella drammatizzazione degli avvenimenti storici e delle leggende nazionali. Naturalmente, le canzoni popolari nelle trascrizioni, spesso abbastanza libere, di Glinka, assumono un alto valore artistico, cui conferisce animazione il frequente uso di modi contrappuntistici e polifonici (imitazioni e fughe). Molto spesso sono canzoni gagliarde e vigorose, talune malinconiche, ma non pessimistiche; anche gaie e festevoli, di una festevolezza un po' primitiva, quasi infantile, ma non rozza e selvaggia; oppure di una potente grandiosità. Ricordiamo tre soli esempi: i caratteristici cori con cui si apre il 1° atto, e l'energica fuga (è la prima volta che questa forma contrappuntistica viene portata su la scena dopo Mozart) con cui questa prima scena corale si chiude; il sereno e giocondo (ma non spensierato) coro dei lavoratori «Su, presti a lavorar nella foresta» nel 3° atto; il soave e fresco coro nuziale «Tra l'erba fresca», su ritmo in 5/4: una bella novità ed anche una bella audacia nell'anno 1836!
La folla si affaccia con questi canti come personaggio, vivo di un'intima robusta vita artistica. I cori costruiti da Glinka su questi motivi di canzoni formano le parti più interessanti dell'opera. Accanto ad essi fioriscono le melodie più aristocratiche dettategli dalla sua forte fantasia musicale; fantasia che, anche accettando gli schemi dell'opera italiana a recitativi arie cori e pezzi d'assieme, rifugge però da certi aspetti superficiali della melodia occidentale, come sarebbe la brillantezza e vivacità tutta esteriore dell'espressione, mentre è incline piuttosto a quella dolce malinconia anche nella gioia che è carattere fondamentale dell'anima slava.
Le parti più deboli dell'opera sono quelle che riguardano l'amore di Sobinin e di Antonida, le quali risentono dell'influsso dell'opera europea contemporanea. Non possiamo però dimenticare lo sconsolato dolore di Antonida, già presaga di sventura dopo la partenza del padre con i soldati polacchi, su la fine del 3° atto. Più rilevata musicalmente è la figura di Wania, e specialmente quella di Sussanin, con l'indimenticabile sua meditazione e la preghiera nella foresta, così nobili nella linea melodica, e già così piene di un senso di eterno nella loro sostenuta e commossa drammaticità.
Del resto questo 4° atto, dal preludio, descrivente la solitudine della foresta, alla morte di Sussanin, è ricco di intensa tragicità ed è il più potente dell'intera opera. Negli altri atti la parte più viva, ripetiamo, è quella corale che in alcune pagine assurge a vera grandezza epica, come, ad esempio, nel solenne maestoso finale dell'opera, a cui si direbbe si sia poi ispirato Mussorgski per certe scene del Boris.
Inoltre Glinka è un magnifico strumentatore, e sotto questo aspetto egli non nasconde di essere stato educato in Germania e di aver subito il fascino dei grandi strumentatori occidentali. Fra le pagine strumentali più fresche e colorite segnaliamo la bella sinfonia, costruita su alcuni dei principali motivi dell'opera; le pittoresche ed eleganti danze polacche del 2° atto, anche se sviano troppo a lungo dal dramma per concedere qualche cosa al piacere coreografico; e gli intermezzi al 4° e 5° atto.
GAETANO DONIZETTI - LA FAVORITA: dramma serio in 4 atti. Prima rappresentazione all'Opéra di Parigi il 2 dicembre 1840. Libretto di Alfonso Royer e Gustavo Väez. L'azione ha luogo nel Regno di Castiglia nell'anno 1340.
Atto 1° - Quadro 1° - Una galleria laterale del monastero di S. Giacomo. - Fernando confessa a suo padre Baldassarre, Superiore del Convento di S. Giacomo e un tempo sovrano di Castigli, di amare una bellissima ignota, e, aspramente rimproveratone dal Padre, dichiara di voler abbandonare il convento. Si allontana chiedendo invano al padre la sua benedizione.
Quadro 2° - Ameno sito su la riva dell'Isola di Leone. - Fernando giunge bendato su una barca, e ad Ines che gli toglie la benda chiede inutilmente il nome dell'ignota amante. La stessa Leonora si rifiuta di svelargli il proprio segreto, rifiuta le nozze ch'egli le propone, e lo consiglia a fuggirla. Ines annunzia che sta per giungere il re. Leonora allora esce rapidamente. Fernando, stupito, la crede principessa di sangue reale e si propone di diventarne degno compiendo illustri imprese.
Atto 2° - Galleria nel palazzo reale, dalla quale si vedono i giardini. - Alfonso XI Re di Castiglia pensa di ripudiare la moglie e di portare sul trono la favorita Leonora di Gusman. Frattanto nella sala si adunano dame e cavalieri per festeggiare Fernando, vincitore degli Arabi. Mentre si svolgono le danze. Don Gasparo, Ufficiale del Re, porge a questi una lettera d'amore scritta da Leonora a un ignoto e da lui sequestrata alla confidente Ines. Intanto Baldassarre irrompe protestando per il progettato ripudio della Regina, sua figlia. Al rifiuto del Re di allontanare Leonora, gli porge l'atto di scomunica del Pontefice.
Atto 3° - Gran sala. - Il Re ringrazia Fernando per la vittoria riportata sui Mori e giura di concedergli qualunque favore sia per chiedere. Fernando gli domanda la mano di Leonora. Alfonso, pure fortemente stupito, fedele al giuramento, ordina che entro un'ora le nozze siano concluse. Così il Re pensa di vendicarsi per il tradimento di Leonora. Ma Leonora decide di salvare Fernando dal disonore incaricando Ines di svelargli chi ella sia. Però Ines viene arrestata per ordine del Re. Questi intanto, innanzi ai cavalieri e ai dignitari consegna a Fernando brevetti nobiliari ed insegne cavalleresche. Ma i cavalieri mostrano a Fernando il loro disprezzo per avere accettato in isposa la favorita del Re, e suppongono che le onorificenze concessegli dal Re siano il prezzo dell'infamia. Fernando offeso li sfida, ma essendogli rivelata la verità, spezza la spada donatagli dal Re restituendogli le insegne, e convinto di essere stato ingannato da Leonora ne rifiuta la mano.
Atto 4° - La facciata della chiesa di S. Giacomo. - Baldassarre piange la figlia morta di crepacuore per il ripudio di Alfonso. Fernando è tuttora oppresso dall'atroce delusione provata nell'apprendere che Leonora era la favorita del Re, e rievoca con nostalgia e dolore l'immagine pura ch'egli si era formato di lei e la dolcezza dello svanito sogno d'amore. Giunge Leonora, la quale vuole ottenere il perdono di Fernando e morire. Fernando la respinge con orrore e sdegno; ma essa gli narra come Ines, incaricata di palesargli la verità, ne sia stata impedita a causa del suo arresto, e gli dice con quale purità di cuore l'abbia amato e lo ami ancora. Intenerito, Fernando cede alla forza dell'amore che tuttora arde nel suo cuore. Ma Leonora, che aveva in precedenza bevuto un veleno, cade ai suoi piedi, e muore lieta del suo perdono.
Opera disuguale, che accanto a pagine scolorite od anche banali (come ad esempio il coro «Dolce zeffiro il seconda», ne presenta altre di altissima ispirazione; accanto a costruzioni del più consueto convenzionalismo melodrammatico ci offre esempi di audace libertà creativa e di rara potenza drammatica. Il dramma si aggira attorno all'amore di Leonora per Fernando, amore che giunge al sacrificio e alla rinunzia della vita, e che perciò la redime. Questo amore fa della protagonista il personaggio fondamentale dell'opera, e fa dell'ultimo atto uno dei più forti di tutta la produzione melodrammatica dell'ottocento.
Accanto a lei Fernando, col suo rapimento amoroso di natura così spirituale, e coi suoi impeti di sdegno allorchè crede di essere stato tradito e ingannato, è pure figura di intensa espressione. La sua passione vive nel canto, e questo canto vive nel sogno, in un'atmosfera di poesia che sembra scendere in lui dal cielo e risalire dal suo pianto al cielo. I due momenti culminanti di questo incielamento sono: la romanza del 1° atto «Una vergine, un angel di Dio», e il disperato ed etereo pianto dell'aria dell'ultimo atto «Spirto gentil» (che è stata portata qui dall'opera Il duca d'Alba), alla quale i soliti «divi» usano aggiungere purtroppo una cadenza di pessimo gusto. Questa, è bene si sappia, non fu mai scritta nè pensata da Donizetti, e dal paradiso a cui ci aveva elevato la musica ci sbatte miseramente su le più tarlate tavole del palcoscenico con un salto e una botta paurosi. Ma quest'aria è un soffio divino; e in fondo non è altro che un motivo di quattro note. Un motivo di campane da morto, una vera elegia sconsolata in morte dell'amore. La seconda parte, più mossa, contiene un più doloroso pathos che via via si accentua e raggiunge lo spasimo nel reiterato «ahimè!» che con un gemito cromatico conduce alla ripresa del tema.
Una cornice di canti sacri racchiude il dramma elevandone il sentimento generale. Che cosa si poteva fare di più semplice, di più apparentemente scolastico del motivo del coro con cui si apre l'opera? Esso non è che una semplice scala di do maggiore, ascendente prima e discendente dopo; ma i contrappunti dell'orchestra e i ritmi trasfigurano l'episodio scolastico in un inno pieno di un vasto respiro religioso. Più severo e grave il cantico «Splendon più belle in ciel le stelle» dell'ultimo atto. E, a tratti, in questo 4° atto, che è tutto una meraviglia, i canti sacri si alternano al dramma umano quasi come un richiamo e un ammonimento celeste, creando un contrasto potente di ombre e di luci, di umano e di divino.
Leonora è una figura dolorante e mesta, presa da un amore che la innalza e la purifica, e dalla tragica necessità di nascondere prima e di rivelare poi all'uomo amato il proprio disonore. Essa si torce con accenti ora accorati ora di vergogna ora di orrore nella catena che sempre più la stringe; alterna gli impeti di passione a quelli di una impotente ribellione. Il suo dramma sembra condensarsi nella melodia dell'«Oh mio Fernando!» piena di sì profondo accasciamento, di così buia amarezza, e pure riscaldata dall'intimo fuoco di un amore senza più speranza.
Anche Baldassarre è figura scolpita in altorilievo con i suoi scatti di sacro furore e con la gravità di una pena smisurata. Meno efficace è riuscito Re Alfonso, che pure non manca di qualche accento di ironia torbida; ma l'espressione del suo amore per Leonora è melodrammaticamente convenzionale e stanco.
L'orchestra, ricca di colore, ma non molto diversa dalla consueta orchestra donizettiana ha una pagina di robusta fattura nella sinfonia. Le «imitazioni» tortuose del «Larghetto» e la concitazione nervosa con cui è sinfonicamente elaborato il tema fondamentale dell'«Allegretto» donano un'impronta dinamica energica al quadro che sta per aprirsi.
Se nei primi tre atti appaiono squilibri notevoli di ispirazione, il 4° atto ci mostra un Donizetti più vigoroso drammaturgo che non fosse nella Lucia. Già il preludio ci offre un contrasto stupendo tra la frase mistica dell'organo e quella fortemente patetica del violoncello. Queste due frasi si alternano fino all'attacco potente del «Maestoso» che sembra aprirci l'animo alla contemplazione della grandezza divina. Seguono i canti sacri, poi la romanza «Spirto gentil», quindi i primi recitativi di Leonora alternati ai canti religiosi interni, fino all'esplosione disperata dell'orchestra alle parole «La morte il cor m'agghiaccia». E incomincia il grande duetto Leonora-Fernando su un movimento animato dei violini che ricorda analoghi disegni della Norma. Segue la fase più drammatica della lotta fra le implorazioni appassionate di, Leonora e la malferma resistenza di Fernando, con l'amara frase di questi: «Nelle sue sale il Re t'appella». Ma al «Larghetto» di Leonora: «Pietoso al par del Nume», il canto reca un fremito di disperazione, un anelito affannoso nella linea che sale e scende, si allarga e si contrae come un'anima incatenata che si divincoli penosamente, che fa presentire Verdi. La voce di Fernando alle parole «A quell'affanno, a quell'accento)) diviene vacillante come il suo spirito in cui la fiamma dell'amore si ravviva, per riaccendersi in un grido estremo d'implorazione su la frase: «Giusto ciel! il mio furore come foglia inaridì)), per abbandonarsi alla piena dell'amore rinato nel calore travolgente del «Vieni, ah! vieni» a cui il ritmo energico dell'accompagnamento conferisce un senso di ebbrezza trionfale e fatale. Invano ora i canti sacri s'interpongono: l'impeto dell'amore si è scatenato con una forza che solo la morte spezzerà su la terra affinchè risplenda in cielo.
GIUSEPPE VERDI (Busseto [Parma] 181-Milano 1901). - NABUCCO: opera in 4 parti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 9 marzo 1842. Libretto di Temistocle Solera.
Parte 1a - Interno del tempio di Salomone a Gerusalemme. - Ebrei e Leviti alzano lamenti e preghiere a Jehova perchè li difenda dai Babilonesi che invadono il paese guidati dal Re Nabucodonosor. Il gran Pontefice Zaccaria li esorta a sperare poichè riuscì a far prigioniera la stessa figlia del Re, Fenena; ostaggio prezioso per ottenere la pace. Ismaele, nipote di Sedecia Re di Gerusalemme, riconosce in lei la fanciulla amata che lo liberò dalla prigionia dei Babilonesi. Vorrebbe salvarla, ma irrompe nel tempio Abigaille, la quale si fa credere figlia di Nabucco. Innamorata di Ismaele, essa gli offre la salvezza del popolo Ebreo se l'amerà, ma Ismaele rifiuta. Intanto una gran folla di ebrei fuggiaschi e smarriti si riversa nel tempio inseguita dai soldati babilonesi. Appare lo stesso Nabucco il quale ordina ai vinti di inchinarsi a lui; Zaccaria fa allora per svenare Fenena, ma Ismaele si interpone e la salva. Nabucco furente ordina ai suoi il saccheggio e l'incendio della città.
Parte 2a - Quadro 1° - Appartamento nella reggia di Nabucco in Babilonia. - Abigaille si è impadronita di uno scritto conservato da Nabucco, dal quale appare che essa non è sua figlia, ma figlia di schiavi. Essa medita di far uccidere Fenena e, spargendo la notizia della morte di Nabucco, impossessarsi del trono. A tale. uopo si accorda con il Gran Sacerdote di Belo.
Quadro 2° - Sala nella reggia. - Fenena, lasciata da Nabucco in sua vece a governare mentre egli è con l'esercito alla guerra, ha data libertà agli Ebrei di ritornare in patria. Essa medesima si è convertita al culto ebraico. Mentre sta per allontanarsi con gli Ebrei, Abigaille fa per carpirle la corona, ma Nabucco, improvvisamente sopraggiunto, la prende, se la pone sul capo e si proclama Dio. Un fulmine scoppia strappando la corona dal capo del sovrano e rendendolo folle. L'ambiziosa Abigaille ne approfitta per raccogliere la corona caduta.
Parte 3a - Quadro 1° - Orti pensili. - Abigaille si è fatta proclamare Regina; essa con inganno fa apporre da Nabucco il suggello reale, ancora in suo possesso, su un decreto che condanna a morte gli Ebrei. Tardi egli si accorge di aver condannata anche Fenena e di essere stato derubato dello scritto riguardante le basse origini di Abigaille; questa, insensibile alle sue implorazioni, lo dichiara prigioniero.
Quadro 2° - Le sponde dell'Eufrate. - Gli schiavi Ebrei invocano il loro Dio. Zaccaria li incita a sperare e profetizza la loro liberazione,
Parte 4a - Quadro 1° - Appartamento come nel 1° quadro della parte 2a. - Fenena viene condotta a morte. Nabucco ode le grida della folla, comprende, rinsavisce, invoca il Dio degli Ebrei, e mettendosi alla testa di guerrieri a lui fedeli corre a liberare la figlia.
Quadro 2° - Orti pensili come al 1° quadro della Parte 3 a - Fenena, confortata da Zaccaria, è già presso all'ara del supplizio, allorchè giunge Nabucco seguito da soldati. Un idolo cade miracolosamente infranto da sè, e Nabucco proclama la gloria di Jehova e la libertà per gli Ebrei. Frattanto Abigaille, presa da rimorso si è avvelenata, e spira chiedendo il perdono di Fenena, e invocando il Dio d'Isreaele.
Giuseppe Verdi, che già era apparso nel 1839 una buona promessa con l'Oberto conte di San Bonifacio, e che poi nel 1840 con l'opera buffa Un giorno di regno era stato tremendamente fischiato, col Nabucco, accolto da ovazioni deliranti, afferma per la prima volta in maniera decisiva la potenza del proprio genio.
Nabucco non è un capolavoro, ma è opera che, specialmente nel 1° atto, lo rasenta, raggiungendo in vari punti la perfezione, e che dovunque attesta la forza di una fantasia personale nuovissima. Ciò che più colpì i contemporanei, e che ancora oggi desta la più viva ammirazione, è il rapido vigore degli accenti drammatici, vigore che se talvolta appare rozzo e qua e là anche volgare, dimostra tuttavia un'indole artistica capace delle più robuste ed intense espressioni. La grandezza del 1° atto deriva anche dall'aver fatto del coro un personaggio vivo, il quale non serve come sfondo pittorico decorativo, ma partecipa attivamente all'azione. Quel suo irrompere, dopo la breve ma impetuosa introduzione orchestrale, nel grido veemente «Gli arredi festivi giù cadano infranti» dà subito la misura del genio drammatico del giovane Verdi. Il coro successivo dei bassi:«I candidi veli, fanciulle, squarciate», più lento e cupo su gli accordi gravi degli ottoni, e la preghiera seguente delle donne: «Gran Nume che voli su l'ali dei venti» su accompagnamento d'arpa e lieve aleggiare di flauti, creano contrasti d'ombre e di luci che accentuano la drammaticità delle emozioni. Poi eccolo, questo coro, dialogare con Zaccaria, ripetere solennemente a gran voce il suo canto di speranza, riprendere la sua invocazione: «ne' tuoi servi un soffio accendi che dia morte allo straniero», e l'allusione che nel '42 andava dritta all'oppressore austriaco dell'Italia non poteva sfuggire al pubblico, e acquistava dalla gagliardìa delle note verdiane una forza che sollevava i cuori. Questo, si capisce, non ha a che vedere con l'arte; ma è certo che con i cori del Nabucco, specialmente col sublime «Va pensiero», Verdi conquistava di colpo la corona di bardo della rivoluzione italiana.
Gli atteggiamenti drammatici del coro non si esauriscono con quelli enunciati dianzi. Ed ecco il movimento agitatissimo «Lo vedeste? Fulminando egli irrompe» allorchè Nabucco sta per giungere. Frasi rotte, interrogative, ritmi vibrati di terzine, accenti rudi, imitazioni, tutto qui è inteso a darci l'impressione dello scompiglio materiale e morale in cui l'arrivo del Re Babilonese ha gettato il popolo ebraico. Nelle ultime scene del 1° atto, il coro si aggiunge al concertato delle parti principali, accrescendo con la sua sonorità e i ritmi spezzati il tempestoso furore di un popolo che si crede tradito.
Negli atti seguenti il coro non è più così in primo piano, però quando entra in scena si mantiene sempre ben vivo; non già nel frivolo coro dei Magi, o nel convenzionale coro di Babilonesi: «È l'Assiria una regina», ma nella minacciosa invettiva contro Ismaele: «Il maledetto non ha fratelli», e nell'alta preghiera deglischiavi Ebrei: «Va pensiero su l'ali dorate», raro esempio di melodia corale dall'amplissimo respiro, che nella sua espressione nobile, austera e fatale, ci raffigura un popolo che sa mantenere anche nella sventura un composto dolore. L'invocazione «O mia patria sì bella e perduta» conserva anche oggi il soffio tragico che gli Italiani avvertirono oltre un secolo fa; non c'è ombra di rettorica in essa, e non abbiamo bisogno di pensare alle odierne o passate sciagure per sentire da quanto alta ispirazione discenda. Questo canto, insieme ai motivi dei cori precedentemente citati, disposti in successione senza sviluppi, e preceduti da un robusto preambolo, formano la nota sinfonia dell'opera, che per la bellezza delle idee e l'impeto ritmico esercita sempre un fascino trascinante.
Fra i personaggi non è forse Nabucco il più scolpito, per quanto non manchi di accenti vigorosi (qualche volta enfatici) e di canti patetici, come la frase che rivolge ad Abigaille: «Deh perdona, deh perdona ad un padre che delira!». Più fortemente la musica caratterizza Abigaille, nei suoi slanci impetuosi, nel suo ardore ambizioso, nel suo odio per Fenena. Il suo sogno: «Anch'io dischiuso un giorno», malgrado il taglio antiquato del pezzo e vari particolari convenzionali, è ricco di poesia nostalgica; e l'impeto gagliardo del «Salgo già del trono aurato» trasfigura la forma banale della cabaletta in un canto in cui freme il sentimento dell'orgogliosa vittoria.
Altrettanto e forse più profonda è la figura di Zaccaria: personaggio coerente dal principio alla fine nella sua fiducia nell'aiuto divino, sorretta dalla sua profetica visione degli eventi che fa di lui non un semplice pontefice, ma un essere superiore, la cui anima è in contatto con Jehova, del quale esprime la volontà. I suoi recitativi (gli ariosi recitativi verdiani che affermano fino da quest'opera la loro ricchezza e densità emotiva), commentati in maniera nutrita dall'orchestra, sono improntati a severa grandezza. Le sue arie hanno pure un disegno largo e robusto in cui si manifesta una nobiltà ieratica imponente, che si conserva anche nelle cabalette accendendole di luci austere. La pagina più alta affidata a questo personaggio, la più alta dell'opera intera dopo il coro «Va pensiero», è la preghiera «Tu sul labbro de' veggenti» che va cantata, secondo l'indicazione segnata da Verdi «tutta sottovoce» ed è accompagnata da quattro violoncelli. È un canto raccolto e patetico, umile ed alto, di chi domanda a Dio che gli conceda di esserne l'interprete per la sua gloria. Di tutt'altra natura, piena di movimento e potente di vigore, orchestrata con suggestivi colori, è invece la profezia del 3° atto: «Del futuro nel buio discerno», che completa la superba figura di questo personaggio.
Gli altri personaggi principali, Ismaele e Fenena, sono scialbi: Verdi, tutto preso dall'aspetto sacro del soggetto, e dalla preminente figura del Profeta (fu lui stesso a chiedere al Solera l'aggiunta della «profezia») sentì meno il dramma di Nabucco; quello di Fenena solo di rinesso, attraverso a Nabucco e ad Abigaille; nulla l' amore (veramente superfluo) di Fenena e Ismaele, tiratoci dentro a forza unicamente perchè non si era mai dato che si scrivesse un melodramma senza scene d'amore.
GAETANO DONIZETTI - LINDA DI CHAMOUNIX: melodramma in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro di Porta Carinzia a Vienna il 19 maggio 1842. Libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla commedia francese La perla della Savoi. L'azione ha luogo verso il 1760.
Atto 1° - Interno di una cascina a Chamounix. - L'affittuaiolo Antonio e sua moglie Maddalena sono preoccupati poichè il proprietario Marchese di Boisfleury ha minacciato lo sfratto; dal quale però è disposto a desistere, a patto di poter allevare egli stesso nel suo castello la loro figlia Linda. La ragazza è innamorata di un giovane da lei non altrimenti conosciuto che sotto il nome di Carlo, Si tratta in realtà del Visconte di Sirval, il quale ha voluto serbare l'incognito. Dopo avere ascoltata la canzone del giovane Savoiardo Pienotto, Linda si allontana appunto con Carlo. Frattanto il Prefetto ecclesiastico informa Antonio che la bontà del Marchese verso la sua famiglia è una finzione per avere nelle mani Linda, su la quale ha illecite mire. Linda viene allora affidata a Pierotto, che assieme a un gruppo di Savojardi si reca in città, con una lettera di raccomandazione del Prefetto per un suo fratello col quale andrà a stare.
Atto 2° - Elegante appartamento a Parigi in casa della Marchesa di Sirval - Linda ha accettato da Carlo, che si è a lei svelato e le ha promesso di sposarla, di abitare presso sua madre. Quivi la trova Pierotto; e quivi la trova pure il Marchese, che avendola riconosciuta alla finestra viene a proporle di andare a vivere con lui. Essa però lo scaccia indignata. Giunge intanto Carlo, il quale vorrebbe informarla che la propria madre, venuta a conoscenza del loro amore, gli ha ordinato di sposare un'altra donna, ma egli non ha cuore di dirglielo. Viene ora il padre di Linda che, vedendola in casa del Visconte, la maledice. Intanto Pierotto le annunzia le nozze di Carlo. A tali eventi Linda subitamente impazzisce.
Atto 3° - Piazza in Chamounix. - Ritornano lieti i giovani paesani. Giunge anche il Visconte, il quale confessa al Prefetto di avere rifiutate le nozze che la madre gli voleva imporre, e di essere venuto a cercare Linda. Il Prefetto lo avverte dello stato di lei, ma Carlo con l'eco dei ricordi e con l'assicurazione del suo amore risveglia in lei la memoria e la ragione smarrite.
La musica mantiene il tono di commedia sentimentale, con qualche accento più forte nei momenti drammatici, e con una parte decisamente comica, che è quella del Marchese di Boisfleury. L'aver fatto di questo tipo un personaggio da vecchia opera buffa gli toglie quanto di odioso presenta il suo carattere di vecchio libertino. Anzi questo Marchese, fatuo, borioso e vagheggino, finisce per diventare anche simpatico quando all'ultimo atto si mostra tutto festosamente lieto per le nozze del nipote Visconte di Sirval con Linda, e quando di fronte a questa si confonde e si confessa:
«ed io.
«buona Linda, io son quel tale...
E Linda, prontamente, tirando un velo sul passato,
«Ch'or sarà mio signor zio.
Tutta la parte musicale del Marchese è del miglior Donizetti: quello effervescente delle più belle pagine dell'Elisir e del Don Pasquale. Così la presentazione «Buona gente, noi siamo chi siamo» del 1° atto, il vivace duetto con Linda nel 2° atto, e specialmente nell'ultimo atto il cantabile: «Ell'è un giglio di puro candore». La prima e l'ultima scena sono rese più vive dall'intervento del coro, che interloquisce, dialoga, commenta con schietta allegria: furbo e insieme non privo di garbo.
Le arie convenzionali, quelle composte perchè ciascuno degli interpreti abbia un pezzo da cantare, ripetono le consuete forme operistiche e il consueto fraseggio donizettiano. Esse sono perciò la cosa più caduca dell'opera, per quanto spontanee e finemente disegnate. Ma toccante, indovinatissima è la canzone di Pienotto «Per sua madre andò una figlia», che si ripete più volte nel corso dell'opera non come un tema sinfonico wagneriano (nel 1842 Wagner era appena al Rienzi e stava lavorando al Vascello fantasma e al Tannhäuser) ma come un richiamo a un determinato stato d'animo: quello che lega Linda al suo paese e alla madre. Il medesimo significato ha l'altro motivo del duetto tra Carlo e Linda (atto 1°) «A consolarmi affrettisi», che ricorda a Linda l'impegno di Carlo a sposarla.
Pieni di movimento i cori, austera la preghiera con cui si chiude il 1° atto e quella più breve ma commovente dell'ultimo atto allorchè Linda ritorna in sè. Quest'ultimo atto è, del resto, il più ispirato, commosso e vario nelle sue alternative di pagine gaie, patetiche e anche drammatiche.
L'orchestra, per la quale Donizetti ha scritto una delle sue più vigorose e starei per dire beethoveniane sinfonie, è una commentatrice sempre ricca di forza e di colore. Specialmente interessanti per l'espressivo uso dello stile imitativo sono certi preludi alle scene più importanti, in particolare quello più estaticamente doloroso che precede l'entrata di Linda nell'ultimo atto.
RICCARDO WAGNER (Lipsia 18l3-Venezia 1883) - IL VASCELLO FANTASMA (L'OLANDESE VOLANTE): opera romantica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro di Corte di Dresda il 2 gennaio 1843. Testo poetico di Wagner.
Atto 1° - Riva circondata da rocce. - Spinta da un violento uragano la nave di Dalando, navigatore norvegese, getta l'ancora. Riconosciuto il luogo, Dalando ordina al pilota di vegliare mentre egli e tutti i marinai riposano; ma il pilota vinto dalla stanchezza si addormenta. Giunge frattanto nella rada il vascello dell'«Olandese volante», con le vele rosse e gli alberi neri. L'Olandese scende a terra e pensa che altri sette anni sono passati. Condannato a errare eternamente in punizione del suo orgoglio, solo una donna fedele può salvarlo. Ogni sette anni, da secoli, la speranza riappare, ma sempre lo delude; ed egli, ormai sfiduciato, invoca l'annientamento. Dalando ritornando sopra coperta vede la nave e scorge l'Olandese. Discende allora e gli domanda chi sia. L'Olandese risponde evasivamente e gli chiede ospitalità per la notte, promettendogli una preziosa ricompensa. Dalando, appresa la ricchezza dello sconosciuto, gli accorda ospitalità e gli promette la propria figlia. Senta, in isposa.
Atto 2° - Camera spaziosa in casa di Baiando. - Senta e alcune ragazze, sotto la vigilanza di Mary, nutrice di Senta, filano e cantano. Ma Senta è assorta nella contemplazione del ritratto dell'Olandese, di cui rievoca la leggenda. Ella lo ama, gli sarà fedele, lo salverà. Sopraggiunge il cacciatore Erik, il quale annunzia l'arrivo di Dalando, e rimprovera Senta per i suoi romantici sogni; vorrebbe essere amato da lei come un tempo, ma Senta si esalta sempre più al pensiero dell'Olandese. Erik fugge con raccapriccio. Ed ecco entrare il padre con l'Olandese; Senta immediatamente riconosce in questi l'oggetto dei suoi sogni, e rimasta sola con lui gli giura fedeltà fino alla morte.
Atto 3° - Una rada presso la casa di Dalando. Nella rada sono ancorati i vascelli dell'Olandese e di Dalando. - Su la nave di Dalando si beve e si canta allegramente, ma su l'altra regna un silenzio di morte; nessuno risponde ai richiami dei marinai e delle fanciulle norvegesi. Alla fine pero dai marinai olandesi si leva un coro tetro il quale termina in una risata infernale che fa rabbrividire i marinai di Dalando; poi tutto ripiomba in un silenzio funebre. Frattanto Erik cerca ancora di distogliere Senta dal suo folle amore per lo straniero e di ricondurla a sè. Il colloquio è udito dall'Olandese che, credendosi tradito, risale disperato su la sua nave e salpa. Senta allora si getta in mare dall'alto di uno scoglio. Tosto il vascello affonda e gli spiriti di Senta e dell'Olandese salgono al cielo.
È questa l'opera con cui Wagner inizia, sebbene ancora incompiutamente, la sua riforma. Il Rienzi, eseguito l'anno precedente, è ancora un'opera composta secondo le formule di Spontini e di Meyerbeer, per quanto vi si avverta già nella strumentazione e nel frequente impiego di armonie cromatiche il fremito di una sensibilità nuova. Nel Vascello fantasma Wagner si stacca completamente dal dramma a fondo storico e si accosta alle leggende nordiche più consone al suo spirito poetico, indispensabili alla creazione di un teatro tedesco. Dalle leggende passerà poscia ai miti, facendo dell'epopea de I Nibelunghi, da lui ampiamente trasformata, il vero e proprio poema drammatico-musicale nazionale della Germania.
Incomincia con Il Vascello fantasma l'uso sistematico dei «temi fondamentali» (grund-motiv), i quali servono a caratterizzare e a richiamare persone o situazioni. Più che veri e propri «temi» capaci di sviluppi sinfonici, essi sono ancora motivi di discreta ampiezza, ed anche per il loro contenuto risultano più «motivi-richiamo» che «grund-motiv», ad eccezione forse del tema dell'Olandese. I principali di questi motivi appaiono già nella mirabile sinfonia, che costituisce una sintesi strumentale del dramma. Il tema demoniaco dei corni con cui la sinfonia si apre, seguìto dallo scroscio fragoroso della tempesta, è il tema della nave maledetta, che diviene tema dell'Olandese. Calmatasi la bufera il corno inglese espone il motivo della canzone di Senta, che a sua volta diventa il terna della redenzione. Ma la burrasca riprende violenta; la lotta fra i due motivi si accende, raggiunge un'espressione di frenetica ansia, di tensione disperata. Fra questi due motivi un altro si infiltra; quello gioioso del canto dei marinai di Dalando. Poi all'improvviso si ha un brusco arresto: la nave maledetta sprofonda, il tema della redenzione trionfa in un gran palpito di gioia.
Sono questi i cardini intorno ai quali s'aggira la leggenda del Vascello fantasma, e su di essi Wagner ha costruito le pagine migliori dell'opera. Tal'è, ad esempio, il monologo dell'Olandese appena sbarcato, che si svolge su un recitativo robusto e cupo, commentato dallo squillare del suo tema selvaggio e dal motivo vorticoso della tempesta, e chiuso dall'appassionato e largo canto «Pur ancora la speranza nell'anima mi splende». Questa non è più melodia secondo le formule chiuse dell'opera italiana, e non è neppure recitativo, ma una forma sciolta intermedia, che tiene dell'«arioso»e che potrà meglio essere definito semplicemente come «canto drammatico». Definizione forse superflua, ma che tentiamo per quell'amore di concretezza a cui è sempre portata la mente quando vuol rendersi conto di qualche cosa di nuovo.
Un'altra bella pagina è la ballata di Senta, costruita sul tema dell'Olandese e su quello della redenzione o della donna fedele fino alla morte; e la maggior bellezza del brano deriva dal contrasto fra questi due motivi: tutto tenebre il primo, tutto luce il secondo.
Il racconto del sogno di Erik si regge anch'esso per la forza drammatica del tema dell'Olandese.
Altra pagina notevole dell'opera è la canzone del Pilota: «Fra tempeste e fortune il lungo errar», cui fanno d'accompagnamento in orchestra vasti soffi del vento e scrosci d'onde. Wagner, ricollegandosi a Weber, non si accontenta più della espressione pura e semplice degli stati d'animo dei personaggi e delle situazioni drammatiche, ma li avvolge nell'espressione poetica dei fenomeni naturali, ai quali è sensibilissimo. È questo un indirizzo nuovo che trova soprattutto la sua estrinsecazione nei mezzi orchestrali, i quali aggiungendo per tal modo la loro voce a quella umana ne allargano la potenza emotiva. L'uomo e l'ambiente si uniscono nella musica di Wagner in un unico fatto espressivo; l'uomo canta i suoi amori o i suoi dolori, la natura (l'orchestra) fa eco creando, a seconda dei casi, simpatie o contrasti sonori spesso drammaticissimi. È un nuovo stile che s'inaugura. A volte non la natura, ma la voce dell'inferno o del cielo risponde alla voce umana.
Un'altra pagina fresca e scorrevole, anche se si riallaccia a forme melodrammatiche francesi, è il coro delle filatrici all'inizio del 2° atto. Non sarà una pagina sublime; il canto fluisce su un contrappunto agile che vuol essere impressionistico, più che descrittivo, del girare uguale delle ruote, e la melodia ne è piacevole, ma si ha torto di dirlo scipito. Stentate e povere sono invece tutte le melodie vocali che vogliono avere la forma delle arie e cavatine secondo le vecchie formule melodrammatiche, che Wagner non sentiva.
Nel 3° atto, dopo il rude e festoso canto dei marinai di Dalando con le ragazze che portano loro da bere, in contrasto col tetro silenzio della ciurma olandese, e poscia col suo demoniaco risveglio (sempre i motivi dell'Olandese e della tempesta che risuonano in orchestra), la musica ha diversi momenti di vibrante concitazione nel duetto Erik-Senta, e una ripresa di alta ebbrezza nel finale allorchè Senta si sacrifica per la redenzione dell'uomo che ama, e sale con lui trasfigurata nella luce del sole.
GAETANO DONIZETTI - DON PASQUALE: dramma buffo in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Italiano di Parigi il 3 gennaio 1843. Il libretto è di Giovanni Ruffini, l'autore del celebre romanzo Il Dottor Antonio; ma essendo stato scritto affrettatamente, ed inoltre, com'egli scriveva alla madre, «essendo stata paralizzata la mia libertà d'azione dal Maestro», non volle che vi fosse apposto il suo nome. Un cospiratore italiano fuoruscito, Michele Accursi, acconsentì a lasciar figurare sul libretto le sue sigle: M. A.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala in casa di Don Pasquale. -Il vecchio Don Pasquale attende impaziente il Dottor Malatesta, il quale finalmente viene a dirgli che ha trovato la sposina che ci vuole per lui, ed aggiunge che è una sua sorella di nome Sofronia. Don Pasquale è giubilante, dice di sentirsi addosso «un fuoco insolito», e Malatesta promette di condurgli subito la giovane. Don Pasquale comunica poi a suo nipote Ernesto che, per punirlo dell'aver rifiutata la mano di una nobile e ricca zitella da lui propostagli, egli si sposerà e lo diserederà. Ernesto dapprima ride, ma poi ci resta male quando sente che si tratta della sorella del Dottor Malatesta. In realtà il Dottore, amicissimo di Ernesto, ha una sorella di nome Norina, che Ernesto ama riamato, mentre l'altra da lui promessa a Don Pasquale è... in convento!
Quadro 2° - Stanza in casa del Dottor Malatesta. - Il Dottore informa Norina del piano ideato per farle sposare Ernesto a dispetto di Don Pasquale. Mediante l'aiuto di un finto notaio essa sposerà Don Pasquale, ma dovrà poi farlo disperare fino a convincerlo a rinunziare a lei. La gherminella piace a Norina che se ne ripromette uno spasso.
Atto 2° - Sala in casa di Don Pasquale come nel 1° quadro del 1° atto. - Il Dottor Malatesta presenta Norina a Don Pasquale facendola passare per sua sorella Sofronia, e scusandone l'aria timida e impacciata col dire ch'è uscita da poco dal convento. Don Pasquale ne è incantato. Ma, firmato il contratto di nozze, la ragazza diventa improvvisamente audace e autoritaria, Ernesto, sopraggiunto e messo subito a parte della trappola dal Dottore Malatesta, ne è divertito; Don Pasquale è allibito; il Dottore finge di trasecolare. Norina dà ordini stupefacenti ai servitori; Don Pasquale tenta di opporsi ma essa resiste e minaccia: ne nasce un finimondo.
Atto 3° - Quadro 1° - Sala come nell'atto precedente. - Don Pasquale considera costernato le liste delle spese fatte dalla sposa, e si appresta ad opporsi a tanto sperpero di danaro. Vuole pure impedirle di andare sola a teatro. Ne succede una vivace disputa durante la quale Norina gli dà. una schiaffo, e quindi parte lasciando cadere una carta. Don Pasquale la raccoglie e vi legge un appuntamento notturno in giardino fissatole da un ignoto amante. Fuor di sè fa chiamare il Dottor Malatesta, e insieme combinano di sorprendere gli adulteri e di cacciare poi, se colpevole, la moglie.
Quadro 2° - Boschetto nel giardino attiguo alla casa di Don Pasquale. - Ernesto canta una serenata, indi si incontra con Norina; ma vengono sorpresi da Don Pasquale e dal Dottore. Mentre Don Pasquale affronta Norina, Ernesto rientra, non visto nè riconosciuto da lui. Scacciata da Don Pasquale, la finta Sofronia resiste. Don Pasquale, allora, accogliendo un suggerimento del Dottore, per far dispetto alla moglie accorda a Emesto il consenso di sposare e portare in casa quella civetta di Nonna, da lui amata. A questo punto Malatesta gli rivela che la supposta Sofronia altri non è che Nonna, e gli chiarisce la trama ordita a fin di bene. Don Pasquale fa buon viso a cattivo gioco e acconsente al vero matrimonio dei due giovani.
A un giorno di distanza dalla prima rappresentazione a Dresda del Vascello fantasma di Wagner, andava in scena a Parigi questo autentico ultimo capolavoro di Donizetti, composto in soli undici giorni! Questo lo disse il Donizetti; in realtà, dalle lettere del Ruffini, pubblicate da A. Lazzari, risulterebbe che l'opera fu composta dal 7 novembre al 15 dicembre 1842: sempre a tempo di récord! Non sappiamo quali modificazioni il musicista abbia voluto introdurre nel libretto, così da indurre il Ruffini a non lasciarvi apporre il proprio nome. Certo è che anche così la commedia è spigliata, interessante, divertentissima, e il compositore dev'essere stato preso, come già accadde per L'Elisir d'Amore, suscitando una delle più alte manifestazioni del suo genio. Ancor oggi non c'è nulla da togliere a questa opera buffa così gentile e maliziosa, in cui la rumorosa risata del Pesarese si trasforma in furbesca e aggraziata arguzia sorridente. Il comico e il sentimentale si innestano l'uno nell'altro, nascono l'uno dall'altro, con estrema naturalezza. L'aria «Cercherò lontana, terra», la cui melodia è preannunciata teneramente da un tromba nel preludio del 2° atto (e chi si aspettava dallo squillante oricalco tanta malinconia quasi fatale?), è una delle più patetiche scritte da Donizetti Ma la pagina più tenera, più nuova e più elegante della partitura è la serenata dell'ultimo atto «Com'è gentil la notte a mezzo April», popolarescamente accompagnata da chitarre, ma nel canto piena di un'effusione lirica amorosa squisitamente delicata e poetica.
L'intervento del coro dà alla costruzione del pezzo un respiro più ampio e un palpito più forte. Essa è seguita dal soave a languido «a due» tra Norina ed Ernesto: «Tornami a dir che m'ami», tutto abbandono beato. Sono due pennellate a stretto rigore non indispensabili alla commedia, ma che vi introducono un soffio di poesia che la innalza.
Del tipo comico di Don Pasquale, vecchio ringalluzzito, dalla Serva Padrona di Pergolesi al Barbiere di Rossini, l'opera buffa italiana aveva abusato, ma Donizetti ha saputo dargli una freschezza nuova di canti. Esso non è più nè brontolone, nè sospettoso, nè pedante. Don Pasquale si è messo in mente di punire il nipote Ernesto prendendo moglie e diseredandolo; così facendo egli acconsente, senza parere, a un suo desiderio di vecchio celibatario, e obbedisce alla propria istintiva avarizia. Però è un ingenuo, un po' ostinato, «buon uomo in fondo», come lo definisce il libretto. Ora, questo carattere è colto in pieno dalla musica donizettina. Se impaziente aspetta il Dottore, non è però irritato: i violini cantano un motivo quasi sentimentale; ma allorchè, dopo il racconto che delle bellezze e delle virtù di Sofronia fa il Dottore, gli si accende l'uzzolo, il suo canto si slancia sul ritmo di una danza comicamente giovanile. E quando annunzia al nipote che prenderà moglie, e lo fa su un recitativo che è quasi un parlato, l'orchestra scatta in un altro motivo vispo come un saltarello. Irascibile diventa, e si capisce, quando la sposa gliene combina d'ogni colore; e la musica lo segue con spirito e con una leggerezza comica ignota al Rossini, il quale, salvo in qualche momento del Conte Ory, scherza e ride sempre fragorosamente.
Anche Norina è una discendente di Serpina della Serva padrona e di Rosina del Barbiere, ma con un nuovo atteggiamento di commediante raffinata. Il suo programma è tutto in quel gioiello di elegante furberia che è la cavatina «So anch'io la virtù magica» dove ritmo, acciaccature, disegno melodico, tutto concorre a scolpire un carattere femminilmente astuto e deciso. È il motivo che forma il pernio della graziosa sinfonia.
La commediante sa fìngersi con arte raffinata una monacella, salvo a mostrare poco dopo con improvviso voltafaccia unghiette e dentini aguzzi da micina aggressiva in un breve recitativo pungente come uno spillone (ma tutti i recitativi del Don Pasquale sono caratteristici e gustosi). Pasquale davanti a questa trasformazione dà indietro atterrito e sgomento. Dopo lo schiaffo la musica assume quasi un tono da elegia. A rasserenare l'atmosfera ecco l'arietta giocosa e carezzevole insieme di Norina: «Via, caro sposino, non farmi il tiranno». Lo spirito ne è conciliante, ma Don Pasquale ne ha avuto abbastanza e tuona: «Divorzio! divorzio!»; la musica, sotto, riprende il fare spigliato e umoristico della commedia: sorride e scherza in modo elegante e festoso.
Il Dottor Malatesta non è un factotum come Figaro, e neppure un ciarlatano come Dulcamara. È un buon uomo inteso al bene di tutti, anche a costo di addolorare un poco un vecchio cliente ed amico. Nell' architettare la commedia egli opera da amico e da medico per guarire il malato da un grave attacco di rammollimento senile. Ci cava una burla che lo diverte alle spalle del ricco babbeo e fa l'interesse della sorella. Così ce lo dipinge senza caricatura ma con faceta ilarità la musica.
Poi ci sono le scene in cui la bellezza nasce dall'accostamento delle tinte diverse con cui sono coloriti i diversi caratteri: contrasto tra il patetico Ernesto e il bisbetico Don Pasquale; contrasto fra la prepotente Norina e l'allarmato e poi indignato sposo. E c'è poi un breve coretto nel 3° atto, l'unico coro dell'opera (toltane la partecipazione corale alla serenata d'Ernesto), quello dei camerieri: «Quel nipotino guastamestiari», di una leggerezza e festevolezza sottilmente umoristica del tutto nuova.
Per concludere aggiungiamo che alla scorrevole naturalezza del dialogo, alla maestria degli intrecci che sembrano lungamente meditati e sono invece usciti da un soffio miracoloso, si aggiunge in quest'opera l'originalità e la bellezza continua dei motivi che rinverdiscono forme che possono sembrare antiquate solo se c'è dentro una sostanza musicale spenta ed inerte.
GIUSEPPE VERDI - ERNANI: dramma lirico in 4 parti. Prima rappresentazione al Teatro La Fenice di Venezia il 9 marzo 1844. Libretto di Francesco Maria Piave, dalla tragedia di Victor Hugo.
Parte 1a - Quadro 1° - Montagne dell'Aragona. - Ernani appare mesto ai montanari ribelli della sua banda brigantesca, e ne racconta loro la cagione. Il vecchio Silva Grande di Spagna, vuol sposare l'indomani la propria pupilla Elvira, amata da Emani al quale essa ha giurato fedeltà. I banditi decidono di rapirla.
Quadro 2° - Ricca stanza di Elvira nel castello di Silva. - Elvira è in attesa di Ernani, allorchè giunge Re Carlo, che l'ama e vorrebbe esserne riamato. Improvvisamente entra Ernani: il Re lo riconosce. Mentre essi disputano, arriva Silva, il quale, non riconoscendo il Re, lo sfida insieme all'altro ignoto rivale. Ma Carlo si fa riconoscere e dice d'essere venuto per consigliarsi con lui circa la successione al trono dopo la morte dell'avo; e nell'intento di allontanare Ernani gli affida un incarico facendolo passare per un uomo del suo seguito.
Parte 2a - Sala nel palazzo di Silva. - Stanno per aver luogo le nozze di Silva con Elvira, allorchè giunge Ernani sotto le spoglie d'un pellegrino. Silva gli promette ospitalità, ma allorchè Ernani apprende che è in procinto di sposare Elvira, gli si svela. Egli aveva chiesto ospitalità nel castello perchè inseguito dal Re, che ha dispersa la sua banda. Infatti il Re giunge e chiede a Silva di Ernani, ma il vecchio, fedele al concetto che l'ospite è sacro, si rifiuta di svelargli il nascondiglio ove lo ha celato al giungere del Sovrano. Carlo allora porta con sè come ostaggio Elvira. Uscito dal nascondiglio, Ernani consegna un corno a Silva dichiarando che si ucciderà non appena ne udrà lo squillo; intanto si accordano per vendicarsi insieme del Re.
Parte 3a - Sotterraneo in Aquisgrana con la tomba di Carlo Magno. - Il Re, in attesa delle decisioni dei Grandi Elettori circa la successione all'Impero, sogna la gloria, ed entra nel monumento del grande Imperatore per pregare. Intanto nel sotterraneo si adunano ribelli, fra i quali Silva ed Ernani che congiurano contro la vita del Re. Ernani viene designato dalla sorte ad ucciderlo; ma allorchè un colpo di cannone annunzia l'avvenuta elezione di Carlo a Imperatore e questi esce dal monumento, l'attentato di Ernani viene sventato. Però Carlo V, ispirandosi alla magnanimità del sommo Imperatore, fa grazia ai congiurati, perdona ad Ernani, rivelatosi per il duca Don Giovanni d'Aragona, e lo congiunge in matrimonio con Elvira.
Parte 4a - Terrazzo nel palazzo di Don Giovanni d'Aragona in Saragozza. - Si festeggiano le nozze del Duca con Elvira, ma improvvisamente si ode lo squillo del corno che Ernani dette in pegno a Silva. Invano i due sposi chiedono pietà; la gelosia rende Silva inesorabile, ed Ernani legato dall'onore alla promessa fatta, si uccide.
Tra il Nabucco e l'Ernani c'è l'opera I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA, eseguita alla Scala l'11 febbraio 1843, e composta su un ingarbugliatissimo e caotico libretto del Solera. In sostanza si tratta di questo: un tale Pagano, innamorato di Viclinda, ferisce il proprio fratello Arvino al quale Viclinda doveva andar sposa. Recatosi in esilio in Terra Santa ne torna perdonato, ma cova ancora in cuore odio geloso pel fratello e amore violento per Viclinda. Volendo uccidere Arvino e rapire Viclinda, per errore uccide il padre. Egli ritorna allora in Terra Santa ove si fa eremita; ivi egli salva la figlia di Arvino, Giselda , e muore combattendo per il Santo Sepolcro, perdonato dal fratello. A questa azione principale un'altra secondaria se ne innesta: quella dell'amore di Giselda per il mussulmano Oronte, figlio del tiranno d'Antiochia, il quale morendo in battaglia si converte al cristianesimo, ed è battezzato dall'Eremita Pagano.
La musica conferma le caratteristiche fondamentali apparse nel Nabucco: veemenza ritmica, fuoco melodico, ariosità dei recitativi; ma tutto ciò si manifesta fra molti squilibri ed anche fra eccessi enfatici, qualche rozzo scatto e qualche banalità. Tuttavia vi sono pure i momenti di alta ispirazione; principalmente la casta preghiera di Giselda «Salve Maria», il sublime terzetto «Qual voluttà trascorrere». preceduto dall'«a solo» di violino, il solenne coro «Gerusalem, la grande!», e l'altra e più alta preghiera corale «O Signore, dal tetto natio», stretta sorella (anche se d'ispirazione meno eccelsa, ma sempre nobilissima) del «Va' pensiero»; il coro così pieno di poetica nostalgia, che al Giusti pareva come
«... voce che si raccomanda
«d'una gente che gema in duri stenti
«e de' perduti beni si rammenti».
Nell'ERNANI vi è più equilibrio, minore volgarità di accenti, più larghezza di ispirazione, più profonda caratterizzazione dei personaggi. Non manca qualche eccesso di violenza, specialmente nella parte del protagonista, il quale del resto ha anche espressioni liriche piene di delicata poesia, quale, ad esempio, la cavatina «Come rugiada al cespite d'un appassito fiore», o la rapita frase all'inizio del duetto dell'ultimo atto: «Ve' come gli astri stessi».
La figura meglio scolpita è quella di Stiva. Ci troviamo di fronte per la prima volta a un amore senile non più pretesto di risa, ma di pietà, perchè l'amore di Silva per Elvira è serio e desta in lui una gelosia capace della più atroce e inesorabile crudeltà. Dunque amore senile tragico. Nella sua cavatina «Infelice! e tuo credevi» c'è un sentimento di tristezza così sincero che toglie ogni volontà di ridere di questo folle vecchio che vuol sposare la giovane pupilla e la trova, in casa propria, contesa da ben due pretendenti! Rossini probabilmente non avrebbe resistito a ridere rumorosamente di una situazione così grottescamente buffa. Verdi no; specialmente il Verdi giovane non sa ridere. È molto se appena sorride con una. punta d'umorismo sottile, ancora remoto germe di quello che sarà l'arguto umorismo falstaffiano del Verdi ottantenne, allorchè Silva s'accorge che uno dei due rivali è il Re, e questi, un po' divertito, più che cantare quasi recita sottovoce, in mezzo allo stupore attonito degli altri, «Vedi come il buon vegliardo or del cor l'ira depone».
L'altro aspetto, quello duro, tutto geloso odio e feroce desiderio di vendetta, è nella scena in cui Silva disfida Ernani, e poscia ne accetta in pegno il corno col famoso patto: «Nel momento in che Ernani vorrai spento, se uno squillo intenderà, tosto Ernani morirà». Il motivo di questa frase, che ha un'espressione minacciosa e fatale, costituisce un tema-cardine dell'opera. Esso apre il preludio e ricompare ancora nell'ultima scena dell'opera ove più aspra e terribile si rivela la personalità drammatica e musicale di Silva. Ma di Silva debbono essere segnalati pure certi tratti austeri e decisi con cui Verdi tratteggia la sua fede al dovere dell'ospitalità e al giuramento, che si esprimono in recitativi perfettamente aderenti a questo spirito, e che diventano più energici allorchè egli esige da Ernani la stessa fedeltà alla parola data ricordandogli con estrema durezza il significato dello squillo del corno.
Re Carlo ha aspetti più vari: delicatamente amoroso con Elvira, nel cantabile «Da quel dì che t'ho veduta» e nell'aria «Vieni meco, sol di rose intrecciar ti vo' la vita», fremente di sdegno con Silva nell'arioso «Lo vedremo, veglio audace», raccolto in ambiziosa meditazione nella cavatina «Oh de' verd'anni miei», e infine già asceso in una sfera di superiore nobiltà nell'invocazione «Oh sommo Carlo» da cui prende origine il luminoso concertato finale del 3° atto. Il quale 3° atto, con le effusioni liriche di Carlo, con i misteriosi e cupi accenti della congiura e lo slanciato prorompente inno «Si ridesti il leon di Castiglia», e la scena dell'attentato, ha diritto ad una considerazione maggiore di quella in cui abbia mostrato di tenerlo certa parte della critica.
Elvira, salvo l'espansione lirica dell'«Ernani, Ernani involami», contesa dai tre uomini, è la figura musicalmente più sacrificata. Essa passa da una delusione all'altra, dall'una all'altra disperazione; e di questo essere continuamente una vittima, soffre anche dal lato musicale.
Certo, l'atto più coerente è il 4°, il quale, toltone il brillante coro d'introduzione, e dopo alcuni felicissimi recitativi e frasi del duetto fra Ernani ed Elvira, si impernia tutto su quel terzetto finale in cui Verdi mostra per la prima volta compiutamente la capacità di costruire una forma vocale polifonica in cui tre caratteri e tre stati d'animo diversissimi trovano un'espressione simultanea di eccezionale rilievo per bellezza di melodia, efficacia drammatica, armoniosità dell'insieme. Facoltà questa che toccò la perfezione nel quartetto del Rigoletto.
RICCARDO WAGNER - TANNHÄUSER: opera romantica in 3 atti. Prima rappresentazione al teatro di Corte di Dresda il 31 ottobre 1845. Testo poetico di Wagner. - L'epoca in cui è posta l'azione è il principio del secolo XIII.
Atto 1° - Quadro 1° - L'interno del «Monte Venere». Vasta grotta; nel fondo un azzurro mare nel quale nuotano Najadi e Sirene. - Tannhäuser esprime a Venere il desiderio di ritornare su la terra. Invano Venere tenta con lusinghe, minacce e seduzioni di trattenerlo, Tannhàuser canta le sue lodi, ma insiste per partire e invoca Maria. Al nome della Madonna la scena cambia subitamente, e Tannhàuser si trova in seno a una ridente valle.
Quadro 2° - Un pastore canta e suona una cornamusa; un corteo di pellegrini attraversa la scena. Tannhàuser leva al cielo una preghiera di ringraziamento. Tornando dalla caccia, il Langravio di Turingia e un gruppo di Cavalieri Bardi scorgono Tannhàuser del quale non avevano da lungo tempo notizie, e lo festeggiano. Wolframo di Escimbach gli dice l'amore ch'egli seppe destare nel cuore di Elisabetta, nipote del Langravio, e la tristezza di lei dopo la sua partenza. Al ricordo di Elisabetta, Tannhäuser si lascia convincere a ritornare al Castello di Varteburgo.
Atto 2° - La sala d'Apollo nel Varteburgo. - Tannhäuser si incontra con Elisabetta, che con ingenua semplicità gli confessa il suo affetto. Giungono quindi i Bardi e numerosi invitati per assistere a una gara poetica. Il Langravio offre la mano di Elisabetta al vincitore, in cuor suo pensando che sarà Tannhäuser, e propone per tema: «Cos'è l'amore». Wolframo inneggia all'amore celeste; ma Tannhàuser ancora soggiogato dal ricordo degli amori di Venere, inneggia all'amore sensuale. Sdegnati, altri cantori insorgono contro Tannhäuser; la tenzone si inasprisce e Tannhäuser prorompe nelle lodi di Venere presso la quale confessa di avere dimorato. Ciò prvoca il furore degli astanti che si precipitano con le spade sguainate contro di lui. Ma Elisabetta si interpone e invoca ch'egli viva per espiare la colpa. Tannhäuser preso, da rimorso corre a raggiungere un gruppo di pellegrini che si recano a Roma; non tornerà alla Corte se non perdonato dal Papa,
Atto 3° - La valle ai piedi del Vaterburgo. - Elisabetta innanzi a un'immagine della Madonna, prega per Tannhàuser. Cosi la trova Wolframo, che l'ama in silenzio con purità di cuore. Passano i pellegrini di ritorno da Roma; invano Elisabetta scruta i loro volti; Tannhäuser non c'è. Essa allora si avvia estenuata dal dolore verso il castello. Wolframo intona una mesta canzone. Udendo il suono della cetra un uomo sparuto e lacero s'avvicina: è Tannhäuser. Egli racconta a Wolframo i patimenti volontariamente cercati e sofferti con umiltà, la sua confessione al Pontefice, l'ira e la maledizione di questi: «Non sarai perdonato se non quando il secco legno del tuo bastone getterà foglie». Disperato egli vuol ritornare al Monte Venere, di cui improvvisamente appare nel fondo la visione tentatrice. Wolframo lo ferma e pronuncia il nome di Elisabetta. Tannhàuser si arresta, la visione tentatrice scompare. Nello stesso tempo un corteo funebre discende dal Varteburgo con la spoglia di Elisabetta. Tannhàuser si inginocchia innanzi alla salma invocandola; il bastone del pellegrino germoglia miracolosamente ed egli cade estinto e perdonato.
Anche in quest'opera i temi conduttori sono pochi e sono costituiti da ampie melodie. Le principali sono sviluppate nella sinfonia, in cui ancora una volta mirabilmente Wagner condensa il dramma esprimendo musicalmente la lotta fra l'amore sacro e l'amore profano. Il motivo d'apertura è appunto il canto sacro dei pellegrini, che sale d'intensità e si affievolisce come un corteo che s'avvicini e poi si allontani scomparendo alla vista. Motivi imbevuti di un erotismo acuto, di un'ebbrezza frenetica, sorgono ora, si inseguono come immagini lascive cariche di tormento delizioso, e prorompono nell'inno a Venere e all'amore. Ma un vento turbinoso sembra investirli e fugarli. Ed ecco emergere nuovamente e sollevarsi in un trionfo di luce sonora l'inno sacro.
Quando si eseguì il Tannhäuser a Parigi il 13 marzo 1861 all'Opéra, dove cadde in modo clamoroso, Wagner tolse questa parte finale della sinfonia collegando i motivi dell'amor profano alla prima scena del 1° atto, la scena del Venusberg, che ampliò accrescendone Impressione sensuale col creare un vero «baccanale» furioso, che è tutto un alternarsi di illanguidimenti e rapimenti, di fremiti voluttuosi e di impeti orgiastici sfrenati. Tutta la prima scena dell'opera vive di questa atmosfera vibrante di una vertigine morbosa dei sensi.
L'opera non conserva però sempre questo colore espressivo. Nel 2° quadro è la cornamusa del pastore che coi suoi accenti idillici crea la sensazione dell'ambiente nuovo in cui Tannhàuser è stato trasportato. All'idillio pastorale segue l'emozione sacra con il passaggio dei pellegrini. Ma le ultime scene dell'atto presentano un'ispirazione meno intensa. Nè questa ispirazione si eleva di molto nel 2° atto dove il duetto d'amore fra Tannhàuser ed Elisabetta appare un po' pallido nella sua casta e voluta contenutezza, e ripete forme operistiche sorpassate. Il preludio coi suoi motivi caldi prometteva assai più.
Un quadro pittorico Wagner ha invece saputo creare con la «Marcia e coro» che accompagna l'ingresso dei Bardi e degli invitati alla Tenzone. Gli squilli ripetuti delle fanfare, il motivo solenne e dolce iniziale, seguìto da altro assai vigoroso, la ripresa del motivo precedente insieme al coro e con espressione sempre più grandiosa e trionfale, fanno di questa musica un blocco di suggestiva e trascinante potenza. Come in questa esposizione di motivi austeri e nobili e nel loro crescendo di sonorità, magistralmente condotto, taluno abbia potuto vedere qualche cosa di volgare, non saprei. Le canzoni della gara (a parte la ricomparsa dell'inno a Venere) non sono altrettanto felici, e nel cozzo drammatico che ne segue vi è molta prolissità e qualche grigiore, non ostante alcuni accenti sentiti di Elisabetta e di Tannhäuser.
Il preludio del 3° atto è costruito con i motivi del viaggio a Roma di Tannhàuser e della maledizione papale, in contrasto col motivo della redenzione. Al preludio drammatico seguono pagine di musica ispirata, ma di svolgimento assai lento: il coro dei pellegrini che tornano da Roma, la preghiera di Elisabetta, e un brano strumentale che accompagna il suo allontanarsi.
La preghiera ha una forma ariosa, che non è più nè quella della romanza nè quella del recitativo. In essa la frase implorante: «sia la mia prece da te accolta» viene più volte ripresa dall'orchestra, fra accordi lunghi e calmi di una calma serafica, con una dolce insistenza piena di ansiosa speranza e di timore. Tutto ciò crea un'atmosfera di tristezza e di abbattimento profondi che preparano in maniera adeguata al malinconico recitativo e alla romanza di Wolframo: «Oh! tu, bell'astro incantator» di così spirituale bellezza. Non importa se il taglio della romanza è quello usuale stronco, con la differenza che invece del «da capo» il motivo viene ripreso dal violoncello; lo nobilita l'ispirazione elevata della melodia.
L'arrivo di Tannhäuser affranto, il concitato dialogo con Wolframo, e finalmente il racconto del viaggio e della condanna subìta, formano le pagine più belle dell'opera. Il racconto, che si inizia su le parole: «Col cor contrito», si svolge seguendo una linea vocale libera, che prende espressione dal contenuto verbale. Un senso di sofferenza profonda, un desiderio umile di redenzione, una concitazione spasmodica fremente, un impeto ardente di fede, si levano da ogni accento del canto, dai disegni e dai colori dell'orchestra, nati da un unico soffio di ispirazione trascendente. Ma come Tannhäuser giunge al ricordo della maledizione papale, un brivido di tragicità paurosa scaturisce dalla violenza dei suoni vocali e orchestrali; qualche cosa di tremendo e schiacciante ferma il respiro e agghiaccia l'animo d'orrore.
Ecco una pagina che non morirà anche se mille modi e mille stili mutassero col mutare dei secoli e dei gusti umani. Tannhàuser si sente dannato: i temi e i canti lascivi del Venusberg, la folle ebbrezza dei sensi gettano ancora la loro voce fascinosa nel dramma. Ancora una volta il nome di Elisabetta ferma il forsennato; un canto grave e funebre fuga le immagini sensuali. La salma di Elisabetta scende dal colle tra severe preci; il peccatore le muore accanto invocando la Santa che morendo si è fatta mediatrice tra lui e il Cielo. Un .inno di gioia si alza solenne come una benedizione.
ETTORE BERLIOZ (Côte Saint-André l803 - Parigi 1869) - LA DANNAZIONE DI FAUST: leggenda drammatica in 4 parti. Prima esecuzione in forma d'oratorio al Teatro dell'Opéra-Comique di Parigi il 6 dicembre 1846. Interpretazione libera del poema di Wolfango Goethe, nella traduzione di Gérard de Nerval. Testo dello stesso Berlioz in unione ad Almiro Gandonnière. - L'adattamento scenico in un prologo e 4 atti è di Raoul Gunsbourg. La prima rappresentazione in quésta forma ebbe luogo al Teatro del Casino di Montecarlo nel febbraio del 1893.
Prologo - Padiglione-veranda con finestre altissime, in Ungheria. - E l'alba: Faust medita su lo spettacolo della primavera che si schiude e della vita mattutina che si sveglia. Canti e danze di contadini salgono dai campi e inteneriscono l'animo di Faust; quindi la sfilata dell'armata ungherese al suono della marcia di Rakoczi suscita in lui sogni di gloria eroica.
Atto 1° - Quadro 1° - Camera da lavoro di Faust in Germania. - Di ritorno dalla campagna, il vecchio Faust è assalito dal tedio della solitudine. Sfiduciato sta per avvelenarsi, allorchè il suono delie campane e i canti dei fedeli annunciano la resurrezione di Cristo. In Faust si ridestano i ricordi della prima fanciullezza, ed egli si sente conquistato alla fede. A questo punto improvvisamente gli appare Mefistofele che lo schernisce e gli promette la felicità e ogni piacere che egli desideri fino ch'egli non dica al tempo di fermarsi. Faust, sedotto, lo segue.
Quadro 2° - La taverna di Auerbach a Lipsia. - Mefistofele introduce Faust fra gente che canta avvinazzata. Un bevitore, Brander, canta la comica storia di un topo. Un coro improvvisa una fuga su la parola «Amen». Mefistofele canta un'altra canzone su la storia di una pulce. Ma Faust è annoiato di tanta volgarità, e Mefistofele lo accompagna altrove.
Atto 2° - Un giardino di rose. - Faust, ringiovanito, riposa, e Mefistofele invita Silfi e Gnomi a danzare e cantare intorno a lui che sogna la giovane e vaga Margherita, Ridestatosi, Faust chiede a Mefistofele di condurlo da lei.
Atto 3° - Da un lato si vede l'interno della camera di Margherita, dall'altro la strada. - Passano cantando gruppi di soldati e di studenti. Mefistofele schiude l'uscio della casa di Margherita e vi fa entrare Faust, che, al sopravvenire della giovane, si nasconde.
Margherita si prepara per andare a riposare, e canta la ballata del «Re di Thule». Stanca, si lascia cadere su una poltrona e si addormenta. Fuori Mefistofele evoca dei folletti, i quali danzano un fantastico minuetto, e accompagnato da loro canta una beffarda serenata. Margherita è agitata da sogni opprimenti; si desta e scorge Faust. Tosto sboccia tra loro l'idillio amoroso; ma sta per spuntare il giorno, e Mefistofele richiama Faust. Una folla di comari circonda l'abitazione di Margherita avvertendo la madre che un uomo è in casa con lei. Nel trambusto Faust e Mefistofele si eclissano.
Atto 4° - Quadro 1° - Camera di Margherita. - La fanciulla piange il suo amore e la sua innocenza perduti. Invano essa attende Faust: egli non torna più.
Quadro 2° - Foreste e caverne. - Faust, disilluso dai piaceri del senso, cerca rifugio e sollievo nel contemplare la Natura. Il continuo scontento di Faust e le sue meditazioni allarmano Mefistofele il quale teme di perderlo. Egli allora gli racconta che Margherita sta per essere trascinata al patibolo per avere ucciso il proprio bambimo. Se vuole salvarla deve prima firmare un giuramento di servirlo domani, Faust acconsente, e poichè teme di far tardi, pronunzia la formula fatale che segna la sua morte: «Tempo t'arresta».
intermezzo - Su due neri cavalli Faust e Mefistofele galoppano velocemente in mezzo a un uragano furioso, fra strida bieche e infernali. Donne e fanciulli terrorizzati dalla corsa diabolica cadono in ginocchio e pregano. Alla fine i due cavalieri precipitano in una voragine.
Quadro 3° - L'inferno. - Dannati e demoni accolgono Faust con una ridda furibonda e assordanti clamori. Poi nel silenzio che segue una voce proclama: «Nel fondo dell'abisso un mistero d'orror si compì!».
Quadro 4° - In cielo. - Serafini genuflessi davanti all'Altissimo pregano per la salvezza della peccatrice, e l'anima di Margherita viene trasportata in Cielo fra cori osannanti.
La Dannazione di Faust fu denominata da Berlioz «opéra de concert», e come tale eseguita senza apparati scenici. Data però la sua natura eminentemente descrittiva e fantastica non diremo che il trasporto su la scena operato nel 1893 dal Gunsbourg le nuoccia, come taluno affermò con uno zelante purismo che appare alquanto esagerato. L'adattamento lascia perfettamente intatta la sostanza musicale del capolavoro, ed anzi in alcuni luoghi la figurazione scenica potenzia il suono. Non così si può dire del libretto che troppo liberamente parafrasa e spesso travisa il poema di Goethe. Però quest'opera rimane comunque episodica e frammentaria, sovente priva d'azione. Sono quadri che l'alta capacità coloristica strumentale di Berlioz, più che la non potente vena melodica, ci offre in una veste di grande interesse estetico.
Il disegno di Berlioz è sottile ed elegante, ma di una essenza più descrittiva che psicologica. Il colore deve ravvivarlo, deve farlo palpitare; ma sono i palpiti di una mente che cerca un ideale quasi astratto, i palpiti di una fantasia accesa alla ricerca del meraviglioso, piuttosto che i palpiti di un cuore commosso. Indubbiamente Berlioz è un poeta, e il sentimento della Natura, specialmente nei suoi aspetti più appariscenti, irradia l'arte sua. Non è dunque un descrittivismo verista, chè anzi il musicista è continuamente alla ricerca di un'emozione poetica, che però gli vien suggerita più dalla sua fantasia romantica che dal cuore, più da quello che vede (specialmente con gli occhi di una immaginazione favolosa) che da quello che sente. Comunque, poeta è senza dubbio, e grande poeta, se pur frammentario.
Anche nella Dannazione di Faust egli è sempre il musicista a programma della Sinfonia fantastica e dell'Aroldo. Ogni quadro potrebbe essere il tempo di una sinfonia fantastica vocale e strumentale. Inutile perciò indagare il rilievo plastico o la coerenza psicologica dei personaggi. Mefistofele, ad esempio, ora è un buon compagnone, ora si atteggia a lirico sognatore; a volte ci appare quasi, oseremmo dire, come un regista coreografico, o come un menestrello sardonico, e qualche volta, sì, è anche il demonio. Anche Faust non è sempre coerente, nè psicologicamente nè musicalmente. Lo è invece abbastanza Margherita.
Più che cercare il valore artistico dei singoli personaggi, in un'opera siffatta conviene cercare quello dei quadri. Osserveremo allora che essi si staccano dalla struttura del vecchio melodramma per accostarsi a quella del dramma musicale. Salvo che nelle canzoni stronche (quella del topolino, quella della pulce, quella del Re di Thule, e la serenata di Mefistofele), il canto segue un andamento libero da ogni convenzionalismo, aderente alle immagini poetiche suggerite dalle circostanze al compositore, sopra un commento mutevole e denso di movimenti polifonici e ritmici, disteso su una tavolozza orchestrale delle più ricche e pittoriche.
Se, come osservò già Verdi, Berlioz in vari effetti strumentali precede Wagner, assai più di Wagner si mostra audace là dove (come nel doppio coro degli studenti e dei soldati) sovrappone tempi e tonalità diverse armonizzando l'insieme con un vivace effetto di contrasto che anima di un soffio di vita realistico il quadro. Altrove è invece il senso meditativo e la poesia naturale a cui esso si ispira che formano la maggior bellezza del quadro. Tale ad esempio, il delicato 1° quadro, con il fresco ondare degli zeffiri primaverili, il garrulo gorgheggio degli augelletti e il lieve fluire delle acque. Il quadro si anima poi dei giocondi canti villerecci, delle rustiche danze campestri, per saettare, con una svolta improvvisa, nella visione eroica della trascinante «Marcia ungherese». La poesia del crepuscolo svolge i suoi veli d'ombra e mistero nel suono della ritirata che si perde in lontananza, e nell'altra meditazione di Faust: «A te grazie, o crepuscolo», su l'atmosfera verginale che aleggia nella stanza di Margherita. Un quadro più profondo di poesia della Natura ci offre la meditazione di Faust: «Natura immensa impenetrabil», con quel vasto e solenne disegno dei bassi che sembra sprofondarci in un abisso arcano dove le sole forze naturali hanno il loro regno. La poesia del sonno come riposo dello spirito e porta di sogni voluttuosi è nel canto di Mefistofele: «Su queste rose», accompagnata dalle gravi quasi magiche armonie dei tromboni. Ma altri quadri ci affascinano per i loro elementi fantastici; tali il lieve aereo coro dei Gnomi e delle Silfidi durante il sonno di Faust, e l'ancor più eterea e immateriale danza seguente tessuta di colori evanescenti, immersa in una trasparenza d'alba lunare. Più fiabesco e diabolicamente bizzarro è invece il minuetto dei folletti, che termina in una ridda con accentuazione aritmica.
Quadri in cui il fantastico domina con potenza tragica sono anche quello della «Corsa all'abisso)) e quello del «Pandemonio». Il primo si svolge su un ritmo che incalza, affannosamente caracollante, fra canti di preghiera dolenti, sinistri cachinni, gemiti misteriosi, e il rombo veemente dell'uragano. Il «Pandemonio» è una voragine di suoni e di voci terrificanti, a cui contrasta l'ultimo episodio, in cui archi e legni sostengono coi loro disegni blandamente ondulati il candore di un canto che non ha più nulla di questa terra e delle sue passioni. E vale la pena di notare come questo canto trasfigurato di spiriti beati, sia ben diverso da quello più umanamente osannante che annunzia a Faust la solennità festiva della Pasqua.
Nel duetto d'amore è forse un certo disagio dovuto all'intima deficienza di calore della vena melodica berlioziana. Non così nell'atto successivo, allorchè Margherita canterà, su un'affannosa palpitazione dei bassi, la desolata melodia preannunziata dal corno inglese: «Perduta ho la mia pace». In questa frase è veramente un infinito sconsolato dolore, che il corno inglese prolunga riprendendo come un'eco profonda il canto. Mettiamo accanto ai quadri le canzoni stronche, le quali formano degli episodi a sè stanti, come le umoristiche canzoni di Brander e di Mefistofele nella taverna di Auerbach, la mordace serenata di Mefistofele con l'accompagnamento degli archi imitante le chitarre, e la mestissima canzone del «Re di Thule» con l'accompagnamento malinconico delle viole.
OTTO NICOLAJ (Königsberg 1810 - Berlino 1849) - LE VISPE COMARI DI WINDSOR: opera comico-fantastica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro di Corte a Berlino il 9 marzo 1849. Libretto di Salomone Mosenthal, tratto dall'omonima commedia di Shakespeare.
Atto 1° - Quadro 1° - Una grande corte, - La signora Fluth e la signora Reich hanno ricevuto una uguale lettera d'amore dal vecchio gaudente Sir Giovanni Falstaff, e combinano di punirlo dell'audacia, burlandosi di lui. Intanto Fenton, giovane povero, chiede al signor Reich la mano della figlia Anna, ma il padre gliela rifiuta pensando che lo stupido ma ricco Sperlich sia miglior partito, mentre la moglie vorrebbe darla al vecchio rodomonte Dottor Cajus, ufficiale francese in ritiro.
Quadro 2° - Camera in casa di Fluth. - La signora Fluth, fingendo di aderire al desiderio amoroso di Falstaff lo ha invitato in casa propria. Improvvisamente giunge la signora Reich la quale annunzia l'arrivo del gelosissimo signor Fluth. Falstaff mene nascosto dentro la cesta del bucato e portato via dai servi. Fluth entra con vari amici, mette invano a soqquadro la casa alla ricerca dell'amante di sua moglie, ed è schernito dagli amici.
Atto 2° - Quadro 1° - Trattoria. - Falstaff fu rovesciato con la biancheria sporca nell'acqua di un fossato; si consola bevendo, ma, incorreggibile, abbocca ad un nuovo invito della Fluth. Intanto il marito della Fluth, spacciandosi per certo Bach, si confessa innamorato della Fluth, e respinto da lei. Chiede a Falstaff, noto per le sue imprese galanti, di conquistarla. Ciò proverebbe falsa la virtù della Fluth e aprirebbe a lui la porta per farsi amare. Falstaff, al quale il finto Bach offre dell'oro per tale impresa, accetta, e gli annunzia d'aver ricevuto un nuovo invito dalla signora Fluth.
Quadro 2° - Giardino in casa Reich. - Sperlich e Cajus vorrebbero parlare ad Anna del loro amore, ma essa giunge solo al richiamo di Fenton, e il loro dialogo è ascoltato dai rivali celati dietro gli alberi.
Quadro 3° - Stanza nella casa di Fluth. - Falstaff è venuto al nuovo convegno con la Fluth, ma la signora Reich accorre di nuovo annunziando l'arrivo del geloso marito. Falstaff viene travestito da vecchia e fatto passare per la zia della serva. Fluth la scaccia a legnate e con gli amici si dà poi a rovistare invano la casa in cerca di Falstaff.
Atto 3° - Quadro 1° - Camera in casa di Fluth. - Già informato dalla moglie dell'accaduto, Fluth combina con lei e con la Reich di invitare Falstaff a un appuntamento nel parco di Windsor per beffarlo. Il padre e la madre di Anna vorrebbero approfittare della festa al Parco per far sposare Anna rispettivamente dal loro protetto mediante un travestimento, ma Anna per conto suo pensa di approfittare dei travestimenti per sposarsi a Fenton.
Quadro 2° - Il parco di Windsor. - Falstaff giunge al convegno travestito, secondo la leggenda, da «Cacciatore nero» e si ritrova con la Fluth e la Reich; ma si ode frastuomo, e le donne fingendosi spaventate fuggono. Una gran folla entra, mascherata da Streghe da Silfidi e Spiriti guidati da Titania (Anna) e da Oberon (Fenton).
Tutti si gettano su Falstaff punzecchiandolo e tormentandolo in mille modi. Alfine Falstaff scorge nella folla le signore Fluth e Reich, e capisce d'essere stato burlato. Intanto in causa del travestimento Cajus si trova ad aver sposato... Sperlich! Ma Anna e Fenton, sposi per davvero, si prostrano innanzi ai genitori e vengono perdonati insieme a Falstaff.
Composta nelle forme del vecchio melodramma, con arie chiuse, qualche superflua ripetizione e qualche convenzionale cadenza vocale, quest'opera è il frutto di una ispirazione felice per scioltezza e per fresca vivacità. Tali caratteri, uniti ad altri pregi, specialmente a quelli inerenti a una fattura sapiente ed elegante, le assicurano la vita anche accanto ad un capolavoro di tanto maggior finezza e profondità, com'è il Falstaff di Verdi. Tuttavia, l'opera del Nicolaj, che non è un'opera d'avanguardia ma ripete le forme del suo tempo, presenta i lati migliori dell'epoca in cui nacque ed è sorretta da un'invenzione melodica personale. Perciò ancor oggi essa non ha sofferto se non in minima parte le ingiurie del tempo.
La musica ha un sapore di burla spigliata a garbata nelle scene comiche, e di una delicata poesia in quelle sentimentali e fantastiche, reggendosi su disegni che non ripetono quelli di nessun altro. C'è l'impronta dell'epoca ottocentesca in cui l'opera fu scritta, nobilitata da una bellezza di forme originali permeate da un fresco spirito di vita. Giustamente l'Abbiati osserva che «l'eleganza dei disegni e la fresca umoristica ispirazione delle Vispe comari del Nicolaj, pongono questa partitura più vicino alle espressioni verdiane che non alle settecentesche di Salieri», il quale compose anch'egli un Falstaff assai scialbo.
Lo stile fonde la chiarezza e concisione vocale italiana all'eleganza francese, mentre per qualche tratto dell'elaborazione strumentale e per la felice compenetrazione dell'aria e del recitativo espressivo richiama Mozart, come per qualche elemento fantastico si rifà a Weber. Ma tutto ciò avviene con una perfetta assimilazione che non soffoca l'originalità della vena, e fra uno svariare di ritmi e di armonie che accresce vita e brio.
Particolarmente curata è la parte della signora Fluth la quale trae dalla musica del Nicolaj una scintillante e fresca gaiezza. Essa è veramente la più vispa comare, e attratta dal gioco pericoloso vi si getta con tutta la sua onesta e giovanile impetuosità e furberia. La scena del 1° atto in cui da sola prova i modi con cui può trarre in inganno e burlare il grosso donnaiolo, è un vero capolavoro di pittura psicologica musicale.
Anche Falstaff è tratteggiato con gustoso umorismo nella sua senile e grossolana sensualità. La fatua e, nei ritmi irregolari, ballonzolante canzone «Di latte in vece a me bambin», ce lo dipinge anche, stupendamente, beone. Un esempio mirabile di rizzante umorismo è tutta la scena del 2° atto in cui Fluth, presentandosi a Falstaff sotto le spoglie di un ipotetico Bach, lo invita a sedurre la propria moglie. Le confessioni espansive di Falstaff, così sincere perchè lontane da ogni sospetto, il racconto dei particolari dell'avventura della cesta in cui riuscì a sottrarsi allora del geloso Signor Fluth, la notizia del nuovo appuntamento, le spavalde vanterie del seduttore, le reazioni represse di Fluth, trovano il musicista pronto a coglierne gli aspetti comici e spassosi con un riso musicale scorrevole e gustoso. Ma, naturalmente, bisogna non pensare a quello ch'è diventata questa scena attraverso al libretto finissimo di Boito e all'arguzia genialissima della musica di Verdi.
Con fervido senso caricaturale la musica schizza i due sciocchi innamorati di Anna, Sperlich e Cajus; ma Fenton è avviluppato dalla tenerezza di un amore che si effonde in accenti di particolare calore, specialmente nella melodiosa serenata «Odi, canta l'usignol». E questa non è la sola bella pagina di effusione lirica; fra le varie altre ricordiamo il poetico episodio orchestrale del sorgere della luna nel parco di Windsor all'inizio della mascherata di cui Falstaff farà le spese.
LUIGI e FEDERIGO RICCI (fratelli - L.: Napoli 1805-Praga 1859; F.: Napoli 1809-Conegliano 1877) - CRISPINO E LA COMARE: melodramma fantastico-giocoso in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro S. Benedetto a Venezia il 28 febbraio 1850. Il libretto di Francesco Maria Piave, graziosa satira dei medici, è derivato da una vecchia commedia dal titolo Medico e la Morte ovvero il Dottore ciabattino.
Atto 1° - Quadro 1° - Un Campo a Venezia. - Il calzolaio Crispino è pieno di debiti e senza un soldo. La moglie. Annetta, giovane e bella, fa la venditrice di storielle, ma nessuno le compera. Il padrone di casa Don Asdrubale tenta di sedurla, e Crispino accorso in sua difesa vien minacciato di sfratto se non paga la pigione. Disperato, Crispino corre via; la moglie lo segue.
Quadro 2° - Luogo remoto con pozzo nel mezzo. - Crispino sta per gettarsi nel posso, quando improvvisamente ne esce la Comare. Essa vuol salvarlo e gli propone di essere medico. Crispino si protesta ignorante, ma la Comare gli dice: quando visiterai un ammalato, se mi vedrai vicino a lui morirà, se non mi vedi vivrà. E intanto gli dà un sacco di monete d'oro per pagare i debiti.
Atto 2° - Scena dell'atto 1° quadro 1°. - Mentre si ride di Crispino che si proclama dottore, vien recato morente un muratore caduto da un'impalcatura. I medici lo dichiarano spacciato, ma Crispino afferma che guarirà. Si fa portare cibi e bevande che in parte ingolla e in parte applica sul morente, e questi rinviene fra lo stupefatto disappunto dei medici e 1° entusiasmo del popolo.
Atto 3° - Quadro 1° - La stessa scena dell'atto precedente, salvo che la casa di Crispino è superbamente rifabbricata. - Il Contino del Fiore, innamorato di Lisetta, figlia dell' avaro Don Asdrubale, prega il medico Fabrizio di convincere il padre della ragazza a dargliela in moglie. Egli rinunzierà alla dote.
Quadro 2° - Interno di farmacia. - Il dottor Mirabolano accusa Crispino di avergli sollevato un cliente; il dottor Fabrizio tenta invano di comporre la lite dei due rivali.
Quadro 3° - Salotto in casa di Don Asdrubale. - Lisetta è spacciata da un consulto di dottori. Crispino dice che vivrà e la fa sposare al Contino. Intanto appare la Comare presso Don Asdrubale. Crispino vedendola dice che Asdrubale sta per morire di sincope, il che infatti avviene fra la meraviglia dei medici.
Quadro 4° - Salotto in casa di Crispino. - Crispino trova la moglie che sta allegramente merendando con amici e parenti. Crispino va in furia, scaccia tutti e minaccia la moglie. Gli appare la Comare che lo rimprovera, ma avendo minacciato anche lei, la Comare lo fa sprofondare.
Atto 4° - Quadro 1° - Volta sotterranea con grandi statue del Giudizio e del Tempo. - La Comare svela a Crispino chi essa è: la Morte; e gli annunzia ch'egli sta per morire, Crispino chiede mezz'ora per rivedere la famiglia. La Comare allora gli fa vedere in uno specchio la moglie e i figli che pregano per lui. Crispino commosso chiede perdono. La scena cambia improvvisamente.
Quadro 2° - Stanza in casa di Crispino, dove questi rinviene fra la famiglia e gli amici festanti.
Che si parli ancora di quest'opera oggi, e specialmente qui, fra la Dannazione e il Lohengrin, può far sorridere. Ma non è men vero che nel momento in cui apparve (a parte il genio eccezionale di Verdi in gestazione) essa rappresentava quanto di meglio poteva offrirci l'arte italiana. Essa è ancora la testimonianza di un mondo artistico in via di scomparsa, e ci fa sentire nella sua modesta ricchezza la povertà del momento; povertà, ripetiamo, controbilanciata, se Dio vuole in modo esuberante, dalla sola potentissima fantasia di Verdi. L'accennarvi potrà chiarire meglio la situazione mondiale del teatro d'opera nel momento in cui in Francia appare, non compreso, il genio rinnovatore di Berlioz, mentre in Germania sta per affermarsi con Wagner un teatro nazionale in una forma artistica delle più rivoluzionarie, e alla vigilia della sfolgorante esplosione verdiana del Rigoletto, del Trovatore e della Traviata.
Circa la musica del Crispino e la Comare è anzitutto da osservare che, malgrado siano stati in due a scrivere l'opera, l'unità dello stile è perfetta, per l'identica sensibilità . dei due fratelli. Poi va detto che, non ostante la trama così ingenua (come s'accontentavano di poco i nostri nonni e bisnonni!), farebbe ancora piacere di sentire quest'opera per la freschezza spigliata e spiritosa della musica. Essa non perde mai il tono burlesco della commedia, neppure nei momenti più apparentemente drammatici, quali la disperazione e il tentato suicidio di Crispino e la mone improvvisa di Don Asdrubale. Com'è carina quella Lisetta che vede morire il padre e non se ne dà per intesa, anzi si sposa subito col Contino! Se librettista e compositore avessero preso questa morte sul tragico e avessero fatto prorompere la figlia in grida strazianti di dolore, addio commedia! Se si vuole, ciò è un poco anche satirico, come volutamente satiriche sono certe intonazioni del canto che intendono appunto (e le didascalie dei musicisti ne sono una prova) di parodiare il modo di cantare degli attori melodrammatici, certe forme caricate dell'operistica ottocentesca, ed anche i passi tipici dei ballerini nei vecchi Balli scenici del secolo scorso.
Non diremo che questa musica sia sempre originalissima, ed è inutile insistere qui su le evi denti derivazioni rossiniane e donizettiane; ma è innegabile che alla fluida scorrevolezza dell'ispirazione fa riscontro la piacevolezza dei motivi e, talvolta, un caratteristico strumentale (setacci e mortai da farmacisti nell'introduzione del 1° atto, colpi di martello del ciabattino, imitazione del tintinnio delle monete quando Crispino batte sul sacchetto donatogli dalla Comare, e del somare forte allorchè Crispino soffia sul viso del muratore morente, l'uso grottesco della tromba, della grancassa e del tamburo nell'introduzione del 3° atto allorchè il coro inneggia a Crispino dottore, ed anche, nell'ultimo atto, l'harmonium per accompagnare la preghiera della moglie e dei figli di Crispino, ad imitazione dell'organo). Non mancano, specialmente nel 1° quadro dell'ultimo atto, anche talune pittoresche intonazioni di carattere magico e fiabesco.
Fra le pagine più indovinate sono da mettere la canzone di Crispino «Una volta un ciabattino» (atto 1°), il terzetto dei dottori (atto 3°, quadro 2°), la canzone di Annetta «Piero mio» (atto 3°, quadro 4°), e l'elegante e leggero valzer finale dell'opera.
RICCARDO WAGNER - LOHENGRIN: opera romantica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro di Corte di Weimar il 28 agosto 1830. Testo poetico di Wagner. - L'azione ha luogo nella prima metà del secolo X.
Atto 1° - Un prato sulle sponde della Schelda presso Anversa. - Re Enrico l' Uccellatore, venuto a raccogliere un esercito per marciare contro gli Ungari, si duole di trovare i Brabantini in discordia fra loro, e ne chiede a Federico di Telramondo la cagione. Questi, suggestionato dalla moglie, accusa la principessa Elsa di Brabante di aver assassinato il fratello Goffredo, erede al trono, Federico, che doveva sposare la giovinetta, inorridito per tale misfatto, vi ha rinunciato sposando Ortruda Radbod. Egli accusa inoltre Elsa di avere un amante segreto. Il Re invita Elsa a scolparsi. Essa, come trasognata, parla di un misterioso cavaliere apparsole, al quale affida la propria difesa. Un araldo chiama l'ignoto campione; ed ecco, fra lo stupore generale, giungere un cavaliere in armatura d'argento su una barchetta guidata da un cigno. Rese grazie al cigno, salutato il Re, il Cavaliere chiede ad Elsa se voglia sposarlo. Avutone il consenso, egli aggiunge che essa deve giurare di non chiedergli mai né il nome nè donde sia venuto. Elsa lo giura. Allora il Cavaliere sfida Talramondo, e in duello lo abbatte, facendogli però grazia della vita.
Atto 2° - Il castello di Anversa. - E notte. Ortruda convince lo sposo ch'egli è stato vinto per arte magica da un incantatore, e si propone di spingere Elsa a chiedergli il nome. Elsa appare al balcone del castello; l'incauta si lascia impietosire dai lamenti di Ortruda e la introduce nel castello. Levatosi il sole, un araldo legge al popolo e ai soldati un proclama del Re: Ortruda e Telramondo dovranno andare in bando; il Cavaliere, dopo le nozze con Elsa, condurrà l'esercito contro gli Ungari. Ma Telramondo circola nascostamente fra i soldati dicendosi vittima di una stregoneria e dichiarando che presto darà prove della propria onorabilità. Esce intanto dal Castello il corteo nuziale; ma allorchè Elsa fa per entrare in chiesa, Ortruda le si para innanzi rinfacciandole le oscure origini del suo salvatore. Anche Telramondo si pone al suo fianco accusando di malefizio il cavaliere del cigno; questi però respinge con sdegno l'accusa. Ortruda e Telramondo sono cacciati in bando, ma Elsa appare turbata dal dubbio che si è insinuato nell'animo suo.
Atto 3° - Quadro 1° - Stanza nuziale nel castello. - Un corteo accompagna Elsa e il Cavaliere, ormai sposi. Rimasti soli, essi effondono la piena del loro amore, ma Elsa vorrebbe, almeno nell'intimità, poter dare un nome allo sposo. Invano il Cavaliere cerca di deviare il discorso, di rassicurarla e di ricordarle il giuramento. Elsa è presa da una smania crescente; il veleno del dubbio insinuatole da Ortruda la rende come demente, e dichiara che anche a costo della vita vuol conoscere il suo nome. Nello stesso momento Telramondo irrompe nella stanza con quattro armati per assalire il Cavaliere, il quale lo uccide; gli altri si prostrano. Il sogno d'amore è distrutto; il Cavaliere ordina che il cadavere di Telramondo sia portato via, indi chiama le ancelle alle quali consegna Elsa semisvenuta. Davanti al Re ella saprà il suo nome.
Quadro 2° - La stessa scena del 1° atto. - Il Cavaliere si presenta al Re e a tutti i guerrieri e narra quanto è avvenuto nella notte. Alla categorica domanda di Elsa è costretto a rispondere: egli mene dal castello del San Gral i cui cavalieri scendono in campo in difesa dell' innocenza. Il cielo accorda loro sempre vittoria, ma una volta conosciuto il loro segreto debbono ritornare al Gral; il suo nome è Lohengrin, figlio di Parsifal Re del Gral. Ed ecco che il cigno giunge per condurre via il Cavaliere. Ad Elsa questi annuncia che Goffredo non è morto, e le lascia la spada, un anello e il corno affinchè glie li consegni quali talismani miracolosi al suo ritorno. Ma Ortruda infernalmente gioisce per aver distrutta la felicità di Elsa, e svela che il Cigno altri non è che Goffredo da lei stessa così tramutato. Allora Lohengrin cade in ginocchio e prega; ed ecco il miracolo: il cigno si trasforma nuovamente in Goffredo, mentre una colomba scende a guidare la navicella su la quale Lohengrin si allontana. Ortruda cade tramortita con un grido di rabbia impotente, mentre Elsa muore di dolore fra le braccia di Goffredo.
«Questa volta - scriveva Wagner a Liszt - io mi sono affaticato a porre la poesia e il dramma in così intima e plastica relazione che mi tengo assolutamente sicuro del fatto mio». Per poesia Wagner intende anche la musica, la quale infatti mai prima d'ora nelle opere wagneriane era stata, se non nel racconto di Tannhäuser, in così intima e plastica relazione col testo letterario e con l'azione. Intorno all'intima connessione fra musica e dramma, che costituisce uno dei cardini dell'arte wagneriana, come Io era già stato per i maestri della Camerata fiorentina, per Monte verdi e per Gluck, Wagner ritorna anche in un'altra lettera a Liszt, nella quale afferma che «ogni battuta della musica drammatica è giustificata solo quando essa esprima qualche cosa nell'azione o nel carattere degli attori».
Domina l'opera un'atmosfera mistica che si sprigiona fino dalle prime note del preludio. Questo preludio, con quelle sue note iniziali alte e lunghe e con l'etereo motivo del Gral sembra spalancarci di colpo le porte del cielo e ci rapisce nella contemplazione dell'infinito. Il passaggio del tema dalle note sovracute dei violini in pianissimo ad altri strumenti e finalmente agli ottoni in fortissimo con un graduale crescendo di intensità sonora e di luminosità, ci solleva da una impressione angelica remota di sconosciute dolcezze alla visione gloriosa del trionfo divino in tutta la sua grandezza e potenza; dalla invocazione della grazia alla realizzazione del miracolo. Come nel preludio, ogni canto ogni frase, ogni gesto del protagonista è imbevuto di luce serafica.
Il misticismo wagneriano, dal quale non si può prescindere in quanto forma tutt'una cosa con la ispirazione musicale, è il sentimento della natura considerata nei suoi più sublimi e arcani misteri; è una religiosa esaltazione della umanità pura e forte come le sorgenti stesse della vita. Lohengrin è uno di questi spiriti purissimi: è 1'incarnazione della potenza del bene, il redentore che atterra la colpa (Telramondo-Ortruda), difende e solleva l'innocenza oppressa (Elsa), ridona la vita (Goffredo). Ma in Wagner il sentimento cristiano è una trasfigurazione del paganesimo. Lohengrin è una incarnazione divina che viene fra gli uomini per amare un mortale; in lui perciò si rinnova il mito di Giove e Semele. Come il dio pagano, richiesto dall'amante che le si sveli nelle sue forme vere non può rifiutarsi, pure conoscendo che il suo splendore la ucciderà, così Lohegrin, ad Elsa che lo interroga, non può tacere l'esser suo, pure sapendo che ciò lo costringe a partire e ad ucciderla. Il mito della redenzione e il mito della rinunzia: ecco i due cardini principali di tutta la costruzione drammatico-filosofica dell'opera di Riccardo Wagner.
Il senso di splendente vibrazione stellare che nasce dalla musica caratterizzante il personaggio di Lohengrin è accresciuto dal contrasto che proviene dalle cupe ombre infernali con cui è dipinta Ortruda. Ombre che si riflettono necessariamente, dopo il 1° atto, su Federico di Telramondo, il quale in fondo è onesto e non ha altra colpa che quella di prestar fede a Ortruda, personificazione del demonio. Il suo canto perciò è improntato a balda sicurezza e a nobiltà cavalleresca, mentre i canti di Ortruda sono tortuosi e violenti. La scena in cui questa forza maligna circola col tema bieco di Ortruda e si espande con un fascino pauroso pieno di suggestione è la prima del a° atto, ed è anche la scena più liberamente concepita dal lato musicale, con una novità sciolta di forme che è la prima vera rivelazione del Wagner futuro.
Fra la luce azzurra o dorata di Lohengrin e l'ombra nera o violacea di Ortruda, c'è il candore di Elsa, la quale, se nel 1° atto e fino alla fine del 2° subisce i riflessi di Lohengrin e si colora, nei temi che la caratterizzano, della propria innocenza e dell'estasi amorosa che la pervade, nel 3° va rapidamente offuscandosi per 1'influsso diabolico di Ortruda fino ad assumere toni fiammeggianti di delirio. L'incubo che la opprime e che la conduce all'errore e alla colpa è espresso nel tema imperioso e fatale del divieto di Lohengrin, tema che appare la prima volta, in forma vocale, su le parole «Mai devi domandarmi», e che, dopo varie ricomparse risuona terribile in orchestra alla fine del duetto del 3° atto quando Elsa sta per infrangere il giuramento, e dopo la violazione di esso.
Anche nel Lohengrin Wagner non fa un uso sistematico dei temi fondamentali. Essi sono pochi, ma compaiono con maggior frequenza che nelle opere precedenti, lasciando tuttavia largo posto a forme vocali e strumentali di quadratura perfetta. Però queste sfumano le une nelle altre e si saldano intimamente senza lasciare mai soluzione di continuità.
In questo fluido tessuto musicale, più costantemente geniale che nelle opere anteriori (il melenso coro del 3° atto «Lieti e fedel» è un'eccezione), in cui non solo i personaggi ma anche il coro ha talora una parte di primissima importanza, alcuni episodi emergono con un più alto rilievo. Bellissima è l'estasi allucinata della musica che accompagna l'entrata e il racconto di Elsa (1° atto); ma l'arrivo di Lohengrin provoca un movimento di stupite esclamazioni interrogative, ammirative e finalmente entusiastiche della folla, in un intreccio di una verità e di una potenza elettrizzante che sale al parossismo allorchè tutte le voci si uniscono nel grido «Miracolo! Miracolo!», e verrebbe la tentazione di scattare in piedi e di urlare col coro. Ma mentre la folla così si agita e palpita, l'orchestra annunzia il meraviglioso evento con un tremulo acuto dei violini sul quale le trombe, pianissimo, fanno squillare, come dall'al di là, il motivo di Lohengrin. Un disegno concitato sale dai violoncelli ad accrescere la tensione. L'orchestra è tutto un mare di brividi e di fremiti ansiosi che aumenta di sonorità fino all'esplosione fortissima del tema di Lohengrin e all'entusiastico scatto della moltitudine. Poi tutto si placa in un silenzio reverente di attesa mentre Lohengrin rivolge il suo mistico saluto di ringraziamento al cigno. La forma qui è totalmente rinnovata. Per la prima volta il senso del miracoloso è portato su la scena in un'espressione musicale che l'artista ha saputo rendere di colpo con un'assoluta perfezione di stile e forza evocativa.
Nel 2° atto segnaleremo il dolcissimo canto di Elsa «Aurette, a cui sì spesso», di una così ingenua purezza di linee che riflette la limpida purezza dell'animo e la serena letizia della giovane sposa, non ancor tocca dal veleno del dubbio. Questo canto così schietto e semplice (nauti clarinetti e violini paiono illuminarlo di bianca luce lunare), crea un drammatico contrasto con la scena precedente (Ortruda-Telramondo) e con la successiva (Ortruda-Elsa) nella quale l'inferno penetra nel paradiso, e i due mondi avversi si insinuano musicalmente l'uno nell'altro con trapassi e opposizioni che riescono tanto più efficaci in quanto l'angelo non sa di avere accanto il demonio. Si ripete, con altra veste, la scena biblica di Eva tentata dal serpe col viso di uomo giusto.
Pieno di poesia è, nello stesso atto, il sorgere dell'alba, con la sveglia suonata dalle trombe che si rispondono lente a diverse distanze. I cori successivi abbassano il livello dell'ispirazione, che però si risolleva con bellezza superba di forme durante la sfilata del corteo nuziale e nell'ultima scena, allorchè il demonio-Ortruda rivela la propria natura.
Il preludio del 3° atto, coi suoi motivi riboccanti di una festosità rumorosa, porta una nota di colore esteriore, ma vigorosa. Ed ecco, dopo il brutto coretto «Lieti e fedel», il duetto Lohengrin-Elsa, culmine del dramma, in cui il sentimento passa dall'amore più etereo al tormento del dubbio e al cozzo dell'Inferno, che rivive in Elsa, col Cielo di cui Lohengrin è il campione. Il crescendo della folle curiosità da cui Elsa è dominata, il frenetico scatenarsi della bufera spirituale che la sconvolge, l'epilogo tragico con l'attentato a Lohengrin e la morte di Federico, sono graduati con una sapienza meravigliosa e portati ad un'altezza espressiva di cui l'arte musicle non conosceva altri esempi.
Nella 2a parte .dell'atto il centro del dramma è il racconto di Lohengrin, recitativo-arioso o canto drammatico, di forma sciolta, tutto imbevuto di un rapimento trascendentale. I suoni acuti, sottili, eterei, quelli con cui s'inizia il preludio dell'opera, lo preparano; essi ci portano subito ad un'altezza suprema, ci introducono nel mistico regno del San Gral. Ogni nota sembra calare da questo mondo arcano in cui domina la più pura virtù cavalleresca, e la grazia divina fa risplendere ogni anno il sangue del Redentore rinnovando la forza e la vita ai custodi della coppa santa. Tra il fruscio degli archi, il fluire di un motivo sovrumanamente dolce, passano leggeri clangori di trombe che suscitano bagliori dorati e recano come l'eco di remoti gloriosi misteri. La rivelazione dell'origine, del nome e della paternità regale e sacra è scandita con accenti di solenne fierezza su accordi pieni degli ottoni, sfolgoranti di luce radiosa.

Foto 7: Scena di Reigebert per il Fidelio di Beethoven.

Foto 8: Scena di Benois per l'Ernani di Verdi.
Il dramma poi precipita col tenero addio di Lohengrin, soffuso di profonda malinconia, col nuovo etereo saluto al cigno, e non senza il vibrante sfolgorio di un altro miracolo: la rinascita del giovane Goffredo dal cigno, e la discesa della mistica colomba; miracolo in cui si perde la catastrofe finale della morte di Ortruda e di Elsa.
[Torna all'indice]
III.
Ottocento (1851-1900)
GIUSEPPE VERDI - RIGOLETTO: melodramma in 3 atti. Prima rappresentazione a La Fenice di Venezia l'11 marzo 1851. Libretto di Francesco Maria Piave, tratto dalla tragedia Le Roi s'amuse di Victor Hugo. - La scena si finge in Mantova e dintorni nel secolo XVI.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala magnifica nel palazzo ducale. - Ha luogo una festa sfarzosa. Il Duca, che ha visto in chiesa una giovane avvenente, già vagheggia nella mente il pensiero di conquistarla. Amore? No; «questa o quella per me pari sono», confessa egli. Frattanto corteggia la bella Contessa di Ceprano, il cui marito è fatto segno ai frizzi mordaci del buffone di corte Rigoletto. Un cortigiano rivela agli amici che Rigoletto possiede un'amante. Ceprano, volendo vendicarsi delle parole motteggiatrici di Rigoletto congiura con gli altri di rapirgliela. Nel colmo della festa il cortigiano Monterone, la cui figlia fu sedotta dal Duca, mene a reclamare riparazione per l'onore offeso; ma Rigoletto lo befla e il Duca lo fa arrestare. Monterone allora impreca al Duca e maledice Rigoletto.
Quadro 2° - L'estremità più deserta d'una via cieca, A sinistra casa con piccola corte cinta da un muro; a destra il palazzo del Conte di Ceprano. - È notte. Rigoletto è sotto l'incubo della maledizione scagliatagli da Monterone. Su la soglia della casa, ove abita la figlia Gilda, egli incontra un masnadiero il quale gli si offre per uccidere qualunque suo nemico. Rigoletto rifiuta l'aiuto di Sparafucile, ma si fa dire dove potrà trovarlo all'occasione. Entra poi nel cortile ove raccomanda alla figlia di non uscire; e raccomanda pure alla governante di vegliare su lei. Mentre parla, la governante fa entrare furtivamente il Duca, il quale si trattiene nell'ombra. Uscito Rigoletto, egli avvicina Gilda e le manifesta il suo amore dicendo di essere uno studente povero di nome Gualtiero Maldé, Partito il Duca, mentre Gilda sale alla sua stanza, ecco giungere i cortigiani per rapire la creduta amante di Rigoletto. Ritorna anche il buffone, al quale non dà pace il pensiero della maledizione. I cortigiani, per rendere la beffa più divertente, lo bendano e lo .pongono ai piedi di una scala dandogli a credere che rapiscono la sposa di Ceprano; poi entrano in casa di Rigoletto e portano via Gilda lasciandolo solo. Quando Rigoletto s'accorge del ratto, urla disperato: «Ah! la maledizione!».
Atto 2° - Salotto nel palazzo Ducale. - Il Duca ritornato alla casa di Gilda l'ha trovata vuota, ma i cortigiani gli annunziano di averla rapita e condotta al castello. Egli si precipita nella stanza ove si trova la fanciulla. Intanto giunge Rigoletto, il quale sospetta dei cortigiani; canticchia con lo strazio nei cuore indagando, pregando e minacciando per riavere la figlia, quando Gilda entra e si precipita fra le sue braccia. Rigoletto ordina ai cortigiani di allontanarsi e questi obbediscono vinti dal suo dolore. Gilda narra al padre il suo amore pel Duca, l'inganno e l'oltraggio patito. Il padre la consola e giura vendetta.
Atto 3° - Sponda destra del Mincio; a sinistra la casa di Sparafucile, della quale si vede l'nterno. - Il Duca, secondo i suoi facili costumi, entra nella casa di Sparafucile per amoreggiare con la di lui sorella Maddalena, strumento del bandito per attirare persone danarose ed ucciderle. Gilda viene condotta da Rigoletto a spiare attraverso alla porta. Essa ha il cuore straziato per l'inganno subito, ma il suo amore non scema per ciò. Rigoletto frattanto incarica Sparafucile di uccidere il giovane che sta con sua sorella (Sparafucile non sa che si tratta del Duca) e di consegnarglielo chiuso in un sacco. Ma Maddalena vuol salvare il bel zerbino, e convince suo fratello a sostituirgli il primo che nella notte si presenti. Avendo udito questo dialogo, Gilda delibera di salvare il Duca, e mentre si scatena un violento temporale bussa alla taverna e si fa uccidere. Allorchè Rigo-letto viene a ritirare il macabro sacco, ode la voce del Duca che, cessata la bufera, si allontana nella notte canticchiando. Stupito, Rigoletto apre il sacco e vi trova la figlia spirante che gli chiede perdono, confessando che muore «per lui!)). Il buffone prorompe ancora nel grido disperato: «Ah! la maledizione!».
Già nel 1849 Giuseppe Verdi, con la composizione dell'opera LUISA MILLER, rappresentata al S. Carlo di Napoli l'8 dicembre di quell'anno, aveva dimostrato di volersi avviare verso un nuovo orientamento nella scelta dei soggetti. La protagonista è la giovane figlia di un povero militare in ritiro, e gli affetti domestici, l'amore reciproco tra padre e figlia, giuocano nel dramma, tratto dall'Amore e raggiro di Schiller, un'azione di primaria importanza, in cui la musica è sempre pronta a penetrare con illuminazioni psicologiche rivelatrici, con attenta e profonda aderenza ai sentimenti più intimi e delicati. Malgrado le forme convenzionali, dalle quali Verdi non è ancora riuscito a liberarsi, e che inceppano il libero volo della sua fantasia, le migliori pagine di quest'opera sono quelle che commentano le pene d'amore della sventurata Luisa e di Rodolfo, e il tenero affetto del padre di lei. Valga come esempio il duettino «Andrem raminghi e poveri», pieno di malinconico abbandono, e la celebre romanza «Quando le sere al placido», in cui trema il più sconsolato e romantico pianto d'amore che sia mai stato pianto dopo lo «Spirto gentil» della Favorita di Donizetti.
Ora eccolo con Rigoletto avviato decisamente per la nuova via, con la sicurezza di chi ha trovato il giusto cammino che si apre su più vasti orizzonti.
RIGOLETTO è il primo vero grande capolavoro di Giuseppe Verdi. L'abbozzo che si conserva ci dimostra come esso sia stato scritto di getto in brevissimo tempo. Pochissime le cancellature; pochissimi i cambiamenti operati nel trasformare l'abbozzo in partitura. La consueta veemenza tragica verdiana in quest'opera si sposa all'eleganza, al brio, a un sentimento della natura esteriore, e soprattutto a una penetrazione dell'anima umana che è delle più profonde che l'arte musicale conosca. I caratteri vi sono rilevati con una potenza shakespeariana che ne illumina i minimi movimenti. E tutto ciò senza che si possa parlare di arte analitica, perchè anzi Verdi rimane sempre il più sintetico rapido e conciso dei nostri compositori.
La fatuità sensuale del Duca è tutta nella ballata elegante e leggera: «Questa o quella per me pari sono», e specialmente nella briosa canzonetta «La donna è mobile»; mentre di sensualità è tutta traboccante l'aria con cui si inizia il celebre quartetto del 3° atto: «Bella figlia dell'amore», così carezzevole e insinuante, vera espressione della più raffinata seduzione. Dal duetto con Gilda si sprigiona invece una sincera tenerezza, un palpito vero, che giustifica il recitativo impetuoso e la soave effusione dell'aria: «Parmi veder le lagrime»; ma non la successiva convenzionale e superficiale cabaletta (quasi sempre giustamente omessa): «Possente amor mi chiama».
Gilda è creatura di una femminilità squisita e di una passionalità eroica. Il suo duetto col padre nel 1° atto, e quello seguente con il Duca, nella loro affettuosa e delicata melodiosità che non manca di slanci e di abbandoni, la caratterizzano efficacemente; e l'aria «Caro nome» è come il gorgheggio d'un usignolo innamorato, penetrato ugualmente di primavera, di luce lunare e di un candore di affetto pieno di serena fede. Ma nella narrazione al padre: «Tutte le feste al tempio», e negli accenti che le prorompono su dal cuore nel quartetto e nell'ultima confessione: «V'ho ingannato», c'è la passione intima della donna capace dell'estremo sacrificio d'amore. Quando però attacca la frase «Lassù in cielo vicina alla madre» su l'arpeggio dei flauti, c'è un balzo che ci trasporta con un senso di catarsi al di sopra della vita mortale.
Per avere poi un'idea della capacità scultoria di Verdi basta ascoltare il breve dialogo fra Rigoletto e Sparafucile nel 2° quadro del 1° atto, su quel penoso canto all'unisono del violoncello e del contrabasso, in cui la figura del mercenario «che libera per poco da un rivale» esce dal recitativo e dal commento orchestrale con colori funerei e biechi che non si dimenticano più. Nell'ultimo atto la coerenza del triste personaggio si mantiene completa.
Non altrettanto bene si può dire dei cori, convenzionali, talvolta inutili, come il «Zitti, zitti» dei cortigiani prima di rapire Gilda; o male intonati al testo, come il marziale «Scorrendo uniti remota via» con cui gli stessi cortigiani comunicano al Duca il rapimento di Gilda.
L'orchestra invece è sempre viva e fresca, con pennellate di colore intense per tragicità, come nel preludio dell'opera, intessuto su la frase di Rigoletto «Quel vecchio maledivami». È una frase dal ritmo lento, che insiste su una nota sola con un senso grave di fatalità. Nel preludio essa martella in modo ossessionante e salendo di intensità acquista energia e durezza per spezzarsi nello spasimo di una serie di singhiozzi. Ma poichè la tragedia sembra derivare le sue origini dalla maledizione di Monterone, così questo tema-cardine, di cui peraltro Verdi non abusa, analogamente a quanto aveva fatto nell'Ernani per il motivo del corno dato in pegno a Silva, si ripete di quando in quando nei momenti fondamentali del dramma e perseguita come una minaccia la coscienza del buffone che aveva irriso alla sventura di un padre. La sapienza orchestrale acquistata da Verdi è testimoniata anche da quell'atmosfera strana, da quella tranquillità sinistra precorritrice della tempesta e dalle sonorità violente della stessa bufera, oltre che dalla frequente stilizzazione di vari elementi espressivi accompagnanti il canto.
Ma la figura che primeggia per forza espressiva tragica e per profonda umanità, è Rigoletto. In lui accanto al buffone, dai sarcasmi mordaci, che si esprime con linee di canto dure e recitative, vi è l'uomo che soffre della propria deformità e della propria condizione sociale. Questo aspetto grandeggia nel monologo «Pari siamo», in cui il recitativo strumentato raggiunge uno sviluppo libero, flessibile alle più tenui fluttuazioni del sentimento, sensibile ad ogni suggerimento delle emozioni più riposte; una cosa tutta nuova che ha la forza di certi monologhi tragici o filosofici di Shakespeare. C'è infine il padre che riversa un torrente di affetti teneri o nostalgici, dolorosi o pietosi, ardenti o gelosi, nei canti più belli: «Deh non parlare al misero», «Ah veglia, o donna», «Solo per me l'infamia», e il divino «Piangi, piangi fanciulla». Il «Sì, vendetta» è uno scarto dalla linea severa tenuta dovunque, una concessione all'effetto teatrale, basato su l'impeto del ritmo e la violenza vocale.
Ma è nella scena con i cortigiani che maggiormente grandeggia la figura di Rigoletto. Il suo cantarellare amaro dove il riso forzato sembra dar luogo ad ogni istante alle lacrime, le sue sfuriate roventi e impotenti, la terribilità del grido «Io vo' mia figlia», il suo pregare umile, e infine il suo pianto disperato, portano alla luce, sotto l'apparenza deforme, un'umanità profonda attraverso a una gradazione di espressioni affettive, con ricchezza e potenza nuova di accenti, quali solo un Michelangelo della musica poteva dare.
Michelangiolesco il Verdi del Rigoletto anche per la sapienza costruttiva che gli permette di fondere insieme e rendere simultaneamente, con estrema nettezza di linee ed efficacia drammatica, quattro stati d'animo differenti nel celebre quartetto del 3° atto. Quando Victor Hugo lo udì, non volendosi inchinare alla grandezza di Verdi e darsi per vinto, uscì in questa frase significativa: «Anch'io, se avessi potuto far parlare nell'istesso tempo quattro persone, avrei ottenuto il medesimo effetto».
IL TROVATORE: dramma lirico in 4 parti. Prima rappresentazione al Teatro Apollo in Roma il 19 gennaio 1853. Libretto di Salvatore Cammarano tratto dal dramma El Trovador di Garcia Guttiérez. - Epoca dell'azione: il principio del secolo XV.
Parte 1a - Quadro 1° - Atrio nel palazzo dell'Aliaferìa in Biscaglia. - Ferrando, uomo d'arme del Conte di Luna, racconta ai servi la storia del fratello del Conte, rapito ed arso quando era ancora fanciullo. Il delitto fu compiuto da una strega per vendicare la madre che era stata condannata al rogo dal padre dell'attuale Conte, sotto l'accusa di averne stregato il bambino.
Quadro 2° - Giardini del palazzo. - È notte alta. Leonora narra alla propria ancella Ines come si innamorò di un ignoto trovatore. Ed ecco, accompagnandosi sul liuto, il Trovatore canta. Leonora corre a lui, e nell'oscurità della notte abbraccia per errore il Conte di Luna che, geloso del rivale, si aggirava pel giardino, Manrico, il Trovatore, la coglie in quest'atto e l' accusa di infedeltà, ma ne riconosce tosto l'innocenza. Il Conte avvampa d'ira, e i due rivali escono mettendo mano alle spade.
Parte 2a - Quadro 1° - Diruto abituro sulle falde d'un monte di Biscaglia, - La zingara Azucena siede presso al fuoco. Disteso vicino a lei è Manrico, il quale si crede suo figlio. Una banda di zingari lavora e canta al suono dei martelli percossi su le incudini. Azucena aggiunge ai loro canti gioiosi una triste canzone in cui rievoca la tragedia della madre arsa sul rogo. Al sorgere dell'alba gli zingari escono, e Manrico chiede ad Azucena a quale istoria alluda la sua canzone. Azucena gli racconta allora la fine atroce della madre, e com'essa per vendicarla abbia rapito un figlio del vecchio Conte; ma nell'atto di gettarlo tra le fiamme, sconvolta la mente per il delitto orrendo che stava per compiere, lo abbia scambiato col proprio figlio. Però non dice a Manrico che egli è il fratello del Conte di Luna, anzi, sollecita, ne estingue ogni dubbio ed eccita in lui l'odio contro il Conte. Frattanto un messo reca a Manrico la notizia che Leonora, credendo morto Manrico, sta per farsi monaca. A tale annunzio Manrico esce precipitosamente, invano contrastato da Azucena.
Quadro 2° - Atrio intemo di un luogo di ritiro presso Castellor. - È notte. Il Conte si prepara con un nucleo di armati a rapire Leonora dal Convento: ma al momento di porre in atto il suo piano sopraggiunge Manrico con uno stuolo dei suoi ad impedirlo,
Parte 3a - Quadro 1° - Accampamento. - Azucena che s'aggira fra i soldati del Conte, riconosciuta da Ferrando per colei che arse il fratello del Conte, è tratta in arresto.
Quadro 2a - Sala in Castellor. - Manrico ha tratto all'altare Leonora, allorchè gli viene annunziato l'arresto di Azucena e la sua condanna al rogo. Manrico raduna i suoi soldati e corre a salvarla.
Parte 4a - Quadro 1° - Un lato del Palazzo del Conte. All'angolo, una torre con finestre sprangate da sbarre di ferro. - E notte. Nel combattimento per liberare la madre, il Trovatore è stato fatto prigioniero e rinchiuso con lei nella torre. Leonora ode le voci di preghiera per i condannati a morte e ne è terrorizzata. Invano implora dal Conte di Luna pietà per Manrico. Alla fine essa gli si offre se lo libererà, ma nascostamente beve un veleno.
Quadro 2° - Orrido carcere. - Azucena è come allucinata dall'ossessione del rogo che l'attende. Alla fine, affranta dalla stanchezza, cede al sonno mentre il pensiero le rievoca la pace dei suoi monti. Leonora reca a Manrico la notizia del perdono del Conte e della sua libertà. Manrico sospetta della sua fedeltà; ma il veleno uccide ormai Leonora provando a Manrico, disperato, la fedeltà eroica della donna. In questo momento entra nel carcere il Conte, il quale conoscendo l'inganno tesogli da Leonora, fa condurre tosto al rogo il Trovatore. Azucena si desta, vede dalla finestra il bagliore delle fiamme, comprende, e grida al Conte inorridito: «Egli era tuo fratello! Sei vendicata, o madre!».
La musica del Trovatore sembra tutta arroventata e fiammeggiante dell'incendio del rogo, illuminata dai bagliori rossi della vampa vorace che distrusse la madre ed il figlioletto di Azucena, e che distruggerà alla fine lei stessa e il Trovatore. Si direbbe che questo rosseggiare di pire si sia comunicato alla fantasia del musicista accendendola e sollevandola verso un più turbinoso spirito tragico. I ritmi di danza, così frequentemente usati da Verdi in quest'opera, ne restano come trasfigurati, e contribuiscono con la loro foga, spesso quasi selvaggia, a rendere più irruente l'impeto della musica, più apocalittica la forza espressiva. L'elemento primordiale e distruttore del fuoco reca alla musica del Trovatore un carattere di elementarità originaria in cui le forme contrappuntistiche e armoniche si inceneriscono come materia superflua. I rozzi e primitivi accompagnamenti ad accordi ribattuti, accordi di natura chitarresca, bastano spesso a questa musica; e mentre da soli appaiono volgarmente urtanti, posti sotto le melodie verdiane del Trovatore non si avvertono più: restano dei puri espedienti per fissare il ritmo e il tono, lasciando alla melodia, nella quale si concentra quasi tutta l'espressione, la possibilità di primeggiare (stavamo per dire vampeggiare e balenare).
Il motivo all'unisono e fortissimo dell'introduzione dopo i tre cupi rulli di timpani, ci porta subito in quest'atmosfera ardente. Dal racconto di Ferrando «Di due figli vivea padre beato» esce qualcosa di bieco, e di maliardo che ci afferra l'animo con forza e lo trascina con sè nel gorgo dell'incantesimo sonoro.
La figura di Azucena è tutta corrusca di queste ignee luci. Essa vive nel ricordo ossessionante e tremendo e nel terrore del rogo. Col semplicismo anzidetto è costruita la sua canzone: «Stride la vampa»; ma quale sinistro fascino ne emana! Più denso e vario nella struttura, ed anche più sciolto nel disegno che alterna il canto strofico al recitativo arioso, è il racconto di Azucena: «Condotta ell'era in ceppi». Il motivo è formato da un breve ritmo ripetuto con insistenza; ma allorchè il racconto si fa più drammatico, la parte vocale non è più se non un succedersi di frasi recitative spezzate, angosciose, mentre i violini sottovoce ripetono il motivo della canzone che evoca le fiamme in cui Azucena fuor di sè gettò per errore il figlioletto. Quanta tenerezza e quanta pietà nella frase: «Ei distruggeasi in pianto, io mi sentiva il cuore dilaniato, infranto!» Ma al ricordo del grido materno: «Mi vendica 1», la declamazione diviene agitatissima, il ritmo del commento (non più accompagnamento) orchestrale affannosamente convulso.
Tutto sembra uno scattare di vampe, fino all'urlo straziante: «il figlio mio, il figlio mio avea bruciato». Ora i disegni ripiegano verso il basso come fiamme che si estinguano, la voce stessa si sprofonda con un senso di orrore pauroso e di smarrimento folle. È questa una delle pagine tragiche più grandi non solo di Verdi, ma di tutto il repertorio melodrammatico.
Poniamo accanto a questa la superba scena del «Miserere». Già fino dal preludio dell'atto incombe una mestizia piena di sconforto che il recitativo di Leonora rende più intenso. Tutta l'aria seguente: «D'amor sull'ali rosee» è intinta di questa tristezza tenera e nostalgica. Le nuoce solo l'inutile cadenza, ultimo residuo di una consuetudine virtuosistica ormai tramontante. Ed ecco, un tetro suono di campana e le voci del coro che cantano la preghiera dei moribondi ci tuffano di colpo nell'atmosfera più tragica. Il canto di Leonora è sostenuto da un sordo fremito convulso degli archi; e mentre la voce della donna, come mancando, discende con una successione di rotti gemiti, la voce di Manrico accompagnata dal liuto si dispiega in un canto pieno di serena rinunzia e di forza liberatrice. Chi ha detto che Verdi non conosce la sublimità della catarsi? È un grosso errore e basterebbe questo canto a provarlo. Tutto ciò crea un'atmosfera funerea, una specie di ombra fonda in cui si distinguono solo colori cupi, sui quali passa come un raggio di sole il canto di Manrico: unica voce in cui aleggia la fede nell'al di là su lo squallido quadro di morte. Dopo così alta visione d'arte, la cabaletta seguente di Leonora: «Tu vedrai che amore in terra» ci trascina nelle paludi del convenzionalismo. Giustamente essa viene quasi sempre omessa.
Sorvoliamo sul disperato duetto fra Leonora e il Conte, come sorvolammo su tante altre bellissime pagine, chè si andrebbe troppo per le lunghe» Soffermiamoci invece su l'ultimo quadro dell'opera per ricordare gli accordi severi che in poche efficaci pennellate ci introducono nell'opacità greve e smorta del carcere. Tutto è sofferenza, dalle linee del canto ai motivi che l'orchestra vi intercala. Fosche livide larve sembrano passare nell'aria; un senso di oppressione mortale, un presentimento di prossima fine, di sfacelo, e, a tratti, i guizzi tragici purpurei del rogo, dominano le anime dei prigionieri nella desolata solitudine che li circonda. Ma un canto nostalgico porta anche qui un soffio lieve e remoto di serenità e di speranza; il canto blando di Azucena: «Ai nostri monti ritorneremo...», cui pacato e dolce risponde Manrico con la frase affettuosissima: «Riposa o madre». Il senso nostalgico della patria, che ispirò a Verdi il «Va' pensiero», aleggia ancora in queste voci che rievocano con un estremo sogno di speranza beni perduti: la pace dei monti, il canto di Manrico sul liuto, il sonno placido della madre. Sogno d'un sogno è questa musica: poesia etema.
L'entrata di Leonora reca con sè una concitazione piena di palpiti; ma dopo la violenta invettiva di Manrico, nel terribile tumulto che regna nel cuore dei due sposi, la voce di Azucena nel sonno continua ad evocare la pace dei monti. Come nel quartetto del Rigoletto, Verdi è ancora, e sarà sempre, il poeta dei potenti contrasti rembrandtiani. La rivelazione del gesto eroico di Leonora fa uscire ancora il musicista in un'ispirazione catartica: «Prima che d'altri vivere»: una grande onda di canto che sembra volersi levare fino al cielo, cui risponde, fra una successione di rotti gemiti, l'altra grande frase di Manrico sostenuta dai violoncelli: «Ed io quest'angelo osava maledir!», nella quale prorompe lo strazio del rimorso.
La fine è rapidissima. È da notare che fu abbreviata da Verdi medesimo, che tagliò lungaggini convenzionali del libretto, al quale collaborò al punto che l'intera stesura del dramma è sua.
In fondo questo Trovatore è una fiaba romantica piena di inverosimiglianze grottesche. Come Rossini un giorno s'accese alle inverosimiglianze buffonesche de L'Italiana in Algeri tanto più quanto più erano buffonesche, così ora Verdi si accende alle inverosimiglianze tragiche del Trovatore: tanto più quanto più sono inverosimilmente tragiche. Entrambi si tuffarono negli eccessi; e dove un mediocre sarebbe affogato nel ridicolo essi ne uscirono con una musica che arde ed annienta ogni convenzione ed ogni enormità. La figura di Manrico è forse musicalmente la più complessa. lì suo amore per Leonora si espande soprattutto nell'aria: «Ah sì, ben mio», di una tenerezza intima e malinconica; quello per la supposta madre ha infinite sfumature, dalle frasi dolcissime dell'ultima scena alla veemente cabaletta «Di quella pira», celebre pezzo di grande effetto sul pubblico (anche per il do acuto che Verdi non scrisse, ma che tuttavia, se è limpido, non nuoce) del quale però non diremo che sia uno dei più belli dell'opera. Come «Trovatore» Manrico si manifesta in due soli momenti: nella strana e originalissima serenata «Deserto su la terra», piena di fuoco impetuoso, e nel canto di morte nel «Miserere». L'attività guerresca invece dà alla parte tenorile di Manrico impeti e squilli che aggiungono baleni a baleni.
E di baleni è ricca anche la parte corale, non solo per il marziale coro: «Squilli, echeggi la tromba guerriera», ma per il rutilante canto degli zingari: «Vedi! le fosche notturne spoglie», dall'intonazione così nuova e dal ritmo così potentemente cadenzato dal metallico batter dei martelli su le incudini. Un'energia gagliarda si sprigiona da questa pagina che sembra un inno alla gioia del lavoro. E si potrebbe giurare che fu Verdi a suggerire a Cammarano questa scena fantasiosamente originale e soprattutto musicale.
LA TRAVIATA: opera in 3 atti. Prima rappresentazione a La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853. Libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alessandro Dumas figlio.
Atto 1° - Salotto in casa di Violetta Valery a Parigi. - Si svolge una festa alla quale prendono parte numerosi ansici innamorati e ammiratori della bellissima mondana. Fra essi è Alfredo Germont, il quale nutre per Violetta una seria passione. Presa da improvviso lieve malore Violetta, che è minata dalla tisi chiede, di restar sola. Mentre gli amici m un'altra sala danzano, Alfredo rientra per informarsi della salute di Violetta e le manifesta il suo amore. Violetta ne è toccata e sogna in questo amore la propria redenzione, ma teme di non potersi levare a tanto, e cede alla consuetudine per le facili voluttà.
Atto 2° - Quadro 1° - Casa di campagna presso Parigi: salotto terreno. - Già da tre mesi Violetta, abbandonando ricchezze e amori, convive con Alfredo. Essi sono felici; però Alfredo viene a sapere che Violetta ha venduto tutto quanto ancora possedeva per sostenere le spese di questa convivenza a cui i mezzi di Alfredo non bastavano. Alfredo corre perciò a Parigi per ripararvi. Nel frattempo il padre di Alfredo, Giorgio Germont, si fa annunziare a Violetta, Egli le narra che il fidanzato della sorella di Alfredo rifiuta le nozze se questi continuerà a convivere con una cortigiana. Le chiede perciò di abbandonare Alfredo. Violetta difende strenuamente il proprio canore, e durante il colloquio Germont ha modo di conoscere la nobiltà del suo animo. Pure è costretto ad insistere, e alla fine Violetta cede: partirà. Invano il padre cerca di consolare Alfredo allorchè viene a sapere ch'essa è fuggita. Un invito ch'egli trova dell'amica Flora Bervoix a una festa in casa sua a Parigi lo convince ch'è stato tradito, e corre a Parigi per vendicarsi dell'abbandono.
Quadro 2° - Galleria nel palazzo di Flora a Parigi, - Una grande animazione regna per l'entrata di alcune mascherate, e frattanto a qualche tavolo si gioca. Violetta appare nel salone al braccio del barone Douphol, suo antico ammiratore. Giunge anche Alfredo. Durante una partita a carte Alfredo provoca Douphol e lo sfida a duello. Mentre tutti entrano in un'altra sala per la cena. Violetta chiama Alfredo e lo prega di allontanarsi per evitare il conflitto. Alfredo la invita a seguirlo, ma Violetta, fedele alla promessa fatta a suo padre, rifiuta e gli lascia credere di amare Douphol. Alfredo allora, esasperato, richiama tutti e getta ai piedi di Violetta una borsa piena d'oro per pagarne i benefici ricevuti. L'oltraggio volgare desta una viva indignazione nei, presenti, fra i quali si fa strada il padre di Alfredo che rimprovera aspramente il figlio, già sùbito pentito del proprio scatto, mentre Violetta gli ripete la grandezza del proprio amore che egli non può comprendere.
Atto 3° - Camera da letto di Violetta in una casa di Parigi. - Violetta è morente: fuori impazza il carnevale. Violetta rilegge una lettera di Germont padre, in cui le dice che nel duello ira Alfredo e Douphol questi fu ferito. Alfredo, saputo il nobile sacrificio compiuto da Violetta, ritornerà a lei per sposarla. Ma essa contempla con sgomento nello specchio la devastazione compiuta dal male, già presaga della prossima fine. Pure, allorchè Alfredo giunge, rinasce in lei la, speranza. Anche il padre di Alfredo viene per essere perdonato; ma la morte di Violetta sopraggiunge rapida.
Due sono i cardini del dramma: amore e morte, e intorno a questi s'aggira l'ispirazione del musicista che forse non salì mai tanto alta nell'espressione del dolore. La morte è già negli estenuanti accordi con cui si apre il preludio: qualche cosa di diafano, di etereo, come un soffio vitale prossimo a spegnersi o come l'evocazione di un mondo di là. Subito dopo appare il motivo della frase che Violetta pronuncerà nel 2° atto: «Amami Alfredo»; motivo al quale poi se ne sovrappone un altro più gioioso e frivolo, ponendo così a contrasto simultaneo i due aspetti dell'amore che lottano nel cuore di Violetta: quello profondo per Alfredo e quello volubile dei sensi; la vita del cuore e quella del piacere. Notiamo che ancora una volta, come già aveva fatto nel Rigoletto, Verdi intende darci col preludio dell'opera una sintesi rapida del dramma, e vi riesce mirabilmente.
Dopo che il brindisi «Libiam nei lieti calici» ha esaltato l'ebbrezza dei godimenti fuggevoli, il nascente amore per Alfredo palpita nell'aria: «Ah forse è lui», ancora contrastato dalla gaia e spensierata cabaletta: «Sempre libera degg'io». Il 1° atto è tutto in questa lotta tra l'eterno e l'effimero, tra amare e godere. Ma nel 3° atto ogni traccia di voluttuosi folleggiamenti è scomparsa per lasciar luogo all'amore puro; se non che, nella rinunzia a cui il vecchio Germont costringe Violetta, questo amore si ammanta di strazio e di malinconia. Tutti i canti di Violetta nel duetto col padre d'Alfredo, quel suo spasmodico ridere e insieme piangere al momento di separarsi dall'amante, il grido disperato «Amami Alfredo», la frase più volte ripetuta e così desolata: «Ah perchè venni incauta» allorchè ritrova Alfredo nella casa di Flora, l'appassionato e angoscioso lamento «Alfredo, Alfredo, di questo core non puoi comprendere tutto l'amore», sono tutte voci dello stesso intenso sublime sentimento d'amore velato da un dolore amarissimo e da una sofferenza atroce.
Alfredo è tratteggiato, quale del resto risulta dal libretto, come d'indole ardente e impulsiva. La purità e la forza del suo amore si esprime nella dichiarazione: «Un dì, felice, eterea», che mette capo all'ampia frase: «Di quell'amor ch'è palpito dell'universo intero», frase che diverrà un «tema-cardine». Con questa definizione, già più volte da noi usata, intendiamo distinguere il raro uso di richiami tematici fatto da Verdi in pochi ma fondamentali momenti del dramma dall'uso sistematico e sinfonico del «grund-motiv» di Wagner. Il motivo dell'amore di Alfredo sarà infatti richiamato nell'aria di Violetta: «È forse lui»; sarà ripetuto da Alfredo stesso sotto al balcone, mentre Violetta sta lottando con sé stessa; ritornerà trasformato nella frase di Violetta: «Così alla misera ch'è è un dì caduta», quasi a far sentire che l'amore di Alfredo poteva redimerla, e quanto tremenda sia per lei la perdita .di questo amore. Apparirà di nuovo nelle note acute dei violini allorchè Violetta legge la lettera di Germont nella quale vi è la promessa del ritorno di Alfredo; riapparirà infine, incielato nei suoi sovracuti, nell'istante in cui Violetta muore redenta per il suo sacrificio d'amore.
Nella parte amorosa di Alfredo l'aria: «De' miei bollenti spiriti» va considerata come una concessione fatta al «tenore», come concessioni all'opera-spettacolo, al gusto pel divertimento, sono i due cori (anche mediocri come musica) delle Zingarelle e dei Mattadori nella torbidamente minacciosa scena del giuoco in casa di Flora, la cui musica è percorsa da un brivido strano di incubo, solcato di tanto in tanto dal ripetuto dolente lamento di Violetta. E la minaccia esplode nello scatto oltraggioso di .Alfredo in cui ritroviamo la violenta natura di Verdi nella sua aspra ruvidezza, L'abbandono amoroso ardente ritorna poi nell'ultimo atto, con un, disegno più carezzevole e tenero, nel celebre Andantino «Parigi, o cara, noi lascieremo».
I canti affidati a Giorgio Germont si mantengono in una linea di affettuosa nobiltà, che si scalda, nel duetto con Violetta, via via ch'egli scopre la non immaginata grandezza d'animo della donna, con una stupenda gradazione d'effetti, per assumere una espressione teneramente paterna nel dolce richiamo: «Di Provenza il mar, il suol», e un «dignitoso fuoco», come dice il libretto, nel rimprovero ad Alfredo: «Di sprezzo degno sè stesso rende».
Il sentimento della morte, che dal preludio al 1° atto, e poi dal malore durante la festa, aleggia per tutta l'opera su la protagonista e tinge d'una tristezza grave ogni suo canto; che si rivela perfino attraverso all'intenso pallore dell' «a solo» del clarinetto allorchè Violetta si accinge a scrivere ad Alfredo che l'abbandona, poichè sa che questo abbandono le costerà la vita, domina interamente l'ultimo atto. Già l'intermezzo ci ripete gli accordi immateriali del preludio al 1° atto; senonchè ora essi non sono più seguiti dal canto d'amore. Un altro canto doloroso si stende come un rimpianto per tutti i sogni, per l'amore, per le stesse sofferenze che la morte annienterà col suo soffio gelido. E le rimembranze ci afferrano, e il rimpianto sale; l'avvenire che stava per aprirsi finalmente alla felicità si rinchiude, le speranze precipitano: tutto si risolve in singhiozzi amari, in gemiti affannosi, in un tremolio di luce fioca che si estingue.
I recitativi seguenti sono tutti improntati a questa mortale tristezza, a questa luce estenuata di un'alba che non avrà meriggio, a questo senso di stanchezza e di sfinimento. Ed ecco che l'oboe ripiomba il nostro cuore nella nostalgia più sconsolata, e la voce di Violetta canta l'elegia suprema, tutta riboccante di un pianto senza speranza di conforto: «Addio, del passato bei sogni ridenti». Qualcosa tenta di sorridere debolmente ancora nel sogno rievocato e si spezza in lagni sommessi. L'urto del Baccanale che sale dalle vie è brutale e contrasta troppo rozzamente col dolore che alita nella stanza della moribonda. Lo scopo intenzionale era quello di creare un contrasto drammatico tra la prossima fine di Violetta e la gioia del carnevale; ma non è questa la gioia a cui la misera aspira, e che la riattacca ancora alla vita con un ultimo sforzo disperato nel grido: a Gran Dio! morir sì giovane», di marca certo un po' donizettiana, ma ispirato a una più forte intensità di passione. Ed ecco il funereo canto: «Prendi, quest'è l'immagine», attraversato dall'altro disperatissimo grido di Alfredo: «No, non morrai, non dirmelo», in cui si condensa tanto strazio umano. Ed è, rapidissima, la fine su l'etereo canto dell'amore.
L'orchestra, benchè abbia momenti efficacissimi, ha la struttura che già osservammo nel Trovatore: accompagnamenti ritmico-tonali di un semplicismo elementare, necessario per lasciar primeggiare il canto vocale nel quale si concentra quasi interamente ogni facoltà espressiva con rilievo e potenza soggiogante.
È questa la terza opera di quella che venne chiamata la «trilogia romantica» per i valori umani che prevalgono nelle singole opere e per l'unico soffio di passione che le generò. Ma mentre al Rigoletto e al Trovatore arrise un successo immediato, La Traviata cadde, per risollevarsi però clamorosamente l'anno successivo.
UN BALLO IN MASCHERA: melodramma in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Apollo di Roma il 17 febbraio 1859. Libretto di Antonio Somma, ridotto, dal Gustavo III. di Svezia di Eugenio Scribe , da Verdi stesso. - L'azione si finge alla fine del secolo XVII.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala in casa del Governatore di Boston. - Il Governatore, Conte Riccardo di Warwich, pensa amorosamente ad Amelia, moglie del suo intimo amico e segretario Renato. Intorno a lui sono gentiluomini fedeli, e fra essi anche due nemici, Samuel e Tom, i quali spiano il momento di sopprimerlo. Inutilmente Renato vorrebbe fare a Riccardo i nomi dei congiurati; egli rifiuta di conoscerli. Viene introdotto il Primo Giudice il quale sottopone alla sua firma la condanna all'esilio di una strega. Oscar, il paggio del Conte, la difende. Riccardo, divertito, decide allora un allegro sopraluogo, e invita gli amici a trovarsi travestiti nell'antro della maga.
Quadro 2° - L'abituro dell'indovina. - Ulrica sta predicendo il futuro a un gruppo di popolani, allorchè Amelia le fa chiedere m colloquio segreto. Essa vuole estinguere una passione amorosa che la tormenta. Solo un'erba fatata colta nel campo dei supplizi - le dice la strega - può servire allo scopo. Riccardo ha udito, nascosto, il dialogo, e si propone di raggiungere colà Amelia. Chiede poi ad Ulrica che gli predica il futuro: «Morirai- gli dice essa - ucciso da un amico: il primo che oggi ti stringerà la mano». Riccardo è incredulo; ed ecco Renato che entra e gli strìnge la mano. La strega riconosce il Conte, però conferma: a V'ha fra loro più d'un traditore». Intanto un marinaio beneficato dal Governatore giunge con uno stuolo di popolo inneggiando alla sua generosità
Atto 2° - Campo solitario ove vengono eseguite le sentenze di morte. - Amelia giunge: è in preda a supertizioso terrore. Riccardo l'ha seguita e le svela il suo amore. Essa pure gli confessa d'amarlo. Improvvisamente giunge Renato, che ha visto dei congiurati armati, aggirarsi intorno e vuol salvare l'amico. A lui Riccardo affida, coperta con un fitto velo, Amelia, ordinandogli di condurla velata in città. Renato lo giura e Riccardo parte. I congiurati che credevano di trovare il Conte, stupiti di vedere Renato con una donna vogliono sapere chi è, e le strappano il velo. Riconoscendo Amelia e credendosi tradito. Renato tramuta la sua amicizia per Riccardo in odio mortale. Egli invita Samuel e Tom ad un convegno e s'accinge a riaccompagnare la sposa in città come aveva giurato, mentre i congiurati si allontanano deridendolo.
Atto 3° - Quadro 1° - Studio di Renato nella propria abitazione. - Renato vuol punire con la morte la sposa infedele, ma essa gli chiede pietà per amore del figlio, proclamandosi innocente. Renato cede e pensa a lavare l'onta nel sangue di Riccardo. Giungono Samuel e Tom, ai quali Renato dichiara di voler partecipare alla loro congiura. Per essere da essi creduto distrugge i documenti che li compromettevano. La sorte designa Renato per colui che dovrà uccidere il Conte. Amelia stessa è stata costretta a estrame il nome dall'urna. Entra poi Oscar con un invito a m ballo mascherato in casa del Conte.
Quadro 2° - Sontuoso gabinetto del Conte. - Riccardo, per salvare l'onore d'Amelia, firma un decreto che eleva Renato ad altra carica in Inghilterra. Oscar gli reca un biglietto datogli da ignota mano. In esso è detto che durante il ballo in maschera si attenterà alla vita del Conte, ma questi non cura la minaccia e si reca all festa per rivedere Amelia prima ch'essa parta con lo sposo.
Quadro 3° - Vasta e ricca sala. - Fervono le danze. Renato riesce a sapere con inganno da Oscar com'è mascherato Riccardo: lo scopre mentre parla ad Amelia e lo ferisce. Prima di morire Riccardo afferma l'innocenza di Amelia e svela a Renato l'incarico affidatogli per allontanarlo insieme alla moglie; e spira perdonando tutti.
Capolavoro perfetto il Ballo in Maschera non è; qua e là vi sono squilibri di stile e banalità d'ispirazione. Pure, quest'opera è la prova di un profondo lavorìo di rinnovamento e contiene pagine di un'altezza superba. Si è anche fatto colpa all'opera di talune espressioni ridicole, come il «raggiante di pallo r», il «raggio lunar del miele», le «orme dei passi spietati», e simili. Ma è da osservare che se queste frasi urtano alla lettura del testo, sfuggono all'esecuzione musicale, incendiate e annientate dalla forza di un'ispirazione che si eleva, come dicevamo, in moltissimi momenti a grande altezza.
Più che la caratterizzazione dei personaggi è la rappresentazione delle situazioni che in quest'opera appare più efficacemente riuscita. L'amore di Riccardo è un misto di idillio e di passione, di estasi sognante e di desiderio sensuale. Fra questi due estremi si muove la lotta del suo animo: tra la romanza gentile «La rivedrà nell'estasi» (il cui motivo ritornerà più volte come tema del suo pensiero amoroso) e la toccante implorazione: «Non sai tu che se l'anima mia»; tra il fremente: «Oh qual soave brivido» e il candore melodico della confessione estrema: «Ella è pura, in braccio a morte te lo giuro». Ma in Riccardo ci sono anche espressioni di elegante vaghezza. Non già la frivola stretta: «Ogni cura si doni al diletto», e neppure la banale chiusa: «Dunque, signori, aspetto vi», ma la galante barcarola: «Di' tu se fedele il flutto m'aspetta», e quel gioiello di stupore e di riso dell'«È scherzo od è follia», dove appunto riso e stupore sono così intimamente fusi nel ritmo e nel canto che le risatine veristiche introdottevi da qualche «divo» (di quelli che pensano che per interpretare sia lecito cambiare, e che immaginano di poter correggere o perfezionare Verdi!) sono stolide profanazioni e deformazioni!
Amelia s'aggira anch'essa tra la forza di un amore che non sa cancellare, e il terrore di cadere nella colpa. Quest'ultimo sentimento si espande nella preghiera ardente: «Consentimi, o Signore, virtù ch'io lavi il core», il cui motivo il flauto con la sua voce eterea alzerà al cielo nel drammatico preludio del 2° atto; mentre il desiderio di non distruggere il suo sogno d'amore ispira la nostalgia del canto: «Ma dall'arido stelo divulsa». Di questa drammatica lotta fra l'amore e il dovere, tra il cuore e la coscienza vive il bellissimo duetto di questo 2° atto, e quello finale su lo sfondo elegante della marzurka che rende ancor più sensibile il distacco delle anime dei due innamorati dal mondo esteriore. Su lo sfondo della sorridente danza si profila la melodia tutto pianto e passione disperata: «T'amo, sì t'amo, e in lagrime».
Anche Renato si muove tra due poli: la sua amicizia fedele per Riccardo prima, il suo odio mortale dopo. Ma non vi è lotta; egli passa di colpo dall'uno all'altro come crede d'aver scoperto nell'amico il traditore. E come egli cantava con ariosa affettuosità (un po' rettorica): «Alla vita che t'arride», così griderà, non senza un po' d'enfasi, ma con fiera drammaticità: «Eri tu che macchiavi quell'anima», e con più intimo senso di dolore e di nostalgia sospirerà: «O dolcezze perdute!». Attorno al suo dolore e al suo sdegno Verdi crea uno dei suoi quadri musicali più stupendi, ponendo l'agitazione che sconvolge il cuore di Renato al centro dell'ironico e beffardo riso dei congiurati: «Ve' se di notte qui colla sposa». Questa fusione di riso e di pianto, di dolore e di scherno è sempre una delle manifestazioni più vive della drammaticità verdiana, in cui spesso l'amarezza delle lagrime sorge da un impossibile riso, e questo fiorisce su lo spasimo della disperazione. Un consimile sogghigno feroce domina, su gli squilli fatali delle trombe, la scena tragica in cui Renato invita Amelia ad estrarre dall'urna il nome di colui che dovrà uccidere Riccardo. Peccato che una scena così potente sia un po' sciupata dal ritorno del meyerbeeriano inno «Sconterà dell'America il pianto».
Ulrica è una strega un po' convenzionale. Tuttavia Verdi ha preso sul serio l'elemento magico che la circonda, vi ha giuocato dentro con dei motivi e uno strumentale impressionistici, e ne è uscita una figura diversa da Azucena, senza intimo dramma, un po' decorativa, ma ricca di colore.
Ma una figura più nuova, più significativa nei riguardi della trasformazione subìta dalla fantasia artistica di Verdi, è il paggio Oscar. Non ha a che fare nè col Cherubino mozartiano, nè con l'Isoliero rossiniano, nè con la fatua derivazione e falsificazione dell'Urbano ne Gli Ugonotti di Meyerbeer. Oscar è una creatura giovanilmente gaia e fresca, senza frenesie erotiche, furbo ed ingenuo insieme, aggraziato e signorilmente elegante. I suoi momenti migliori sono la brillante difesa d'Ulrica: «Volta la terrea fronte alle stelle», il suo grido d'inorridito stupore: «E tal fia dunque il fato?» dopo la predizione funerea della strega; il suo intervento con l'annunzio della festa dopo la tragica congiura, con una gaia leggerezza di motivi trillanti in cui è il Verdi nuovo, ma anche con un balzo in cui è tuttora la potenza drammatica del migliore Verdi vecchio. La sua arietta: «Di che fulgor, che musiche» getta un sorriso di grazia su la cupa bellezza delle scene precedenti: con lui entra un soffio d'aria pura e un po' di cielo sereno primaverile. L'ultima sua canzone: «Saper vorreste» è piena di furbesco garbo, di una scherzosità maliziosa e lieve che, dopo: «La donna è mobile» del Rigoletto, conferma le possibilità artistiche di un Verdi che le opere precedenti non lasciavano sospettare, e che sboccherà come un miracolo verso gli ottant'anni in quella perfezione di eleganza e di leggiadria che è il Falstaff.
CARLO GOUNOD (Parigi 1818-ivi 1893. - FAUST: dramma lirico in 5 atti. Prima rappresentazione al Teatro Lirico di Parigi il 19 marzo 1859. Libretto di Giulio Barbier e Michele Carré.
Atto 1° - Gabinetto di Faust. - È notte. Faust, vecchio, stanco di una vita inutile divenutagli insopportabile, sta per avvelenarsi, allorchè gli appare Mefistofele, il quale gli promette giovinezza e piaceri purchè egli si impegni di darsi a lui dopo morte. Per deciderlo gli fa apparire la affascinante visione di Margherita. Faust accetta il patto, lo firma, e, ringiovanito, parte con Mefistofele.
Atto 2° - Una porta della città; da un lato un'osteria, - È festa: danze e canti. Anche Mefistofele canta una canzone al dio dell'oro. Indi predice a Siebel che ogni fiore ch'egli vorrà dare a Margherita appassirà. Valentino, udendogli nominare la sorella si irrita e sguaina la spada; ma, Mefistofele gliela fa cadere in frantumi. Allora Valentino e la folla gli mostrano la croce dell'elsa, innanzi alla quale Mefistofele indietreggia e fugge. Mentre studenti e ragazze danzano, passa Margherita. Faust le offre il braccio per accompagnarla a casa, ma essa pudicamente rifiuta.
Atto 3° - Il giardino di Margherita. - Siebel vuol deporre fiori davanti alla porta di Margherita, ma i fiori ch'egli tocca avvizziscono. Bagna allora la mano in una pila d'acqua santa e i fiori restano freschi. Mefistofele però vi colloca accanto un astuccio di gioielli. Margherita giunge cantando la canzone del «Re di Thulé»; ella scorge l'astuccio, lo apre e, affascinata dallo splendore dei gioielli, se ne adorna ammirandosi in uno specchio. In tale atteggiamento la colgono la nutrice Marta, Mefistofele e Faust. Questi le si accosta e le dichiara il suo amore. Frattanto Mefistofele annunzia a Marta la morte di suo marito e facilmente la consola. Sull'atto di partire con Mefistofele, Faust ritorna indietro e corre di nuovo a Margherita che si lascia cadere fra le sue braccia, mentre Mefistofele nell'ombra sogghigna.
Atto 4° - Quadro 1° - La stanza di Margherita. - La giovane piange per l'abbandono di Faust e per gli scherni di coloro che le furono un tempo amiche. Invano Siebel cerca di consolarla. Essa si avvia alla chiesa a pregare per Faust e per il figlio.
Quadro 2° - Una strada; a sinistra una chiesa. - Margherita s'accosta per pregare. Un misterioso coro di dèmoni la chiama, mentre si odono venire dall'interno canti sacri. Mefistofele, non visto da lei, le ricorda i lieti giorni della sua innocenza e le proibisce di pregare; le grida che è dannata, ed essa fugge inorridita. Ritornano i soldati dalla guerra, e fra essi Valentino. Siebel gli svela la colpa di Margherita. Mentre Valentino entra in casa, Mefistofele canta a Margherita una serenata ironica. Valentino l'ode ed esce a battersi col seduttore della sorella, ma Faust lo ferisce mortalmente. Prima di spirare esso maledice Margherita.
Atto 5° - Prigione. - Margherita, accusata di aver ucciso il figlio e cagionata la morte del fratello, è stata condannata a morte. Faust giunge con Mefistofele per salvarla, ma essa vaneggia, e dopo un primo slancio d'amore, lo respinge. Impaurita dal volto infernale di Mefistofele, invoca Iddio e muore. «Dannata!» grida Mefistofele, ma un coro celeste risponde: «È salva!», e inneggia a Cristo resuscitato.
Il libretto riduce il poema goethiano al semplice romanzo d'amore di Faust e Margherita, con l'aggiunta di un servo bizzarro che è Mefistofele, cavaliere galante e stregone prestigiatore. Della grande scommessa fra Cielo e Inferno altro non resta che la firma del contratto di cessione dell'anima di Faust a Mefistofele a morte avvenuta. Ma come vada poi a finire non si sa. Cosicchè il personaggio di maggior rilievo non è nè Mefistofele nè Faust, ma piuttosto Margherita, e dal suo nome avrebbe potuto, più giustamente intitolarsi l'opera.
È quindi attorno alla gentile, fragile, e infine pentita fanciulla che si concentra il meglio della musica di Gounod: l'incontro con Faust, l'aria così fresca e ingenua del «Re di Thulè», la scena dei gioielli (che è l'unica un po' brillante), l'arioso «Ei m'ama», la scena della chiesa, l'ultima effusione d'amore del «Sì, sei tu! io t'amo», e l'impeto di mistica esaltazione finale: «O del ciel angeli immortali», ripetuta per tre volte, con un senso di liberazione crescente, in un tono sempre più alto. Sono tutte pagine bellissime; talune, come l'aria dei gioielli, di un'ispirazione assolutamente nuova e di un'intimità psicologica rivelatrice.
Faust vive anch'egli soprattutto nei suoi momenti d'espansione lirica. Le sue meditazioni filosofìche, più che nei recitativi e nel maestoso «Ah! vieni, estremo de' miei dì!» (ma perchè poi maestoso?), direi che stanno racchiuse nella parte del preludio, dove i temi s'aggirano con un carattere veramente meditativo che le imitazioni fugate approfondiscono. La seconda parte di questo preludio non è che la trascrizione orchestrale dell'aria «Dio possente, Dio d'amor», con cui Valentino partendo per la guerra raccomanda a Dio l'innocenza immacolata della sorella; e se si pensa quale fine ignominiosa faccia questa innocenza non si può fare a meno di trovare in questa citazione del motivo, subito nel preludio dell'opera, un senso piuttosto ironico. E neppure approveremo la spensierata strofetta: «Io voglio il piacer, le belle donzelle» che, se Faust fosse giovane, diremmo dongiovannesca, ma essendo egli vecchio è soltanto un compassionevole sfogo di rammollimento senile. Solo perchè non aveva «il piacere e le belle donzelle» voleva uccidersi Faust? Tutt'altra cosa sono invece, una volta ringiovanito, i canti pieni di poesia a lui affidati, dal delicato e quasi timido: «Permettereste a me», al commosso: «Salve dimora casta e pura», il cui spunto però proviene da una frase dell'Adagio del Concerto in do min. per piano e orchestra di Beethoven; dall'appassionato «Dammi ancor contemplare il tuo viso», all'estatico «Notte d'amor tutta splendor».
Ora, le melodie gounodiane, siano esse di Faust, di Margherita o d'altri, s'impongono per il fascino tipicamente francese che loro proviene dalla finezza con cui sono disegnate, dall'eleganza delle loro movenze, dall'abbandono lirico e dalla delicatezza poeticamente sognante dell'espressione, dalla grazia mollemente sensuale della strumentazione, da tutto un insieme di particolari aristocratici senza essere preziosi, che allontanano ogni intonazione banale o, volgare. A tutto ciò egli sa dare una finitezza formale aerata ed ampia, senza ridondanze rettoriche, quadrata senza rigidezza, scorrevole senza faciloneria, cosicchè la tendenza romantica del sentimento è in lui dominata da una classicità costruttiva piena di buon gusto, oltre che di molta sapienza. Sono i caratteri che fanno di Gounod l'immediato maestro di Giulio Massenet. Lo stesso Mefistofele è un buon diavolaccio, signorile ed espansivo cavaliere con Marta, ricco di sfumature umoristiche, buon vocalista e improvvisatore di eleganti canzoni strofìche: più vivace e bizzarra, che diabolica l'aria: «Dio dell'or», più ironicamente sottile e maliziosa la serenata: «Tu che fai l'addormentata». Altrove talvolta nervoso, ma sempre signorilmente francese.
In un solo momento egli appare veramente demoniaco: nella scena della chiesa: la scena più fortemente drammatica di tutta l'opera. Su un tremolo degli archi i bassi presentano un disegno cromatico ascendente e discendente di espressione tetra e bieca. Il disegno striscia nelle parti superiori e si arresta su alcuni squilli fatali che aprono la via a una severa progressione dell'organo. Questo preludio prepara al recitativo senza accompagnamento di Margherita che si prostra per pregare. Ma ecco che, su una ripresa dell'organo, Mefistofele si oppone alla preghiera della colpevole: un movimento rapido e sordo di terzine accompagna le voci dei demoni che chiamano Margherita. La giovane è turbata, e Mefistofele inizia il suo canto nostalgico e seduttore: «Rammenta i lieti dì...». Lo sgomento di Margherita aumenta; su di esso piomba dall'alto il corale religioso che evoca il «Dies irae)>: accordi compatti, grevi come macigni, alternati alle terzine diaboliche dell'orchestra. Fra una strofa e l'altra del coro, su degli accordi aspramente balzanti, Mefistofele grida parole di minaccia: «No, per te Dio non ha più perdon!». Il tumulto nel cuore di Margherita è estremo: al colmo dello spavento essa leva finalmente al cielo una preghiera disperata, e il coro le si associa quasi ad accrescerne forza. Ma Mefistofele le urla: «Tu sei dannata!», e la donna fugge in preda a folle terrore; l'organo riprende a preludiare casto, incorniciando la scena drammaticamente umana con le sue note che sembrano la voce di un mondo superiore ed estraneo ad ogni male terreno.
Questa scena piena d'ombre e di luci, di potenti contrasti e di profondità psicologica, in cui le voci di Mefistofele e dei demoni rappresentano le voci stesse della coscienza colpevole di Margherita, è veramente una delle più grandi scene drammatiche che siano state scritte. Tanto dobbiamo, più che al sentimento drammatico, scarso in Gounod, come provano le altre sue opere, al suo forte sentimento religioso, che gli detta altre pagine alte: la scena in cui la folla presenta a Mefistofele l'elsa a croce delle spade con un solenne inno sacro su le parole: «La croce dai demoni tuoi ci guarda»; la chiusa del 4° atto, dopo la morte di Valentino, su la preghiera corale: «Che il Signore l'accolga pietoso nel suo sen!». Questo Valentino, piuttosto tronfio ed enfatico, che muore maledicendo e profetando a sproposito, non ci commuove, e diremmo anzi che talora riesca perfino poco simpatico; ma la pace che il popolo invoca sul suo cadavere e la dolcezza toccante della frase dei violini che chiude l'atto ci riconciliano con lui.
L'ultima grande pagina sacra è, come s'accennò dianzi, l'estrema invocazione «O del ciel angeli immortali», con quei balzi di tono ad ogni ripresa che paiono altrettanti strappi per staccarsi dalla terra ed elevarsi al Cielo. L'etereo grido: «È salva!», sul movimento d'arpa, e la frase ascendente degli archi, da cui scaturisce su le sonorità piene dell'organo e gli squilli delle trombe angeliche il maestoso coro sacro finale: «Cristo risuscitò », compiono la catarsi elevando d'un tratto il romanzo di Margherita alla dignità di poema sacro.
Dopo di che possiamo anche sorvolare sul Valzer, su l'aria di Siebel: «Le parlate d'amor», e su una quantità d'altre cose graziose, eleganti ed anche densamente poetiche sparse lungo tutta la bella partitura.
BIZET GIORGIO (Parigi 1838- ivi 1875) - I PESCATORI DI PERLE: opera in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Lirico di Parigi il 29 settembre 1863. Libretto di Pietro (detto Eugenio) Cormon e Michele Carré.
Atto 1° - Una spiaggia nell'isola di Ceylon. - Nadir, tornando dopo una lunga assenza, si incontra con Zurga, amico suo dall'infanzia, e ora capo della tribù indigena, col quale era stato in lite per una donna amata da entrambi. Ora essi si giurano fedele amicizia. Frattanto appare una nave che accompagna la vergine che ogni anno, dopo aver giurato di rimanere insensibile ad ogni amore, si reca velata a pregare nel tempio posto sulla scogliera, per allontanare pericoli e tempeste. Essa presta il giuramento;però ha visto Nadir e trasalisce. Anche Nadir alla voce della giovane crede di riconoscere l'amata Leila. Allorchè Leila inizia la sua preghiera e tutti si sono allontanati, tranne Nadir, essa solleva il velo cosicchè l'amante pienamente la riconosce e appassionatamente l'invoca.
Atto 2° - Le rovine di un tempio. - Nel buio della notte Nadir si ritrova con Leila; ma vengono scoperti, e poichè Leila ha tradito il giuramento, dovrà scantare con la morte il suo fallo insieme all'amante. Zurga vorrebbe salvarli, ma come il velo è tolto dal capo di Leila egli ravvisa la donna che amò e che fu causa della discordia con Nadir. Preso da geloso furore ora egli vuol vendicarsi dell'amico che lo ha ingannato.
Atto 3° - Quadro 1° - L'interno della tenda di Zurga. - Il rimorso per aver condannato a morte l''amico rende disperato Zurga; però invano Leila lo prega di fargli grazia: l'amore per Leila lo ha ripreso e la gelosia lo acceca. Prima di essere condotta al supplizio essa consegna a un pescatore una collana che le fu donata da un uomo da lei salvato. Zurga la riconosce: egli stesso, salvato un giorno da Leila, gliela donò. Si slancia allora dietro a Leila per sottrarla alla morte.
Quadro 2° - Una landa selvaggia. - Gli indiani preparano il rogo, ma al momento in cui Nadir e Leila stanno per esservi gettati, Zurga sopraggiunge annunziando che l'accampamento è in fiamme. Nel tumulto che ne segue, Zurga fa fuggire i due prigionieri, ma accortisi gli indigeni di ciò, Zurga stesso vien tratto a morte.
Dentro il quadro dell'opera ottocentesca tradizionale, I pescatori di perle presenta i segni di un'originalità di fantasia e di una volontà di rinnovamento che la fanno meritevole di sopravvivere. Disegni nuovi, emozioni prima inespresse, armonie che si tolgono più volte dal consueto, senza sforzo, per una sensibilità che avverte legami nuovi fra le note e fra gli accordi, il palpito dei ritmi, alcune preziose finezze strumentali, tutto ciò si incontra quasi ad ogni scena dell'opera, specialmente nel 1° atto, che è il più bello e il più vario. È anzi quest'atto la prova di tale originalità ancora incompiutamente sbocciata, e del rinnovamento ancora accennato in potenza più che attuato.
C'è anche, nella musica di quest'opera, quella calda sensualità mediterranea, quell'irruenza di passione, e quella trasognata ed estatica malinconia che ancor più si rivelerà in Carmen, e che spingerà Federico Nietzche, nella sua ribellione al prepotente giogo wagneriano, a considerare Bizet come il liberatore da tale soggezione. Al calore e al colore mediterraneo, che talvolta trabocca in esuberanze liriche, Bizet aggiunge la signorile eleganza tutta francese che splende nel gusto squisito dell'orchestrazione e delle armonie.
Del 1° atto sono particolarmente ispirati il preludio (che poi si ripete tal quale all'arrivo e alla partenza di Leila), e il primo coro, dalle movenze vivaci e caratteristiche, ma senza nulla che voglia essere di proposito ricostruzione ambientale archeologica. La novità dei disegni e dei ritmi basta a darci in modo sufficiente un senso vago di esotismo, senza portarci fuori dalla sensibilità musicale dell'ottocento. E così sarà pure per la preghiera di Leila: «Brama, gran Dio», e per la canzone di Nadir: «De la mia vita rosa assopita» (2° atto), la più indovinata per la novità assoluta del suo disegno che rievoca modi di un leggendario oriente.
Una delle gemme dell'opera è lo stupendo duetto fra Nadir e Zurga: «Del tempio al limitar», nel quale i due amici rievocano la lontana prima apparizione di Leila. La melodia ampia, sottolineata da arpeggi vasti come l'onda dell'emozione che si risveglia in loro, dà una sensazione profonda e complessa, di nostalgia e di misticismo, qualcosa di appassionato e di fatale. È l'incantamento a cui non si resiste, e che travolgerà la loro esistenza. Cosicchè questo motivo diventerà un tema che si ripresenterà ogni volta che Leila viene rievocata col suo fascino avvincente, che il tremolo dei violini renderà ancor più vago e misterioso.
Ma il fascino misterioso dell'amore, con la nostalgia dei suoi ricordi, la mollezza languida della sua tenerezza sensuale, e l'aerea penombra del sogno, è, con una intensità d'espressione incomparabile, espresso nella celebre romanza di Nadir: «Mi par d'udire ancor». Contribuiscono al senso d'incantamento e di sogno che si sprigiona da quest'aria, il disegno ondulato dell'accompagnamento con le sue curve morbide, e la melodia purissima, che oscilla attorno a note lunghe come sospiri, tutta penetrata di luce crespuscolare: poesia nel più alto senso della parola. I leggeri brividi della ripresa ne accrescono l'espressione sensuale, pur mantenendone il carattere aereo. Peccato che, dopo questa pagina celestiale, la chiusa dell'atto si svolga su un canto frivolo, quasi da cabaletta alla Thomas, come quello che segue la preghiera di Leila: «Nei limpidi cieli».
Nel 2° atto le pagine più belle sono la romanza di Leila: «Siccome un dì», soffusa di serena dolcezza e di fidente passione, e quella parte del duetto Leila-Nadir che incomincia dalle parole «Non hai tu compreso un cor fedel», il cui limpido e plastico fraseggio è ricco di una devota e calda tenerezza tutta meridionale, in particolare per certe cadenze e certi gruppetti pieni di voluttuoso abbandono.
Il 3° atto non raggiunge più l'altezza dei precedenti, per quanto non manchi di momenti felici, come l'aria di Zurga: «O Nadir», in cui vibra l'espressione di un amaro rimpianto; e il terzetto: «Fascino etereo» che ha lo slancio di un inno di liberazione.
GIACOMO MEYERBEER - L'AFRICANA: opera in 5 atti. Prima rappresentazione postuma all'Opéra di Parigi il 28 aprile 1865. Libretto di Eugenio Scribe .
Atto 1° - L'aula del Consiglio del Re di Portogallo a Lisbona. - L'ammiraglio Don Diego ha destinata in isposa la figlia Inez a Don Pedro, Presidente del Consiglio del Re. Ma Inez ama Vasco di Gama, partito con una spedizione capitanata da Bernardo Diaz, la cui flotta corre voce sia stata distrutta da una tempesta. Al Consiglio, adunato per studiare i mezzi di andarne alla ricerca, si presenta il superstite Vasco, con due schiavi presi in Africa, Nelusko e Selika, e chiede una flotta per proseguire l'impresa che la morte impedì a Diaz di condurre a compimento. Ma il Consiglio respinge la sua domanda, e poichè egli reagisce con parole roventi, lo fa arrestare come empio.
Atto 2° Carcere dell'Inquisizione. - Vasco dorme; Selika, che lo ama, lo sente nel sonno pronunciare il nome di Inez. La scoperta del suo amore per un'altra la addolora; pure, a Nelusko, che odia Vasco sia perchè straniero, sia perchè geloso di Selika, impedisce di ucciderlo. Vasco si desta e si pone a studiare ancora su una carta geografica il viaggio oltre il Capo di Buona Speranza: Selika gli indica la via giusta, e Vasco in un impeto di entusiasmo l'abbraccia, Inez, che ha ottenuto per lui la libertà, lo sorprende in questo amplesso. Vasco per placarne la gelosia le offre in dono Selika e Nelusko. Ma ora Vasco apprende che il Re ha affidato a Don Pedro una flotta per attuare il progetto da lui ideato, e che Ines sarà sua sposa.
Atto 3° - La nave dell'Ammiraglio Don Pedro. - Nelusko, del cui consiglio Don Pedro pienamente si fida, fa deviare la nave. Vasco che su altra nave era pure partito alla volta del Capo, ora sbarca su quella di Don Pedro per prevenirlo circa il pericolo di un naufragio contro scogliere, e dell'assalto di tribù selvagge. Don Pedro non gli crede e vuol farlo fucilare. Selika allora si interpone minacciando di uccidere Inez. Don Pedro cede e lo fa trarre prigioniero nella stiva. Frattanto si leva una violenta tempesta approfittando della quale orde di selvaggi sbarcano su la nave facendo strage dei naviganti.
Atto 4° - Spiaggia dei mare: a sinistra l'ingresso di un tempio indiano. - Si svolgono solenni cerimonie e danze per festeggiare il ritorno della regina Selika. Vosco, scampato all'eccidio, ammira estasiato la bellezza del luogo e sogna di farne omaggio al suo paese, allorchè viene sorpreso e minacciato di morte da fanatici indiani. Selika interviene in tempo e dichiara che durante la sua prigionia Vosco le salvò la vita e che è suo sposo. Vosco, convinto che Inez sia spenta, riconoscente alla generosità di Selika acconsente ad essere unito a lei. Ma, mentre si svolge il rito nuziale, da lontano si ode la voce di Inez che canta una mesta canzone.
Atto 5° - Quadro 1° - I giardini della regina. - Inez e Vasco si sono incontrati; Selika li ha sorpresi e arde di sdegno, ma persuasa che l'amore di Vasco per Inez è inestinguibile, fa condurre entrambi su una nave affinchè possano fuggire.
Quadro 2° - Promontorio in vista del mare. Nel mezzo un grande albero di Manzanillo: l'albero della morte. - Selika scruta il mare, e mentre osserva la nave allontanarsi con a bordo Vasco e Inez, cade uccisa dagli effluvi venefici dei. fiori dell'albero fatale.
La struttura dello spartito è sempre quella della grand-opéra. Indubbiamente la sapienza costruttrice si è ancor più raffinata, ma l'Ispirazione non raggiunge più la potenza espressiva rivelata ne Gli Ugonotti. L'ispirazione di Meyerbeer aveva avuto ancora momenti felicissimi nell'opera IL PROFETA (1849). Il dramma del giovane albergatore Giovanni di Leida che, per vendicare il rapimento della sua fidanzata Berta effettuato dal prepotente Conte d'Oberthal, si fa credere il Profeta di una nuova religione, e poscia, maledetto dalla madre ch'egli finge di non riconoscere, dalla fidanzata che gli rimprovera il sangue di innocenti da lui versato, e tradito dai suoi, fa saltare il palazzo in cui si trova a convito insieme a questi, aveva eccitata favorevolmente la vena del musicista. Il preludio pastorale, l'arrivo degli Anabattisti, il racconto del sogno di Giovanni e la espansiva romanza: «Sopra Berta, l'amor mio», la preghiera: «Ciel, pietà», l'inno trionfale: «Re del cielo e de' beati», il lamento di Fede: «Pietà d'un'alma afflitta», il duetto fra Berta e Fede: «Per serbar me fedel», la Marcia dell'incoronazione, la preghiera: «Domine salvum fac», e l'imprecazione di Fede, sono tutte pagine belle, esenti da quella fatuità edonistica e da quell'enfasi rumorosa che si riscontra in tante opere del Berlinese. In particolare appare scolpita con un rilievo psicologico intenso la parte di Fede nel suo immenso amore pel figlio, nel suo orrore per lo sciagurato al quale la voce popolare attribuisce delitti di sangue, nello sconforto della solitudine in cui l'ha piombata l'abbandono del figlio.
Ne L'AFRICANA le parti più robuste sono quelle corali. Non che, per esse, il coro assurga a personaggio importante dell'azione, che anzi nella maggior parte dei casi rimane un elemento riempitivo nei concertati, decorativo o diversivo negli altri momenti. Ma non si può negare un sentimento di austera ieraticità al coro degli Inquisitori: «Dio che la terra venera», nè una solenne religiosità alla preghiera dei Marinai: «O grande San Domenico» con effetti potenti di contrasto fra il primo motivo grave, la seconda parte: «O celeste Provvidenza» così dolce e umile, e il ricomparire imperioso, quasi pauroso, del motivo iniziale, che riconduce bruscamente alla tonalità di partenza, e prosegue fermo e implacabile sotto le deviazioni tonali delle parti superiori. Bello, anche se di carattere puramente decorativo, il coro: «Su, su, marinar». Nè mancano di vigore le parti corali nei concertati alla fine del 1° e del 4° atto. Una forma delicatissima di canto polifonico si può ammirare ancora nel settimino: «Me sola egli ama» in cui l'amore assume un'espressione quasi religiosa.
L'elemento pittoresco è dato specialmente dalla canzone di Nelusko: «Adamastor» e dai cori e danze del 4° atto, che ci dipingono un'oriente barbarico molto europeizzato e soprattutto molto esteriore, non solo archeologicamente falso (ma l'arte non è archeologia, e perciò questo sarebbe il meno male) ma con una mira particolarmente coreografica, il che dà alla ricostruzione di questo mondo esotico una patina oleografica piuttosto scadente. Il carattere di Nelusko è però il meglio scolpito, così nella sua devozione a Selika come nel suo odio agli Europei e nei suoi inganni per trarli a rovina; così nel nobile canto: «Figlia di regi», come nel suo energico allarme: «All'erta, marinar».
Il carattere di Vasco è troppo vacillante e contradditorio nel libretto per poter trovare nella musica un chiaro rilievo. Però esso non manca di simpatiche effusioni liriche, specialmente nella bella frase del 2° atto: «Sei l'angiol diletto»; come l'amore di Selika trova la più lirica espansione nel canto slanciato: «O trasporto, o dolce incanto» al 4° atto.
Ma la perla dell'opera, la pagina vittoriosa del tempo e delle forme mutevoli è Paria di Vasco: «O paradiso» che è tutt'un getto d'ispirazione col recitativo che la precede: «Mi batte il cor». I suoni aerei dei violini e dei flauti, il canto del como inglese, creano un'atmosfera di incantesimo su cui si stende la melodia vocale deliziosamente stupita. Peccato che su la fine il «pezzo» prenda la mano al compositore staccandosi dall'ambientazione scenica per diventare qualche cosa a sè con la mira all'effetto teatrale, con la cadenza in cui, non sapendo più come procedere, le stesse parole sono ripetute fino alla sazietà, e con l'inevitabile si bemolle, razzo tenorile finale offerto all'applauso della folla.
L'orchestrazione e i giuochi contrappuntistici dimostrano una raffinatezza di gusto superiore a quella che ha presieduto alla composizione de Gli Ugonotti della Dinorah e dello stesso Profeta. Questa medesima romanza: «O Paradiso» e molti altri particolari sparsi dovunque ne sono una prova. Fra le altre trovate strumentali nuove non va dimenticato il drammatico «a solo» degli archi (le famose «16 battute dell'Africana») con cui si apre il quadro finale; a solo veramente animato, nella sua nuda semplicità, da un potente soffio di fatalità.
RICCARDO WAGNER - TRISTANO E ISOTTA: dramma musicale in 3 atti. Prima rappresentazione al Regio Teatro di Monaco (Baviera) il 10 giugno 1865. Il poema è di Wagner.
Atto 1° - La tolda d'una nave. La parte anteriore è divisa dal resto mediante una tenda. - Giunge la canzone di un marinaio;le sue parole sembrano irridere alla principessa Isotta d'Irlanda, che Sir Tristano conduce in isposa a Marke, Re di Cornovaglia, e la irritano. Essa ordina alla fedele ancella Brangania di recarsi da Tristano a comandargli che venga come vassallo a farle omaggio. Al messaggio recato da Brangania risponde con scherno lo scudiere Kurvenaldo, il quale aggiunge alle parole una canzone in cui ricorda come Tristano abbia ucciso Moroldo, il fidanzato di Isotta. La principessa racconta allora a Brangania come essa raccogliesse Tristano ferito, il quale celò il vero essere suo sotto il finto nome di Tantris. Riconosciutolo poi per l'uccisore di Moroldo, volle vendicare il fidanzato, ma uno sguardo di lui la disarmò. Essa lo curò e lo lasciò partire, e ingrato tornò per recarla schiava al vecchio Re Marke, che essa odia. Brangania, esperta in filtri magici, le mostra un filtro d'amore che la stringerà al Sovrano di Cornovaglia; ma Isotta trasceglie il filtro di morte e le ingiunge di mescerlo in una coppa a lei e a Tristano. Se non che Brangania, sconvolta dall'orrore per quanto la sua signora le ha imposto, invece del filtro di morte versa nella coppa il filtro d'amore. E quando la nave sta per giungere in porto, i due giovani si trovano nelle braccia l'uno dell'altro, legati per sempre da un amore sovrannaturale.
Atto 2° - Giardini innanzi all'appartamento di Isotta. - È notte; Re Marke e la sua Corte sono partiti improvvisamente per una caccia. Isotta vuol spegnere la fiaccola accesa innanzi alla porta, la cui luce (segnale convenuto) tiene lontano Tristano. Invano Brangania, che teme gli inganni del cavaliere Melò, tenta di opporsi. Isotta sa che Melò è fido amico di Tristano, e resa imprudente dal suo ardore amoroso, spegne la fiaccola: Brangania veglierà. Tristano accorre; il dialogo fra i due amanti è tutto un delirio d'amore. Brangania più volte dall'alto della torre li ammonisce che il giorno sta per sorgere; essi non la odono. Quando improvvisamente irrompe Kurvenaldo gridando a Tristano: «Salvati!», e dietro a lui giungono Melò, il Re, e la Corte. Melò si vanta col Re di avergli consigliato l'agguato che gli ha permesso di scoprire l'infedeltà di Isotta e il tradimento di Tristano. Ma il Re non ha una parola di sdegno contro la sposa; solo lamenta dolcemente che Tristano lo abbia ingannato, Di chi potrà ora fidarsi se Tristano è infido? Tristano non si difende: il Re non può comprendere quanto è accaduto. Andrà in esilio; e chiede a Isotta se vorrà seguirlo. Essa dichiara che lo seguirà dovunque egli vada, e Tristano la bada. Melò scatta sdegnato per l'offesa fatta al Re; Tristano accusa allora Melò di tradimento: innamorato anch'egli di Isotta, tradì l'amico denunziandolo al Re. Estrae la spada sfidandolo, ma come Melò si getta contro di lui, la lascia cadere e resta mortalmente ferito.
Atto 3° - Giardino innanzi al castello di Kareol, proprietà di Tristano. Di là dal parapetto il mare. - Su un letto, all'ombra di un gran tiglio, giace assopito Tristano, vegliato da Kurvenaldo che qui lo condusse. Si ode la triste nenia d'un pastore. Kurvenaldo attende Isotta, ma la zampogna del pastore lo avverte che il mare è deserto. Tristano rinviene e racconta i sogni del suo sopore febbrile, poscia rievoca Isotta. Egli la sente appressarsi ed è preso da una sovreccitazione che invano Kurvenaldo tenta di calmare. All'improvviso la zampogna del pastore fa udire un motivo gaio. Tristano balza insofferente dal letto; udendo la voce d'Isotta si strappa le bende dalla ferita e cade estinto nelle braccia di lei. Ora il pastore annunzia l'arrivo di un altro vascello: è Re Marke il quale, informato da Brangania del filtro bevuto dagli amanti, viene a portare il suo perdono e a congiungerli. Ma Kurvenaldo crede a un nuovo tradimento di Melò, fa barricare le porte del castello e chiama all'armi. Nel combattimento Kurvenaldo è uccìso; il Re entra solo in tempo a vedere Isotta che spira sul cadavere di Tristano.
Questo, molto in succinto, il fatto, purtroppo spogliato di tutto quanto è il pensiero e i suoi trapassi, lo spirito e la sua essenza, la poesia e la sua atmosfera. Chi può ridire il superbo e sdegnoso carattere di Isotta e la fierezza di Tristano nel 1° atto, la folle ebbrezza d'amore d'entrambi nel 2°, la rude fedeltà di Kurvenaldo e quella sottomessa di Brangania, la bontà di Re Marke? In realtà, non si può riassumere con altre parole tutto quello che di amaro, di selvaggio e di appassionato passa nei discorsi di Isotta, la profondità del dialogo amoroso tra lei e Tristano nel 2° atto, la cupa invocazione alla notte in cui è già il presentimento della morte nel totale abbandono all'amore senza scampo, il sublime rapimento di Isotta morente, il cui spirito ormai è in armonia con lo spirito dell'Universo. Poema notturno, il fatale sommergersi nella voluttà dell'amore, nella delizia del delitto, in quella vita d'al di là che è la morte, ha un tono sempre trasognato e delirante che solo la musica può esprimere al di sopra delle parole del poema, ma che per la sua delicata essenza si corre il rischio di sminuire, di deturpare, di distruggere attraverso a parafrasi e a commenti. Tutte le volte che si legge qualche «guida» o altra qualsivoglia esegesi di quest'opera di Wagner si rimane sempre scontenti. Gli stessi gesti dei personaggi, i lunghi sguardi, i silenzi, sono pregni di una poesia che è intraducibile; ed anche la separazione della parola dalla musica, o di questa da quella, spezza e dissolve l'incanto artistico. Non possiamo dunque che offrire ai lettori dei cenni esterni.
La struttura dell'opera è già quella a tessuto sinfonico tematico che Wagner denominò «dramma musicale»: Wortton-drama, sintesi di tutte le arti. I temi non hanno mai carattere descrittivo esteriore, non esprimono la cosa, ma «l'idea» della cosa, e il loro susseguirsi e intrecciarsi costituisce la «melodia infinita». Su tale tessuto si stende il canto: recitativo cantabile, melopèa, o canto drammatico espressivo, legato, sì, alla parola, ma non tanto al suono esteriore di essa quanto allo stato d'animo da cui la parola sorge e alle complesse emozioni che l'accompagnano.
Bisogna poi tener presente che, a parte l'alone magico creato dall'azione del filtro, i personaggi appartengono ad un mondo leggendario remoto e sono degli «eroi», e perciò il loro canto, anche senza voler fare di proposito dell'arcaismo (e Wagner si tenne ben lontano da qualunque ricostruzione archeologica) non può nè deve essere quello, ad esempio, che Verdi attribuisce a degli «uomini» come Rigoletto, Manrico, Violetta, Otello, Falstaff. Il senso dell'arcaico, dell'eroico, del leggendario e del magico, sono insiti nella natura di espressione ottocentesca e specificamente wagneriana dei motivi.
Ai caratteri anzidetti va aggiunta la sensibilità erotica morbosa di altri motivi, spinta fino allo spasimo e al delirio, segnatamente nel lungo duetto del 2° atto, e nella scena dell'arrivo di Isotta nel 3°. Il tessuto sinfonico scorre dal preludio dell'opera alla morte di Isotta con un impeto travolgente in cui i richiami tematici hanno una tale spontaneità da annullare completamente ogni impressione cerebrale che il congegno meccanico poteva lasciar sospettare. Ciò si deve non solo alla forza espressiva prodigiosa ìnsita nei temi stessi, ma all'intuizione di un genio che ha saputo sottomettere senza sforzo apparente la maestria costruttrice (e in questa maestria comprendiamo anche la sensibilità dei timbri orchestrali) all'ispirazione. In alcuni momenti essa si condensa in pagine di trascendente espressività: tale il preludio al 1° atto, nel quale i principali temi dell'incantamento amoroso e quello della morte che rugge tetro nei bassi, trovano un'esposizione drammaticamente eloquente e colori di potente suggestione. Tale anche il finale dell'opera in cui l'ansietà del tema che sale per gorghi sonori e per strappi veementi sprigiona una forza di liberazione catartica travolgente.
Ma accanto a questi due brani celebri, che si eseguiscono di frequente anche staccati dall'opera come pezzi sinfonici da concerto, quanti altri che racchiudono un'intensa bellezza lirica o drammatica! Così il concitato racconto di Isotta nel 1° atto, la scena del filtro in cui l'azione magica (veramente non più necessaria nei riguardi di Isotta dopo la confessione fatta da costei del fascino amoroso operato dallo sguardo del creduto Tantris, ma utile a giustificare il tradimento fatto al suo buon Re da questo campione dell'onore e della fedeltà), l'ardente impazienza di Isotta descritta nel preludio del 2° atto mentre la fanfara dei cacciatori si allontana nella notte piena di vibrazioni suadenti, l'impeto frenetico dell'incontro con Tristano, l'abbandono funereo e sensuale insieme dell'inno alla notte, il nobile lamento del Re, la malinconica desolata nenia del corno inglese che apre, senz'accompagnamento, il 3° atto, l'allucinato delirio di Tristano. Poi ci sono i numerosi particolari: frasi del canto, colori dell'orchestra, modulazioni imbevute d'una mollezza voluttuosa, che in qualche momento di più viva ebbrezza, come nella chiusa del duetto d'amore del 2° atto, par trasformarsi in vertigine dei sensi.
Ma citare scene, pagine, episodi, particolari, è frammentare inutilmente un'opera che presenta una unità di stile meravigliosa da cima a fondo, ed 'è voler trattare la poesia come un soggetto da tavolo anatomico o da laboratorio chimico. Noi dobbiamo rivolgerci al senso di poesia dell'ascoltatore affinchè egli si immerga in questo fiotto di altissima musica-poesia e poesia-musica e se ne lasci permeare. Forse poche parole di Wagner medesimo sintetizzano meglio d'ogni lungo discorso ciò che la musica di questa opera esprime: «sospiro e speranza, lamento e desiderio, voluttà e tormento». Ed anche le ultime parole di Isotta possono servire di commento alla musica del Tristano: «Nell'ondeggiante oceano dell'armonia sonora, del respiro del mondo nell'alitante Tutto, naufragare, affondare inconsapevolmente, suprema letizia!».
FEDERICO SMETANA (Leitomischl [Boemia] 1824 - Praga 1884) - LA SPOSA VENDUTA: opera comica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Nazionale di Praga il 30 maggio 1866. Libretto di Karol Sabina.
Atto 1° - Un villaggio; da un lato una locanda. - La bella Marenka, figlia dei contadini Kruschina e Kathinka, deve sposarsi per volontà dei suoi genitori, con Vasek, giovane un po' sciocco e balbuziente, figlio dei ricchi proprietari Tobia ed Agnese Micha. Essa è però segretamente fidanzata con Jenik, giovane da poco giunto in paese, e del quale ignora il passato. Richiestone, egli le dice che è di ricco casato. Mortagli la madre, il padre si sposò nuovamente. La matrigna con perfidia volse il cuore dello sposo contro il figlio, che fu cacciato di casa. Frattanto il mercante di matrimoni Kezal si è già messo d'accordo coi genitori di Marenka, ma la ragazza dichiara di amare Jenik e rifiuta le nozze proposte.
Atto 2° - Osteria. - Marenka, fingendosi un'altra e dicendo a Vasek che lo ama, gli fa giurare che non sposerà Marenka. Intanto Kezal propone a Jenik di cedergli per trecento fiorini la sua fidanzata a favore del figlio di Tobia Micha. Jenik acconsente a firmare il patto a condizione che in esso sia espressamente detto che nessuno, all'infuori del figlio di Tobia Micha, possa sposare Marenka. E il contratto viene pubblicamente firmato, ma grande è lo scandalo di tutti quando si sa che Jenik ha venduto la fidanzata.
Atto 3° - La scena del 1° atto,-Giunge in paese una compagnia di commedianti; Vasek sedotto dalle grazie di una giovane ballerina si lascia indurre a far la parte dell'orso in sostituzione di un attore che si è ubbriacato. Frattanto Marenka ha saputo che Jenik ha rinunziato a lei per del denaro e lo rimprovera piangente per il vile mercato; però egli appare tranquillo e sorridente, e ciò accresce la sua indignazione. Ma come giunge Kezal con i parenti, Micha e sua moglie riconoscono Jenik per il figlio un giorno cacciato. Marenka dunque sposerà, com'è stabilito nel contratto, il figlio di Micha. Kezal rimane con un palmo di naso per essere stato cosi ben giuocato. All'improvviso si odono grida di spavento: «salvatevi, l'orso si è slegato!». Ma il primo movimento di paura si tramuta in risa generali allorchè si scorge che l'orso non è altri che Vasek travestito.
Questa, che è la più unitaria e perfetta fra le opere di Smetana, ha una musica scorrevole, tutta improntata a una gioconda festività, e qua e là venata di sentimento affettuoso, È ancora l'opera ad arie, a duetti, a terzetti, a concertati; ma i recitativi legano queste parti con eleganza di stile, valendosi di un linguaggio anch'esso fluido e semplice, sorretto spesso da efficaci commenti strumentali. Precede una spigliata vivacissima sinfonia che inizia con un movimento fugato pieno d'animazione e scivola via con una vertiginosa rapidità da moto perpetuo, alternando alla sua veloce giocosità episodi patetici e ritmi di danza balzanti.
È un gioiello frequentemente eseguito in concerti; ma non altrettanto frequentemente si rappresenta quel gioiello che è l'intera opera. Eppure la musica di Smetana, specialmente in questo spartito, è melodicamente ispirata, ariosamente cantabile, e congiunge a un senso di popolarità dei ritmi e degli spunti una garbata signorilità di modi. La commedia stessa è divertente e la musica ne dipinge bene i principali tipi, specialmente quello del mercante Kezal nella sua grossolana prosopopea quattrinaia, e quello di Vasek dalla comica balbuzie e dalla ingenua stupidità. Tipi che la musica ironizza con simpatia e finezza con una satira bonaria senza pesantezza.
Forse perchè non c'è la risata rumorosa, esuberante, quest'opera non è popolare fra noi, dove il pubblico cerca sempre l'estremo della violenza, così nel riso come nel pianto. È probabile pure che il predominio dell'elemento pittoresco e caratteristico ambientale su quello sentimentale contribuisca a diminuire l'interesse del pubblico per La sposa venduta. Lo stesso garbo aggraziato ed arguto, la raffinatezza dello stile, il gusto aristocratico delle lineature e dell'armonia, la delicatezza dello strumentale senza concessioni a gusti plateali, fanno di quest'opera qualcosa che non può essere alla portata di qualunque palato; non che vi sia del difficile, ma esige sensibilità aristocratica. Eppure, il colore smagliante dei cori e delle danze dovrebbe vincere anche la freddezza di chi non si scuote che sotto lo stimolo di eccitamenti potenti.
Queste danze e questi cori dai ritmi marcati, dai motivi popolareschi (senza veri e propri elementi folkloristici) dai colori brillanti ed accesi, sono quanto di più caratteristicamente boemo si possa immaginare. Un senso di vita sana e gioiosa tipicamente nazionale si effonde da queste musiche piene d'aria e di luce. Tutta una stirpe campagnuola, con i suoi costumi e le sue tradizioni, palpita e respira in queste che sono le pagine più belle e vive dell'opera.
AMBROGIO THOMAS (Metz 1811-Parigi 1896) - MIGNON: dramma lirico in 3 atti. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 17 novembre 1866. Libretto di Michele Carré e Giulio Barbier, dal romanzo Wilhelm Meister di Wolfango Goethe.
Atto 1° - Cortile di un'osteria tedesca. - Borghesi seggono ai tavoli bevendo, o s'aggirano conversando. Nel cortile entra un vecchio cantore, Lotario, del quale si dice abbia smarrita la ragione in seguito a un grave dolore. Egli cerca dovunque invano la figlia Sperata, che scomparve da casa ancora bambina. Entra anche lo zingaro Giarno con una compagnia di salterini. Fra essi è una giovinetta chiamata Mignon, che Giarno vuol far cantare e ballare. Ma poichè essa si rifiuta. Giarno minaccia di batterla col bastone. Un giovane ricco signore, Guglielmo Meister, in viaggio di diporto, si interpone e compera la fanciulla. La frivola e volubile Filina, attrice in una compagnia di commedianti, che ha assistito alla scena, si fa presentare dal suo compagno di teatro Laerte a Guglielmo. Non ostante gli avvertimenti di Laerte sul carattere di Filina, Guglielmo se ne invaghisce. Allontanatasi Filina con Laerte, Mignon viene a ringraziare Guglielmo per averla liberata. Guglielmo l'interroga sul suo passato e la sua famiglia, ma ella non sa che descrivere il suo paese di nascita, «la terra ove fioriscono gli aranci»: l'Italia; e solo ricorda il momento in cui bambina fu rapita da una tribù di zingari. Essa ha pure un colloquio con Lotario, il quale rimane stupito vedendola prendergli l'arpa e cantare accompagnandosi con abilità. Intanto Filina è stata chiamata a recitare con la sua compagnia al castello del Barone di Rosemberg. Essa vi invita Guglielmo. Il nipote del Barone, Federico, giovane innamorato di Filina, presente all'invito, si ingelosisce di Guglielmo; ed anche Mignon, che si è istintivamente affezionata al suo liberatore, prova un involontario senso di amarezza e di fanciullesca gelosia.
Atto 2° - Quadro 1° - Un elegante gabinetto di toeletta nel castello del Barone. - Filina sta apparecchiandosi per la recita; Guglielmo l'ha seguita. Egli ha seco Mignon, vestita da paggio. Rimasta sola, essa è puerilmente attratta dalle ricche vesti abbandonate da Filina, delle quali va ad abbigliarsi nel suo gabinetto. Sopraggiungono intanto Guglielmo e Federico. Questi, riconosciuto in Guglielmo un rivale, lo sfida a duello. Mentre incrociano le spade. Mignon, rivestita con gli abiti di Filina, si precipita a dividerli. Federìco allora si allontana ridendo. Guglielmo rimprovera dolcemente Mignon, e l'avverte che dovrà separarsi da lei. Federìco rientra con Filino, la quale schernisce Mignon. Questa allora si strappa di dosso vesti e merletti con dispetto.
Quadro 2° - Un angolo del parco annesso al castello. - Mignon, arsa dalla gelosia per Filina, sta per gettarsi nel lago, allorchè giunge Lotario. Il dolore e Vira di Mignon lo esaltano ed egli corre a dar fuoco al castello. Mentre i comici e gli invitati si riversano nel parco applaudendo Filina, le fiamme divampano. Guglielmo si precipita nell'interno e ne trae svenuta Mignon che Filina aveva inviata a cercarle dei fiori dimenticati.
Atto 3° - Una galleria adorna di statue nel palazzo Cipriani, in Italia presso un lago. - Qui Guglielmo ha trasportata Mignon, dopo che l'ebbe salvata dall'incendio. Essa rimase a lungo incosciente; Lotario l'ha seguita. Un servo racconta a Guglielmo che nel lago, quindici anni addietro, scomparve la figlia del padrone di casa. Pel dolore la madre morì e il padre impazzì. Ora il palazzo Cipriani sarà venduto. Mignon intanto entra e si guarda intorno come se quei luoghi destassero in lei qualche ricordo. Guglielmo, che si è innamorato di Mignon ed ha ormai scoperto il segreto del suo cuore, le confessa il suo amore. Frattanto, su la soglia di una porta da lungo tempo chiusa, appare in ricchi abiti Lotario. Egli reca un cofano dal quale Mignon trae diversi oggetti che vagamente le ricordano qualcosa del passato. Essa incomincia a leggere da un libro di preci, poscia lo lascia cadere e prosegue a memoria. Infine volgendosi ravvisa la stanza e il ritratto di sua madre. Lotario, il quale altri non era che il Conte Cipriani, la riconosce allora per Sperata, la figlia sua da tutti creduta annegata nel lago, da lui solo ritenuta ancora viva e costantemente ricercata.
Il carattere prevalente della musica di Mignon è la tenerezza patetica, che però talvolta giunge al sentimentalismo, e che conferisce alla partitura un'espressione troppo uniformemente dolciastra. A ciò devesi aggiungere una scrittura piuttosto sciatta e molte parti frivole e banali. Particolarmente debole riesce la figura di Filina, non solo per l'indole sua antipatica, ma per quel suo fatuo e perenne gorgheggiare che, se è in carattere con la superficialità vanesia e citrulla della sua anima, non è per questo meno stucchevole. Stupidissimo, anche musicalmente, è Federico, e insignificante Laerte.
Toccante è invece, per verità di sentimento, la figuretta di Mignon col suo sospiroso sogno del bel cielo d'Italia, con la sua fiera ribellione alla brutalità di Giarno, con la sua istintiva antipatia per Filina, e l'altrettanto istintiva simpatia per Lotario, con la puerile e femminea curiosità per gli abiti e i cosmetici di Fi-lina, e con l'impulsivo attaccamento al proprio liberatore Guglielmo. Questi aspetti, che i librettisti tolsero al romanzo goethiano, la musica segue e colora con vena ispirata e con un bel rilievo plastico.
Da questa giusta intuizione sono nate alcune delle più belle e popolari pagine dell'opera: la poetica romanza: «Non conosci il bel suol», l'agile canzone: «Leggiadre rondinelle», entrambe così imbevute di luce e così piene di aspirazione alla libertà, la «Stiriana» così giovanile e gioiosa: «Io conosco un garzoncel», il cantabile, in verità un poco gounodiano, «Ella è là presso a lui», in cui per la prima volta si espande liricamente l'amore di Mignon per Guglielmo, il duetto con Lotario: «Sofferto hai tu?», in cui trabocca una piena di dolore così intensa e commovente, e infine le'ultime scene dell'opera, dal sorridente: «Ah! son felice!», in cui rinasce il respiro della vita, alla preghiera purissima e delicata: «O Vergin Maria», che segna il risveglio della memoria e il riconoscimento del padre.
Di Lotario la musica descrive bene la smemorata ma sempre nobile figura, anche nella miseria, e lo circonda di un'aureola di affettuosità paterna misteriosamente istintiva e intuitiva, sia che stupisca all'udire Mignon a suonar l'arpa, sia che ne indovini l'odio per Filina, che lo spinge ad appiccare il fuoco al teatro, sia che ne indovini l'amore per Guglielmo, fino al supremo grido di riconoscimento allorchè la vede continuare la preghiera senza più leggere, e ricordare la stanza e l'effige materna.
Guglielmo, dopo il primo impulso generoso, espresso in un recitativo senza carattere, cade nella trappola di Filina senza che la musica abbia se non frivoli disegni sensuali, ma senza vero sentimento e anche senza civetteria; e la breve frase «Quante grazie! quante vezzi!» benchè ricca di fascino, è troppo poco per dirci il sorgere di questo, sia pur effimero sentimento.
Riesce invece ben delineato il nascere e lo svilupparsi dell'amore per Mignon, amore però che avviluppa anche Guglielmo in una sciropposa sentimentalità, ma che si espande indubbiamente in tre pagine sognanti per delicatezza intima di poesia: la melodia: «Addio, Mignon! fa core», la romanza «Ah non credevi tu», e il patetico Andante «La tua bell'alma» ove l'affetto si stende in una canora onda di suoni piena di umana tenerezza.
GIUSEPPE VERDI - DON CARLO: opera in 5 atti. Prima rappresentazione all'Opéra di Parigi l'11 marzo 1867. Libretto di Giuseppe Méry e Camillo Du Locle.
Atto 1° - La foresta di Fontainebleau. - Don Carla, Infante di Spagna, si incontra con la Principessa Elisabetta di Valois che gli è stata promessa in isposa. L'amore avvampa prontamente nel cuore di entrambi; ma giunge la notizia che il Re Enrico di Francia ha concessa la mano di Elisabetta al sovrano di Spagna Filippo II, padre di Carlo, come suggello di pace fra le due nazioni, Elisabetta sacrifica con dolore il suo nuovo affetto per Carlo al bene del popolo.
Atto 2° - Quadro 1° - Il chiostro del convento di San Giusto. A destra una cappella con la tomba di Carlo V. - Don Carlo, disperato per aver perduta Elisabetta, si incontra con Rodrigo Marchese di Posa, suo intimo amico, il quale lo incita a dedicarsi alla difesa del popolo fiammingo. A lui Carlo confida il suo amore per la Regina.
Quadro 2° - Sito ridente alle porte del chiostro. - Rodrigo si presenta alla Regina e le dà nascostamente un biglietto di Carlo con il quale il principe le chiede un colloquio prima di partire per le Fiandre. Elisabetta lo accoglie da sola, ma alle sue parole d'amore oppone un rifiuto, e Carlo parte disperato. Sopraggiunge il Re, il quale, trovata Elisabetta sola, esilia la Contessa di Aremberg, Dama della Regina. Filippo si intrattiene poi con Rodrigo, il quale vorrebbe consigliarlo a regnare con minore durezza e a dare la libertà al suo popolo. Filippo lo chiama sognatore; pure, ne riconosce la nobiltà dell'animo e lo prega di studiare Carlo e la Regina, della cui fedeltà sospetta.
Atto 3° - Quadro 1° - I giardini della Regina a Madrid. - Carlo ha ricevuto un biglietto con un appuntamento notturno; egli crede si tratti di Elisabetta, ma giunge invece la principessa Eboli che ama Carlo e si crede da lui riamata. Ella s'accorge però del proprio errore, e scoperto l'amore di Carlo per la Regina, minaccia di vendicarsi. Interviene Rodrigo il quale, non riuscendo a placare Eboli, si fa dare da Carlo carte compromettenti circa la congiura delle Fiandre, volendo salvarlo nel caso che Eboli lo facesse arrestare.
Quadro 2° - Gran piazza innanzi a Nostra Donna d'Atocha. - Passa il corteo che accompagna alcuni condannati al rogo. Al sopraggiungere del Re gli si fa innanzi Carlo con una deputazione di Fiamminghi, chiedendo per sè il Brabante e la Fiandra. Al rifiuto del Re, Carlo esasperato sguaina la spada, ma Rodrigo lo disarma. Il corteo si rimette in moto e accompagna il Re e la Corte ad assistere ali' «auto-da-fè».
Atto 4° - Quadro 1° - Il gabinetto del Re. - Il Re si crede tradito dalla consorte e la sua tristezza è profonda. Egli chiede poi il parere del Grande Inquisitore a proposito della ribellione di Carlo, e quegli lo consiglia a fare arrestare il principe. Uscito l'Inquisitore sopraggiunge la Regina per denunziare il furto di uno scrigno. Il Re, che ha avuto in realtà da Eboli lo scrigno della Regina, glielo presenta e lo apre. Trovatovi il ritratto che Carlo donò ad Elisabetta quando erano fidanzati, il Re non ha più dubbi sul tradimento di entrambi e insulto la Regina. Eboli confessa poi il suo fallo ad Elisabetta, e questa le ordina il ritiro in un convento.
Quadro 2° - Prigione. - Carlo è stato imprigionato, ma Rodrigo viene ad annunziargli la sua liberazione. Egli ha fatto trovare fra le proprie carte i fogli riguardanti la congiura, e la sua morte è certa. Infatti di lì a poco uno sgherro con una fucilata l'uccide. Quando il Re giunge per liberare il figlio, questi gli svela il generoso sacrificio di Rodrigo. Frattanto fuori il popolo si solleva in favore di Don Carlo, ma a domare il tumulto basta l'intervento del Grande Inquisitore.
Atto 5° - Il chiostro di San Giusto come al quadro 1° dell'atto 2°. - Elisabetta saluta Don Carlo che partirà per la Fiandra. L'addio è un superamento eroico del loro amore. Ma il sospettoso Filippo II li sorprende e chiede al Grande Inquisitore che faccia giustizia. L'ombra di Carlo V, già apparsa in altri momenti dell'azione, interviene in difesa del principe trascinandolo nel Mausoleo.
Il Don Carlo, composto per l'Opéra, risente in parte dei gusti viziati di questo ambiente teatrale parigino, nel quale erano ammessi solo melodrammi del tipo meyerbeeriano detto «grand-opéra», e cioè opere in cinque atti, con ampio sfarzo di costumi, gran movimento decorativo di masse, azione a colpi di scena, e balli con spettacolosa coreografia. Questo tipo melodrammatico aveva già fatto sentire il suo influsso malefico nel 1855 su la composizione de I VESPRI SICILIANI. Esso, con la sua prolissità, con le sue divagazioni esteriori, urtava contro la nervosa stringatezza tutta veloce impeto drammatico di Verdi. E tuttavia, a dispetto del libretto prolisso, farraginoso, pessimamente condotto e peggio concluso, I Vespri contengono tante pagine bellissime fra cui lo stupendo tragico IV atto, e soprattutto quella prodigiosa sinfonia in cui, per essere libero dalle pastoie convenzionali del testo, Verdi ha condensato tanta forza espressiva, riunendo i motivi più alti dell'opera in una sintesi che ha il respiro di un poema sinfonico.
Col DON CARLO Verdi non poteva evitare completamente il danno inerente alla struttura della «grand-opéra». Tuttavia l'esperienza fatta con I Vespri e la maggiore maturità tecnica e stilistica gli permisero di portare lo schema della, grand-opéra su un piano più alto. Non potè evitare le prolissità, le divagazioni e la banalità delle danze; ma seppe dare all'ispirazione una nobiltà di sentimento e, nei momenti più drammatici, una potenza espressiva mai raggiunta da Meyerbeer, se non forse nel celebre duetto del 4° atto de Gli Ugonotti,
Una delle scene, ad esempio, in cui appare sensibile l'influsso meyerbeeriano, ma in cui appare anche altrettanto evidente la differenza fra l'euforia esteriore e decorativa di Meyerbeer e la forza tutta inferiore di Verdi, è quella del corteo che accompagna Filippo ad assistere all'«auto-da-fè». La struttura del pezzo richiama alla mente, nelle linee generali, il corteo del Profeta ma le tinte meyerbeeriane sono brillanti e superficiali, mentre Verdi dipinge un quadro vigoroso che sembra un affresco del Tintoretto.
Sono fra le pagine migliori dell'opera il duetto tra Rodrigo e il Re alla fine del 3° atto, la grand'aria di Filippo nel 4° atto:«Dormirò sol», il successivo duetto col Grande Inquisitore, e l'aria d'Elisabetta: «Tu che la vanità conoscesti del mondo» nel 5° atto: quattro fra le più alte ispirazioni verdiane.
L'aria «Dormirò sol» è preceduta da un'introduzione orchestrale la quale crea un'atmosfera di tristezza che il recitativo sconsolato e la melodia successiva incupiscono, pieni come sono più che dell'annientamento di ogni sogno d'amore e della solitudine sulla terra, della più nera solitudine nella tomba. Il duetto col grande Inquisitore è dominato dall'austera e glaciale gravità del motivo dei bassi che sembra recare in sè il peso di un incubo spietato e di una fatalità di tremenda. L'aria Elisabetta è preceduta da un preludio che al solenne motivo di Carlo V alterna frasi gonfie d'ansia e di dolore che ci raffigurano la lotta che sì svolge nell'animo dell'infelice Regina orante innanzi al sepolcro del grande Imperatore. Quest'aria per l'ampiezza delle frasi e per la loro efficacia drammatica, per l'evocazione nostalgica dei ricordi, per la poesia del sentimento, per l'ansietà angosciosa del movimento «agitato» che l'attraversa, per la sciolta libertà delle forme, non trova riscontro se non nelle più alte e rare pagine di tutta la letteratura musicale.
Ma anche nelle parti che si potrebbero dire prolisse, in quanto non indispensabili allo svolgimento dell'azione e alla precisazione dei caratteri, o in quanto rallentano il dramma» ve ne sono di così ispirate che spiacerebbe di veder sopprimere qualora si volesse snellire e sveltire la mole ponderosa dell'opera. Tale è, ad esempio, l'aria di Eboli: «O don fatale», dai movimenti così vari e drammatici.
Allo snellimento dell'opera aveva già pensato Verdi, consapevole dei suoi difetti ma anche ben cosciente del suo valore. Egli ne fece nel 1884 un'edizione in 4 atti, sopprimendone i ballabili, l'atto i, breve ma ricco di stupende melodie, e rinfrescandola, irrobustendola ed anche modificandola in più punti. È questa l'edizione più di frequente eseguita. Essa incomincia con quello che nella i» edizione figura come quadro 1° dell'atto 2°. Ma nel 1887 egli ripristinava l'atto 1°, lasciando intatte le varianti introdotte negli altri.
Fra queste varianti è da ricordare il delicato Preludio al 3° atto, intessuto su lo spunto dell'aria di Carlo: «Io la vidi», con una ricerca nuova di emozioni armoniche, attraverso a progressioni e modulazioni, in un continuo sfumare di timbri diversi. E varianti notevoli sono anche nel robusto e severo duetto tra Filippo e il Conte di Posa, animato dal contrasto fra il leale e generoso sentimento di liberalità di Rodrigo e la cupa diffidenza, l'ottusa crudeltà del Re.
Dovunque Verdi ha rimesso le mani, ha potato e irrobustito, approfondendo l'espressione del recitativo, moltiplicando i colori dell'orchestra e densificandone la partecipazione con ricchezza di disegni e movimenti che schiudono ormai le porte a un nuovo linguaggio musicale: quello che Verdi userà per l'Otello.
RICCARDO WAGNER - MAESTRI CANTORI DI NORIMBERGA: opera in 3 atti. Prima rappresentazione al Regio Teatro di Monaco (Baviera) il 21 giugno 1868. Testo poetico di Wagner. - L'azione si svolge a Norimberga verso la metà del secolo XVI.
Atto 1° - Interno della chiesa di S. Caterina. - Alla fine della funzione religiosa il cavaliere Walter di Stolzing ferma la giovine Eva Pogner per chiederle se è fidanzata. La nutrice Maddalena lo informa che Eva andrà sposa l'indomani a quello tra i Maestri Cantori che vincerà la gara di canto. Davide, apprendista presso Hans Sachs, espone confusamente al Cavaliere in che consista il difficile esame per diventare Maestro. Poco dopo entrano i componenti la Corporazione dei Maestri Cantori. Fra essi è il ricco orefice Veit Pogner, padre di Eva, che il Cavaliere conosce. A lui Walter esprime il suo desiderio di diventare Maestro. Pogner espone ai Maestri i termini della gara e presenta Walter come aspirante Maestro. Ciò dà subito ai nervi al bilioso scrivano Sixtus Beckmesser, il quale, agognando alla mano di Eva, sospetta nello Stolzing un rivale. Lette le regole che il cantore deve osservare, Beckmesser si ritira come «marcatore» dietro una tenda per segnare su una lavagna gli errori di Walter. Questi improvvisa un canto che sembra duro e sgrammaticato ai Maestri, e più al «marcatore», il quale di li a poco fa osservare ai colleghi la lavagna su cui ha segnato un numero stragrande di errori. Però il celebre poeta-ciabattino Hans Sachs prende le difese di Walter e lo invita a proseguire, ma i Maestri, sobillati anche dalle critiche mordaci di Beckmesser, respingono con sdegno il candidato.
Atto 2° - Una strada di Norimberga: a destra la casa di Pogner, a sinistra la casa e la bottega di Hans Sachs. - Eva, avendo appreso da Maddalena la fallita prova di Walter, si reca da Sachs per avere più precise notizie. Questi è convinto che i Maestri furono ingiusti, ma ad Eva lascia credere il contrario. Anche Sachs ama segretamente Eva, ma accortosi della sua passione per Walter, rinunzia all'impossibile sogno e decide di aiutare i due giovani. Uscita sdegnata dalla bottega di Sachs, per l'apparente ostilità di questi verso Walter, Eva si incontra con l'innamorato, col quale delibera di fuggire. Frattanto Beckmesser, vedendo alla finestra Maddalena e scambiandola per Eva, si mette a cantarle la canzone ch'egli ha preparato per conquistarla nella gara, È una canzone molto pedante che Sachs disturba picchiando fortemente col martello su una scarpa, sotto pretesto di segnalargli in tal guisa gli errori. Il vicinato protesta dalle finestre contro questi clamori notturni; molti scendono su la via, ne nascono litigi che si trasformano ben presto in una baruffa generale, della quale Eva e Walter vorrebbero approfittare per fuggire. Ma Sachs vigila e interviene, rimandando Eva a casa e sospingendo Walter dentro la propria bottega. Si ode squillare il corno della guardia notturna: tutti fuggono, la quiete ritorna nella via.
Atto 3° - Quadro 1° - Interno della bottega di Sachs. - Dopo gli avvenimenti passati, Sachs, sempre più deciso a favorire i due giovani innamorati, ascolta Walter cantargli un sogno d'amore fatto nella notte, e ne trascrive su un foglio il testo dandogli preziosi consigli su la forma. Nella stanza rimasta per un momento vuota, entra Beckmesser. Le busse prese durante la baruffa lo fanno zoppicare. Scorge il foglio scritto da Sachs, immagina di averlo rivale alla gara e dà in ismanie. In quella arriva Sachs, il quale gli assicura che il canto non è suo, e gli fa dono del foglio, Beckmesser parte felice, convinto di avere una poesia di Sachs e di vìncere con questa la gara. Eva viene da Sachs col pretesto di una scarpa stretta, ma in realtà per avere notizie di Walter. Questi intanto entra e canta una nuova strofa, perfetta, della canzone. Eva indovina la generosità di Sachs e fa per abbracciarlo, ma questi la fa scivolare nelle braccia di Walter.
Quadro 2° - Vasta pianura presso il fiume Pegnitz. A destra la tribuna per i Maestri. - Una grande folla di popolo è in attesa della gara. Sfilano le corporazioni operaie coi loro stendardi. All'arrivo di Hans Sachs il popolo sorge intonando solennemente una delle sue più belle canzoni. Ha poi inizio la gara, alla quale si presenta per primo Beckmesser. Egli si sforza di adattare al canto già preparato la poesia datagli da Sachs; ma non essendo riuscito a mandarla a mente, la travisa in modo grottesco destando le più allegre risate del pubblico. Beckmesser scarica allora la colpa su Hans Sachs, ma questi presenta in Walter l'autore della poesia e invita il pubblico ad ascoltarlo. Il suo canto entusiasma e commuove la folla e persuade, i Maestri. Per tal modo Walter vince la gara conquistando insieme la mano di Eva.
Per una volta tanto Wagner è sceso dal mondo degli eroi a quello degli uomini, anzi dei borghesi, ed ha creato ugualmente un capolavoro. Una fluente onda melodica percorre da capo a fondo la partitura de I Maestri Cantori e l'investe con una luce di poesia intima e commossa. Anche in quest'opera egli, da buon tedesco, non può a meno di essere qua e là prolisso; ma la bellezza dell'ispirazione fa dimenticare facilmente qualche soverchia lungaggine che, all'atto pratico, su le scene italiane, viene spesso assoggettata ad amputazioni che non oseremmo dire inopportune, Con la canzone del 1° atto di Walter e quella finale della gara, con la canzone di Beckmesser, la canzoncina di San Giovanni di David, la canzone umoristica che Sachs intona lavorando, i cori sacri del i ° atto, il saluto corale ad Hans Sachs nel 3°, la musica del corteo, con i cori e le canzoni delle singole corporazioni, si può dire che l'opera non manca di pezzi quadrati, anche se abilmente fusi col resto; e non vi manca neppure la forma concertata, e perfino un quintetto e una sinfonia. Cosicchè si direbbe che Wagner in quest'opera abbia tentato deliberatamente un innesto del melodramma italiano sul sinfonismo germanico.
La sinfonia è un pezzo celebre che si impernia sui principali motivi dell'opera, a cominciare da quello pomposo e pesante dei Maestri, e attraverso a quelli dell'amore (che frammenti del tema precedente contrappuntano in maniera pedantesca, particolarmente contrastante con il libero volo del canto di Walter) giunge fino allo strepitoso tema delle corporazioni che si conclude con una ripresa più solenne e affermativa del motivo dei Maestri. Costruzione architettonica potente e sfarzosa per varietà di colori e di disegni armoniosamente intessuti ed elaborati.
Ma questo che diciamo della sinfonia si può, in verità, dire di tutta l'opera. Aggiungiamo che, pur avendo l'occhio alle grandi linee costruttive, ogni episodio della partitura rivela un fine lavoro di cesello, cosicchè numerosissimi sono i particolari che si impongono per la squisitezza della fattura e per la delicatezza dei contrasti strumentali che rispondono non a un puro senso decorativo ma a valori espressivi psicologici e a un alto senso di poesia. Da notare pure una maggiore stabilità armonica, poggiante principalmente sul chiaro e robusto tono di do maggiore.
Fra le pagine nelle quali Wagner fa maggiore sfoggio della sua stupenda maestria di polifonista vocale e strumentale è da porre al centro la baruffa con cui si chiude il 2° atto. Su la densa struttura del «fugato» orchestrale, in cui giocano un tema che saltarella dispettoso e buffo e la canzone di Beckmesser in avvolgimenti duramente litigiosi, si scatenano ben diciannove parti vocali anch'esse urlanti, gementi, rimbrottanti con ira, in una disposizione di effetto babelico, ma che all'analisi risulta architettonicamente ineccepibile. Poi, d'improvviso, un contrasto repentino che ci solleva dal mondo delle contese labili a quello della natura eterna: il suono del corno della guardia che fa sfollare rapidamente la via, lasciando emergere la voce dell'estatica serenità notturna. Ed è un vero prodigio magico creato dalla musica questo trapasso dal putiferio di prima a questa poesia di una plenilunare primavera punteggiata dall'umoristica paura del guardiano che sospetta una tregenda di spiriti.
Una consimile baruffa, ma più in piccolo e senza l'appoggio della forma «fugata», c'è già alla chiusa del 1° atto, allorchè i Maestri insorgono insofferenti contro il canto di Walter che si prolunga provocante sul loro clamore. Ma qui la scena si chiude su un'allegra vertiginosa danza dei garzoni e apprendisti. Un altro brano polifonico, di tutt'altro carattere, da non passare sotto silenzio, è quello che nel 3° atto segue la canzone di Walter, e in cui l'onda molle del suo «improvviso» si prolunga nelle voci del coro provocandovi echi e risonanze melodiose di consenso; e questo è veramente il trionfo del canto e della poesia.
Accanto al romanzo d'amore di Eva e Walter e alla generosa rinunzia di Sachs, c'è la musica e l'umanità elementare, l'una e l'altra un po' rozza ma onesta e sincera, di David, il garzone e apprendista di Sachs. E c'è la satira della pedanteria musicale, di quel conservatorismo che fa consistere tutto nelle regole, trascura lo spirito e resta fermo alle tradizioni formalistiche e incapace di comprendere la necessità storica e artistica dello sviluppo delle forme. Questa satira mirava a colpire quella critica che si era mostrata ostile alla riforma wagneriana e alla sua musica, e in primo luogo l'Hanslick. Ne venne fuori la pungente macchietta di Beckmesser, acre, invidioso, ottuso, tutto regola e niente musica. I suoi motivi sono stecchiti, maligni e fatui. Pieno di scatti nervosi e di smorfie irose allorchè sospetta in Walter e in Sachs dei rivali, la sua boria si espande tronfia e vacua nella attività di «marcatore». La scena in cui trova in casa di Sachs la canzone di Walter è una delle più caratteristiche per l'espressione musicale goffamente grottesca di questo personaggio. Ma il capolavoro che musicalmente più lo scolpisce è la balorda e arida canzone che egli canta nel 2° atto, la quale acquista nel 3° una comicità ridicolissima allorchè, per adattarvi, spropositandolo, il testo datogli da Hans Sachs, ne stiracchia il motivo rendendolo ancor più risibile.
Eva è figura che la musica aureola di candore e di trepida passione, non senza qualche punta di malizia, come quando in chiesa allontana due volte la nutrice per poter parlare a Walter, e non senza qualche ingenuo e focoso dispettuccio, come quando inveisce contro Sachs che crede colpevole, come gli altri Maestri, di aver respinto Walter. L'atmosfera in cui vive è quella della poesia notturna e sospirosa che circonda lei e Walter nel 2° atto. Walter, non è altrettanto evidente, e rimane come assorbito dal casto amore di Eva. Più che come personaggio egli ci interessa come poeta nei suoi due canti: in quello un po' (e volutamente) prolisso e stentato (nella seconda parte tortuoso e percorso da amara e contenuta ira) del 1° atto, e in quello largamente disteso, alato e caldo della canzone finale: pezzo strofico, ma concepito e condotto con libertà di disegno e di sviluppi che, soggetti all'ispirazione del momento, variano di volta in volta.
Ma la figura più significativa dell'opera è quella di Sachs. Wagner si è identificato in questo personaggio ed ha saputo renderlo con un rilievo musicale profondo. La grave nobiltà e la generosa bontà della sua anima sono trasfuse nei suoi canti così semplici e chiari, e riaffermate in ogni motivo orchestrale che lo riguarda. Il suo primo intervento a favore di Walter durante la prima prova ci svela già tale aspetto psicologico. Nel 2° atto poesia e musica approfondiscono questa bonaria e Urica immagine, dapprima accentuando, attraverso alla sua meditazione sul profumo dei lilla (la traduzione italiana dice erroneamente gelsomini) la sua sensibilità poetica, poi lasciandoci intravvedere la sua affezione per Eva mentre egli punzecchia la fanciulla innamorata e curiosa dicendo male di Walter e lodando Beckmesser (e la musica asseconda con grande finezza questo gioco), e infine nella umoristica «canzone biblica» e nella turlupinatoria censura a colpi di martello della canzone di Beckmesser. Ma nel 3° atto la musica dipinge con intensa espressione il lato più intimo e poetico del Maestro-ciabattino: la sua rinunzia. La malinconia grave e calma del preludio a un certo momento s'inciela nell'impossibile sogno d'amore, e le note si aureolano di una struggente tenerezza. È questa la pagina più profonda di tutta l'opera, e quella in cui la poesia raggiunge la maggior espressione meditativa.
Le scene successive insistono su questo atteggiamento; ma all'ultimo lungo discorso fatto dopo la vittoria di Walter, con l'esaltazione della Germania, non è già più Hans Sachs che parla, ma Wagner con tutto il peso del suo nazionalismo egocentrico. Occorre però convenire che, non appena il coro riprende voce, inneggiando a Sachs simbolo dell'arte tedesca, la musica assume una grandiosità da epopea.
GIUSEPPE VERDI - LA FORZA DEL DESTINO: melodramma in 4 atti; 2a edizione eseguita per la prima volta alla Scala di Milano il 27 febbraio 1869. Libretto di Francesco Maria Piave. -Epoca dell'azione: verso la metà del XVIII secolo.
Atto 1° - Sala in casa del Marchese di Calatrava. - Leonora, dopo aver data la buona notte al padre, rimane combattuta fra il suo amore di figlia e quello per il giovane Don Alvaro. Essa ha promesso di fuggire con lui. Don Alvaro, sopraggiunto, la trova in quello stato di perplessità e dubita dell'amor suo, ma Leonora si decide a seguirlo. Se non che sono sorpresi dal Marchese, il quale insulta il presunto seduttore della figlia. Alvaro non vuole difendersi, getta anzi l'arma, ma da questa parte un colpo che ferisce mortalmente il Marchese, il quale spira maledicendo la figlia.
Atto 2° - Quadro 1° - Grande cucina d'un'osteria nel villaggio di Hornachuelos. - Don Carlo di Vargas, fratello di Leonora, vuoi vendicare la morte del padre uccidendo la sorella e il seduttore, fuggiti dopo la morte del padre. Egli, sotto le mentite spoglie dello studente Pereda, interroga, indaga e racconta anche senza dire i nomi la storia della sorella. Leonora è giunta alla medesima osteria e riesce, tra le canzoni degli ospiti e il movimento dei passeggeri, a fuggire senz'essere riconosciuta.
Quadro 2° - Spianata davanti a un Convento fra scoscese montagne presso Hornachuelos. - Leonora domanda del Superiore, gli racconta la propria storia e ottiene di potersi rifugiare in una grotta nei pressi del convento.
Quadro 3° - L'interno della chiesa del convento. - Leonora, col volto celato, viene accolta come penitente nello speco dal quale i fratelli giurano di tenersi lontano. Se un pericolo le sovrasta, potrà chiamare il Superiore suonando una campana.
Atto 3° - Quadro 1° - Bosco presso Velletri. - Don Alvaro, nella notte in cui fuggì con Leonora, inseguito dai famigli del Marchese, fu separato da lei. Egli la crede estinta, commessa crede lui ucciso in quella medesima notte. Ora, capitàno dell'esercito spagnolo in Italia sotto il falso nome di Don Federico Erreros, ha occasione di salvare la vita a un ufficiale che si fa chiamare Don Felice de Bornos, ma che in realtà altri non è che il fratello di Leonora. I due, senza riconoscer si, si giurano eterna amicizia.
Quadro 2° - Abitazione di un ufficiale superiore dell'esercito spagnolo in Italia. - Don Alvaro viene recato gravemente ferito. Egli consegna all'amico un plico, ingiungendogli di bruciarlo se morirà. Ma il sospettoso Don Carlo scopre nella valigia ov'era il plico un ritratto di Leonora, Questo gli dice che il ferito è il seduttore della sorella e l'uccisore del padre. Intanto gli viene annunziato che il ferito è salvo; egli dunque potrà sfidarlo e vendicare l'onore offeso.
Quadro 3° - Accampamento militare. - È l'alba. Guarito Don Alvaro, Don Carlo gli si svela e lo sfida, ma l'arrivo di una ronda interrompe il duello. Il campo intanto si risveglia alla vita fra canti guerrieri.
Atto 4° - Quadro 1° - Interno del Convento presso Hornachuelos. - Don Alvaro si è fatto frate col nome di padre Raffaele; ma Don Carlo è riuscito a rintracciarlo. Lo provoca, lo insulta e lo costringe a battersi.
Quadro 2° - Lo speco fra le rupi, ove vive Leonora. - Don Alvaro batte alla porta dell'eremo chiedendo soccorso: egli ha ferito gravemente Don Carlo. Leonora suona la campana d'allarme, poscia, riconosciuto Don Alvaro e udito da lui quanto è accaduto, corre a prestar soccorso al fratello; ma questi raccogliendo le estreme forze la colpisce a morte. Accompagnata verso lo speco dal Superiore, essa muore perdonando al fratello e dicendo ad Alvaro che l'attende in cielo.
La farsa del Destino ebbe la prima rappresentazione al Teatro Imperiale Italiano di Pietroburgo il io novembre 1862. Ma questa prima edizione fu ritirata da Verdi, e poscia ampiamente trasformata, tanto nell'azione come nella musica, specialmente nelle ultime scene; e aggiuntavi anche la sinfonia famosa, fu ridata alla Scala nel 1869. È opera indubbiamente farraginosa, ma non è l'inverosimiglianza dei casi che disturba: nella vita a volte si danno inverosimiglianze anche maggiori. È l'affastellamento dell'azione, la molteplicità degli ambienti e delle folle, il numero dei personaggi inutili, la mole degli episodi puramente decorativi e ingombranti che rendono il dramma slegato e caotico. C'è di tutto: cori di gente all'osteria, cori di frati, e cori di soldati; un corteo di pellegrini, una vestizione, e una battaglia; il risveglio di un accampamento militare, e lo scodellamento della minestra ai poveri; rivenditori ambulanti, ronde soldatesche, e duelli; le canzoni guerresche, le predizioni d'una zingara, e la buffa predica di un frate.
La concisione e la snellezza drammatica indubbiamente ne soffrono; ma in questo caleidoscopio di personaggi minori e di episodi di contomo il quadro generale della vita umana si dilata come in un romanzo, pur rimanendo tutto ciò estraneo al dramma. Il musicista vi ha preso interesse, e ne è nata una musica ricca di colore e di forza. Valga qualche esempio: la preghiera: «La Vergine degli Angeli», di così pura melodicità e di così mistica religiosità, è un episodio non indispensabile all'azione, ma completa e chiude il quadro della vestizione portandovi una nota di sublimità. Altro esempio: la piccola ronda del 3° atto; superflua allo svolgimento del dramma, essa reca però un tocco delicatissimo di poesia alla pittura ambientale. Tutta la scena del campo non ha nulla a che vedere con i fatti riguardanti i tre protagonisti (Leonora-Alvaro-Don Carlo), ma è indubbiamente un affresco pieno di vita realistica, dalle canzoni piene di brio di Preziosilla al passaggio dei venditori ambulanti, dal coro-tarantella: «Nella guerra è la follia» alla predica piena di gongorismi di Fra Melitone, e finalmente al ritmatissimo e dinamicissimo «rataplan».
A proposito di Preziosilla e di Fra Melitone è bene poi ricordare che, malgrado nella vicenda fatale non abbiano che una parte completamente indifferente (in ispecie Preziosilla), Verdi considerava della massima importanza questi due personaggi. Si capisce che doveva pensare alla novità ch'essi rappresentavano per lui sotto l'aspetto musicale. Infatti nella tragica malinconia della musa verdiana, questi due personaggi, come già l'Oscar del Ballo in maschera, gettano una luce vivida.
Oscar, Preziosilla, e specialmente Melitone, rappresentano tre esperienze gaie, brillanti ed anche comiche su la via di quel ritorno all'opera buffa che gli fallì nel 1840 con Un giorno di regno, e che raggiungerà, con perfezione senza pari, nel 1893 col Falstaff. Più che la spiritosa e balda Preziosilla, le cui più vivaci espressioni hanno sempre la forma strofica della canzonetta, sono figure nuove e riuscite la piccola macchietta del rivendugliolo Trabuco, in cui è comicamente stilizzato il modo di annunciare la merce proprio degli ambulanti da fiera popolare, e quella più grossa e grassa del frate Melitone. Il canto di questi si svolge per recitativi melodici liberamente concepiti, sapidi di humor, e sostenuti da piccanti commenti orchestrali. Lo stile comico di Rossini e di Donizetti sono lontani, come lontanissimo è lo stile di Falstaff ma in Melitone ferve una vita nuova che si trasente densa d'avvenire: così specialmente nella predica ai soldati, e nella scena coi poveri in cui la figura del frate pettegolo emerge ancor più pel contrasto con l'austera figura del Superiore.
Il dramma che si impernia su l'implacabile persecuzione del caso, o, come dice il titolo dell'opera: su «la forza del destino», concentra in una breve sintesi tematica la sua essenza. È il tema che appare subito dopo i sei squilli energici con cui si apre la potente sinfonia, e impronta della propria irruenza insistente la sinfonia stessa originandone gli sviluppi più interessanti della parte centrale, e investendo pure come una minaccia l'«Allegro» finale. Esso ricompare poi, senza obbedire ad un principio sistematico, come tema-cardine nei momenti più significativi dell'azione. La quale trova nell'ispirazione verdiana una vigoria espressiva ed una bellezza melodica piena di quell'impeto irresistibile e di quel plastico rilievo che avvicinano il genio del Maestro a quello di Shakespeare. Ci si riferisce, naturalmente, a talune delle scene più intense e profonde: al monologo di Leonora innanzi al convento, monologo che dall'angoscia smarrita sale alla disperata preghiera; al duetto successivo col Padre Guardiano, ricco di così volitiva energia nei canti della donna e di così alta nobiltà in quelli del Superiore; al duetto Don Carlo-Alvaro nel 4° atto, in cui Verdi sa trarre una forza drammatica nuova dal contrasto fra la violenza rude di Don Carlo e l'umiltà dapprima faticosamente conservata e poi gradatamente perduta di Alvaro.
Pensiamo ancora alla nostalgica romanza di Alvaro: «O tu, che in seno agli Angeli», preceduta dal vaghissimo e malinconico a a solo» del clarinetto; all'abbandono esausto del «Pace, mio Dio!» di Leonora; e infine al terzetto ultimo dove la frase del Padre Guardiano: «Non imprecare, umiliati» ci strappa con alto rapimento alla miseria terrena per aprirci l'austera contemplazione dell'al di là; rapimento che si accentua con la frase dei fagotti che sottolineano il senso di redenzione che invade l'anima commossa di Alvaro e quello di liberazione che si espande dalla melodia di Leonora: «Lieta poss'io precederti». Ecco un'altra scena la quale smentisce in pieno che Verdi sia sempre terragno e che gli manchi il senso della catarsi.
AIDA: opera in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro dell'Opera del Cairo il 24 dicembre 1871. Libretto verseggiato da Antonio Ghislanzoni su trama di Manette Bey, modificata e stesa nel testo prosastico da Verdi stesso.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala nel Palazzo del Re a Menfi. - Radamès, giovane guerriero Egiziano aspira ad essere il condottiero delle truppe nella guerra imminente, e, conquistata l'Etiopia, a ridare patria e trono alla schiava Aida da lui amata. Ma di Radamès è innamorata anche la principessa Amneris, figlici del Faraone. Essa sospetta in Aida una rivale e attraverso abili conversazioni con Radamès e con Aida cerca di scoprire tale segreto. Intanto un messo reca la notizia che gli Etiopi, guidati dal Re Amonasro (che gli Egissi non sanno essere il padre di Aida) hanno invaso l'Egitto. Il Re rivela che Radamès è stato indicato da Iside guaio condottiero. Aida è combattuta fra l'amore per Radamès e quello per la patria.
Quadro 2° - Interno del tempio di Vulcano. - Fra danze e cantici sacri si svolge la cerimonia per la consegna del vessillo a Radamès e la sua consacrazione a capo dell'esercito.
Atto 2° - Quadro 1° - Sala nell'appartamento di Amneris. - Con astuta finzione Amneris fa confessare alla schiava il suo amore per Radamès. Le annuncia però con oscure minacce ch'essa è sua rivale.
Quadro 2° - Uno degli ingressi alla città di Tebe. - Radamès, a capo dell'esercito vittorioso, seguito da numeroso stuolo di prigionieri, è accolto trionfalmente. Fra i prigionieri è Amonasro. Egli si dà a conoscere come il padre di Aida, ma tace di essere anche il Re. Anzi afferma che il Re Etiope è caduto in battaglia ai suoi piedi. Radamès domanda al Re la liberazione dei prigionieri Etiopi, ma Ramfis, Gran Sacerdote, si oppone. Il Re allora trattiene come ostaggi Aida e suo padre, e dà la libertà agli altri. Annunzia inoltre a Radamès che in premio della vittoria gli concede la mano di Amneris.
Atto 3° - Le rive del Nilo. Da un lato il tempio di Iside. - Ramfis conduce al tempio Amneris, affinchè preghi tutta la notte prima delle nozze. Giunge poi Aida la quale attende per un colloquio Radamès. Il padre lo ha saputo: avverte Aida che gli Etiopi si accingono ad invadere di nuovo l'Egitto e che Radamès sarà ancora il condottiero degli Egizi. Egli esige ch'essa gli chieda la via che terrà l'esercito. Minacciata, percossa, Aida è costretta ad acconsentire. Essa induce Radamès a fuggire con lei e si fa indicare la strada che percorrerà l'esercito Egiziano. Amonasro celato è in ascolto; ma anche Amneris dal tempio ha udito il dialogo e addita a Ramfis i traditori. Amonasro dopo aver tentato di uccidere Amneris fugge con la figlia, mentre Radamès si consegna al Sacerdote.
Atto 4° - Quadro 1° - Sala nel palazzo del Re. - Amonasro è stato inseguito ed ucciso; di Aida si è perduta ogni traccia; Amneris ora vorrebbe salvare Radamès. Ma questi rifiuta di discolparsi e mene condannato ad essere sepolto vivo sotto l'altare del Nume.
Quadro 2° - La scena è divisa in due piani. Al superiore l'interno del Tempio di Vulcano, all'inferiore il sotterraneo ov'è stato rinchiuso Radamès. - Aida, presaga della condanna di Radamès, è penetrata furtivamente nel sotterraneo. Essa mene a spirare fra le braccia dell'amante, mentre nel tempio si svolgono riti propiziatori e Amneris implora da Iside pace per il sepolto,
Invano la critica si è appuntata contro quest'opera al suo apparire ed anche in epoca recente. Essa resiste magnificamente al tempo per l'altezza, la forza e il colore della sua musica. In un certo senso figlia della «grand-opéra» con danze, cortei sfarzosi, riti sacri pittoreschi e colpi di scena, Aida presenta tuttavia una rapidità e concisione drammatica e un'intima compenetrazione di tutti i suoi elementi poetici che nettamente la distaccano dal genere francese-meyerbeeriano. Nulla vi è di superfluo; le stesse sue romanze, come le celebri «Celeste Aida» di Radamès, e «O cieli azzurri» di Aida (quest'ultima nostalgica lirica fu composta nel 1872 per la riproduzione dell'Aida alla Scala di Milano) sono momenti lirici essenziali nella vita spirituale dei personaggi.
Si è parlato, a proposito delle pitture ambientali di Aida dì «oleografìa», ed anche recentemente si è cercato di sottovalutarne l'interesse artistico a vantaggio della pura umanità dei personaggi. Questo punto di vista ci sembra assolutamente sbagliato. Verdi, persuaso com'era che in arte «copiare il vero - sono sue parole - può essere una buona cosa, ma inventare il vero è meglio», si guardò bene dal fare una ricostruzione archeologica dell'Egitto faraonico. E del resto su che cosa avrebbe potuto basarsi, mancando di ogni elemento folkloristico e storico? «Inventò» il vero, e fece opera d'arte. Prendendo a fondamento alcune alterazioni della scala caratteristiche della musica orientale, specialmente antica, si servì di esse per «inventare» una musica di sapore esotico e vi riuscì mirabilmente. Di tali alterazioni non ne fece un sistema: quando i personaggi parlano delle loro passioni: amori, dolori, odi, ire, sospetti, passioni che sono di tutti i tempi e di tutti i popoli, Verdi parlò da musicista ai musicisti, secondo il suo stile profondamente umano ed universale. Ma quando i sentimenti dei personaggi si originano dall'ambiente, si riflettono su di esso, o sono comunque in istretto rapporto con esso, allora i modi esotici affiorano e gettano una nota di nostalgia o di arcaicità che, com'ebbe giustamente ad osservare il Bonaventura, «è più orientale che se fosse realmente orientale».
Queste atmosfere di color locale le troviamo nei preludietti dell'oboe alla romanza: «O deli azzurri», all'invito di Aida: «Fuggiam gli ardori inospiti», nei cori e nelle danze sacre, nella danza dei moretti al 2° atto, e nel primitivismo della marcia trionfale affidata alle trombe lunghe e del grido d'angoscia delle sacerdotesse: «Soccorri a noi!» all'inizio del 3° atto. A proposito del quale grido d'angoscia vale la pena di ricordare com'esso si innesti su una squisita pagina di sensibilità della natura: quella che evoca la poesia di una notte lunare presso il Nilo, col mormorio calmo delle acque, il canto arcaico di un flauto campestre, le salmodie sacre dei sacerdoti, e l'alta invocazione delle sacerdotesse che getta nella calma descrizione d'ambiente un senso di smarrimento drammatico.
Certo, se tutto ciò non va sottovalutato non va neppure sopravalutato, e la maggior grandezza di quest'opera non sta nelle evocazioni di color locale orientaleggianti e arcaicizzanti, per quanto stupende, ma nell'altezza e nella forza dell'ispirazione lirico-drammatica che sa trovare temi di scultoria potenza e di sovrana bellezza. I quali temi, o almeno Ì due principali, sono condensati nel breve preludio: il sospiroso sognante motivo dell'amore di Aida, e quello duro e tetro dei sacerdoti che si svolge strisciando come un serpe insidioso e cozza tosto tragicamente col precedente. Tema di vita il primo, tema di morte il secondo.
Verdi scrisse per l'esecuzione alla Scala una sinfonia per l'Aida, ma dopo la prova la ritirò, ben convinto che essa nella sua maggiore pretensiosità non poteva sostituire la concisione rapida e la perfetta bellezza del preludio.
Un altro tema importante, quello agitato che sottolinea la gelosia di Amneris, fa la sua comparsa nel primo dialogo di Amneris con Radamès, e sarà poi largamente sfruttato in tutto il corso dell'opera.
Al di sopra delle pitture di color locale, dei motivi tematici, e delle romanze, soste liriche le quali lumeggiano e approfondiscono particolari stati d'animo, sta il recitativo melodico verdiano in cui si concentra tutta la forza del dramma. Questo recitativo, fattosi ormai duttile, plastico, capace di trasfigurare la parola e i sottintesi moti dell'animo che l'accompagnano, di gettare nell'azione (con l'efficacissimo ausilio di un'orchestra ricca di colore, di movimento, e continuamente mutevole di disegni) il peso di un linguaggio potentemente incisivo, denso di poesia tragica e lirica, agisce come una forza rinnovatrice del melodramma già altamente perfezionata. Fino dal Don Carlo, e sempre più con La forza del Destino, e poi con l'Aida, il «melodramma», nel significato e nella struttura antica, scompare. Siamo di fronte a quella che con felice espressione Giuseppina Strepponi, la compagna intelligente e l'interprete fedele del pensiero verdiano, chiamò «l'opera-poema), concezione d'equilibrio fra testo e musica; non rappresentazione di momenti lirici e drammatici, ma espressione lirico-drammatica continuativa e totale in una libera fusione di elementi e di forme poetico-musicali.
Non si tratta già di un'applicazione della riforma wagneriana, come da alcuni critici affrettatamente fu detto. Il recitativo conserva un carattere precipuamente e italianamente melodico-vocale. Esso presenta ora aspetti strofici, ora si dissolve in frasi liberamente costruite, di ritmo vario e di espressione mutevole. Questa è la struttura delle più belle scene dell'opera, quali, ad esempio, il duetto, poi terzetto, del i atto fra Amneris, Radamès e Aida; il drammaticissimo duetto fra Amneris e Aida nel 2° atto; il veemente duetto fra Aida e Amonasro nel 3°. Il sospetto, l'amaro sarcasmo, l'odio minaccioso, improntano fortemente di sè le espressioni musicali di Amneris nei suoi colloqui con Aida, mentre i canti di questa appaiono sotto il riflesso seducente della sua invincibile passione amorosa e del suo timore per la potente rivale, timore che si espande in dolenti singhiozzi e nel totale abbandono dell'invocazione alla pietà dei Numi.
Radamès è tutto nei suoi canti d'amore, più che nelle espressioni guerrière, in verità assai rare e deboli. La sua energia si risveglia solo allorchè, credendo d'avere ormai perduta per sempre Aida, deliberato di morire, rifiuta ogni difesa. Quanto ad Amonasro è questa la figura più vigorosamente scolpita di tutta l'opera. La sua anima, che è un misto di violenza barbarica e di furberia felina, trova accenti che fanno di questo Re Etiope qualcosa di monumentale. La sua presentazione rude e vibrata negli ottoni, il suo astuto racconto ora fiero ora mellifluo, e infine la potente forza di suggestione con cui soggioga la volontà di Aida, hanno del michelangiolesco. Aida, gettata a terra, non ha più che un'implorazione di vittima vinta: «non maledirmi!», mentre l'orchestra è tutto un ansimante ascendere di singulti dolorosi.
Nel duetto del 4° atto fra Radamès e Amneris, il cozzo tragico dei due inconciliabili amori determina un altro dei momenti salienti della fantasia musicale verdiana. La musica si espande in forme più ampiamente strofiche, e si leva al sublime nello slancio catartico del canto di Radamès: «È la morte un ben supremo». L'ultimo duetto, che completa questo senso di distacco, è quello finale tra Radamès e Aida, in cui fiorisce il celestiale rimpianto del «Morir sì pura e bella», e la melodia liberatrice dell' «O terra, addio», mentre su le teste dei moribondi le mistiche carole perpetuano il senso della vita terrena, generando per contrasto un'impressione ancor maggiore di distacco fra il mondo di là che s'apre e quello di qua che scompare. E sembra quasi che nel buio della tomba ov'è morte, penetri la luce di una vita più verace, mentre i riti luminosi del tempio non appaiono più che come opachi elementi decorativi ormai esteriori e remoti, su cui l'ombra della morte sta scendendo per l'eternità.
GIORGIO BIZET - DJAMILEH: opera comica in un atto. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 22 maggio 1872. Libretto di Louis Gallet, derivato dal poema Namouna di Alfredo De Musset.
Atto unico. - Haroun cambia amante ogni mese. Già da un mese appunto ama Djamileh; ora cede Djamileh a Splendiano, che l'ama, e lo incarica di trovargli una fanciulla nuova. Splendiano dà notizia di ciò a Djamileh, la quale, addolorata, fa a Splendiano questa proposta: «Fammi prendere il posto della fanciulla che dovrà sostituirmi. Se è vero che Haroun non mi ami più, sarò tua». Scesa la sera Djamileh viene condotta da Haroun. La sua timidezza accende di desiderio Haroun; ma un raggio di luna gliela fa riconoscere. La fedeltà della giovane lo commuove; pure vorrebbe lottare contro il nuovo sentimento che investe il suo cuore. Tenta di scacciare Djamileh, ma il suo dolore lo vince, e finisce per aprirle le braccia. Splendiano e gli amici compaiono su la porta: Haroun scorgendoli copre con un velo il volto di Djamileh.
Partitura piena di eleganza, di buon gusto, di sentimento, alla quale non mancano neppure tocchi di pittoresco colore orientale. Opera comica, come fu chiamata, non è: di comico non c'è proprio nulla. C' è invece del sentimento delicato e fìne. Nelle melodie è una mollezza tutta orientale. Già il primo coro interno con cui l'opera si apre, al ritmo del tamburo basco e su gli accordi prolungati delle arpe, mentre Haroun sogna a occhi aperti fumando e il sole tramonta, diffonde un suggestivo senso di incantesimo voluttuoso. Il duetto seguente tra Haroun e Splendiano è pieno di quella leggerezza spigliata che ottimamente caratterizza la fatuità e instabilità amorosa di Haroun, mentre le strofe di questi: «Tu vuoi saper», con l'ampia e calda melodia, ne mettono in luce il lato sentimentale o meglio sensuale.
Altra pagina ben caratteristica per l'indovinatissimo colore orientale e le preziose armonie, è la canzone (Ghazel) di Djamileh: «Nour Eddin, re di Lahore». Altra cosa graziosissima è il coretto: «Chi sarà la bella», degli amici di Haroun incuriositi alla vista di Djamileh, tutto leggerezza vaga, a note staccate misteriose, di una gentilezza che staremmo per dire falstaffiana. E stupisce che i Francesi, tanto sensibili a tutto ciò che risponde a finezza ed eleganza di gusto, abbiano fatto cattiva accoglienza a pagine come queste, accusando Bizet... di wagnerismo! Vero ch'egli era ammiratore di Wagner, ma vero pure che si avviò per una strada diametralmente opposta, come dimostrerà Carmen, l'opera portata alle stelle da Nietzsche appunto come simbolo dell'antiwagnerismo più deciso.
E non è tutto qui: più alto ancora per ispirazione e intensità di sentimento è il «lamento» di Djamileh, con quel suo penoso oscillare della frase vanamente in cerca di riposo. Di colori suggestivamente orientaleggianti per gli intervalli alterati, con rapidi passaggi dal maggiore al minore, per il canto molle a note lunghe e per la ripetizione insistente del primo motivo languido malinconico e sensuale, è ancora la danza-coro dell'Almea (l'Aida di Verdi era uscita l'anno prima; ma l'avrà conosciuta Bizet?). Chiude l'opera un duetto Haroun-Djamileh appassionato e in qualche momento di una forte drammaticità.
Tutto ciò meriterebbe .all'opera un risveglio. Oggi certe parti possono anche sembrare invecchiate; ma sta di fatto che ve ne sono di tuttora ben vive, come sembra certo che l'opera non ebbe buone accoglienze in grazia di quel tanto che allora appariva nuovo ed audace, e che, non compreso, indignò.
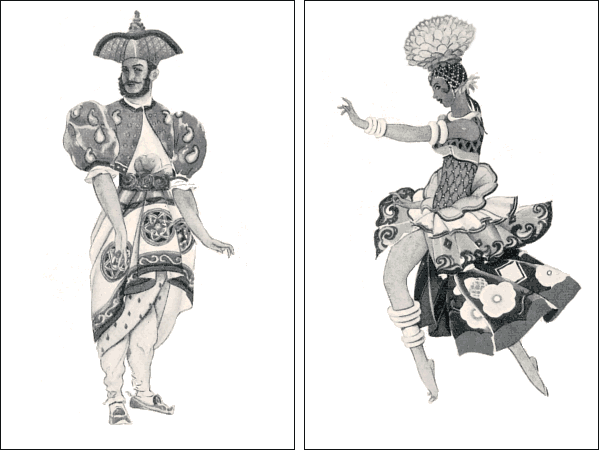
Figura 9: Figurini di Brunelleschi per I Pescatori di Perle di Bizet.

Figura 10: Scena di Cascella per la Carmen di Bizet.
MODESTO MUSSORGSKI (Karevo [Pskow] i839-Pietroburgo 1881). - BORIS GODUNOFF: dramma musicale popolare in un prologo e 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro Maria di Pietroburgo il 24 gennaio 1874. Libretto di Mussorgski, tratto dalla tragedia di Alessandro Puschkin.
Prologo - Quadro 1° - Il cortile del convento di Novodievitci presso Mosca. - Sotto la minaccia dei bastoni della polizia, la folla implora ad alta voce Boris Godunoff di accettare la corona di Czar della Russia. Su la fine passa un corteo di pellegrini.
Quadro 2° - La Piazza di Mosca fra la cattedrale dell'Assunzione e quella degli Arcangeli. - Boris ha accettato lo scettro di Czar ed esce in processione dalla cattedrale dell'Assunzione, ove ha avuto luogo l'incoronazione, fra il popolo festante.
Atto 1° - Quadro 1° - Una cella nel monastero del Miracolo. - È quasi l'alba: Pimmen, frate cronachista, veglia lavorando, mentre il giovane compagno Grigori dorme. Questi si desta di soprassalto per un sogno che lo atterrisce. Chiede poi a Pimmen notizie sull'età che avrebbe il giovane Czarevic Dimitri, che Boris fece sgozzare per salire al trono. Grigori è preso da una grande ambizione di combattere e di regnare.
Quadro 2° - Una locanda alla frontiera della Lituania. - Insieme a due frati beoni e vagabondi, Varlaam e Missail, entra pure, travestito, Grigori. La sua fuga dal convento è stata segnalata e la polizia lo ricerca. Un ufficiale di Polizia, analfabeta, gli fa leggere l'editto con l'elenco dei connotati; ma il furbo Grigori finge di leggervi quelli di Varlaam. Trovandosi nel pericolo, Varlaam, che sa leggere appena, compitando a fatica, legge i connotati esatti, corrispondenti a quelli di Grigori. Questi, vistosi scoperto, salta dalla finestra.
Atto 2° - Gli appartamenti dello Czar al Kremlino, - Xenia, la figlia di Czar Boris, piange la morte del fidanzato. Invano il fratello Teodoro, la Nutrice e lo stesso Czar cercano di consolarla e di distrarla dal suo dolore. Ma Boris ha l'animo tormentato dal rimorso per la morte del fanciullo Dimitri, assassinato insieme ad altri trenta innocenti per nascondere la vera causa del delitto. Sono passati cinque anni dalla sua ascesa al trono: il suo carattere si è fatto crudele e sospettoso, mentre intorno a lui nell'ombra si svolgono congiure, alle quali forse tien mano lo stesso suo ministro Sciuisky, colui che lo aiutò a compiere il misfatto. Questi gli dà notizia di una congiura capitanata da uno che si fa chiamare Dimitri. Boris, preso da un brivido superstizioso, si fa allora narrare la fine del piccolo Czarevic. Ma non resiste agli orrendi particolari del racconto, ed è assalito da un delirio in cui gli par di vedere venirgli incontro minaccioso il fantasma del principino ucciso.
Atto 3° - Quadro 1° - Gabinetto di Marina Mniscek nel Castello di Sandomiro in Polonia. - La figlia del Voivoda si abbiglia per una festa notturna; essa vuol conquistare il cuore di colui che si fa credere Dimitri e che si dice scampato per miracolo all'eccidio tramato da Boris, e sogna di ascendere con lui al trono di Russia. Della sua ambizione approfitta il gesuita Rangoni, il quale vuol avere in lei un messo di propaganda della fede cattolica e di persecuzione contro gli Ortodossi: a questo scopo essa dovrà sedurre il falso Dimitri.
Quadro 2° - Un giardino nel Castello dei Mniscek. - L'ex frate Grigori, fattosi credere Dimitri, attende Marina. Egli promette a Rangoni tutto dò che vorrà se lo farà parlare con Marina. Questa con astuta seduzione si fa promettere da Dimitri che la sposerà.
Atto 4° - Quadro 1° - La foresta di Kromy. - Una folla di rivoltosi compie diversi atti di violenza contro Bojardi e Gesuiti, inneggiando infine al passaggio del falso Dimitri. Solo l'Innocente, un povero scemo, piange su le sventure eterne della plebe.
Quadro 2° - La sala della Duma al Kremlino. - Boris si presenta ai Bojardi per averne consigli nella lotta contro il falso Dimitri. Egli è ormai in preda a frequenti allucinazioni, durante le quali gli sembra di vedere il fanciullo assassinato. Pimmen viene introdotto alla sua presenza e gli rivela che innanzi alla tomba di Dimitri un cieco ha acquistata la vista ed ha veduto il fanciullo. Boris al racconto del miracolo è colpito da un violento attacco al cuore, e muore dopo aver dato al figlio Teodoro saggi consigli e aver chiesto umilmente perdono a Dio del suo gran delitto.
Il libretto è piuttosto frammentario, e non tutto è essenziale al dramma, che perciò appare di lunghezza soverchia. Per abbreviarne la durata in generale all'esecuzione viene soppresso il 1° quadro del 3° atto, e viene soppressa la scena fra Dimitri e Rangoni nel 2° quadro dell'atto medesimo. Il quale 3° atto fu aggiunto da Mussorgski dopo le prime rappresentazioni dell'opera, per consiglio di amici. Inoltre all'esecuzione teatrale la disposizione dei quadri viene spesso variata. Lo strumentale dell'opera, nella partitura più frequentemente eseguita, è stato rifatto da Rimski-Korsakoff, avendo di mira un arricchimento di effetti sonori e timbrici, ma in realtà alterando talvolta in maniera dannosa la semplicità dell'orchestrazione mussorgskiana, anche se in qualche momento poteva apparire primitiva, debole, o scorretta.
Per l'uso fatto da Mussorgski di motivi popolari autentici russi, o creati dalla fantasia del musicista su lo stampo della canzone popolare russa (canzone della Nutrice, canzone di Teodoro, canzoni di padre Varlaam, tema del preludio, motivi di varie parti corali) l'opera ha un'impronta tipicamente nazionale. Ma non questo di certo basterebbe alla sua vitalità e alla sua grandezza. Ciò che fa del Boris un capolavoro non soltanto russo ma mondiale, è la forza e il rilievo con cui (pur basandosi spesso su elementi vocali propri dell'arte russa) sono scolpiti i caratteri dei personaggi; la vita conferita alla massa corale che diventa un personaggio di primo piano; e infine il senso tragico profondo che investe non solo talune scene ma l'intera opera, e l'anima tutta di un soffio potente.
Tra le figure minori spiccano Pimmen, Varlaam e l'Innocente. Pimmen ha un linguaggio vocale austero e sereno che si muove su uno sfondo di armonie gravi e dolci, e di canti sacri lontani, ed è presentato su un mormorio impressionistico degli archi che sembra come un calmo fluire perenne del tempo. Il suo intervento ha valore decisivo sul precipitare della tragedia. Ma anche nel suo racconto del miracolo all'ultimo atto, il suo canto si mantiene pacato e terso, cosicchè lo si direbbe un messo celeste venuto per annunziare l'ultima ora al peccatore.
Varlaam è tutt'altro tipo; rumoroso, buontempone, beone, la sua musica si muove su disegni vivaci e burleschi, qua e là caricaturali, com'è nella canzone «Cammina lui» e nella faticosa lettura dell'editto. L'Innocente con la sua ignara ingenuità e bontà di uomo semplice di mente, e pure con il suo profetico e malinconico senso della fatalità del dolore e della vanità di ogni tentativo per evitarlo, è figura che la musica ha disegnato con lineamenti di un'intima evidenza. Con altrettanta evidenza realistica la musica ci raffigura l'ambigua personalità del principe Sciuiski. Nella tortuosità dei disegni, nell'enigmatica dolcezza dei suoi canti, passa sottile e penetrante la sua perfida viltà.
La folla, anche se non è il personaggio più importante, come da taluno esagerando si è detto, è però personaggio che riempie di sè quasi ogni scena, ed è ritratta con realistica evidenza nei suoi atteggiamenti di sommissione e di ribellione, di preghiera e di esultanza. I suoi canti si ispirano al folklore popolare e costituiscono uno sfonda musicale movimentato su cui spicca vieppiù tragicamente l'isolamento dello Czar nella terrificante lotta interiore della sua coscienza. È nel 1° quadro del 4° atto che la folla si presenta come protagonista assoluta. La lotta del falso Dimitri contro Boris ha scatenato questa folla, con le sue passioni primitive, veementi e mutevoli, in due opposte direzioni. La musica che caratterizza i movimenti vari e impulsivi di queste masse è tutta a scatti e a frasi spezzate, sottile nell'ironia, acre nel sarcasmo. Poi, d'improvviso, si spiega in ampie ondate popolaresche di canti tutto ritmo e fuoco, o irrompe come ventata tempestosa o si eleva in un solenne impeto innico. Vi è dentro tutta l'anima russa, con le sue ingenuità e i suoi esaltamenti, col suo misticismo ed anche con i suoi scatenamenti barbarici.
Marina è figura molto secondaria, la cui anima vanesia e ambiziosa è stilizzata su ritmi di polacche e di mazurke che le creano attorno un'atmosfera ambientale fittizia e artificiosa. Ma al suo canto d'amore «Oh! Zarevic, io t'imploro», per quanto risenta delle forme d'ispirazione occidentali e specialmente francesi, non si può negare una seducente espressività sensuale.
Il protagonista, Boris Godunoff, grandeggia con forza e rilievo estremamente potenti. La tristezza grave mista a superstiziosa religiosità con cui ce lo presenta l'orchestra al suo primo apparire, ci mette subito a contatto con le fosche ombre che attraversano la sua anima ambiziosa e colpevole, ormai rosa dal rimorso e, perseguitata da un arcano terrore. Queste ombre egli diffonde attorno a sè. Com'entra nella stanza dove sono i suoi figli, questi subitamente ammutoliscono come severamente li minacciasse «un grande nibbio». Eppure un angolo casto esiste ancora nell'anima di colui che fece assassinare trenta fanciulli perchè perisse il piccolo erede al trono; ed è quello in cui, per contrasto, palpita con una tenerezza struggente l'amore pei suoi figli: Xenia, dolce malinconica figura di giovinetta, e Teodoro, fanciullo buono e gentile.
Una tristezza angosciosa lo opprime. La gloria, la famiglia, Dio, tutto gli sembra perduto; e l'onda della melodia si solleva come per un bisogno di respiro, di liberazione, di pianto. Ma il rimorso e il terrore gli divorano le lacrime; la diffidenza e il sospetto si impadroniscono di lui. L'annunzio della congiura di Sciuiski lo fa esplodere in uno scatto d'ira. Ma l'astuto ministro riesce a sviare la tempesta e gli ricorda la morte atroce del fanciullo e l'aspetto angelico del cadaverino stretto a un giocattolo: la musica, capolavoro d'espressione, è tutta un misto di delicata innocenza e di spasimo atroce.
Ciò che segue a questo racconto di Sciuiski è pressochè indescrivibile a parole. La pendola suona: il suo ritmo si amplifica paurosamente nella fantasia agitata e nella coscienza terrorizzata di Boris, suscita nella sua mente un'allucinazione delirante. Boris crede vedere il fantasma sanguinante di Dimitri; l'orchestra è un bieco e sordo turbinio di suoni, un alternarsi di accordi lugubri, di stridule risa, crea un'atmosfera di sinistra terribilità, mai udita nella letteratura musicale d'ogni tempo ed epoca.
L'ultimo quadro dell'opera ci ripresenta Boris in preda al delirio. La voce di Sciuiski lo richiama alla realtà, ma il racconto del miracolo compiuto da Dimitri crea la catastrofe. Dopo le raccomandazioni fatte, in tono austero e quasi religioso, a Teodoro, nella musica si seguono il motivo solenne dell'incoronazione, la campana dei morti, la voce del coro che annuncia: «Muore un fanciullo». Boris con un supremo sforzo si erige gridando: «Sono lo Czar!», ma tosto piomba a terra invocando Iddio. I bassi chiudono la tragedia sospirando cupi il motivo della sua angoscia.
GIORGIO BIZET - CARMEN: dramma lirico in 4 atti. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 3 marzo 1875. Libretto di Enrico Meilhac e Ludovico Halevy, dalla novella omonima di Prospero Merimée.
Atto 1° - Una piazza di Siviglia; a destra la Manifattura Tabacchi; a sinistra un corpo di guardia dei Dragoni. - Col cambio della guardia giunge il brigadiere Don Josè, al quale la sigaraia Carmen con fare sfrontato getta un fiore. Frattanto la giovane Micaela, fidanzata di Don Josè, mene a recargli notizie della madre lontana che lo benedice. Ma ecco, appena partita Micaela, nella Manifattura scoppia una rissa provocata da Carmen, la quale viene arrestata da Don Josè. Ma Carmen con raffinata civetterìa seduce Don Josè, gli dà un appuntamento presso l'osteria di Lillas Pastia, e fugge.
Atto 2° - L'interno dell'osteria di Lillas Pastia. - Carmen danza e canta per un gruppo di ufficiali dei Dragoni, fra i quali, suo più fervido ammiratore, è il capitano Zuniga. All'osteria arriva pure il Torero Escamillo, il quale è subito preso dalla bellezza di Carmen. Partiti costoro, giunge Don Josè, appena uscito dal carcere ove fu rinchiuso per aver lasciata fuggire Carmen. Ligio al dovere egli vorrebbe rientrare in caserma appena ode suonare la ritirata; ma Carmen cerca di trattenerlo. Nel frattempo ritorna Zuniga; fra lui e Don Josè si accende una lite per Carmen. Essi stanno per battersi, allorchè alcuni zingari contrabbandieri, della cui società fa parte Carmen, intervengono separandoli e dichiarando di doverli condurre per precauzione con loro.
Atto 3° - Luogo selvaggio fra le gole dei Pirenei. - Escamillo, salito sui monti per amore di Carmen, si incontra col geloso Don Josè e sta per battersi con lui. Carmen li divide e trattiene a stento Don Josè mentre Escamillo, provocante, si allontana. Intanto alcuno della banda ha trovata nascosta Micaela, venuta a cercare Don Josè: sua madre muore e lo chiama. A. malincuore, e minacciando Carmen, egli la segue.
Atto 4° - Una piazza di Siviglia: in fondo l''Arena. - La folla si accalca per assistere all'arrivo del corteo del Torero. Carmen giunge a braccio di Escamillo. Mentre questi entra nell'Arena, alcune amiche avvertono Carmen di stare in guardia poichè hanno visto aggirarsi nei pressi Don Josè. Eccolo infatti: egli piange, e scongiura Carmen di ritornare con lui.. Ma Carmen rifiuta, ed unisce al rifiuto lo scherno gittandogli ai piedi l'anello che le aveva donato. Dall'interno dell'Arena giungono grida di evviva al Torero; Carmen vorrebbe entrare; Josè glielo impedisce e accecato dalla gelosia l'uccide;poi, disfatto, si lascia arrestare, invocando disperatamente: «Mia Carmen adorata!».
Carmen, accolta al suo apparire con vera incomprensione, si impose poi gradatamente per quel grande capolavoro che è, fino ad essere esaltata dal filosofo Federico Nietzche come l'opera della ribellione antiwagneriana. Essa era stata composta nella forma dell'opera comica francese, cioè a scene staccate, con recitativi parlati. Più tardi Ernest Guiraud dette loro un'intonazione musicale sufficientemente aderente allo stile bizetiano.
La parola «capolavoro» non ci esime dall'accennare a qualche lato debole dell'opera. Ci riferiamo a quelle scene di carattere comico o brillante che alla prima esecuzione apparvero le migliori; tanto il punto di vista del pubblico era fuori di strada! I personaggi del Dancairo e del Remendado, in compagnia di Frasquita e Mercedes, recano infatti su la scena accenti di una gaiezza frivola in una forma che talvolta rasenta l'operetta; così nel quintetto: «Noi s'ha in vista un bell'affare», nel finale del 2° atto dalle parole: «Bel capitan»; ed anche nel pezzo concertato del 3° atto: «È nostr'affar il doganier», che era stato composto per L'Arlesiana, e che è troppo marzialmente ritmato.
Si è detto che con Carmen nasce la «scuola verista», ma bisogna dire subito che ciò riguarda il soggetto, il quale non ci mette davanti agli occhi nè gli eroi e gli Dei wagneriani, nè i fastosi cavalieri e i falsi eroi (spesso solo borghesi coperti di svolazzanti manti e di cimieri piumati) del melodramma sette-ottocentesco. Si tratta di gente del popolo, coi loro difetti e le loro virtù reali, e con i conflitti passionali che conducono alle catastrofi delittuose. Ma che cosa è verista nella musica di Bizet? Non certo la «romanza del fiore», e neppure la scena finale. Mentre Josè si slancia con il coltello alla mano su Carmen, la musica trasfigura il gesto verista facendoci udire il coro «Toreador attento» (la causa occasionale ultima del dramma), e il tema fatale della passione di Don Josè: l'unico grund-motiv dell'opera, quello che risuona forte e terribile nella chiusa al preludio del 1° atto, anche allora dopo il motivo festoso della folla animata in attesa della corrida, e dopo quello del Toreador. La musica dunque risale dalla verità bruta della coltellata agli elementi psicologici del dramma: il bei Toreador che ha ammaliato e abbagliato cuore e sensi di Carmen, e la passione disperata di Don Josè.
Tutta la musica dell'opera si aggira fra questi due elementi estremi, calda di sensualità, accesa d'impeto, abbacinata di sole meridionale, attraversata a quando a quando da ritmi e da colori di danze e di canzoni spagnuole. Queste canzoni rappresentano l'altro dei più meravigliosi aspetti di quest'opera spagnolissima scritta da un francese. Bizet non si serve del folklore; gli basta aver conosciuto musiche della Spagna per scriverne delle altre che non sono imitazioni, ma nuove creazioni originalissime, imbevute del più tipico e vivace spagnolismo immaginabile. Vi sono motivi di una luminosità tutta meridionale e mediterranea, come ad esempio quello brillantissimo con cui l'opera si apre, o quello più marcato del Toreador, oppure quello più militaresco ma anche giovanilmente sbarazzino della Marcia dei monelli al cambio della guardia. Ma altri motivi sono la Spagna stessa nei suoi ritmi, nelle sue melodie, nelle sue tinte.
Di questo colorismo ambientale Bizet non si è fatto un sistema, ma quando l'occasione si presenta, senza rinunziare allo psicologismo pel quale dramma e personaggi appaiono così vivi, di una vitalità interiore ed artistica, la pennellata viene giù sicura, vivida, con una forza che sa fondere miracolosamente ambiente e situazione. E allora sono gesti musicali pieni di sensualità, eleganze armoniche procaci, calde ondate di suono fascinatrici, barbagli violenti di sole da far gridare «odo la luce» come Tristano. Ci basta ricordare la molle civettuola Habanera: «È l'Amor uno strano augel», l'impertinente e seduttrice Seguidilla: «Presso il bastion di Siviglia», la Canzone e danza boema: «All'udir del sistro il suon», così piena di vivacità e di colore spagnolo non ostante la denominazione di «boema», l'aria dei «Dragoni d'Alcalà» che Don Josè canta venendo da Carmen, e che forma, contrappuntata e orchestrata con un gusto elegantissimo, l'intermezzo del 2° atto. La danza voluttuosa che Carmen canta e balla accompagnandosi con le castagnette per divertire e affascinare Don Josè, il balzante Bolero che costituisce l'altro elegantissimo preludio al 4° atto (e il cui motivo è realmente preso da una canzone di Manuel Garcia). Anche le stesse strofe di Escamillo: «Con voi ber», benché di gusto grossolano, come si addice a questo professionista di uno sport poco raffinato e barbarico, e il successivo e più vibrante: «Toreador attento», hanno l'irruenza e il calore delle creazioni soleggiate del sud.
All'infuori di questi quadri pieni di intenso colorismo, in cui la vivezza del ritmo va di pari passo con la bellezza della melodia, tutto il resto reca l'impronta di una potente passionalità lirica e drammatica. Citiamo, per esempio, fra le espressioni più nuove per il tono funereo e fatale, al quale accrescono ombra gli accordi lunghi e pesanti dell'orchestra e le note gravi del canto, la meditazione di Carmen su le carte da gioco: «Invan per evitar risposte ben severe» (atto 3°).
È noto che il tenore deve possedere la duplice qualità di tenore lirico e drammatico. Nei primi due atti è lirico, e tale lirismo culmina nella elegiaca «romanza del fiore». Tutta ondeggiante fra lagrime di tenerezza e di nostalgia, aderente al sentimento fino allo spasimo, questa romanza, appoggiata a un movimento sincopato dell'accompagnamento, si chiude su una modulazione armonica a sorpresa che ne accentua il senso di doloroso smarrimento. Ma nel 3° e 4° atto la passione ha fatto dell'onesto Don Josè un uomo torturato dalla gelosia fino all'estrema violenza e al delitto. Gli accenti musicali divengono allora aspri e taglienti, come nel duetto del 3° atto con Escamillo; sordamente minacciosi, come nel finale dello stesso atto. Divengono ancora dolorosamente sommessi all'inizio dell'ultimo dialogo con Carmen, dove la voce di Josè è rotta da pause, spezzata da singhiozzi a stento trattenuti, vibrante di un tormento angoscioso. Ma come le ripulse di Carmen si fanno più dure ed ostili, e dal circo giungono gli evviva a Escamillo che esaltano sempre più la sensualità della donna fino allo scherno e all'oltraggio verso Don Josè, la voce di questi ritorna tragicamente delirante e violenta. Nell'orchestra una tempesta di terzine prima, un rumoreggiare cupo dei bassi poi, dicono la lotta che si è scatenata nell'animo disperato del giovane.
S'è già detto perchè questo non sia «verismo», cioè bruta e materiale riproduzione della realtà, ma potente trasfigurazione sonora di atteggiamenti profondi della psiche.
Fra questo scatenarsi di passioni sensuali passa, figura di grazia delicata, eco di una dolente madre lontana, la casta e dolce Micaela, con il suo timido e innocente amore e le sue ansiose trepidazioni.
Aggiungono vita al movimento drammatico dei personaggi principali e secondari, i cori, ora di un'animazione brillante, come quelli che iniziano il 1° e l'ultimo atto; ora pieni di ombra e di mistero come quello dei contrabbandieri: «Ascolta, ascolta», nel 3° atto; ora di una sfumata poesia sul dolce mormorio degli archi, come il coretto delle sigaraie nel 1° atto: «Bel seguire è nell'aere lieve fumo», preceduto da un sospiroso coro all'unisono dei tenori: «Suona la campana». E qui ci sarebbe da fermarsi su le eleganze armoniche fìnissime che rendono così vaghi non solo questi cori, ma numerose altre pagine dell'opera. Alle eleganze armoniche vanno aggiunte quelle strumentali, sparse dovunque, che illeggiadriscono come un cesello (cui accresce grazia l'uso di delicati contrappunti) specialmente gli intermèzzi, fra i quali uno dei più vaporosi ed elegiaci è quello del 3° atto, che era stato composto per L'Arlesiana,
ARRIGO BOITO (Padova 1842 Milano 1918) - MEFISTOFELE: opera in un prologo, 4 atti ed epilogo. Prima rappresentazione dell'edizione attuale al Teatro Comunale di Bologna il 4 ottobre 1875. Libretto di Arrigo Boito, dal poema di Wolfango Goethe.
Prologo - Nebulosa. - Mefistofele scommette col Cielo di trarre all'infemo Faust, vegliardo studioso che ricerca il vero assoluto. La scommessa è accettata. Un gruppo di Cherubini volanti disturba Mefistofele che fugge. Penitenti, Cherubini e Falangi celesti elevano preci ed inni a Dio.
Atto 1° - Quadro 1° - Porta e bastioni a Francoforte sul Meno. - È la Domenica di Pasqua. Faust, accompagnato dall'allievo Wagner, passeggia osservando l'andirivieni della folla in festa. Ma un frate grigio che sembra tracciare magiche spire attorno a lui lo spaventa,
Quadro 2° - Officina di Faust. - Faust rientra meditando; mentre sì'accinge a leggere il Vangelo, il Frate grigio appare e si trasforma in cavaliere. È Mefistofele, il quale gli promette di servirlo in ogni sua brama se Faust a sua volta promette di servirlo nell'al di là. Faust accetta e si dichiara pronto a morire allorchè dirà all' attimo fuggente: «arrestati, sei bello!». Indi sul mantello di Mefistofele i due volano via.
Atto 2° - Quadro 1° - Giardino. - Faust ringiovanito e sotto il nome di Enrico, corteggia Margherita, mentre Mefistofele fa complimenti alla vecchia Marta. Faust chiede a Margherita che lo riceva in casa, e le dà un narcotico per addormentare la madre.
Quadro 2° - Scena deserta e selvaggia fra le vette del Brocken. - Faust, accompagnato da Mefistofele, assiste al Sabba delle streghe e dei demoni. Mefistofele è nel suo elemento; si fa portare un globo che simboleggia il mondo e che egli spezza al suolo. Sui frantumi s'intreccia una ridda infernale.
Atto 3° - Carcere. - Margherita è stata imprigionata e condannata a morte sotto l'accusa d'aver avvelenata la madre e annegato il bimbo natagli da Faust. Essa è impazzita. Faust viene con Mefistofele per liberarla, ma Margherita muore invocando perdono da Dio e provando ribrezzo per Faust. Una voce dal Cielo proclama: «È salva!».
Atto 4° - Le sponde del fiume Penejos nell'Attica. - Elena rievoca l'incendio di Troia. L'apparizione di Faust vestito da cavaliere del XV secolo provoca il più vivo stupore in Elena e nelle sue ancelle. Faust rende omaggio ad Elena, immagine della bellezza eterna, e le insegna la rima. Questa scena è il simbolo della fusione fra la Poesia classica e quella romantica.
Epilogo - Laboratorio di Faust. - Faust, di nuovo vecchissimo, medita. Mefistofele vorrebbe deciderlo a dire all'attimo fuggente «Arrestati, sei bello!», ma Faust è scontento: egli vagheggia un mondo ove gli uomini vivano in pace sotto leggi savie. Il sogno di bontà allarma Mefistofele che stende nuovamente il mantello invitando Faust a salirvi; ma Faust pone fra sè e Mefistofele il Vangelo, grida all'attimo «arrestati sei bello!» e muore. I Cherubini spargono rose su Faust, mentre Mefistofele vinto sprofonda.
La prima edizione del Mefistofele naufragò clamorosamente alla Scala la sera del 5 marzo 1868, un po' per la novità del soggetto, un po' per la prolissità dell'opera. L'autore la tagliò e rimaneggiò ampiamente. Fu sacrificato il «Prologo in Teatro» dialogo in prosa tra un Critico teatrale, uno Spettatore e l'Autore; abbreviato il quadro della «Domenica di Pasqua ') e quello del «Sabba romantico», soppressa tutta la prima parte del 4° atto (quella del Palazzo Imperiale, in cui Mefistofele è in funzioni di buffone di Corte e di stregone, creatore di un'illusione scenica che Faust, irrompendo improvviso, distrugge); e l'Intermezzo sinfonico che descriveva una battaglia, e abbreviato anche l'Epilogo. Ne uscì un libretto letterariamente meno coerente ed organico, ma l'opera musicale divenne più snella ed equilibrata.
Nessun dubbio che il Mefistofele di Boito è più prossimo al pensiero poetico di Goethe che non il romanzesco Faust di Gounod e la frammentaria Dannazione di Faust di Berlioz. La musica presta invece il fianco alla critica sotto vari aspetti. Boito, in fondo, confessava la propria debolezza di creatore in quei suoi versi nei quali affermava:
«... sogno un'arte splendida
«che forse in cielo ha norma,
«franca dei rudi vincoli
«del metro e della forma,
«piena dell'Ideale
«che mi fa batter l'ale
«e che seguir non so.
Le incertezze ch'egli ebbe nel comporre il Nerone, incertezze durate tutta la vita, e l'incompiutezza in cui l'opera postuma fu lasciata, confermano questa sua incapacità a raggiungere l'alto ideale vagheggiato.
Lo strumentale del Mefistofele mostra in realtà molte deficienze di equilibrio e di colore. I temi usati, spesso mancano di originalità; ve ne sono parecchi attinti a Beethoven, e non hanno che sviluppi sinfonici limitati. I «vincoli del metro e della forma» non sono in realtà superati, poiché l'opera è ancora costituita da pezzi chiusi e da forme stronche, con netto predominio dell'elemento vocale a base di larghe simmetriche melodie. Taluna di queste forme non è neppure esente da enfasi, come il finale del Sabba classico: «Amore! misterio», mentre altre appaiono banalmente operettistiche, come il finale dell'atto i : «Fin da stanotte».
L'intenzione sinfonica del compositore è evidente, per esempio, nella divisione ch'egli fa del Prologo in quattro tempi, e nelle loro denominazioni: « 1° tempo: Preludio e coro; 2° tempo: Scherzo strumentale - Intermezzo drammatico; 3° tempo: Scherzo corale; 4° tempo: Salmodia finale». Ma la bellezza di questo Prologo, che indubbiamente è la parte più splendente di tutta l'opera, non consiste certo nella sua elaborazione sinfonica, la quale si limita a qualche gracile contrappunto, ma nella «visione» religiosa ch'essa evoca.
Aperto da aerei squilli di trombe che si rispondono come dalle diverse profondità del cielo, e che si alternano a motivi serafici di flauti e d'arpe, questo inizio del Prologo ci trasporta davvero nell'immensità radiosa dello spazio. La forma è nuova e solenne: i cori seguenti, vari e devoti, solcati da quel trasvolare quasi veristico di angeli, che col loro veloce appressarsi e vanire ci conferma ancor più la sensazione di infinito spaziale dataci prima dagli echi degli squilli; cori interrotti solo per lasciar posto all'«Intermezzo» di Mefistofele, ripresi e condotti alle massime sonorità attraverso a un trascinante crescendo, e conclusi infine robustamente con gli stessi squilli iniziali, mantengono perennemente viva innanzi alla nostra fantasia la mistica luminosa visione evocata fino dalle prime note. E poi, finalmente, non siamo più di fronte al solito coro superfluamente riempitivo del melodramma ottocentesco. Qui i personaggi (angeli, cherubini, serafini, ecc.) sono invisibili; è il Cielo intero che canta: questo è pure nuovo e grande; anche se è più oratorio che teatro.
Il senso spaziale, che è elemento di poesia così importante nel Prologo, reca il suo vasto respiro anche in altri momenti dell'opera; così nelle voci che si allontanano nella notte cantando «Il bel giovinetto sen viene alla festa», nelle voci che si rispondono come echi fantastici nelle gole del Brocken, e negli avvolgimenti della «fuga infernale» con cui termina il «Sabba romantico». Spaziali sono le voci che annunziano la salvazione di Margherita e quella di Faust; e spaziali sono pure le invocazioni lontane di Faust: «Elèna, Elèna!», che rispondono alle strofe del canto «La luna immobile», così imbevuto di ellenica, purezza, e la stessa chiusa del «Sabba classico» con le voci delle Corètidi che si perdono mormorando soavemente. Questa predilezione per gli effetti spaziali, nuova nel teatro, è tipica dell'atteggiamento poetico boitiano tendente a dare al dramma umano risonanze cosmiche, a dilatare le voci dell'uomo nelle voci della natura.
Ma dopo aver notati questi aspetti positivi dell'opera musicale, non si può passare sotto silenzio quello che è, a parer nostro, il difetto maggiore, e cioè la debole e falsa caratterizzazione del protagonista. Questo Mefistofele, spirito che nega, forza del male che vuole il nulla del creato, nemico della luce, come dice il suo nome, la. cui atmosfera vitale è il delitto, ci è presentato con un motivetto dall'espressione sardonica e beffarda, sufficiente a dipingere un piccolo cornuto diavolo subsannante, ma non un personaggio infernalmente tragico e fatale come lui. Il suo è un tema saltellante più pittorico che psicologico, e per di più ripetuto sempre in modo stereotipo. Le pagine che dovrebbero meglio caratterizzare Mefìstofele sono tutte strofiche, e nella forma della ballata: così nella presentazione a Faust: «Son lo Spirito che nega», dove per non guastare la linea del canto già prestabilito Boito si riduce a ripetere più volte le stesse parole come nelle arie del più vieto melodrammismo. Così pure nella «Ballata del mondo» (la definizione è di Boito medesimo), e peggio ancora nel già citato Allegretto: «Fin da stanotte nell'orgie ghiotte». Non che qualche frase qua e là non lo colga più profondamente, ma, in generale, il protagonista demoniaco è (eccetto che nel Prologo) musicalmente quasi mancato. Poteva essere il personaggio più rivoluzionario, ed è riuscito il più melodrammatico. Cosicchè, a conti fatti, dal punto di vista della musica, l'elemento più rivoluzionario e novatore è risultato il Cielo! Questo va pur messo all'attivo del miscredente Boito!
Liricamente riuscito è invece il personaggio di Faust, tanto nel suo pensoso dialogo con Wagner, come nella meditazione strofica: «Dai campi, dai prati», anche se lo spunto è beethoveniano. La presenza di questi spunti beethoveniani è una conferma della difficoltà inventiva di Boito, fatto questo osservato già da Verdi allorchè affermava: «gli manca il motivo». Liricamente commosso è anche il cantabile: «Se tu mi doni», e tutto l'atto del giardino è pieno di frasi affettuose ed eleganti, fra le quali emerge il cantabile: «Colma il tuo cor d'un palpito». Altrettanto elevata e bella è la presentazione di Faust ad Elena: «Forma ideal purissima», cui segue, in una zona di più alta ispirazione, la melodiosa risposta di Elena: «Dal tuo respiro pendo». L'ultimo canto di Faust, la romanza: «Giunto sul passo estremo», è la più sognante e idillica espressione vocale di questo personaggio così ansioso di poesia in ogni suo atteggiamento scenico e musicale.
Delle due donne amate da Faust, Margherita rappresenta «il reale»: il dolore. Come tale più che nella scena del giardino, è nelle espressioni strofiche del canoro delirio: «L'altra notte in fondo al mare», e nella trepidante evocazione: «Spunta l'aurora pallida» ch'essa appare riuscita. A proposito della quale ultima aria conviene precisare che non esisteva nè nella prima edizione eseguita alla Scala nel 1868, nè nella seconda a Bologna nel 1875. Essa fu aggiunta per l'esecuzione a La Fenice di Venezia nel 1876. Altrettanto dicasi della «Ridda e fuga infernale», la quale corona coreograficamente un quadro già di per sè abbastanza saturo di coreografia decorativa più che di drammaticità; ma è musicalmente originale e solidamente costruita. Nell'esecuzione bolognese del 1875 fu invece aggiunto il sognante a due: «Lontano, lontano, lontano», che Boito aveva composto (spunto beethoveniano anche questo) per un progettato Ero e Leandro.
L'altra donna amata da Faust, Elena, rappresenta «l'ideale»: la poesia classica. L'atto in cui essa appare è aperto e chiuso da accordi arcaicizzanti in un modo ellenico, ed è improntato ad una purezza aristocratica di linee, dall'estatica canzone «La luna immobile», dalle aeree lievi danze in cerchi (Chorèa), dall'incantamento dell': «Amore! misterio», il quale però, come dicemmo, dà soverchiamente nell'ampolloso. Ma la pagina in cui Elena acquista una vita propria è l'evocazione vigorosamente tragica dell'incendio di Troia: «Notte cupa, truce, senza fine funèbre!», in cui, come nel coro precedente, per la prima volta la musica si adagia sul metro esàmetro, e lo fa con libera fluidità di atteggiamenti.
In complesso: il successo duraturo dell'opera ha molti elementi a suo favore, specialmente nel calore dell'ispirazione melodica, in alcune grandi e nuove intuizioni, e - dal punto di vista del pubblico - nel tradizionalismo delle sue forme.
AMILCARE PONCHIELLI (Paderno Fasolaro [Cremona] 1834 - Milano 1886) - LA GIOCONDA: dramma in 4 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano 1'8 aprile 1876. Libretto a firma Tobia Gorrio (pseudonimo-anagramma di Arrigo Boito) dal dramma Angelo di Victor Hugo.
Atto 1° - Cortile del palazzo Ducale a Venezia, - Il cantastorie Barnaba, spia della Repubblica, vorrebbe indurre alle proprie brame una cantatrice detta «La Gioconda», ma questa, innamorata del principe genovese proscritto Enzo Grimaldi, che crede un povero marinaio dalmata, lo respinge. Barnaba allora, per vendicarsi della ripulsa, addita alla folla come strega la madre cieca di Gioconda. La vecchia sta per essere posta a morte dai popolani che Barnaba ha aizzati, ma Enzo interviene in sua difesa, e Laura, moglie di Alvise Badoero, uno dei Capi dell'Inquisizione, la salva. La deca in segno di riconoscenza dona a Laura un rosario. Laura, che da giovinetta amò Enzo, non sa reprimere la propria commozione rivedendolo, ed Enzo pure la riconosce. Tutto ciò non sfugge a Barnaba, il quale per togliere alla Gioconda Vuomo che essa ama, propone ad Enzo di farlo fuggire con Laura. Enzo accetta, ma Barnaba denunzia segretamente ad Alvise la progettata fuga degli amanti. Gioconda ha udito a caso quando Barnaba dettava la denunzia a uno scrivano, ed è presa da un dolore disperato.
Atto 2° - Riva d'un'isola disabitata. In fondo il brigantino di Enzo. - È notte. Barnaba conduce Laura ad Enzo, ma sopraggiunge la Gioconda. Fra le due donne ha luogo una disputa violenta durante la quale la Gioconda, accecata dalla gelosia, sta per uccidere Laura; ma vedendole in mano il rosario, la riconosce per colei che le salvò la madre, e avvertendola che sta per giungere Alvise, la fa fuggire. Intanto Alvise, in seguito alla denunzia di Barnaba, ha fatto circondare la nave di Enzo, ma questi, avvisato dalla Gioconda, la incendia e si getta in mare mentre i marinai si disperdono.
Atto 3° - Quadro 1° - Stanza nella Cà d'Oro. - Alvise per vendicarsi del tradimento di Laura le impone di bere un veleno prima che il canto d'una serenata che s'ode sia cessato. Ma partito Alvise, la Gioconda, riuscita a penetrare fino a lei, le toglie di mano il veleno facendole bere un narcotico.
Quadro 2° - Sala sontuosa. - Durante la festa, che si svolge in casa di Badoero, Enzo si rivela ad Alvise e gli rinfaccia l'assassinio di Laura. Alvise allora solleva una tenda e mostra Laura stesa sul letto di morte annunciando di avere vendicato l'oltraggio da lei recato al suo onore. Nella confusione che ne segue, Gioconda si promette a Barnaba, se questi salverà Enzo.
Atto 4° - Atrio di palazzo diroccato nell'isola della Giudecca. - Laura, ancora addormentata, viene deposta su un letto dietro un paravento. La Gioconda si propone di far fuggire Enzo e Laura; poscia si ucciderà. Ma come giunge Enzo, per farsi uccidere da lui gli dice di avere rapito il cadavere di Laura. Al colmo dell'ira, Enzo si slancia contro di lei armato; nello stesso istante Laura, destatasi, lo chiama. Essa gli svela la generosità della Gioconda, la quale li fa fuggire insieme. Barnaba viene ora a prendere il premio promesso, ma allorchè sta per stringere a sè la donna, questa rapidamente si trafigge, Barnaba per vendicarsi le grida che ha affogata sua madre, ma la Gioconda è già morta: «non ode più!».
Il soggetto, che servì per l'opera IL GIURAMENTO di Saverio Mercadante (Milano, Scala, 1837), è tratto dal dramma Angelo di Victor Hugo. L'opera di Mercadante ebbe ai suoi tempi un grande successo, ma non si resse a lungo su le scene. La sua musica, non scevra di effetti esteriori, è in generale costruita su formule convenzionali, e per quanto sapientemente strumentata, non è ricca di intimo calore. Essa tuttavia presenta accenti e modi drammatici ai quali certo non rimase indifferente il Verdi delle prime opere.
LA GIOCONDA di Ponchielli presenta ben altra vitalità. Eppure a quest'opera, che ebbe un successo trionfale e fu salutata come un capolavoro, non mancarono le critiche più aspre. Non si deve però esagerare, come si fece in occasione del suo cinquantenario parlando di «aberrazione» e di «obbrobrio». Capolavoro non è, i difetti sono vari, ma numerosi e notevoli sono anche i pregi. Mettiamo fra i difetti la tendenza all'enfasi rumorosa, la quale soprattutto diviene catastrofica nel finale del 3° atto. È ben vero che c'è di mezzo l'uccisione per veleno (tale hanno ragione di ritenerla Badoero e gli astanti) di Laura, e la scenografica macabra presentazione del suo cadavere biancovestito sul cataletto circondato dai ceri accesi; ma l'orchestra ci dipinge un orrore troppo esteriormente clamoroso. Quest'enfasi gonfia spesso di falsa pletora le frasi più semplici, come, ad esempio, la declamazione: «O monumento» di Barnaba, che perde nel vociamento ogni intimità meditativa, e il grido di Gioconda: «Suicidio», che nessuno il quale voglia davvero uccidersi sente il bisogno di strillare ai quattro venti. Diciamo la verità: di queste gonfiature enfatiche ci ha colpa anche Boito che, con la falsa rettorica dei versi di queste due situazioni, offre al musicista un facile appiglio a falsare l'interpretazione musicale.
Così è pure nel duetto del 2° atto fra Laura e la Gioconda, in cui le due donne contendono in modo assurdo e rettorico sul loro particolare modo di amare Enzo «come il fulgor del creato!» o «come il leone ama il sangue», continuando a gettarsi in faccia una serie di paragoni uno più grottesco dell'altro. Il musicista non poteva non lasciarsi trascinare da questo torrente immaginifico, ma conveniamo che poteva esser peggio. La frase è sgorgata necessariamente un po' stentorea, ma è ricca di veemente passione ed è di un bel disegno melodico largo, al quale l'indicazione «i primi due quarti affrettati, gli altri due trattenuti» conferisce un particolare fremito ansioso vivamente drammatico.
Ai difetti di enfasi ridondante, vanno aggiunte alcune banalità, come, ad esempio, qualche parte del coro «Feste, pane», il finale della «danza delle Ore», e alcuni altri momenti particolarmente urtanti. Poniamo nel passivo dell'opera anche alcuni aspetti grossolanamente bandistici della strumentazione.
Detto questo, è però doveroso riconoscere che l'opera contiene anche reali bellezze, così di fattura come d'ispirazione melodica, la quale ultima spesso attinge un sincero calore e si presenta in disegni che, se anche risentono del gusto verdiano, hanno una loro fisionomia personale inconfondibile. Il senso costruttivo ha spesso una chiara eleganza e una solidità ariosa. Prendete il Preludio dell'opera: lo sviluppo delle frasi e il loro concatenamento vi sono spontanei, densi di meditazione. La comparsa del motivo «A te questo rosario» appare logica. Il subdolo motivo che caratterizzerà Barnaba vi è giocato e contrappuntato con abilità e drammaticità. Imperniato su questi due motivi, il Preludio si svolge con arte piena di buon gusto, e non cede all'enfasi che per un brevissimo istante che può anch'essere giustificato da necessità dinamica.
Un altro buon esempio della sapienza costruttiva di Ponchielli è la scena in cui al dialogo tra Barnaba e Zuane si alternano le risa e le grida dei giocatori, la preghiera della Cieca e i commenti degli astanti; tutto ciò ben fuso in un sol blocco, e condotto con un crescendo ottimamente graduato al fortissimo fino all'uscita di Enzo sul grido «Assassini!». Questo non è quasi più teatro; è vita. Lo stesso concertato finale del 3° atto, che pure, come s'è detto, è così macchinoso ed ha una chiusa così enfaticamente rumorosa, è costruito con solida e ben proporzionata architettura, non scevra da vigorosi movimenti drammatici.
Più elegante e arioso il finale del 1° atto, che comincia con un'intonazione severamente religiosa. Su la trama del coro e dell'organo si stende il recitativo spasimante della Gioconda,, il quale sbocca, con uno sfogo incontenibile di pianto, nella frase: «O cuor! dono funesto!», che per altezza e intensità di espressione è la più bella dell'opera, una delle più belle del teatro melodrammatico; frase sotto la quale pensiamo che avrebbe potuto metter la firma lo stesso Verdi. E tutto questo è anche molto nuovo. Poichè nell'opera di Ponchielli, in tutte le sue opere, è sensibilissimo il desiderio di romperla con le tradizioni e di trovare qualcosa che esca dal convenzionale e che rinnovi le forme.
La Gioconda è un «melodramma», perfino coi ballabili secondo il tipo grand-opéra, e con molti episodi secondari che intralciano l'azione ma che rendono varia la rappresentazione, specie nelle parti corali e nei concertati, oltrechè nelle danze. Ma spesso si avverte che il Maestro non si accontenta di quello che è stato fatto, che vuol essere lui, con i suoi pregi e i suoi difetti, e che va alla ricerca di uno stile suo particolare che lo tragga oltre le forme passate e contemporanee. A questo rinnovamento stilistico egli giunge soprattutto nella romanza «Cielo e mar», che non è più una romanza di stampo solito. Le forme tradizionali sono superate e infrante, il discorso musicale si scioglie in un'onda lirica vocale, la quale si espande su un tessuto orchestrale tenue e delicato. È un soffio sincero e sentito di poesia estatica e nuova.
Altrettanto nuovo e drammaticamente robusto è il duetto finale dell'opera, tutto fremente nel contrasto tra la delirante e sensuale bramosia di Barnaba, e la fìnta civettuola gaiezza della Gioconda. Ma numerosi altri sono i momenti in cui l'originalità del musicista riesce ad aver ragione dei molti dubbi che continuamente lo assillavano, e che stanno a dimostrare le reali difficoltà ch'egli aveva a superare le forme della tradizione. Quando egli riesce a vincere la sua battaglia, escono non solo la balzante Furlana del 1° atto, gli aggraziati coretti dei marinai, l'elegante Barcarola di Barnaba del 2° e la languida Serenata corale del 3°, ma scoppiano melodie traboccanti di espansiva liricità come la romanza della Cieca: «Voce di donna o d'angelo», l'appassionata esclamazione di Enzo: «O grido di quest'anima», e la citata celestiale frase di Gioconda: «O cuor! dono funesto!».
Concludendo: se l'opera vive, malgrado i suoi innegabili difetti, non è tutto per colpa del cattivo gusto di una parte del pubblico così detto «grosso», come si ripete spesso, e non sempre disinteressatamente, ma per gli altrettanto innegabili valori positivi dell'ispirazione e a volte anche della fattura di molte sue pagine.
RICCARDO WAGNER - L'ANELLO DEL NIBELUNGO: un prologo, L'ORO DEL RENO, e tre «giornate»: LA WALKIRIA, SIGFRIDO, IL CREPUSCOLO DEGLI DEI. Prima rappresentazione al Teatro di Bayreuth dal 13 al 17 agosto 1876. Wagner medesimo prese gli episodi principali dai poemi dei Nibelunghi dell'Edda, della Volsungsaga, e li rifece liberamente e ricompose in una grandiosa «Tetralogia» nella quale l'altezza poetica s'accompagna alla profonda significazione morale e allo splendore musicale.
L'ORO DEL RENO; prologo in un atto e 4 scene dell'Anello del Nibelungo.
Scena 1a - Il fondo del Reno. - Woglinde, Wellgunde e Flosshilde, le figlie del Reno, vegliano nell'oscurità crepuscolare a guardia dell'oro attaccato a uno scoglio centrale. Scherzano e cantano lietamente nuotando, allorchè dall'apertura d'una roccia sbuca un orrido nano: il nibelungo Alberico. Alla vista delle fanciulle egli è preso da desiderio sensuale,, ma esse lo scherniscono e sfuggono destramente ai suoi goffi inseguimenti. A un tratto un raggio del sole nascente illumina il masso d'oro. Imprudenti, le fanciulle ne rivelano le meravigliose virtù: chi lo rapisce e, maledicendo all'amore, con esso si foggia un anello, diviene padrone del mondo. L'avido Nibelungo si arrampica su lo scoglio, maledice l'amore, e fra la costernazione delle figlie del Reno strappa l'oro alla roccia e s'inabissa.
Scena 2a - Vette montane che il giorno sorgente illumina. - Su una vetta più eccelsa si erge un grande castello: è il Walhalla, dimora degli Dei, che Wotan ha fatto costruire dai giganti. Wotan ha loro promesso in premio la Dea della giovinezza, Freia; ma in pari tempo ha lanciato il Dio del fuoco, Loge, alla ricerca di qualche altro compenso da offrire loro per riscattare Freia. Vengono i giganti Fafner e Fasolt a reclamare l'adempimento del patto; ma Wotan cerca di trattare ancora con loro in attesa che giunga Loge. Questi infatti arriva, e narra della smisurata potenza conquistata da Alberico per mezzo dell'oro rapito al Reno. I giganti si dichiarano pronti a scambiare Freia con l'oro; frattanto trascinano in ostaggio la Dea, mentre Wotan e Loge discendono nell'abisso del Nibeheim per carpire l'oro ad Alberico.
Scena 3a - Caverna sotterranea. - Alberico, col potere conquistato a mezzo dell'oro, domina ferocemente la schiatta dei nani che lavorano per lui a creargli un tesoro. Egli ha al dito l'anello fatale. Inoltre il fratello suo Mime gli ha costruito un elmo magico che permette a chi se lo pone in capo di trasformarsi come vuole. Wotan e Loge apprendono tutto ciò appunto da Mime. Sopraggiunto Alberico, questi non sa resistere alla vanità di mostrare agli stranieri il proprio potere. Si pone l'elmo in capo e si trasforma in drago; poscia, per astuto suggerimento di Loge, si trasforma in rospo. Ma Loge prontamente gli pone un piede addosso, gli strappa l'elmo, lo lega e lo trascina con sè.
Scena 4 - Le vette come nella scena 2a. - Alberico è costretto a consegnare agli Dei il proprio tesoro. Anche l'anello gli viene strappato da Wotan. Slegato e liberato, prima di partire egli maledice l'anello e coloro che lo possiederanno, indi si sprofonda di nuovo nel Nibelheim. Giungono intanto i giganti con Freia per restituirla in cambio dell'oro, che viene accumulato innanzi a lei fino a che la sua persona rimanga interamente celata. Ma da uno spiraglio Fasolt vede ancora il suo sguardo; per otturarlo occorre l'anello, che Wotan cede dopo lunga resistenza, e solo per consiglio di Erda, la sapienza terrestre, improvisamente apparsagli. Ed ecco, la maledizione di Alberico incomincia ad agire: per la divisione del tesoro sorge fra i giganti una lite, nella quale Fafner uccide Fasolt. Wotan pensa a creare un liberatore dalla maledizione; e intanto, su un ponte formato da un arcobaleno che il Dio Donner ha fatto uscire dai nembi tempestosi, gli Dei fanno il loro ingresso nel Walhalla. Accompagna la loro marcia trionfale l'ironia di Loge che ne prevede la fine, e il pianto delle figlio del Reno.
Il sistema wagneriano della «melodia infinita», cioè della melodia senza più forme stronche chiuse, ma a carattere continuamente mutevole in aderenza al linguaggio dei personaggi, è qui applicato in pieno, senza eccezioni, talvolta quasi con. pedanteria. Tale aderenza riguarda non solamente lo spirito della parola, ma l'emozione da cui nacque, l'indole e la natura di chi l'ha pronunciata, il momento psicologico in cui fu detta, ed anche il carattere sonoro della parola stessa, il suo collocamento nel periodo, e l'intonazione naturale del periodo medesimo. Se non che in moltissimi casi l'ispirazione brucia tutte queste intenzioni particolari nel fuoco di un'espressione più sintetica, obbedendo solo al soffio lirico o drammatico del momento. Cosicchè nella traduzione (salvo i casi in cui Wagner è rimasto più rigidamente conseguente al sistema), purchè fedele[5], non molto si perde dei rapporti fra parola e musica.
Ma la «melodia infinita» non è tanto nella parte vocale come in quella orchestrale. L'orchestra, celata nel «golfo mistico» per renderla invisibile in quanto non fa parte della rappresentazione scenica, crea l'atmosfera, ci dà l'al di là delle parole, l'indole dei personaggi, i misteriosi rapporti della natura con essi, mediante l'uso di «temi fondamentali» o grund-motiv, il cui susseguirsi, i cui colori strumentali, i cui intrecci, i cui sviluppi, originano la grande sinfonia, nella quale la voce medesima del cantante resta molte volte sommersa.
Il «dramma musicale» di Wagner costituisce dunque una reazione al «melodramma» italiano, in quanto concentra il dramma nella sinfonia orchestrale, mentre nell'opera tradizionale il dramma trova la sua principale espressione soprattutto nel canto vocale.
Dato l'incisivo e plastico rilievo dei temi, la ricchezza e varietà degli intrecci e dei colori orchestrali, il tessuto sinfonico acquista una potenza espressiva che ha del leonardesco. Anche se tale tessuto scorre senza interruzioni, è tuttavia possibile identificare alcuni quadri che si possono facilmente isolare. Sono i brani che si odono spesso eseguiti in concerti, e che per la speciale loro natura sinfonica nulla perdono da tale isolamento, così come nulla perde una Sibilla o un Profeta della Sistina staccati dalla più vasta sinfonia della volta immortale, o l'episodio di Francesca o di Ugolino estratti dalla mole poderosa della Divina Commedia.
Nell'oro del reno, uno di tali brani è il preludio dell'opera. Un lungo mi bemolle profondo ci immerge nella immobilità primordiale dell'elemento liquido e nel buio della notte. Alcune quinte oscillano poscia in piani diversi, ma sempre bassi. a segnare l'inizio del movimento, della vita. Finalmente un canto si stacca dalla profondità e sale; una linea uguale lo segue a distanza e s'intreccia con esso, e un'altra vi si aggiunge, un'altra ancora, fino a otto (le voci di otto comi) che coi loro disegni esprimono un movimento ondoso calmo e grave. Con l'intervento degli archi (sempre persistendo il pedale di mi bemolle) il moto si fa via via più fluido e scorrevole, fino a che su la sinfonia orchestrale si innesta la canzone fresca, e anch'essa ondulata, delle figlie del Reno.
Più tardi l'intervento di Alberico coi suoi disegni vocali rotti e aspri, reca un turbamento e un intorbidamento dell'espressione, fino all'apparire del tema luminoso e magico dell'oro. Lo strappo dell'oro, la fuga di Alberico, le grida impotenti delle fanciulle, si fondono ai turbinosi disegni che esprimono lo scompiglio delle acque per la violenta azione che vi si è svolta. Poi gradatamente torna la calma e la luce: un motivo solenne, maestoso, intonato dagli ottoni, ci trasporta innanzi alla visione del superbo Walhalla. Al calmo e fermo linguaggio musicale di Wotan si contrappone quello nervoso e irruente della sua sposa Fricka. Il dialogo si svolge prevalentemente fra il tema del Walhalla e quello imperioso del patto stretto da Wotan coi giganti, mentre l'arrivo di costoro è marcato dal loro tema pesante e rude. Ma quando giunge Loge l'orchestra è tutta un brusio, tutta piena di instabili disegni vorticosi e scintillanti che rappresentano l'elemento insidioso del fuoco. Il racconto in cui Loge afferma di aver percorso tutto l'universo ma di non avere trovato nulla il cui valore superi l'amore di una donna, benchè intessuto su alcuni motivi fondamentali, è quasi un pezzo chiuso ed ha un afflato lirico slanciato.
Molto spesso nei teatri l'opera, che dura complessivamente circa due ore e mezzo, viene divisa in due atti, di cui il 1° ha termine con la discesa di Wotan e di Loge nel Nibelheim. Il brano sinfonico in cui è descritto il viaggio degli Dei, robustamente percorso dal martellante ritmo della fucina, serve di introduzione al 2° atto (3a scena), episodico per la natura stessa degli avvenimenti, ma non frammentario.
Un altro brano sinfonico analogo al precedente ci riporta su le vette, alla luce del sole. Di una drammaticità terrificante è la maledizione di Alberico, il cui motivo diverrà uno dei temi dominanti della Tetralogia. Delicato episodio strumentale è quello che commenta il ritorno della luce; violenta e affannosa la scena dell'accumulo dell'oro innanzi a Freia, che culmina con l'uccisione di Fasolt. Il delitto getta un'ombra tetra su la scena. Per sbarazzare l'atmosfera nebbiosa Donner scatena una rapida tempesta, dalla quale emerge il tema ampio, luminoso dell'arcobaleno, che innestandosi a quello del Walhalla inizia la descrizione della marcia degli Dei alla loro dimora. Da lunge piangono le Ondine, ma gli ottoni lanciano il motivo vittorioso della spada liberatrice, e il tema dell'arcobaleno conclude in maniera trionfale l'ingresso degli Dei nella reggia.
LA WALKIRIA: 1a «giornata» in 3 atti, dell'Anello del Nibelungo.
Atto 1° - Interno dell'abitazione di Hunding; al centro un tronco di frassino. - Infuria un temporale. Sigmondo, figlio di Wotan e di una donna terrestre, entra e si getta spossato presso il focolare. Egli fu lievemente ferito in combattimento, Siglinda, moglie di Hunding, lo soccorre. Rinfrancatesi, egli vorrebbe tosto partire, ma Siglinda lo consiglia ad attendere lo sposo. Fra i due si è stabilita subito un'intensa simpatia. Hunding rientrando acconsente ad ospitare il forestiero, ma vuol conoscere chi è. Sigmondo dice di essere della stirpe dei Welsunghi, che i Naidinge hanno sempre perseguitato. La madre e la sorella gemella scomparvero allorchè i Naidinge gli incendiarono la casa, e perdette le tracce del padre Wolfe (soprannome di Wotan) durante un inseguimento. Poco prima, in un combattimento contro i Naidinge, gli si spezzarono le armi, fu ferito, dovette fuggire, e trovò rifugio nella casa di Hunding. Questi, riconosciuto in lui un nemico, gli conferma che l'ospiterà per la notte, ma lo sfida a duello mortale pel mattino seguente; pensi egli a trovarsi un'arma. Siglinda frattanto ha seguito come affascinata il racconto di Sigmondo ed ha ascoltato con crescente agitazione la risposta di Hunding. Andato questi a riposarsi, essa ritorna presso Sigmondo al quale addita, infissa fino all'elsa nel frassino, una spada che nessuno riuscì mai a strappare dal tronco. Alla descrizione di colui che ve la conficcò, Sigmondo riconosce il padre, il quale gli aveva promessa un'arma pel supremo cimento. Durante il colloquio ravvisa in Siglinda la sorella creduta estinta;l'amore fra i due divampa violento. Cessata la tempesta un colpo di vento spalanca la porta: la luce lunare e gli effluvi della primavera sono per gli amanti un potente richiamo. Sigmondo strappa dall'albero Notung, la spada, e fugge con Siglinda.
Atto 2° - Montagna rocciosa e selvaggia. - Wotan ordina alla Walkiria Brunilde di recare vittoria a Sigmondo nel prossimo combattimento con Hunding. Ma poco appresso Fricka, accusando Wotan di proteggere l'adulterio e l'incesto, lo costringe a ritirare l'ordine dato. Giungono Sigmondo e Siglinda; questa, affranta e delirante, sviene. Durante il suo sopore Brunilde appare a Sigmondo e gli annunzia la morte imminente. Sigmondo minaccia di uccidere prima Siglinda; allora Brunilde, commossa, gli promette il proprio aiuto contro l'ordine del padre. Infatti, sopraggiunto Hunding e iniziatosi il duello; Brunilde protegge Sigmondo contro i colpi del nemico. All'improvviso però appare Wotan, il quale spezza la spada di Sigmondo; Hunding ne approfitta per ucciderlo. Ma con un gesto di disprezzo Wotan fa cadere estinto lui pure, indi si lancia dietro a Brunilde, la quale raccolte le schegge della spada è fuggita con Siglinda.
Atto 3° - La vetta di un monte presso una foresta. -Le Walkirie, le figlie guerriere di Wotan e di Erda, cavalcano veloci nella tempesta trasportando eroi morti in battaglia. Essi verranno rianimati e condotti ad abitare nel Walhalla. Brunilde giunge trafelata con Siglinda e chiede protezione alle sorelle. Avvìa verso est Siglinda dopo averle consegnate le schegge della spada che serviranno al nascituro eroe, figlio di Sigmondo, e si nasconde fra le Walkirie, mentre arriva Wotan irato. Questi minaccia di gravi pene le vergini se oseranno difendere la sorella colpevole. Brunilde allora si presenta a Wotan, il quale pronuncia la condanna: bandita dal Walhalla, essa non sarà più che una semplice donna schiava e scherno dell'uomo; le altre Walkirie dovranno fuggirla, pena la stessa sorte se rimarranno. Con grida di terrore e d'orrore le Walkirie s'involano. Ma rimasta sola con Wotan, Brunilde riesce a commuoverlo e a fargli attenuare la sentenza: non un uomo, ma soltanto un eroe che non conosca il terrore potrà farla sua sposa. Wotan la addormenta con un bacio, indi invoca Loge affinchè cinga il monte di fiamme. Solo chi non teme il terrore potrà varcarle e destare la vergine assopita.
L'opera, pur conservando la consueta struttura sinfonico-tematica, è una delle più ricche di melodia anche vocale. La melodia wagneriana, naturalmente, non si cristallizza in strofe; aderisce al discorso, ed ha perciò quell'andamento sciolto e a ritmo libero che la fa designare col nome di «melopèa». La maggiore abbondanza di tali effusioni liriche nella Walkiria proviene dall'importanza che nella vicenda scenica assumono le manifestazioni dell'amore: quello dei due sposi-fratelli che domina gran parte del primo atto e una scena del 2°; e quello di Wotan per Brunilde che trionfa nella scena finale dell'opera.
Il fascino amoroso che lega Sigmondo e Siglinda ha una prima espansiva effusione nel motivo dei violini con cui Wagner esprime la pietà di Siglinda allorchè porge da bere al ferito, e subito dopo nel motivo dei violoncelli, che costituisce il vero e proprio «tema dell'amore», allorchè i due giovani si fissano con interesse e passione crescente. Il primo è un motivo che inizia come un sospiro di tenerezza e si espande in un'onda di amoroso abbandono. Il secondo ha il senso di un incantamento magico in una luce di passione estatica. Ma nel duetto che chiude l'atto 1°, a parte le varianti e gli ampliamenti in senso melodico dei temi precedenti, altri motivi di natura largamente cantabile vi si aggiungono a fare di tutta questa scena un vasto canto di eroismo e d'amore. Al centro sta la dolcissima e quasi strofica canzone della primavera: «Cede il verno ai rai del mite april». E lasciamo pur dire quelli che affermano che in questo momento Wagner si è dimenticato del sistema venendo meno all'unità dello stile. La pagina è bella e perciò la rottura del sistema (se di rottura si può parlare) perdonabile; aggiungiamo che non è questa l'unica volta che Wagner allenta la rigidità del sistema per darci pagine più liberamente e poeticamente ispirate.
Tutta percorsa da un'angosciosa febbre, da una delirante passione è la scena del 2° atto fra i due amanti, che precede l'apparizione di Brunilde a Sigmondo.
L'altro amore, quello di Wotan per Brunilde, amore di padre costretto da una legge superiore a punire la figlia colpevole di una grave disobbedienza, si effonde in un ampio ed alto canto: il celebre «Addio di Wotan», in cui la tenerezza del padre si sposa alla commozione del Dio. Ma diremmo che nella melodia larga e patetica ciò che più fortemente stringe il nostro cuore non è la voce del Dio, sibbene il sentimento di paterna profonda umanità che trabocca da ogni accento, mentre l'orchestra disegna il blando motivo del sonno imminente, Addormentata la vergine, cinta di fiamme dardeggiami la vetta, sul guizzante irrequieto tema di Loge («Incantesimo del fuoco») e sul cullante motivo del sonno insieme congiunti, dagli ottoni si leva solenne e potente il motivo dell'eroe liberatore: Sigfrido.
Ma altri motivi melodici di ampio respiro troviamo in vari momenti dell'opera, perfino nella scena del 2° atto fra Wotan e la sdegnata Fricka. Scena per tanti aspetti fondamentale, perchè da essa incomincia il dramma del Dio posto in conflitto con sè stesso, la cui coscienza si trova nella necessità di obbedire alla legge, mentre il suo amore per i figli Sigmondo e Siglinda vorrebbe l'opposto; e perchè da questo conflitto nasce il dramma di Brunilde che avendo ricevuto l'ordine di obbedire alla legge finisce per obbedire istintivamente all'intimo desiderio del padre. Tutto questo è ancora conseguenza della maledizione dell'oro.
Non si possono ascoltare certi recitativi largamente cantabili di Wotan e di Brunilde senza sentirci piombati in un'atmosfera di fatalità tragica, il cui soffio potente dominerà poi l'incontro fra Brunilde e Sigmondo. È questa la scena più profonda e più austera dell'opera, scena che si svolge in una magica immobilità statuaria, solo verso la fine animata da qualche gesto, illuminata per mezzo della musica e particolarmente della strumentazione da una luce soprannaturale. È la scena che fece dire a Wagner: «quest'atto è scritto solo per gli spiriti forti».
E ancora motivi di nobile e larga melodicità troviamo nel 1° atto, e sono il motivo della stirpe sventurata dei Welsunghi e quello del loro eroismo: motivi di una severa malinconia, anche nell'espressione eroica, i quali formeranno la base sinfonica di quella meravigliosa pagina che è la «Marcia funebre in morte di Sigfrido» nel Crepuscolo degli Dei.
A contrasto con il rapimento eroico ed amoroso di Sigmondo e Siglinda sta la figura aspra di Hunding, scolpito come nel bronzo dal suo motivo cupo e rozzo, il cui ritmo solo, ripetuto dai bassi o dai timpani, quasi senza colore, basta ad imprimere alla musica un carattere tetro ed ostile. Brunilde invece è tutta nel fatalismo trascendentale dei suoi canti del 2° atto, nella sua veggente devozione filiale, e nello sgomento allorchè subisce la pena che da virago la fa donna. Ma il suo giubilante e selvaggio grido di guerra con cui ci si presenta al 2° atto diverrà, fondendosi con altri ritmi similari in un formidabile sviluppo a periodi simmetrici, il germe di una delle più fantastiche scene uscite dal genio di Wagner: la celebre «cavalcata delle Walkirie» con cui si inizia il 3° atto.
SIGFRIDO: 2a giornata in 3 atti e 4 quadri, dell'Anello del Nibelungo.
Atto 1° - Interno di una caverna, dall'apertura della quale si vede la foresta. Sul fondo è situata una fucina da fabbro, - Sul davanti il nano Mime, fratello di Alberico, sta inutilmente tentando di saldare su un'incudine i pezzi della spada infranta di Sigmondo. Egli sa bene chi sia la donna che, morente, glieli affidò, e il cui neonato allevò; e sa pure che per mezzo di quel bimbo, divenuto ora un giovinetto coraggioso, e con quella spada rinsaldata potrebbe impadronirsi dell'oro nibelungo uccidendo il gigante Fafner che, trasformatosi in drago, ne sta a guardia entro una caverna. Sigfrido giungendo lo rimprovera e minaccia per la sua incapacità. Partitosene irato, si affaccia all'ingresso Wotan in veste di Viandante. Questi si offre di rispondere, pena la testa, a tre quesiti che Mime gli proporrà; ed avendolo fatto esattamente, richiede a sua volta al nano un impegno uguale: la testa di Mime gli apparterrà se non saprà dare risposta. A due quesiti il nano risponde prontamente, ma al terzo: «chi salderà Notung», il nano non sa dare risposta. Il Viandante gli svela allora che la spada potrà saldarla solo chi non conosca il terrore: a lui appartiene la testa di Mime. E detto questo se ne va lasciando il nano nel massimo sgomento. Ritorna Sigfrido al quale invano Mime, con racconti paurosi, cerca di incutere il terrore. Infine il giovane, vista l'incapacità del nano, decide di saldare egli stesso la spada, e postosi alacremente all'opera in breve la fonde e la tempra. Intanto Mime prepara un beveraggio avvelenato da porgere a Sigfrido allorchè avrà ucciso il drago.
Atto 2° - Bosco foltissimo presso l'antro del drago Fafner. - Alberico vigila all'entrata, e si insospettisce al sopraggiungere del Viandante. Questi risveglia il drago per annunciargli il prossimo arrivo di colui che lo ucciderà; ma Fafner risponde con uno sbadiglio annoiato e si riaddormenta. Wotan allora mette in guardia Alberico contro il fratello e lo consiglia ad intendersi con lui. Allorchè Mime arriva con Sigfrido, Alberico si nasconde. Sigfrido allontana Mime e resta solo; seduto sotto un albero pensa a sua madre che morì nel dargli la vita. Egli non vide mai alcuna donna: non conosce che Mime, ed orsi e lupi. Ora ascolta lo stormire delle fronde e il canto d'un uccellino; vorrebbe intenderne il linguaggio e parlare con lui. Si prova a imitarne la voce con un suffolo, ma dall'instrumento non escono che suoni aspri. Indispettito getta il suffolo e dà fiato al corno; al suo squillo risponde l'urlo rauco del drago, che uscendo dalla caverna provoca il giovinetto. Questi si slancia su di lui e gli pianta Notung nel cuore. Portata involontariamente la mano insanguinata alla bocca, Sigfrido si accorge che ora può comprendere ciò che l'uccellino gli canta. Questi lo invita ad entrare nella caverna e a impadronirsi dell'anello e dell'elmo magico. Mentre Sigfrido è dentro alla grotta. Mime e Alberico si incontrano e si bisticciano violentemente per il possesso del tesoro, ma al ritorno di Sigfrido, Alberico torna a celarsi. Ora l'augellino mette in guardia Sigfrido contro gli inganni di Mime; e quando questi gli si avvicina, e con parole falsamente premurose gli offre la bevanda avvelenata, Sigfrido, che ne intende i nascosti malvagi propositi, gli taglia la testa. Alberico nascosto dà in un'orrenda sghignazzata. L'uccellino sollecita poscia Sigfrido a salire sul monte per destare la fanciulla addormentata dentro il recinto di fiamme: egli stesso gli indicherà la via col suo volo; e Sigfrido lo segue.
Atto 3° - Quadro 1° - Luogo selvaggio ai piedi d'un monte. Wotan invoca Erda affinchè gli sveli il modo di vincere il destino ch'egli sente svolgersi e precipitare ostile agli Dei; ma l'onnisciente rifiuta di parlare. Ed ecco giungere Sigfrido. Wotan tenta di opporsi al suo cammino, ma Sigfrido spezza con la propria spada la lancia del Dio e prosegue.
Quadro 2° - La vetta di un colle, come nel 3° atto della Walkiria. - All'ombra di un frassino dorme chiusa nell'armi Brunilde. Sigfrido ha varcato le fiamme, scorge la donna assopita, e per la prima volta prova una violenta emozione ch'egli scambia per terrore. Taglia con la spada l'armatura che cinge la vergine, si china a baciarla, e a quel bacio Brunilde si sveglia. Ella saluta la luce, ricorda il passato e riconosce in Sigfrido il figlio di Siglinda che essa salvò. Si accorge ora di non essere più la Walkiria ma una semplice donna; vorrebbe resùtere a Sigfrido, ma il suo travolgente amore la vince e con lui inneggia alla nuova vita che per entrambi si schiude.
Meno teatrale de La Walkiria, con atti in cui non figurano mai più di due personaggi in scena, col lungo soliloquio di Sigfrido al 2° atto, con un'unica donna che fa la sua comparsa solo alla fine dell'opera, questa «seconda giornata» dell'Anello non è nè un melodramma nè un dramma musicale. È un fiabesco poema sinfonico-vocale sceneggiato, in cui è rappresentata la balda e coraggiosa giovinezza di Sigfrido nei suoi primi contatti con la natura e con l'amore. Questo ragazzo, animato da un puro sentimento istintivo di lealtà e di umanità che gli fa odiare così la forza bruta di Fafner come i raggiri malvagi di Mime; che sogna la madre, che non vide mai, con i grandi occhi teneri della cerva; che sente l'impulso ardente di correre pel mondo armato di una spada, avido di eroiche gesta; che a contatto con il nano falso e ripugnante aspira a un amico leale e non trova di meglio che un orso; che ascolta le voci della natura, stormire di fronde, mormorio di fonti, canto di uccelletti, e preso da un desiderio panico vorrebbe intenderne il linguaggio; che non conosce il terrore e trema la prima volta dinanzi a una fanciulla addormentata, è una delle più poetiche figure che mente d'artista abbia concepito. Perciò, anche se meno teatrale, Sigfrido è la più alta delle quattro opere che costituiscono l'Anello del Nibelungo.
La musica che caratterizza il giovane eroe è tutta slancio audace, trepida ansia, sognante meditazione. Quando, nel 1° atto, egli irrompe con l'orso nella caverna di Mime, con lui irrompe un soffio caldo di vita. Lo squillo del suo corno, che forma il suo tema, il suo grido gioioso, portano un'animazione nuova su la scena. La sua ira accentua, col rapido disegno dell'orchestra, questo senso di energico fervore che la sua inchiesta sulla madre vena di poetico pathos attraverso al canto dei violoncelli, fino al momento in cui esplode ardente e impaziente l'affermazione: «Vo' dal bosco andar nel mondo e mai più qui tornar!». Ora la musica acquista altri colori: l'ingresso del Viandante serve a rievocare avvenimenti delle opere precedenti non sempre necessari, e sui quali incombe un senso di oscura fatalità. Ma col ritorno di Sigfrido, ritorna la luce e la vita; e allorchè egli inizia la fusione della spada, un canto gagliardo sgorga dalle sue labbra e dal suo cuore fidente con un vigore lirico che è la più completa espressione del suo entusiastico spirito eroico e della sua esuberante giovinezza. È un canto liberamente strofico che sprigiona un gioioso senso di forza ìnsito nei ritmi balzanti, accresciuto dal martellare cadenzato su l'incudine, reso ancor più fervido e febbrile dall'impetuoso movimento dell'orchestra, chiuso trionfalmente dallo scatenarsi del tema di Sigfrido portato ad un'espressione di giubilo delirante.
Il Sigfrido più intimamente poetico e più ingenuamente fanciullo è quello del 2° atto, allorchè il suo animo si rasserena al lieve stormire delle fronde, mentre l'assale struggente il desiderio della madre. Al brusìo dell'orchestra, che rievoca il risveglio del bosco al soffio della brezza mattutina, si intrecciano due ampie melodie patetiche: quella dell'amore materno e quella della sventura dei Welsunghi. Dall'alto d'un ramo un uccelletto gorgheggia: atmosfera di idillio agreste, incantesimo di vita elementare, un prodigio d'arte. Il giovinetto sogna; la sua anima si sveglia con lo svegliarsi della natura; per fondersi meglio con essa egli è attratto ad imitare il canto dell'uccelletto. Ma il gioco non gli riesce: l'episodio musicale acquista un valore comico quasi veristico, al quale fa immediato contrasto il favoloso combattimento col drago eroicamente aperto dalla squillante fanfara del corno di Sigfrido.
Nel 3° atto il giovane eroe, ormai deciso a conquistarsi la compagna promessagli, vince impaziente in un rapido contrasto l'opposizione, più verbale che attiva, di Wotan, e sale attraverso alle fiamme su la vetta ove dorme Brunilde. Ma prima ancora di vederla egli è di nuovo preso dalla poesia del paesaggio che gli sta intorno, dalla poesia del silenzio e dell'altitudine, ch'egli esprime con l'estatica frase: «O solitudin beata del ciel!». Poesia contemplativa che dalla voce del canto passa all'orchestra con delicatezza eterea. Poi tutto un nuovo fiotto di emozioni sorge: la vista della dormiente e il primo stupore di Sigfrido, al quale fa tosto sèguito un turbamento profondo ch'egli scambia per terrore, un languore, uno struggimento, un fremito d'ansia che gli tolgono ogni forza. È il sorgere dell'amore con tutta la sua fresca fragranza e le sue vertigini in un cuore ancora vergine e ingenuo. In questo nuovo mondo di emozioni, mai espresse fino allora dalla musica, Wagner ha saputo cogliere anche la minima sfumatura.
Dopo il dolcissimo bacio che risveglia Brunilde, la Walkiria rimane per un momento la figura principale, isolata nel suo fulgido saluto alla luce. Ma come s'inizia l'animato colloquio con Sigfrido, questi riacquista la sua balda personalità, che vieppiù si impenna di maschi accenti quanto più la donna tenta di opporre la propria divinità perduta (il mistico: «Io eterna fui, eterna sono») alla prorompente passione dell'eroe che l'ha conquistata. E tutto preso dalle necessità dell'espressione musicale, nei momenti di maggior rapimento estatico Wagner dimentica (laus Deo!) il sistema teorico secondo il quale, per rispetto alla verità, i personaggi debbono cantare uno alla volta (come se non fosse già contro verità il farli cantare) e unisce le due voci di Sigfrido e Brunilde in un'impeto d'accordo armonioso e vittorioso.
A contrasto con la gagliarda e luminosa rappresentazione musicale dell'eroe giovinetto, sta quella altrettanto perfetta del perfido nano. La musica ce lo raffigura ora perplesso ora pavido, ma più spesso subdolo. I suoi canti hanno in generale, specie nei suoi dialoghi con Sigfrido, un'espressione sorniona querula e melensa. Ma questo misto di viltà e di malvagità, insieme alla sua natura fisica di nano e alla sua scarsa intelligenza, attestata dalle futili domande rivolte al Viandante, ha dato a Wagner lo spunto per diverse pennellate grottesche. Grottesco e pettegolo è soprattutto il suo bisticcio al 2° atto con Alberico, il quale appare torvo e violento, non solo nella lite col fratello, ma anche nel diverbio con il Viandante. Ma anche Mime è una vittima della maledizione che pesa sull'oro, ch'egli pure ha lavorato e desiderato; e perciò soccombe, ma la morte di questo ridicolo pretendente non riceve altro commento che la beffarda sghignazzata di Alberico.
La musica che caratterizza le comparse di Wotan è improntata ad una grave angoscia. Solo nel dialogo con Mime al 1° atto essa assume talvolta sfumature di fine umorismo. Wotan è incalzato da un destino che invano si industria di evitare. La sua invocazione e il suo dialogo con Erda sono pieni di afflato tragico e si svolgono su un movimento orchestrale tempestoso che solo mentre parla la saggia Wala (altro nome di Erda), e alla fine, allorchè Wotan accetta il proprio ineluttabile fato, si placa in una gravità solenne e profonda che contiene accenti di espressione magica. Rassegnato e intimamente lieto egli contrasta vanamente al nipote il cammino che segnerà il tramonto degli Dei e il trionfo di un mondo pacificato e libero dalla maledizione dell'oro.
IL CREPUSCOLO DEGLI DEI: 3a giornata in un Prologo, 3 atti e 6 quadri, dell'Anello del Nibelungo.
Prologo - Sul colle delle Walkirie (l'ultima scena del Sigfrido). - Le tre Norne stanno tessendo i destini del mondo. Rievocano avvenimenti passati, ma quando slanciano il filo al quale si lega la vita di Sigfrido esso si spezza, «Il sapere etemo è finito», esclamano desolate, e discendono a Erda. - È l'alba. Uscendo con Brunilde dalla abitazione scavata nella roccia, Sigfrido si accomiata per andare a compiere nuove gesta eroiche. Prima di lasciarla le dà l'anello d'oro ch'egli conquisto a Fafner. È l'anello che dà la potenza sul mondo, ma la cui maledizione è ignota a Sigfrido e a Brunilde. Poi Sigfrido parte: si ode il suo corno squillare gioioso sempre più lontano mentre egli risale in barca lungo il Reno.
Atto 1° - Quadro 1° - L'atrio della reggia dei Gibicunghi. - Hagen, figlio naturale del nano Alberico e della regina Grimhilde, sposa di Gibich e madre del Re Gunther e di Gutruna, pensa che alla grandezza del fratellastro e della sorellastra manchi solo un matrimonio illustre. Per Gutruna ha pensato all'eroe Sigfrido, il quale potrebbe conquistare per Gunther la fanciulla che risiede sull'alto monte, cinta da una siepe di fiamme: Brunilde. Egli sa bene che Brunilde è già sposa a Sigfrido, ma si guarda dal narrarlo. Figlio di Alberico, egli vuol vendicare in Sigfrido l'affronto fatto al padre allorchè Wotan gli rapi l'oro, e impadronirsi del tesoro dei Nibelunghi. Perciò quando sente passare sul Reno Sigfrido, lo invita ad entrare e gli offre per mano di Gutruna una bevanda in cui ha versato un filtro d'amore e un filtro che toglie la memoria del passato. Istantaneamente Sigfrido dimentica Brunilde e s'accende d'amore per Gutruna. Espostogli il desiderio che Gunther ha di sposare Brunilde e le difficoltà, egli giura di conquistarla per lui. In compenso avrà in isposa Gutruna; e parte tosto per l'impresa.
Quadro 2° - La vetta delle Walkirie come nel Prologo. - La Walkiria Waltraute viene ad implorare Brunilde di restituire alle figlie del Reno l'anello maledetto per evitare la fine degli Dei e danni a sè e a Sigfrido. Ma Brunilde non le crede, si disinteressa della sorte degli Dei, e rifiuta di separarsi dal pegno d'amore lasciatole da Sigfrido. Waltraute parte da lei nella massima angoscia predicendole sventure. Ed ecco giungere Sigfrido; egli mediante l'elmo magico ha presa la figura di Gunther. Un rapido colloquio, una breve lotta e la resistenza di Brunilde è vinta. Anche Panello le viene strappato. Poscia Sigfrido sguaina la spada che pianterà tra sè e la donna, pegno della fede giurata a Gunther.
Atto 2° - Riva sul Reno, davanti alla reggia dei Gibicunghi. - Hagen ascolta i consigli di frode che nel dormiveglia Alberico gli suggerisce per rapire l'anello a Sigfrido. Questi, di ritorno, narra ad Hagen come gli riuscì la conquista di Brunilde. Hagen dà fiato al corno e chiama a raccolta i vassalli e i guerrieri per festeggiare le nozze di Gunther. Quando Brunilde giunge con Gunther, vedendo Sigfrido con l'anello in dito gliene chiede ragione, poichè essa, per l'inganno dell'elmo ritiene di essere stata vinta da Gunther; e infine lo accusa di tradimento dichiarando di essere stata sua sposa. L'eroe immemore giura di non avere ingannato Gunther, ma Brunilde giura essa pure che Sigfrido è suo sposo. Hagen, dopo che Sigfrido si è allontanato con Gutruna, spinge Brunilde e Gunther alla vendetta, e ne giurano insieme la morte.
Atto 3° - Quadro 1° - Selva selvaggia presso il Reno. - Le Ondine tentano di indurre Sigfrido a rendere loro l'anello, ma il giovane rifiuta. Le fanciulle si allontanano predicendo all'eroe sciagura. Intanto Sigfrido è raggiunto da Hagen, da Gunther e da un numeroso stuolo di cacciatori, e mentre si dispongono per riposare, Hagen gli chiede di narrare le sue imprese. Per risvegliarne la memoria gli versa nella coppa un filtro. Sigfrido racconta, innanzi a Gunther inorridito dalla rivelazione, come conquistò la prima volta Brunilde; ma all'improvviso Hagen lo ferisce alle spalle e si allontana. L'eroe stramazza al suolo, e negli ultimi accenti invoca teneramente Brunilde. La salma è sollevata e riportata da un muto corteo alla reggia.
Quadro 2° L'atrio della reggia dei Gibicunghi come nell'atto 1°. - Gutruna attende ansiosa il ritorno di Sigfrido, atterrita da sinistri presagi. Ed ecco, le recano il cadavere dello sposo non suo. Hagen e Gunther ora contendono fra loro per il possesso dell'anello, ed Hagen stende morto il fratellastro; ma avvicinandosi poi alla salma di Sigfrido per trarle l'anello dal dito, la mano si leva verso di lui minacciosa. Frattanto giunge Brunilde: essa ha saputo dalle figlie del Reno la verità , e conosce di quale perfida macchinazione fu vittima Sigfrido. Ordina che si alzi un rogo, vi fa porre sopra il cadavere dell'eroe, e vi si getta essa stessa. L'anello, purificato dalle fiamme cade nel Reno. Hagen si precipita per carpirlo, ma afferrato dalle Ondine mene trascinato sotto le acque. Intanto le vampe del rogo levandosi alte si apprendono al Walhalla ove Dei ed eroi periscono. Così la maledizione che pesa sull'oro compie l'estrema catastrofe.
La presenza dominante della cupa e bieca figura di Hagen, l'atmosfera pesante di frode e di delitto ch'egli crea intorno a sé, il groviglio complicato dei casi e delle situazioni, la lentezza generale dei movimenti musicali, il lunghissimo soliloquio finale di Brunilde, rendono quest'ultima giornata dell'Anello tetra e faticosa. Cosicché quando all'inizio del 3° atto riudiamo ancora il canto gioioso delle fìglie del Reno, e le risposte tragicamente spensierate, ma improntate musicalmente a sorridente serenità, di Sigfrido alle loro richieste, sembra che penetri nella bruma della vicenda mitica un raggio di sole, e pare che il respiro si allarghi. Naturalmente ciò non significa che prima di questa scena la musica non risplenda di stupende bellezze. Il Prologo, ad esempio, con la presenza delle Nome, conoscitrici del passato e del presente, divinatrici del futuro, tessitrici di quel destino del mondo che nè Wotan, Dio degli Dei, nè Erda, la Terra onnisciente, possono mutare, è tutto pervaso da un senso magico e primordiale nei movimenti fluenti e fatalistici dei temi conduttori.
Subito dopo la scomparsa delle Nome, la voce dei violoncelli evoca un'alba piena di calma e serena aspettazione, i corni vi intercalano sottovoce il motivo di Sigfrido, ed ecco disegnarsi un motivo nuovo che esprime una dolce ebbrezza: quello di Brunilde non più Walkiria ma donna amante. Tutta la scena successiva è traboccante di questo ardore e dello slancio di Sigfrido teso verso nuove imprese eroiche. Slancio che si prolunga nell'episodio sinfonico che collega il prologo con il 1° atto e che va sotto il nome di «Viaggio sul Reno». Il motivo di Sigfrido squilla gioiosamente e quasi balza in un ritmo di danza, contrappuntato da altri motivi agili e freschi degli archi. Ma il tema delle Nome, quello delle figlio del Reno, quello dell'oro precisano il destino che incombe nell'ombra.
Con i motivi dell'oro e dell' anello, pensieri dominanti di Hagen, l'interludio si collega al 1° atto che si apre appunto col motivo cupo di Hagen. La trama sinfonica densa e multicolore si smaglia e si rasserena per qualche momento dopo che Sigfrido bevuto il filtro, si accende di un nuovo sentimento d'amore per Gutruna. Ma al giuramento il canto arrotonda i periodi, rafferma il senso melodico, prende un'andatura quasi strofica, alterna e congiunge le voci alla maniera italiana. Staremmo per dire alla maniera meyerbeeriana, senza che ciò sottintenda alcunchè di offensivo per Wagner, poichè in situazioni analoghe Meyerbeer sa trovare la vena più robusta anche se (come Wagner in questo «giuramento» del Crepuscolo) un po' magniloquente.
Quasi sempre saltata, per abbreviare l'atto che in unione al prologo dura circa due ore, è la scena fra Brunilde e Waltraute. Però essa è fondamentale per lo scioglimento del dramma, in quanto una decisione sola potrebbe deviare o arrestare il corso degli eventi: la restituzione dell'anello alle figlie del Reno. Per due volte si presenta nel dramma questa possibilità: una al 1° atto, allorchè Waltraute lo chiede a Brunilde; un'altra nel 3°, allorchè uguale richiesta vien fatta dalle Ondine allo stesso Sigfrido; e tutt'e due le volte alla domanda è opposto un rifiuto. Inoltre nel corrucciato dialogo fra Brunilde e Waltraute ci si rivela in modo netto la natura ormai terrestre di Brunilde: l'amore di Sigfrido vale per lei più del crollo degli Dei e della fine dello stesso padre Wotan. La scissione fra Cielo e Terra in questa scena avviene in modo completo e irrevocabile, e la musica lo sottolinea con una terribilità angosciosa quasi inumana; come terribilmente inumana è la fine di questo atto di una veemenza soffocante.
Il 2° atto è pure tetro e cupo, con una tessitura sinfonica densissima. Nè vale ad alleggerire l'oppressione la breve scena in cui Hagen chiama vassalli e guerrieri alle nozze di Gunther, perchè la sua allegria e pesante e sinistra, come (giustamente) barbarico e pesante è il coro che accoglie l'arrivo di Brunilde e di Gunther. Tutto ciò è bene in carattere coll'aggrovigliatissima azione, ma non è fatto per rendere più tollerabile un atto che dura inoltre un'ora buona. Solo alla fine, dopo la decisione di uccidere Sigfrido, le voci ancora una volta si uniscono con libero sentimento drammatico, a dispetto delle tirannie sistematiche. Ma in questo cupo quadro, per chi abbia pazienza e amore dell'arte, quanti meravigliosi episodi e particolari strumentali e sinfonici: le trasformazioni tematiche geniali, la ricchezza dei colori anche nell'uniforme cupezza generale, il senso trascendentale dei motivi, i contrasti drammatici fra la balda sicurezza di Sigfrido lo sdegno doloroso di Brunilde la timida dolcezza di Gutruna la sospettosa diffidenza di Gunther la torva astuzia di .Hagen!
La prima scena del 3° atto riporta la serenità e la gioia. Il canto motteggiatore e scherzoso delle Ondine, il loro gaio cicaleccio che si stende su un liquido fluttuare di armonie e di arpeggi, la spensierata galanteria di Sigfrido, donano a tutto l'episodio un senso di freschezza primaverile.
Per un momento l'arrivo di Hagen e di Gunther con i cacciatori riannebbia l'atmosfera; ma il racconto di Sigfrido col ritorno dei noti motivi delle sue gesta, col richiamo al mormorio della foresta e al canto dell'uccellino, e finalmente col ricordo di Brunilde, costituisce un'altra pagina di poesia idillica rapitrice.
Il quadro dai colori luminosi è troncato di colpo dall'uccisione dell'eroe. Un crollo immenso, uno strisciare pauroso di note e poi il saluto del morente a Brunilde, che coincide musicalmente col saluto di lei alla luce dopo il risveglio, tutto rifulgente del tintinnio delle arpe. Un silenzio tragico segue alla morte: gli archi riprendono a strisciare con un senso di terrore per fermarsi sul motivo mesto dell'infelice stirpe dei Welsunghi; poi su strappi fortissimi si inizia la marcia funebre dell'eroe. I temi pieni di grave tristezza, quelli eroici dei Welsunghi, lo squillo di Notung, il motivo e la fanfara non più gaia ma tragica di Sigfrido, i motivi dell'amore di Siglinda e di Brunilde, creano un quadro di una trionfale bellezza in una monumentale grandiosità di costruzione sonora veramente degna del più sublime degli eroi.
Poscia l'azione riprende torbida e violenta e la musica ritesse la sua densa trama, in cui i motivi noti risuonano in un'atmosfera allucinante. Ma verso la fine del lungo racconto di Brunilde, nel quale essa ricorda la purità e la grandezza dell'eroe, si leva una melodia alata, una melodia ampia e di una forza trasumanante, una vera melodia liberatrice in cui i paurosi incubi della tragedia naufragano trasfigurati. Il Walhalla crolla divorato dalle fiamme; di tutto il nero accavallarsi di eventi tragici originati dalla maledizione d'Alberico non resta che questo sublime canto che inneggia alla redenzione del mondo nell'amore.
CAMILLO SAINT-SAËNS (Parigi 1835-Algeri 1921) - SANSONE E DALILA: opera in 3 atti. Prima esecuzione al Teatro Granducale di Weimar il 2 dicembre 1877. Libretto di Ferdinando Lemaire.
Atto 1° - Piazza nella città di Gaza in Palestina. - Gli Ebrei piangono la perduta libertà e invocano V aiuto di Jehova. Sansone coll'ardente parola li solleva dall'avvilimento e li trascina allentusiamo e alla fede. Il satrapo Abimelech, che ha osato bestemmiare il Dio degli Ebrei e levare la spada contro Sansone, viene da questi ucciso, e i suoi seguaci posti in fuga. Le donne Filistee danzano in onore del vincitore e Dalila gli promette le più dolci voluttà.
Atto 2° - La valle di Soreck, innanzi alla dimora di Dalila. - Il Sommo Sacerdote di Dagone chiede a Dalila di scoprire il segreto della forza di Sansone e di dargli nelle mani questo nemico. L'amore ha guidato Sansone, suo malgrado, verso la casa di Dalila. Invano egli lotta tra il dovere e la passione; questa, più forte di lui, lo vince ed egli entra nella dimora della donna. Dopo qualche istante si ode il grido di trionfo di Dalila: «A me. Filistei!». I soldati in agguato si precipitano per impadronirsi di Sansone al quale Dalila ha tagliato le chiome.
Atto 3° - Quadro 1° - La prigione di Gaza. - Sansone accecato e incatenato sta girando una macina, e di tanto in tanto interrompe il lavoro per chiedere perdono a Dio del fallo commesso. In altra parte Ebrei prigionieri lamentano il suo tradimento. Poscia dei Filistei entrano nella prigione e trascinano con loro Sansone.
Quadro 2° - Interno del tempio di Dagone. - Sacerdoti e popolo irridono a Sansone, che ascolta impotente, fra due colonne madri del tempio, i canti della loro orgia e i loro insulti. Anche Dalila lo schernisce ricordandogli le voluttà perdute, ma Sansone, dopo aver invocato umilmente da Dio un ultimo favore che dimostri la sua potenza, scuote le due colonne e fa crollare il tempio che seppellisce lui e i Filistei.
L'opera presenta forme classiche nelle quali passa un soffio di ariosa nobiltà. Nella musica non concessioni a gusti banali. La melodia riesce accessibile prontamente non perchè si abbassi al livello comune dell'intelligenza mediocre, ma perchè, pur nella sua aristocrazia stilistica, nella sua eleganza prettamente francese, ha chiarezza di linee e rilievo espressivo, spesso potente. In qualche scena la levigatezza della forma in unione a una certa esteriorità convenzionale di rappresentazione dà nell'oleografico. È il caso, ad esempio, delle danze nel tempio di Dagone: pagine piacevolissime per la ritmica viva, la melodicità limpida, lo strumentale colorito, ma di un orientalismo o arcaicismo o primitivismo (tranne qualche momento) piuttosto all'acqua di rose. Troppo melodicamente europee per essere orientali, troppo ottocentesche per essere arcaiche, troppo raffinate per essere primitive: però belle di un gusto decorativo signorile.
Un'altra scena che, non ostante diverse sparse bellezze e vari tratti robusti, appare nel complesso compassata e convenzionale, è il duetto tra Dalila e il Sommo Sacerdote nel 2° atto.
Le parti più nobilmente e vigorosamente scolpite sono quelle che riguardano i due protagonisti, e i cori. Sansone è ritratto nei suoi tre aspetti principali. Nel 1° atto ci appare energico e ardente di fede. La sua voce squilla risoluta nel primo intervento presso gli Ebrei piangenti: «Figli miei, v'arrestate!»; sale a grado a grado fino all'affermazione: «Noi rialzerem l'altar del gran Dio d'Israel!», per acquistare tono più discorsivo e commosso, che s'infiamma di profetico fervore al canto espansivo dell'invito: «Imploriam a' suoi piè il Signor».
Ma alla fine del 1° atto Sansone è già in preda alla passione amorosa. Al canto lusinghevole di Dalila egli risponde con movimenti cromatici discendenti e con oscillazioni vocali che esprimono il suo stato di inquietitudine e di perplessità. Nel 2° atto è ormai solo una vittima che lotta debolmente e senza volontà, incapace di sciogliersi dal fascino erotico che l'ha soggiogato. La tempesta che infuria non è soltanto un'eco casuale della natura circostante al turbamento di Sansone, ma è la stessa tempesta dell'animo suo. E poche volte la fusione dell'ambiente con l'intimità spirituale d'un personaggio è riuscita così profonda e totale.
Nel 1° quadro del 3° atto l'eroe vinto, accecato, senza più forza (che pena faticosa nel disegno degli archi!) implora soltanto con estremo abbandono; una frase angosciosa, prima annunciata dal corno inglese» poi, con più anima, dai violini, risponde al suo pianto. E gli rispondono, come una voce interna di rimorso, i rimproveri degli Ebrei tornati in schiavitù.
Dalila è dipinta coi colori più teneri dell'ebbrezza dei sensi già al suo primo apparire alla fine del 1° atto, con quel canto così molle e pieno di note basse voluttuosissime, la cui malìa infernale è tosto avvertita dal Vecchio Ebreo che invano mette in guardia Sansone. Ma nel 2° atto la seduzione si accende di bagliori ancora più sensuali e si espande in ondate di melodia piene di un penetrante languore. È un turgore di delizie e di sottili effluvi che alfine si schiude come un gran fiore profumato nel sognante canto: «S'apre per te il mio cor»; melodia dal respiro ampio, tutta sostenuta da ondate di brividi dolcissimi. Chi potrebbe sospettare che sotto una lirica tanto sentita si annidi la più atroce finzione? E, come non bastasse, alle parole: «Ah! rispondi a' miei deliri», questo canto così fascinoso si scioglie in una melodia ancor più sensuale, formata da una successione di molli discese cromatiche, seguite da una serie di progressioni passionali ascendenti che ripiombano su le note basse come chi stia per mancare affranto dall'ebbrezza. Tempesta e brividi si alternano nell'orchestra sotto la seconda strofa; tempesta e brividi che sconvolgono il cuore di Sansone e lo ammolliscono. Poi la bufera si accentua sempre più, il motivo della seduzione si anima, diventa febbre, diventa delirio sotto il quale ogni capacità di resistenza dell'uomo è infranta. L'ottocento musicale in fatto di seduzione erotica non aveva ancora visto nulla di simile!
Infine i cori (non parliamo di quelli del 3° atto, robusti, ma un po' melodrammatici) hanno un vigore inconsueto. Dopo il gran pianto con cui l'opera s'inizia, e il cui commento orchestrale così pieno di turbamento è derivato dalla scena delle tenebre del Mosè di Rossini, e dopo il discorso di Sansone, le voci del coro acquistano gagliardia di ritmi e di accenti, fino ad esplodere nel sussultante eroico inno: «Spezza i ceppi, Israel». Ma uno dei più caratteristici e nuovi è il coro: «Inno di laudi, inno d'esultanza», che i Vecchi Ebrei cantano dopo l'uccisione di Abimelech e la fuga dei Filistei, Su quel testo e dopo tali avvenimenti gloriosi si penserebbe che dovessero scoppiare grida di gioia frenetica. Niente di tutto questo! Il musicista ha resistito all'invito «melodrammatico» allettante. Ha steso una serie di accordi ascendenti di archi legni e comi, lenti, pianissimo, quindi fa entrare poche voci di basso, da principio scoperte, all'unisono, che levano un cantico sommesso, raccolto, quasi stupito, come se temessero di vedere a un tratto distrutta con un soffio la realtà della vittoria. E nulla rende meglio di questo coro la pavida commozione dei vecchi che sanno come il male sia sempre in agguato dietro ogni gioia, che hanno quasi il presentimento della tragedia vicina, e, nello stesso tempo, la loro umile venerazione per la potenza smisurata di Jehova.
AMILCARE PONCHIELLI - IL FIGLIUOL PRODIGO: melodramma in 4 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 26 dicembre 1880. Libretto di Angelo Zanardini.
Atto 1° - La valle di Gessen. - È la Pasqua, Ruben, la sua pupilla Jeftele e gli altri componenti della tribù sono raccolti presso la mensa. Manca solamente Azaele, figlio di Ruben; quand'ecco giungere uno straniero, l'Assiro Amenofi, il quale racconta che Azaele con un colpo sicuro di freccia gli salvò la sorella che stava per essere assonnata da una pantera. Ritorna infatti Azaele con Nefte. Il suo cuore è triste; il desiderio di una vita di piacere quale i due Assiri gli promettono nella loro terra, lo tormenta. Egli decide dipartire;invano il padre e la promessa sposa Jeftele tentano di dissuaderlo:essi lo vedono, disperati, allontanarsi con i due Assiri,
Atto 2° - Quadro 1° - Atrio dei Sacerdoti contiguo al tempio d'Ilio a Ninive. - Amenofi vorrebbe sacrificare Azaele al Dio dell'Assiria, ma Nefte che se n'è innamorata, si rifiuta di servire al piano criminale di Amenofi.
Quadro 2° - La gran piazza di Ninive. - Movimento di folla festante. Da un lato Azaele e Amenofi giocano a dadi. Invano Nefte sconsiglia il giovane Ebreo dal proseguire; fra i due giocatori s'accende una rissa che viene troncata al giungere di un corteo sacro. Tra la folla Ruben, che è venuto a Ninive accompagnato da Jeftele per ricercare il figlio, crede di riconoscerlo, ma Jeftele che pure l'ha riconosciuto, per tranquillizzarlo gli dice che non è lui.
Atto 3° - Il sacrano del tempio d'Ilio a Ninive. -Jeftele, penetrata nel tempio per ritrovare Azaele, è stata arrestata come profanatrice. Amenofi col pretesto di interrogarla allontana tutti, e rimasto solo con lei le confessa di avere allontanato da lei Azaele unicamente per possederla. Di fronte alla ripulsa di Jeftele, Amenofi le dà un'ora di tempo per scegliere tra il suo amore e la morte. Azaele che era stato rinchiuso nel sacrario come iniziato alla religione assira, pentito dei suoi trascorsi e Volendo salvare Jeftele, chiama i sacerdoti e si accusa di aver voluto penetrare i segreti della loro religione per vilipenderli. Frattanto, accompagnato da Nefte, giunge anche Ruben che riabbraccia il figlio e gli perdona. I sacerdoti, la folla e Amenofi staccano a forza Azaele dal padre e da Jeftele e lo trascinano al fiume.
Atto 4° - A Gessen, come nel 1° atto. - Azalee, che Nefte, ha tratto in salvo, è ritornato ed ha appreso che il padre è impazzito dal dolore avendolo creduto morto. Egli è affranto dal cammino, disfatto dal rimorso. Nessuno l'ha ravvisato, ma Jeftele lo riconosce. Essa lo ama sempre, gli perdona e lo costringe a restare. Al rivederlo il padre riacquista la ragione e stringe le mani di lui a quelle di Jeftele benedicendolo, fra l'esultanza del popolo.
L'azione diluita, spesso statica, ancora legata alle forme convenzionali del melodramma ottocentesco, impaccia spesso la fantasia dell'autore e rende l'opera meno teatrale della Gioconda. Tuttavia nel 1° e nel 4° atto il carattere biblico del soggetto, il sentimento religioso austero che ne risulta, hanno distolto il compositore dalle consuete enfasi, dalle rumorose quanto vuote perorazioni.
La musica perciò in questi due atti acquista un'espressione intima e raccolta che (fatta eccezione per la romanza «Cielo e mar»), invano cercheremmo nella Gioconda. L'atmosfera generale appare nobilitata, il disdegno melodico è più fine, l'elaborazione contrappuntistica più interessante, la stessa orchestrazione più delicata e suggestiva. C'è anche, in questi due atti, un colore pastorale diffuso che emerge a volte dai disegni melodici dell'orchestra, a volte da quelli dei cori; colore suggestivamente appropriato. E c'è un'evidente intenzione di togliersi dal consueto e dal volgare, che sostiene l'ispirazione e la dirige verso una controllata sincerità d'espressione. L'intermezzo del 4° atto palpita di un'emozione sacra e contemplativa più oratoriana che melodrammatica. E così è di talune arie e recitativi, come l'aria di Azaele: «Piangi, povero cor» (atto 1°), così commossa e tenera, il lamento di Ruben: «V'ha un figliuolo d'Israele» (atto 2°), tanto doloroso e penetrante nella sua semplice lineatura, e il saluto di Azaele: «Tenda natal» nell'ultimo atto, così imbevuto di affettuosa nostalgia.
Accanto a queste pagine qualche parte profana ha trovato pure accenti di languida e carezzevole sensualità in antitesi drammatica efficace con le parti religiose. Così, ad esempio, il terzetto del 1° atto: «E languir, Azael, qui puoi tu», il quale merita di essere ammirato per la robusta costruzione. Ponchielli rivela, qui, come in altri pezzi d'assieme e nei concertati, l'arte di un maestro sicuro. E, a proposito di concertati, forma ormai convenzionale pel troppo abuso, è notevole come egli abbia saputo imprimere un carattere cupamente tragico in quello finale del 3° atto: «Cupa, sinistra la funebre squilla», a frasi rotte e voci scoperte fra gli squilli di trombe che si ripercuotono ora vicini ora lontani con un senso di fatalità e di misterioso terrore lugubre e, starei per dire, verdiano. E bisogna pur dire che nessuno allora, nè poi in Italia, seppe scrivere pagine che stessero accanto a quelle del gigante di Busseto, senza sfigurare, come questa.
Non mancano neppure le effusioni vigorose, come la introduzione e la quasi mefistofelica invettiva di Amenofi, e il coro: «Vibrate, cimbali d'or!» nel 2° atto, pieno di una gioiosa esultanza. Una figura particolarmente sentita e che trova nella musica un candore ardente e commosso di espressione, è quella della dolce e fedele Jeftele.
Ma, detto questo, bisogna convenire che dalla musica della Gioconda, non ostante taluni difetti, emana un maggior calore, e un quid, inspiegabile a parole perchè sfugge ad ogni analisi, che la rende più prontamente e durevolmente penetrante, e che costituisce la ragione principale della sua costante fortuna.
PIETRO CIAICOWSKI (Votkinsk [Viatka] 1840 - Pietroburgo 1893). - EUGENIO ONEGHIN: dramma lirico in 3 atti e 7 quadri. Prima rappresentazione privata del Teatro del Conservatorio di Mosca il 29 marzo 1879; prima rappresentazione pubblica al Teatro Imperiale di Mosca il 23 gennaio 1881. Libretto di Schilovski dal romanzo in versi di Alessandro Puschkin.
Atto 1° - Quadro 1° - Giardino e casa di campagna di Madama Larina. - Lenski, amico di casa, viene a far visita conducendo seco l'amico Eugenio Oneghin, non più giovane libertino. Al solo vederlo Tatiana, figlia di Madama Larina, temperamento di sognatrice romantica, ne è affascinata. Di lei pure è preso Oneghin, il quale inizia subito nei suoi riguardi una sottile opera di seduzione; mentre Lenski è innamorato della sorella Olga.
Quadro 2° - Stanza di Tatiana. - La passione divora già in pieno il cuore di Tatiana; essa non può prender sonno, e alfine si decide a scrivere a Oneghin una lettera in cui gli confessa il suo amore. La consegna poi alla nutrice, la Niania, affinchè la rechi a lui segretamente.
Quadro 3° - Un'altra parte del giardino di Madama Larina, - Oneghin s'incontra con Tatiana e le dice che ebbe la sua lettera, ma che non vuol sposarsi poichè il suo cuore è volubile.
Atto 2° - Quadro 1° - Salone in casa di Madama Larina, ove si svolge una festa da ballo. - Oneghin danza con Tatiana, ma udendo intorno qualche commento spiacevole sul conto suo, vuol vendicarsi di Lenski, che l'ha condotto in casa della Larina, ed impegna per più danze Olga, destando in Lenski, il quale conosce le arti di seduttore di Oneghin, una viva gelosia. Fra i due nasce una violenta disputa che termina con una sfida a duello di Lenski ad Oneghin.
Quadro 2° - Un mulino in riva a un canale: paesaggio d'inverno. - Lenski è già arrivato per il duello: poco dopo giunge anche Oneghin. Al segnale del direttore dello scontro, Oneghin spara su Lenski il quale cade ucciso sul colpo.
Atto 3° Quadro 1°- Una sala nel palazzo del Principe Grémine a Pietroburgo. - Sono passati vari anni dal duello. Oneghin è roso dal rimorso per l'uccisione dell'amico e dalla noia per la propria vita dissoluta e senza vere gioie. Ora egli si incontra nuovamente con Tatiana, sposa al vecchio Principe Grémine; e rivedendola s'accorge d'amarla veramente, e di quanto perdette e a torto disprezzo nel passato.
Quadro 3° - Salotto della principessa Grémine, - Oneghin confessa a Tatiana la sua passione. Essa dapprima lo schernisce, poi, vinta, gli confessa di amarlo. Ma con uno sforzo di volontà lo respinge lasciandolo nella massima disper astone.
L'opera ha molte parti convenzionali in cui il soggetto è sfruttato unicamente per costruire il «pezzo» di musica. Per esempio: la prima scena del 1° atto serve soltanto a permettere la costruzione di un elegante e cantabile quartetto, morbidamente disteso su ondulazioni di terzine dell'arpa. I cori e le danze hanno un puro scopo decorativo, quello soprattutto di rendere piacevole e vario l'insieme. E così è di molte altre scene e canzoni. Perfino il quadro del duello (2° del 2° atto) è costruito in maniera da permettere la formazione di «pezzi». Perchè Lenski si trova sul terreno dello scontro prima dell'avversario? Perchè il musicista possa fargli cantare la bella romanza: «Tutto mistero è questo giorno». Romanza nella cui profonda tristezza passa un arcano presentimento dell'al di là. Perchè i due testimoni si ritirano a confabulare fra loro in fondo alla scena, lasciando soli sul davanti i due avversari? Perchè questi possano intanto esporre la loro meditazione (e stranamente pensano ciascuno le stesse cose con le stesse parole) in forma di duetto armoniosamente congegnato a cànone e melodiosamente condotto. Pagina di musica piena di nostalgica malinconia e di poetica vaghezza ma del tutto inutile agli effetti dell'azione.
Non ostante le pittoresche pennellate russe recate da qualche coro e da qualche danza, specialmente dal coro e danze dei contadini nel 1° atto, lo stile è modellato su quello dell'arte europea occidentale, e in particolare francese.
La melodia di Ciaicowski, levigata e piacevolmente affettuosa, si abbellisce di un gusto armonico, contrappuntistico e strumentale che mira in modo costante a un'eleganza signorile, a una ricchezza di particolari che adorna senza appesantire, a una grazia sobria e mai leziosa. L'artista che ha dettato tutte queste pagine fu, indubbiamente, un musicista di facile vena e insieme di squisita sapienza e di un gusto fine e garbato, alieno da durezze come da banalità. Una tenera e spesso intensa e pensosa malinconia, a volte romanticamente sognatrice, che bene si accorda coi personaggi e l'azione, domina la creazione e le conferisce una tinta unitaria, sì, ma anche un po' uniforme, malgrado la varietà dello strumentale. Cosicchè l'opera ha un carattere in prevalenza lirico, tutta effusione di sentimento, anche se non molto profondo.
Nell'onda melodica che scorre per tutta l'opera sprigionando un fascino di seduzione artistica che sembra una emanazione del fascino di seduzione erotica del protagonista, alcune scene emergono per un particolare rilievo espressivo, per una maggiore incisività ed emotività drammatica. Tal' è la scena in cui Tatiana scrive la lettera a Oneghin; scena famosa e ancora ammirevole per la concitazione dei movimenti e per quel misto di fatalità, di passione esaltata e di sognante languore che la pervade.
Drammatico pure il finale del 2° atto per il suo vigore ritmico, e la scena del duello sul quale incombe una cupa desolata tragicità. Per trovare un'altra scena di uguale forza drammatica bisogna superare vari valzeretti, polacche, canzonette, lievi, eleganti, colorite, ma di espressione alquanto superficiale e di natura puramente edonistica, e arrivare all'ultima scena dell'opera: il duetto finale tra Oneghin e Tatiana. Qui ci troviamo dinanzi a un contrasto violento: l'amore disperato di Oneghin, il quale sente che la perdita di Tatiana, non più come amante ma come sposa, è la sconfitta definitiva di tutta la sua dissipata esistenza; e la lotta altrettanto disperata di colei che, pure confessando a sè stessa e ad Oneghin il suo amore, si rifiuta di fuggire con lui per un senso superiore di onestà e di dignità. La musica a questo cozzo si accende dei più romantici quasi wertheriani bagliori, in una esasperazione febbrile di accenti e di melodie roventi, tese da un'intimo spasimo di delirio che afferra e scuote profondamente. È la pagina più alta dell'opera.
GIACOMO OFFENBACH (Colonia 1819-Parigi 1880). - I RACCONTI DI HOFFMANN: opera fantastica in 4 atti. Prima rappresentazione postuma all'Opéra-comique il 10 febbraio 1881. Libretto di Giulio Barbier tratto da varie novelle di Teodoro Guglielmo Hoffmann.
Atto 1° - Interno di una trattoria. - Il Consigliere Lindorf corrompendo un servo della cantante Stella, si impadronisce di un biglietto nel quale essa dava un appuntamento amoroso al poeta Hoffmann, e si propone di impedire il convegno. Hoffmann, che sta bevendo e cantando con amici, d'improvviso si astrae pensando a Stella. Lindorf lo provoca ironico. Hoffmann accusa il diabolico Lindorf di avergli sempre attraversata la via e avvelenato le gioie;e confessa di amare in Stella tre donne diverse. Invitato dagli amici incuriositi, Hoffmann incomincia a narrare il suo amore per Olimpia. - Su questo inizio si chiude il velario, poichè i «racconti» di Hoffmann incominciano al 2° atto con la rappresentazione dei casi che ne costituiscono i soggetti.
Atto 2° - Sala in casa di Spallanzani. - Hoffmann si è innamorato di Olimpia, figlia del fisico Spallanzani. Ma essa non è che una bambola meccanica creata dallo Spallanzani su progetto dello stregone Coppelio. Un tocco su una spalla ne mette in moto i congegni che la fanno parlare, cantare e danzare. Coppelio vuole essere pagato da Spallanzani per avergli ceduta la propria invenzione, e il furbo fisico gli rilascia una tratta su un banchiere ebreo che sa fallito. Intanto Olimpia canta e danza fra l'ammirazione di un folto gruppo di amici dello scienziato. Ma mentre essa trascina in un vorticoso roteare l'illuso Hoffmann fino a farlo cadere esausto, Coppelio ritorna, e per vendicarsi della beffa giuocatagli da Spallanzani fracassa l'automa.
Atto 3° - Galleria sontuosa di un palazzo sul Canal Grande a Venezia. - La bellissima cortigiana Giulietta sta banchettando con un gruppo di amici, fra i quali Schlemil e Hoffmann. Ma Giulietta non è che una schiava del demonio Dapertutto. Essa ha già conquistato per lui l'anima di Schlemil; ora Dapertutto le impone di affascinare Hoffmann e darlo in suo potere. Giulietta seduce Hoffmann e gli svela che Schlemil ha la chiave della sua stanza. Hoffmann allora lo provoca, e con la spada offertagli da Dapertutto l'uccide. Ma quando, presa la chiave, entra nella stanza di Giulietta, questa è fuggita.
Atto 4° - Quadro 1° - Stanza. - Antonia, dotata di una bellissima voce, arde di un'indomabile passione per il canto; passione che ne minaccia resistenza, come già condusse alla tomba sua madre. Perciò suo padre Crespel le proibisce severamente di cantare. Ma il satanico dottar Miracolo con suggestione ipnotica le impone di cantare. Invano anche Hoffmann, che l'ama e che ha appreso il perìcolo che le sovrasta, la scongiura di non cantare più. Evocata dal dottor Miracolo, la madre stessa di Antonia prende corpo dall'effige di un ritratto e la invita a cantare. E Antonia, esausta dalla lotta, cade, e muore cantando una canzone d'amore fra le braccia del padre disperato e sotto gli occhi di Hoffmann affranto.
Quadro 2° - La scena dell'atto 1° - Hoffmann ha terminato il racconto dei suoi tre amori. Ma Olimpia, Giulietta, Antonia e Stella non sono che una donna sola, come Coppelio, Dapertutto, Miracolo e Lindorf non sono che una sola personificazione del demonio: creazioni della sua fantasia di poeta. Ora egli beve ancora per affogare nel vino ogni dolore terreno, ma la Musa gli appare e lo infiamma e lo protegge mentre egli si addormenta ebbro, e Stella si allontana con Lindorf.
La trama fiabesca e poetica del libretto bene si prestava ad accendere la bizzarra e vivace fantasia del musicista. La sua vena, usa al garbo comico dell'operetta in cui profuse abbondanza di melodia chiara e di gaio umorismo, ha saputo immedesimarsi nei personaggi e negli avvenimenti grotteschi e satanici, umani e fantastici dei racconti hoffmaniani, colorendoli con vigore e abbondanza di motivi. I quattro personaggi di Lindorf, Coppelio, Dapertutto e Miracolo, personificanti il demonio che perseguita il poeta nei suoi amori impedendogliene sempre la felice conclusione, sono raffigurati da un unico tema che appare ogni qualvolta uno di essi entri in scena. È un tema breve costituito da una rapida progressione discendente chiusa da un trillo. Qualche cosa di diabolico c'è, ma piuttosto blando; si tratta soprattutto di un tema grottesco e beffardo che però non subisce alcuno sviluppo sinfonico. Non è dunque che un rapido accenno tra l'umoristico e l'ironico, un cartello di presentazione per riconoscere nella quadruplice apparizione un'identità e unità satanica. Anche le canzoni affidate a questi quattro personaggi non sono gran che maligne: la più efficace è quella di Dapertutto: «Gira, specchio fatal» nel 3° atto. Ma assai più efficaci sono i recitativi e i dialoghi che acquistano di atto in atto sempre maggiore drammaticità per concretarsi nella figura veramente infernale di Miracolo con suggestività impressionante.
Le tre donne: Olimpia, Giulietta e Antonia (Stella appare solo fugacemente alla fine dell'opera per recitare poche parole in un breve «melodram») hanno invece tre espressioni musicali differenti in corrispondenza alle loro tre indoli diverse. Olimpia è una grande bambola automatica, e la musica che essa canta ha un carattere aggraziato ma meccanico, da carillioncino settecentesco; carattere meccanico che si accentua in quelle ripetizioni rallentate d'una nota seguita da una scaletta cromatica che discende e si affievolisce come se la molla del motore fosse scaricata e la macchina stesse per fermarsi.
Giulietta è una cortigiana; ma la cullante barcarola veneziana che apre e chiude il 3° atto incorniciandolo, non ambienta personaggi ed azioni in maniera troppo sensuale. Il canto di Giulietta acquista invece un tono di calda passionalità nel duetto con Hoffmann, raggiungendo su la fine di esso una forte espressione drammatica con qualche accento magico.
Antonia è la giovane artista su cui incombe l'ala della morte. La sua canzone «Prese il vol la tortorella» è intinta di flebile malinconia rassegnata, ma non diremo che rechi in sè quell'ombra mortale che il tragico fato che sovrasta alla giovinetta lasciava prevedere. Nè l'altra melodia «È una canzon d'amor», col suo ritmo molle di barcarola e il suo tranquillo disegno, giustifica i sintomi paurosi che Hoffmann scorge in lei: l'accendersi dello sguardo, le gote che s'arrossano, la mano che trema, l'affanno di cuore. Ma dall'entrata del Dottor Miracolo tutto cambia: l'atmosfera si colora di tinte magiche e demoniache nell'evocazione dello spirito di Antonia. Sotto a un motivo sardonico e maligno turbina un movimento di terzine basse in un disegno ostinato e minaccioso mentre Miracolo suggerisce i suoi rimedi infernali, Crespel lo scaccia inorridito e Hoffmann leva un supremo grido di ribellione e di disperazione. Questo terzetto raggiunge uno dei culmini drammatici più originali e suggestivi di tutta l'opera. Successivamente l'apparizione del fantasma materno, la lotta interiore e la morte di Antonia originano un nuovo terzetto (Antonia - la Madre - Miracolo) di efficacia anche maggiore per la vibrazione del ritmo, per l'afflato della melodia, e per quel misto di rapimento estatico e di febbrile tormento che emana dall'insieme della salda costruzione.
Quanto ad Hoffmann, egli figura quale beone scettico e poeta erotico. Il primo carattere però è accennato solo nel 1° atto e nel finale, e più che altro risulta indirettamente dai cori spensierati degli amici. Di Hoffmann è rilevata anche la sua bizzarra fantasia di poeta nella «canzone di Kleinzac», che egli svia verso la visione lirica di Stella. E in questa visione, come nella romanza del 2° atto «Un sol sospir» su l'ondulato e sognante disegno ostinato del corno e dell'oboe; nell'ampia frase «A quel gioir divin» nel duetto del 3° atto con Giulietta; nel duetto con Antonia: «L'anima in te riposa» al 4° atto, il musicista ha saputo trovare accenti di una nobile e affettuosa dolcezza patetica senza cadere nel sentimentale.
Ai personaggi principali si affiancano le quattro macchiette dei servi Andrea, Cocciniglia, Pitichinaccio e Franz, oltre a qualche personaggio minore e a Nicklausse, l'amico di Hoffmann. I servi, soprattutto con gli elementi comici che li accompagnano, recano varietà, ma talvolta con le loro canzoni, anche se aggraziate, riescono ingombranti e superflui. Toltone ciò e qualche, momento di più debole ispirazione, quest'opera reca indubbiamente elementi nuovi nella storia dell'espressione musicale, e specialmente, come si disse, nel fantastico una geniale e nuova forza di rappresentazione drammatica. Notevole poi che Offenbach raggiunga le più forti tinte romantiche attraverso a forme classicamente equilibrate e simmetriche.
GIUSEPPE VERDI - SIMON BOCCANEGRA: melodramma in un prologo e 3 atti; 2a edizione. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 24 marzo 1881. Libretto di Francesco Maria Piave, in parte rifatto da Arrigo Boito. - Epoca: verso la metà del secolo XIV.
Prologo - Una piazza di Genova; a destra il palazzo dei Fieschi. - Chiamato in Genova dal filatore d'oro Paolo Albiani, Simon Boccanegra viene da questi convinto a lasciarsi eleggere Doge di Genova. Simone acconsente, soprattutto per amore della nobile Maria Fieschi, dalla quale ebbe una figlia, ma che gli fu negata in isposa dal superbo padre Jacopo Fiesco. Però Maria è morta proprio pochi istanti prima, Fiesco, uscendo desolato dal palazzo si incontra con Simone, il quale implora da lui pace e perdono. Fiesco si dice disposto a concederglielo solo se gli consegnerà la figlia; Simone gli confessa che gli fu rapita e ne perdette ogni traccia. Partito Fiesco, Simone entra nella di lui casa per rivedere Maria, e scopre così che essa è morta. Frattanto il popolo accorre festante acclamando a Simone Doge.
Atto 1°, Parte 1a - Giardino in casa Grimaldi. - Dagli avvenimenti del Prologo si immaginano trascorsi 25 anni. Amelia Grimaldi (così la chiamano tutti, ma in realtà, come si verrà a sapere, essa è la figlia scomparsa del Boccanegra) ama il gentiluomo genovese Gabriele Adorno, il quale ne chiede la mano al Fiesco tutore di lei. Da questi apprende che Amelia non è la figlia dei Grimaldi (morta suora a Pisa) ma un'ignota orfanella ivi raccolta. Frattanto è annunciato il Doge, che reca la grazia pei Grimaldi, esiliati; ma dalle parole di Amelia e da un medaglione apprende che essa è sua figlia, alla quale aveva imposto il nome della madre: Maria. Il Doge aveva promessa la figlia dei Grimaldi a Paolo, ma conosciuta ora la verità, glie la nega, senza però dirgliene il perchè. Indispettito, Paolo pensa di rapirla.
Parte 2a - Sala del Consiglio nel palazzo Ducale - Mentre il Doge legge ai Consiglieri un messaggio del Petrarca, il quale invoca pace tra Genova e Venezia, su la piazza scoppia un tumulto. Sono stati arrestati Gabriele Adomo e Jacopo Fiaschi. Gabriele ha ucciso un tale che aveva rapita la Grimaldi per ordine di un potente; egli sospetta del Doge e fa per ferirlo, ma Amelia, improvvisamente sopraggiunta, si interpone salvando la vita al padre. Essa racconta come fu rapita, e lascia capire, senza farne il nome, che l'istigatore del rapimento è vivo e presente. Tra Patrizi e Plebei sta per scatenarsi un conflitto, subito sedato con parole di fiera rampogna dal Doge. Questi poi trattiene prigioniero l'Adorno, e costringe Paolo a maledire il perfido istigatore del rapimento di Amelia, certo che non può essere che lui.
Atto 2° - Stanza del Doge. - Paolo, per vendicare il rifiuto opposto dal Doge alla sua richiesta a proposito di Amelia, e l'umiliazione subita con la maledizione impostagli, versa un veleno in una bevanda preparata pel Doge, e tenta di incitare Jacopo Fiesco a ucciderlo, ma questi, nobilmente sdegnato, rifiuta. Allora si rivolge a Gabriele lasciandogli credere che il Doge abbia mire infami su Amelia. Gabriele si decide al misfatto, ma al momento di agire Amelia ancora si frappone. Apprende dal Doge che essa è sua figlia, e, pentito, si dichiara suo partigiano.
Atto 3° - Interno del Palazzo Ducale. - Una rivolta della plebe, suscitata da Paolo, viene domata, e Paolo condotto al supplizio; ma prima di morire svela a Fiesco che avvelenò il Doge. Frattanto fuori si odono canti sacri per le nozze di Adomo con Amelia. Fiesco si presenta al Doge, che è già presso a morire, e questi gli rivela che la creduta Amelia Grimaldi non è altri che la figlia Maria ritrovata. A tale notizia il cuore di Fiesco si intenerisce, ed egli si riconcilia col Boccanegra. Sopraggiungono Maria e Gabriele, e a questi Simon Boccanegra, morendo, trasmette il potere. Alla folla che veniva ad acclamare il Doge, Fiesco ne annunzia la morte e la successione in Gabriele Adorno.
Il Simon Boccanegra andò in scena la prima volta alla Fenice di Venezia la sera del 12 marzo 1857, e cadde clamorosamente. Vi contribuirono certamente non poco l'aggrovigliata e poco comprensibile azione e la tetraggine del libretto, ma ne ebbe colpa anche la musica, in varie parti non ispirata, e scritta secondo formule convenzionali trite. Tuttavia alcuni elementi del dramma avevano fortemente preso l'animo del compositore, specialmente la figura generosa e coraggiosa del Doge. Ecco perchè, a distanza di ben ventiquattro anni, Verdi riprese l'opera, persuaso ormai che conteneva elementi vitali, ma che doveva in gran parte essere non solo ritoccata ma rifatta.
Per il rifacimento del libretto si servì di Arrigo Boito, il quale iniziò appunto con quest'opera la sua collaborazione poetica con Verdi. A lui il Maestro suggerì l'episodio della lettera del Petrarca invocante pace tra Venezia e Genova, e, in generale, raccomandò la figura di Simone allo scopo di approfondirne la psicologia e pome in maggior rilievo la grandezza morale. Le aggiunte nella 2a parte del 1° atto, con la violenta invettiva: «Plebe! Patrizi! Popolo», l'appassionata invocazione: «E vo gridando pace, e vo gridando amor!», e la tremenda maledizione di sè stesso alla quale il Doge costringe il perfido Paolo Albiani, istigatore del rapimento di Amelia, contribuiscono appunto a rendere più vigorosa e monumentale la figura del protagonista. Ma i numerosi ritocchi e rifacimenti, sia nel canto che nell'orchestra, la soppressione di molte forme convenzionali e scarsamente ispirate, lo snellimento di varie situazioni, hanno portato pure a una radicale trasformazione dell'opera, la quale ora si regge assai robustamente. Non che qualche squilibrio tra il vecchio e il nuovo non si avverta; non che qualche parte debole, che potrebbe essere soppressa con vantaggio, non resti ad attenuare qua e là l'efficacia drammatica della musica; ma sono difetti che non compromettono la struttura e la vitalità complessiva dell'opera.
Campeggia ancora con un profilo plastico ed energico per umanità e tragicità la figura del Doge Simon Boccanegra, non solo nella 2a parte del 1° atto già citata, ma anche nel prologo e negli atti successivi; segnatamente nel caldo duetto con Amelia, nella ia parte del 1° atto, in cui avviene il riconoscimento della figlia; nella scena drammatica del 2° atto in cui Amelia rivela al padre che ama Adorno, suo mortale nemico; nella scena successiva in cui dall'odio contro l'Adorno, che tentava di assassinarlo, il Doge passa, per amore della figlia, alla pietà e al perdono, sollevandosi ancora con nobiltà di accenti in una visione superiore di pace tra gli avversi partiti cittadini. Ancora di più grandeggia la figura del Doge negli appassionati canti della scena in cui si riconcilia con Fiesco rivelandogli che Amelia Grimaldi è la figlia tanto tempo cercata, e nella scena solenne della morte.
Ma accanto al Doge un'altra figura si erge con fierezza e nobiltà di accenti, ed è Jacopo Fiesco, così nel grave pianto: «Il lacerato spirito» del Prologo, come nell'aspro duetto successivo con Simone; nel mistico «Vieni a me, ti benedico» del duetto con Gabriele Adorno nel 1° atto, come nel duetto con Simone dell'ultimo atto, ove finalmente questo carattere austero e inesorabile si piega ad umanissimo canto nel commosso: «Piango perchè mi paria in te del ciel la voce»!
Di canti e recitativi oscillanti tra l'amore e l'ira è piena la parte di Gabriele, mentre più teneramente è caratterizzata Amelia, specialmente nel racconto che della sua infanzia fa al Doge, e che permette a questi di riconoscere in lei la figlia creduta estinta; e nel racconto del rapimento, in modo particolare allorchè all'invocazione di pace del Doge essa aggiunge la propria voce con un canto dolcissimo e pure, per l'emozione, rotto qua e là nel ritmo.
Meno precisa, anche per colpa del libretto è la parte del bieco Paolo Albiani. I cori partecipano all'azione con alto senso drammatico, e lo strumentale distingue quest'opera dalle precedenti per l'accuratezza espressiva e coloristica, specialmente nelle parti composte nel 1881, nelle quali si presente l'autore del prossimo Otello.
RIGGARDO WAGNER - PARSIFAL: dramma mistico in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro di Bayreuth il 26 luglio 1882. Testo poetico di Wagner.
Atto 1° - Foresta nel dominio del Gral. - Il Re Amfortas, languente per una ferita insanabile infertagli dal mago Klingsor, viene portato al bagno per lenire lo spasimo. Gurnemanz, il vecchio custode del Gral, narra ad alcuni scudieri che un giorno il Re, per un inganno tesogli dal mago, peccò con una donna; fu allora che Klingsor potè rapirgli la sacra lancia con cui Longino aveva ferito Cristo, e colpirlo. Intanto la selvaggia Kundry ha recato dal lontano oriente un balsamo per la ferita del Re. Ma fu Kundry stessa che, obbedendo alla potenza del mago, trasformata in bellissima fanciulla così da non poter essere riconosciuta, sedusse Amfortas. Gurnemanz racconta pure che Klingsor aspirò un giorno a divenire cavaliere del Gral, ma incapace di conservarsi casto, fu respinto dal vecchio Re Titurel. Fu allora che per vendicarsi, si dette alla magia e attrasse Amfortas nel suo giardino incantato, ove appunto cadde in peccato di lussuria. Ma una profezia accennò a una via di salvazione per Amfortas ad opera di un «puro folle» divenuto «per pietà saggio».
Ed ecco d'improvviso, levarsi alte grida; le guardie conducono un giovinetto che nel recinto del Gral ha ucciso un cigno sacro. Rimproverato aspramente da Gurnemanz egli si commuove, spezza l'arco e getta le frecce. Interrogato, non sa dir nulla di sè; solo ricorda di essere fuggito dalla madre Herzeleide, per vivere una vita selvaggia. Ma Kundry sa che si chiama Parsifal, e che suo padre Gamuret cadde in battaglia. Dopo la fuga del figlio la madre morì di dolore. Alla tragica notista Parsifal dapprima si getta contro Kundry, poi sviene. Tornato in sè Gurnemanz lo conduce al Castello del Gral. Frattanto Kundry è presa da profondo sopore, precorritore di un'evocazione di Klingsor.
Mentre Gurnemanz e Parsifal si avviano, la scena cambia lentamente e ci introduce nel tempio del Gral. - I cavalieri e lo stesso Re Titurel, che per la tarda età cedette la sovranità del Gral al figlio Amfortas, pregano questi di compiere il rito sacro scoprendo la coppa nella quale Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue di Cristo. È il rito che mantiene in vita e dà forza e valore ai Cavalieri del Gral. Ma questo rito rende più acerbo lo strazio della piaga del peccatore; perciò Amfortas si induce a compierlo solo dopo una lunga resistenza. Nell'oscurità del tempio il calice s'illumina di luce viva. Parsifal attonito si è portata una mano al cuore, ma non sembra aver compreso il miracolo e il suo significato, nè partecipa all'agape sacra. Gurnemanz allora lo scaccia, mentre dall'alto una voce ripete la profezia del puro folle che la pietà fa saggio.
Atto 2° - Il castello fatato di Klingsor. - Il mago vede in uno specchio Parsifal che si avvicina; egli allora evoca Kundry e le impone di sedurre il giovinetto. Lancia intanto i suoi guerrieri contro il giovane, che tutti li abbatte.
Appare quindi un giardino incantato. - Uno stuolo di fanciulle-fiori si fa incontro all'eroe vincitore rimproverandogli dapprima la sua crudeltà, tentando poi con vezzi procaci di sedarlo; però Parsifal le allontana infastidito. Ma una voce lo chiama per nome: è Kundry, resa stupendamente affascinante dalla magìa di Klingsor. Essa ricorda al giovane la sua fanciullezza e la morte della madre. Parsifal al ricordo è preso da un vivissimo dolore. Essa allora gli offre come conforto il suo amore, e gli imprime un lungo bacio su la bocca. Parsifal si svincola; preso da orrore comprende in questo istante la colpa e la ferita di Amfortas, e sente che deve salvarlo. Invano Kundry tenta di avvolgerlo in un fascino voluttuoso; egli la respinge. Ma Klingsor compare su la torre del castello e getta contro Parsifal la lancia sacra; questa si ferma sul capo di Parsifal che afferratala traccia con essa nell'aria un gran segno di croce. A questo atto il castello e il giardino sprofondano e Kundry cade con un grido. Allontanandosi con la sacra lancia Parsifal le dice:«Tu sai dove puoi vedermi ancora».
Atto 3° - Paesaggio montuoso e ameno nelle vicinanze del Gral. - È primavera: mattino del Venerdì Santo. Amfortas non ha più osato scoprire la coppa del Gral, perciò il vecchio Re Titurel è morto e Gurnemanz è molto invecchiato. Kundry è ritornata per servire ancora; ed ecco giungere un cavaliere chiuso in armatura bruna. Levatosi l'elmo, Gurnemanz lo riconosce, e riconosce la lancia sacra. Perciò il vegliardo lo cinge Re del Gral mentre Kundry gli lava i piedi. Intorno la primavera è un incanto di fiori in questo Venerdì Santo di redenzione; e Parsi/al compie il primo atto del suo regno battezzando Kundry. Quindi si avvia con Gurnemanz al tempio.
La scena cambia lentamente come nel 1° atto. - I Cavalieri sono convenuti per il funerale di Titurel, allorchè giunge Parsifal il quale col tocco della sacra lancia sana la ferita di Amfortas. Indi compie il rito dello scoprimento della coppa santa che si illumina, mentre dall'alto una colomba cala posandosi su l'elmo di Parsifal, e Kundry, redenta, cade estinta.
Anche questa volta Riccardo Wagner, traendo gli elementi da diversi poemi medievali, trasformandoli e rinnovandoli con sentimento moderno, ha composto un poema di alto soffio lirico e drammatico. Il suo polifonismo strumentale si espande in quest'opera in un'onda mistica di nobilissima purezza. Questo carattere fondamentale del Parsifal si afferma subito nel vasto preludio, domina quasi interamente il 1° atto, e totalmente il 3°. E nel preludio ci si presentano subito i grund-motiv dell'opera: quello etereo dell' «agape d'amore», con cui il preludio stesso si inizia, e che i cori nel tempio riprenderanno e svolgeranno su le parole «Il mio corpo sia pane, il mio sangue sia vino per nostro amore!», quello della «fede», enunciato affermativamente dalle trombe, e quello quasi incorporeo del «Gral». Alternati ad ampi arpeggi che sembrano salire dalla sfera terrestre al cielo e perdersi nell'infinito, questi motivi con la loro religiosità creano subito lo stato d'animo che ambienta inequivocabilmente il dramma in una atmosfera di incantamento mistico.
In questa atmosfera mistica i personaggi si muovono aggiungendo alla trama sinfonica la vita dei loro temi personali. Diciamo subito che il maggior peso dell'opera è Gurnemanz per la prolissità e anche talvolta la pedanteria dei suoi discorsi. Naturalmente ciò non toglie che il suo canto sia nobilissimo, ma la sua calma bontà, i suoi austeri rimbrotti e la lunghezza delle narrazioni rendono la sua figura artisticamente uniforme e relativamente greve.
Amfortas è tutto uno spasimo di dolore mortale nei suoi lamenti e nei temi orchestrali che ne accompagnano la presenza e i discorsi. E poiché anch'egli è piuttosto verboso, finisce per recare un'altra nota di uniformità e di prolissità.
Più vario e vivo è Parsifal. Il suo tema enèrgicamente ritmato che i corni squillano al suo apparire, le sue prime risposte fiere ed ingenue, gli scatti impetuosi, le sùbite pietà, l'inconscia intrepidezza, l'amore per la madre e il dolore profondo per averne causata la morte, sono tutti elementi che la musica raccoglie e coi quali traccia attorno al giovinetto un alone di eroica e innocente baldanza che a tratti non può non ricordarci Sigfrido. Le pagine musicalmente più dense ed efficaci nei riguardi del protagonista sono quelle del duetto con Kundry al 2° atto, dal momento in cui il ricordo della madre e il bacio di Kundry risvegliano in lui la coscienza, e ne determinano la reazione vittoriosa. Nell'ultimo atto Parsifal è già consapevole della sua alta missione, ha accenti regali e divini da personaggio trasumanato.
Kundry, dal lato psicologico come da quello musicale, è la figura più complessa. Il tema col quale il musicista ce la presenta è un rapido guizzo serpentino, un brivido demoniaco. Ma la sua duplice natura di fedele ancella del Gral e di seduttrice lussuriosa, di Maddalena e di Circe ad un tempo, quel suo desiderio di redenzione che si alterna alle brame di voluttà, quel misto di umiltà cristiana e di erotismo pagano, la luce di magìa che la circuisce per opera di Klingsor e la soggioga e quella di umiltà e di pietà che la purifica e trasfigura allorchè serve al Gral, fanno di lei una creatura nuova e strana. La varietà e la ricchezza di questi elementi hanno offerto al compositore la possibilità di creare uno dei personaggi più plasticamente rilevati, più affascinanti e più profondi del teatro wagneriano. La scena di seduzione del 2° atto, così impregnata di aromi armonici e cromatici tristaneggianti, pieni di sensualità, che segue alla molle e fiabesca scena di seduzione delle fanciulle-fìori, è riuscita, anche per il contrasto drammatico con la pietà, il risveglio della coscienza e la reazione sacra ed eroica di Parsifal, la più potente dell'opera.
Klingsor è figura bieca e violenta che ricorda per certi atteggiamenti musicali sinistri o tempestosi Ortruda ed Hagen. Ma il colorito magico e la luce fosca che da lui emanano, si diffondono su tutto il 2° atto, rischiarandosi solo di un chiarore delicatamente favoloso di floridi motivi da poema cavalieresco nella scena delle fanciulle-fiori.
L'elemento più altamente religioso è concentrato nei cori che si svolgono su ritmi energici mentre i Cavalieri entrano e si dispongono nel tempio, e soprattutto nei cantici che discendono dalle voci giovanili disposte a varie altezze nella cupola centrale, ora in dense polifonie, ora in aeree monodie spirituali.
L'orchestra concorre pure potentemente a creare questo elevato fervore sacro nelle vigorose sintesi affidatele, sia nel citato preludio del 1° atto, sia nei due viaggi di Parsifal e Gurnemanz verso il tempio del Gral, e principalmente nel vasto episodio che va sotto il nome di «Incantesimo del Venerdì Santo». Nei due viaggi i motivi fondamentali si svolgono con solennità sopra uno sfondo sonoro di campane, che sembra ampliare smisuratamente la scena e tradurre materialmente l'espressione di Gurnemanz «Il tempo qui diventa spazio!».
Quanto all'«Incantesimo del Venerdì Santo», esso si sviluppa dopo la già serafica scena della consacrazione di Parsifal a Re e del battesimo di Kundry. Un motivo cantabile, largo, fluisce dalla voce pastorale dell'oboe su un lieve ondulare degli archi in sordina simile a un sospiro del vento tra le piante; raccolto dal clarinetto, passa poi ai violini, ritorna all'oboe, si alza di intensità, acquista volume e calore, e schiude al cuore una visione sonora di pace estatica, di celestiale felicità piena di religioso incanto. Il brano sinfonico è così perfetto in sè, di una tale tersa purezza di linee, di una luminosità così piena e dolce che le voci dei cantanti appaiono superflue. Questa è la ragione per cui viene spesso staccato ed eseguito nei concerti per la sola orchestra senza che nulla svapori della sua eterea bellezza.
GIULIO MASSENET (Montaud [St. Etienne] 1842 - Parigi 1912). - MANON: opera in 4 atti e 6 quadri. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 17 gennaio 1884. Libretto di Enrico Meilhac e Filippo Gille, dal romanzo «Histoire du chevalier Des-Grieux et de Manon Lescaut» dell'Abate Antonio Francesco Prévost.
Atto 1° - Cortile d'un'osteria ad Amiens. - Con la vettura di posta giunge Manon Lescaut, che per il suo amore del lusso e per la sua civetteria i genitori destinano a un convento, È ad attenderla il cugino sergente, il quale la lascia poi sola qualche momento. Durante l'assenza di Lescaut la vede il vecchio banchiere libertino Guillot de Morfontaine, che le propone di fuggire con lui. Giunge poco dopo lo studente cavaliere Renato Des Grieux. Nei due giovani s'accende fulmineo l'amore e, approfittando della carrozza inviata da Guillot, essi fuggono insieme a Parigi.
Atto 2° - Stanza in casa di Des Grieux a Parigi. - Des Grieux scrive al padre chiedendogli di poter sposare Manon; ma il vecchio Conte ha già disposto di rapire il figlio. Infatti, il cugino Lescaut, che ha scoperto il rifugio dei due amanti, giunge accompagnato da tale De Brétigny, innamorato di Manon; e mentre Lescaut parla con Des Grieux, Brétigny informa Manon del prossimo ratto del giovane, e le offre il proprio amore e le proprie ricchezze. Il fascino dell'oro abbaglia Manon, Essa si commuove innanzi al piccolo desco che sarà distrutto ascolta estatica il sogno d'amore che le espone Des Grieux, ma finisce per lasciarlo rapire.
Atto 3° - Quadro 1° - Il Corso della Regina a Parigi. - È giorno di festa popolare. Guillot fa portare il ballo dell'Opera su la via innanzi a Manon, avendo saputo che questo suo desiderio le era stato negato da Brétigny. E ancora una volta la ricchezza ha facile vittoria su di lei. Però essa è triste poichè udì dalla bocca stessa del Conte Des Grieux che suo figlio si è fatto Abate a San Sulpizio.
[Questo quadro è generalmente saltato].
Quadro 2° - Il parlatorio del Seminario di San Sulpizio. - Des Grieux ha avuto un grande successo oratorio; il padre ne è contentar lo consiglia però ancora a riflettere prima di legarsi con voti definitivi alla vita ecclesiastica. Ma Des Grieux è risoluto; egli spera cosi di dimenticare Manon. Quando però Manon sopraggiunge, e con appassionata seduzione risveglia alla sua memoria i ricordi del loro amore, non resiste e fugge con lei.
Atto 4° - Quadro 1° - U hotel di Transilvanici: grande salone da giuoco. - Des Grieux, ridotto alla miseria dalla passione di Manon per il lusso, mene da lei convinto a tentare il gioco, Guillot, che vuol vendicarsi per l'abbandono di Manon, invita Des Grieux a giocare, lo lascia vincere, ma poi, accusandolo di aver barato con la complicità di Manon, li fa arrestare entrambi. U intervento del padre salva però Des Grieux.
[Omettendo il 1° quadro del 3° atto, il presente quadro viene eseguito come 2° dell'atto 3° e il successivo forma da solo l'atto 4°].
Quadro 2° - La strada d'Havre. - Lescaut ha tentato di far evadere Manon dal carcere, ma non vi è riuscito. Corrompe allora una sentinella della scorta affinchè lasci uscire dalle file Manon. Ma la giovane, esausta ormai dalla fatica e dai patimenti, muore fra le broccia di Des Grieux.
Questa Manon è opera di una finezza e di un'eleganza di stile eccezionali. All'abbondanza ed espressività della melodia vanno congiunte un'armonizzazione che senza ricercatezze sa ottenere enetti di signorile buon gusto, e una strumentazione delicatamente cesellata e ricca di colore. A questi pregi generali ne vanno aggiunti altri specifici, quali la felice caratterizzazione dei personaggi e la pittura ambientale suggestiva. Tutto ciò è dominato da un vigile senso dell'Equilibrio, da un'armoniosa chiarezza costruttiva e da una raffinata sensibilità poetica.
Quel misto di amore sincero per Des Grieux e di passione indomabile per il lusso, che forma il fondo drammatico dell'anima di Manon, è espresso dal musicista con sincerità di accenti e con intimità psicologica acuta in ogni sfumatura. Il racconto del viaggio rivela già la pronta emotività di Manon e la sua facile accessibilità al piacere. Ma poco dopo, alla vista delle ingemmate cocotes, la sua avidità di ricchezza e di lusso scoppia irrefrenabile, anche se la coscienza della sua impotenza contro il destino la fa singhiozzare triste e rassegnata «Or via, Manon, non più chimere». Il fascino amoroso di Des Grieux la vince poi prontamente, ma è, malgrado la delicatezza sincera e intensa di un sentimento nuovo, ancora e soprattutto l'aspirazione prepotente a una vita di piacere sensuale che la fa fuggire con lui.
Tutte queste oscillazioni, questi scatti, queste ansietà e questi turbamenti del suo spirito, anche se non li apprendessimo dal testo, ce li dice in modo penetrante la musica di Massenet. Il turbamento di Manon è ancora evidente nei motivi agitati che accompagnano il suo dialogo con Brétigny durante il quartetto del 2° atto, e nel successivo monologo «Ebben, lo degg'io». Ma nell' «Addio» al «piccol desco» la sincerità del suo amore per Des Grieux amora di nuovo con nostalgica tenerezza; tenerezza che è simile a un pianto silenzioso, così intimo che anche l'orchestra quasi si tace.
La spensierata giovinezza ha poi in lei due altri momenti di espansiva liberazione. Uno è lo spigliato canto «Cammino per tutti i sentier» e le seguenti strofette «Obbediam del core alla voce», così piene di grazia fresca e lieve, quasi settecentesca, e che purtroppo nessuno conosce perchè sono nel 1° quadro del 3° atto che viene saltato. L' altro è la canzone «Il tintinnar dell'or», brillante e scettica, ma un po' banale; le manca soprattutto quell'espressione febbrile dell'ardore di godimento che è invece nelle parole di Manon.
Ma è nella scena di seduzione al monastero di San Sulpizio che l'amore di Manon per Des Grieux si manifesta col più voluttuoso affanno dei sensi nel continuo vacillare del ritmo, nelle continue mutazioni del tempo, del movimento, del tono, e nel languore bruciante delle frasi, specialmente in quella conclusiva: «La tua non è la mano che mi tocca!».
Nell'ultimo atto invece l'amore sensuale sembra affondare in un languore di morte, con un senso di spossatezza profonda; mentre alla voce appassionata di Dex Grieux che tenta di richiamare Manon alla vita, essa risponde con la frase «Sento una pura fiamma che fuga il dolor e rinnovella il cor», in cui passa una luce nuova di trasfigurazione, e che la voce vaga del clarinetto rende anche più eterea. Ma il distacco del suo cuore dal mondo non è così grande che essa, già prossima a morte, con un supremo tratto di femminile civetteria, non ravvisi nel tremolio di una stella il fulgore di una gemma.
Des Grieux è musicalmente meno complesso e profondo. La sua presentazione su un motivo che si collega al pensiero del padre (e ritorna infatti all'inizio del 2° atto mentre Des Grieux scrive al padre) è affettuosa e nulla più. È un motivo che subisce varianti e si anima coll'animarsi dei pensieri. Ma come Des Grieux vede Manon, l'agitazione cambia carattere e cede il posto a melodie ricche di tenerezza, di calore, di fascino, fino all'insinuante «A Parigi n'andrem». Da questa scena il personaggio di Des Grieux è musicalmente immerso in un rapimento di passione che lo domina, sensi ed anima, e che culmina nel poetico «sogno» del 2° atto. Un canto dolce, sereno, si stende su un vaghissimo ondeggiare di violini in sordina creando uno stato di estasi trasognata piena d'incanto. «Una follia!», sospira affascinata e pure incredula Manon.
La lettura della lettera è pure imbevuta di questa tenerezza poetica, di questo vivere beato fuor della vita, in un mondo chimerico di felicità. Ma anche tradito, l'amore di Des Grieux per Manon è tutt'altro che vinto. Lo sentiamo negli accenti quasi disperati dell'invocazione: «Ah! ten va, o vision». Il severo «Magnificat» che la incornicia rende per contrasto anche più sensibile questa malsicura fermezza del cuore, che la successiva seduzione di Manon fa crollare con relativa facilità. La passione, una volta ripresolo, non lo abbandona più, anzi si arroventa, lo soggioga internamente, e si espande nella ripetuta ardente esclamazione: «Manon, sfìnge fatal» nella scena del giuoco, nei desolati monologhi dell'ultimo atto e nelle frasi piene di trasporto dell'estremo dialogo con l'amante morente.
Delle altre figure del dramma, Brétigny è appena debolmente tratteggiato; più viva l'orgogliosa e maligna figura di Guillot con le sue senili velleità amorose. Lescaut è dipinto a tratti un po' rudi e grossolani, come si conviene ad un soldato bravaccio, non molto scrupoloso e giocatore, ma con bonarietà. Nobile e austera è per contro la figura del vecchio Conte Des Grieux, nel canto sempre dignitoso, largo; con una vena di paterna affettuosità allorchè raccomanda: «La man puoi dare a onesta figlia», più severo nello sdegnato «Sì, son qui per strapparti all'infamia!».
Tutto è a posto, tutto è ispirato, e tutto è squisitamente fine e signorile in quest'opera di uno dei più sensibili e raffinati musicisti di Francia.
MODESTO MUSSORGSKI - KOVÀNCINA: dramma musicale popolare in 5 atti. Prima rappresentazione postuma al Teatro Maria di Pietroburgo nel febbraio 1886, nella revisione e strumentazione di Nicola Rimski-Korsakow. Il primo disegno del dramma è di Vladimiro Basilievich Stass.ow, ma fu profondamente modificato da Mussorgski medesimo. L'azione si svolge nell'anno 1682. - Kovàncina è la parola che si dice usasse in tono dispregiativo lo Czar Pietro il Grande allorchè gli fu riferita la congiura ordita contro di lui dai Principi Kovansky.
Atto 1° - La piazza rossa di Mosca. - È l'alba. Alcuni Strielzi (guardie) si vantano di atrocità da loro commesse nella notte. Poscia il Boiardo Sciakloviti dètta a uno Scrivano un denunzia contro il Principe Ivan Kovansky, capo degli Strielzi, e suo figlio Andrea, accusandoli di complotto contro lo Czar Pietro il Grande. Ivan mene quindi nella piazza e incita il popolo a combattere contro lo Czar e i Boiardi. Rimasta vuota la piazza vi giunge la giovane Emma, inseguita dal principe Andrea, il quale ha perseguitato, ucciso od esiliato i suoi parenti per possederla. Ma in aiuto di lei interviene una giovane vedova. Mar fa, che fu anch'essa amata e poi abbandonata da Andrea. Sopraggiunge anche Ivan, il quale pure invaghito della bellezza di Emma ordina agli Strielzi di arrestarla, ma Andrea piuttosto che cederla al padre tenta di ucciderla. Interviene allora Dositeo, capo della setta dei «Vecchi Credenti», il quale affida Emma a Marfa affinchè la conduca al sicuro, ed alza la voce contro la corruzione dei costumi invocando l'aiuto divino.
Atto 2° - Gabinetto in casa del Principe Basilio Golizin. - È sera. Golizin sta scorrendo una lettera della Zarevna, che fama, allorchè giunge Mar fa. Questa, dopo aver compiuto scongiuri magici, profetizza a Golizin l'esilio, la prigione e la perdita degli averi. Quando Mar fa esce, egli dà ordine che sia affogata nelle paludi. Poscia, mentre Ivan e Golizin si accusano reciprocamente di soperchierie, e Dositeo cerca di porre fine alla disputa, ritorna precipitosa Marfa raccontando che la si voleva affogare e chiedendo grazia. Giunge pure il Boiardo Sciakloviti il quale avverte Ivan che una denunzia è affissa contro i Kovansky, e che lo Czar ha ordinato di vigilare intomo ad ogni loro atto.
Atto 3° - L'oltremoscova: il sobborgo degli Strielzi. - È mezzogiorno. Marfa, seduta davanti alla porta della casa di Andrea, canta una malinconica canzone d'amore. La vecchia settaria Susanno, che l'ascoltata, l'accusa di empietà a Dositeo, che però la difende. Poco appresso, mentre il Boiardo Sciakloviti dispera della salverà della patria, e gli Strielzi ubbriachi si bisticciano con le loro donne, irrompe trafelato lo Scrìvano il quale narra la disfatta degli Strelzi a Bielgorod per opera dei soldati dello Czar. Gli Strielzi invocano Ivan affinchè li conduca a combattere, ma questi annuncia loro che ogni speranza di vittoria è svanita.

Figura 11: Scena di Grandi per il Sansone e Dalila di Saint-Saëns.

Figura 12: Scena di Zampini per il Mefistofele di Boito.
Atto 4° - Quadro 1° - Ricca sala da pranzo in casa del Prìncipe Kovansky. - Fanciulle e schiave persiane stanno rallegrando con canti e danze il pranzo di Ivan. Un servo di Golizin viene ad avvisarlo di un perìcolo imminente, ma egli non se ne cura; anzi avendolo il Boiardo Sciakloviti invitato a recarsi dalla Zarevna, egli si crede tornato in onore e si accinge ad uscire. Ma su la soglia un sicario l'uccide. Sciakloviti dà in una risata di trionfo.
Quadro 2° - La piazza davanti alla chiesa di S. Basilio a Mosca. - Golizin si reca in esilio salutato con rispetto dal popolo. Marfa annunzia a Dositeo che i soldati dello Czar hanno ordine di far strage dei Settori; Dositeo allora ordina di preparare dei roghi sui quali essi si getteranno prevenendo la strage. Andrea apprende da Marfa che Emma è con i seguaci dello Czar e sta per ricongiungersi al fidanzato. Essa gli annunzia pure la morte del padre, e lo trae con sé in salvo. Frattanto un araldo rende noto che lo Czar ha fatto grazia agli Strielzi.
Atto 5° - Un eremo nel bosco presso Mosca. - È notte di luna. Dositeo e i confratelli della setta dei «Vecchi Credenti» si preparano a morire sui roghi per non cadere nelle mani dei soldati dello Czar. Andrea è ancora fisso nell'idea di ritrovare Emma, ma al sopravvenire dei soldati dello Czar, Marfa lo trascina con sè nel rogo sul quale si gettano Dositeo e tutti i «Vecchi Credenti».
Come nel Boris, anche nella Kovàncina uno dei protagonisti principali è la folla: dal lato musicale certo il più importante di tutti. Da ciò la denominazione di «dramma popolare» dato da Mussorgski alla Kovàncina. Però la folla che nel Boris è prevalentemente statica, nella Kovàncina è attiva. Ora sono pennellate di color locale, come la canzone allegra «C'era una comare» o quella più rude «Oilà, prodi armigeri», rispettivamente dei Moscoviti e degli Strielzi, nel 1° atto, o le molli canzoni d'amore di un sapore arcaico e popolare che le fanciulle cantano per dilettare Kovansky; ora sono intrecci polifonici festosi di effetto grandioso, come quelli del popolo che inneggia ad Ivan Kovansky nel medesimo 1° atto. Talvolta è il cantico religioso dei Settari (2° e 3° atto), o quello così orientale nelle sue intonazioni e così vigoroso nel suo andamento ritmico e melodico degli Strielzi nel 3° atto: «Ah, lieto il cor avevam», o quello aspro ed iroso delle lor mogli: «Ah, maledetti beoni», e l'altro ancor più violento e turbinoso delle medesime contro i loro mariti: «Morte agli empi!», che si alterna con le invocazioni degli Strielzi alla Pietà formando un drammaticissimo contrasto. Poi nel 5° atto ci sono i cori mistici dei Settari che s'avviano al rogo, di cui l'ultimo: «Dio della gloria», d'intonazione sacra trionfale, è stato composto da Rimski-Korsakow su gli appunti lasciati da Mussorgski, poichè l'opera, per la sopravvenuta morte del compositore, era rimasta interrotta a questo punto. Più attivo è l'intervento del coro nei dialoghi degli Strielzi con lo scrivano, e in quello successivo con Ivan Kovansky, che si chiude con una preghiera; e nei commenti del popolo all'arrivo dei soldati dello Czar, nel 2° quadro del 4° atto.
Questi movimenti di masse nelle loro varie manifestazioni costituiscono un quadro pieno di vita realistica che proietta luci e colori intensi sul dramma dei personaggi vivificandolo. Molti di questi cori sono originati da spunti di canzoni popolari abilmente sfruttate dal musicista, e sono la parte più vigorosa dell'opera. Completano questo quadro movimentato di masse le danze persiane nel 1° quadro del 4° atto, calde pennellate di colore orientale; la prima ricca di languore sensuale, e la seconda di un'ebbra vivacità.
Accanto alla folla emerge la figura ieratica di Dositeo, tratteggiata in ogni suo canto, in ogni recitativo, con solenne spiritualità. Essa riceve, naturalmente, il maggior rilievo musicale nell'ultimo atto, dominato da una passione religiosa che giunge al fanatismo suicida, senza enfasi, ma con austera grandezza.
In Marfa questo fanatismo religioso si sposa stranamente a un amore sensuale per il principe Andrea e si circonda di un'aureola profetica e magica. Insinuante e maliardo insieme è il suo canto «Ah, tal fede, mio principe, serbavi a me!» con un senso di calma che non si muta neppure dopo che Andrea ha tentato di ucciderla, e che diventa estasi sovrannaturale nella frase: «Vede il dolente mio cuore il destino». Ma nel 2° atto la profezia dell'esilio a Golizin è nella prima parte (evocazione) di un'espressione cupa e misteriosa che ci tuffa in una favolosa magìa, mentre la seconda parte (profezia) si svolge su un canto spiegato pieno di una calma fatale impressionante. Ariosa e quasi .procace è invece la canzone d'amore «Ha percorsi la giovane tutti i prati», che Marfa canta all'inizio del 3° atto, non senza una certa intonazione mistica che sarà posta in valore nel successivo duetto tra Marfa e Dositeo; mentre oscillante fra gli accenti drammatici e quelli mistici è il contrasto successivo tra Marfa e la fanatica Susanna. Ma nel duetto tra Marfa e Dositeo ecco un altro canto in cui il tormento amoroso lotta con un sentimento religioso di purificazione. Intinto di espressione profetica e fatale è ancora il canto di Marfa nel duetto con Andrea nel 2° quadro del 4° atto; e di nuovo, con accenti che fondono insieme passione terrestre e celeste, amore e morte, in un rapimento esaltato, essa parla ad Andrea nell'ultima scena dell'opera prima di trarlo sul rogo. Marfa non è capace di una rinuncia, non pensa a salvare Andrea, non desidera che le sopravviva: ma vuol morire con lui in un supremo abbraccio tra le fiamme purificatrici, fino all'ultimo sensuale e mistica.
Di questi contrasti psicologici fortemente drammatici vive il personaggio di Marfa; il più complesso dell'opera e forse il più complesso fra quanti abbia espressi la musica di Mussorgski Noi occidentali e meridionali potremmo soltanto lamentare che queste melodie siano formate spesso da brevi temi insistentemente ripetuti, senza sviluppo. Avvezzi all'ampiezza di respiro, ad esempio, delle melodie belliniane, noi sentiamo necessariamente in queste melodie mussorgskiane una certa angustia di fantasia, ma bisogna pure pensare che tutti i canti popolari russi (ed è la vena popolare che alimenta le opere nazionali russe) sono costruiti in questa maniera che è tipica dell'oriente. Modificarne la struttura vorrebbe dire perdere le caratteristiche e i colori primitivi principali dell'arte nazionale russa, falsarne l'essenza. Mussorgski e l'orchestratore Rimski-Korsakow hanno forse avvertita la monotonia che da queste ripetizioni poteva nascere, ed hanno provveduto a variarne ogni ripresa col mutarne l'armonizzazione, i disegni contrappuntistici e lo strumentale.
I personaggi di Ivan e Andrea Kovansky, di Golizin e del boiardo Sciakloviti hanno un minore rilievo. Sciakloviti acquista una vera personalità soprattutto nel grande lamento del 3° atto, di così sconsolata espressione. Di espressione piuttosto generica sono anche i recitativi, accompagnati troppo spesso all'unisono dagli archi. Le scene amorose presentano pure uno scarso interesse. Non così invece i tratti gustosamente umoristici nella prima scena dell'opera, dove due Strielzi ridono di un loro commilitone addormentato, e in tutta la parte del pavido scrivano.
Il preludio dell'opera è una pagina assai nota per le esecuzioni che se ne fanno in concerti. Essa si impernia su un tema che ambienta subito l'ascoltatore nell'atmosfera religiosa che domina il dramma, mentre efficacemente descrive, secondo l'indicazione del compositore medesimo, I'«alba su la Moscova», alba tranquilla, senza tragici presentimenti. Il tema, stupendamente orchestrato da Rimski-Korsakow, non presenta sviluppi, ma, com'è consuetudine di Mussorgski, ad ogni apparizione ci si offre in una veste diversa. È un tema che anche Borodine ha sfruttato nel preludio «Al Convento». Esso ha una certa affinità con la stupenda marcia funebre che accompagna la partenza di Golizin per l'esilio.
Anche il preludio del 5° atto ha un carattere tra il descrittivo e l'impressionistico, carattere che l'autore ha indicato espressamente con questa frase: «Mormorìo di una pineta al chiaro di luna, crescente e decrescente come le onde su gli scogli». È un mormorio dolce che accompagna la meditazione di Dositeo prima dell'annunzio ai fedeli del prossimo necessario sacrificio; meditazione che fluisce calma e imbevuta ormai della luce dell'ai di là di cui la luce lunare sembra lo specchio.
GIUSEPPE VERDI - OTELLO: dramma lirico in 4 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 5 febbraio 1887. Libretto di Arrigo Boito dalla tragedia di Shakespeare.
Atto 1° - L'esterno del castello a Cipro: nel fondo gli spaldi e il mare. - È sera; infuria un uragano. Durante il difficile approdo della nave che conduce Otello, generale moro al servizio della Repubblica di Venezia e vincitore dei Turchia, l'alfiere Jago confessa all'amico Roderigo il suo odio per il condottiero. Egli non sa perdonargli di aver dato a Cassio il grado di capitano che ambiva per sé. Perciò, sapendo che Roderigo ama la giovane sposa di Otello, Desdemona, gli promette il suo aiuto per trarre alla rovina Otello. Mentre si festeggia con fuochi e canti la vittoria, Jago fa bere Cassio. Ubbriacatolo provoca una rissa nella quale Cassio ferisce il capitano Montano. Otello al clamore della contesa interviene, e udito il racconto di Jago, destituisce Cassio dal grado di capitano e fa sgombrare il luogo. Anche Desdemona è uscita, e nella notte già alta l'amore dei due sposi si effonde in un'onda di dolci ricordi.
Atto 2° - Sala terrena nel castello. - Jago spinge Cassio in giardino a parlare con Desdemona affinchè interceda presso Otello e lo, ritorni in grazia. Sopravvenuto Otello, Jago si mostra accorato, e alle domande del moro risponde con vaghi sospetti e frasi ambigue svegliando in lui la gelosia e incitandolo a vigilare. Desdemona viene poi a chiedere la grazia per Cassio, ma Otello svia il discorso accusando ardore alle tempie. Desdemona vuol fasciargli la fronte con un fazzoletto, che Otello adirato getta al suolo. Raccolto da Emilia, ancella di Desdemona e sposa di Jago, questi glielo strappa di mano. Uscite le donne, Otello chiede a Jago la prova della colpevolezza di Desdemona, e Jago prima gli narra un sonniloquio di Cassio, poi gli dice di aver visto nelle sue mani un fazzoletto che, alla descrizione, Otello riconosce per quello ch'egli donò un giorno a Desdemona come primo pegno d'amore. Ormai convinto da tali prove del tradimento della sposa, Otello giura di vendicarsi, e Jago pure giura di aiutarlo a tale scopo.
Atto 3° - Gran sala nel castello, - Jago prepara Otello ad assistere, nascosto, a un suo colloquio con Cassio in cui potrà vedere il fazzoletto. Desdemona torna a parlare di Cassia a Otello, e ciò esaspera la gelosia del moro che insulta e scaccia la moglie. Poco dopo l'innocente Cassio mostra a Jago il fazzoletto che dice d'aver trovato in casa propria. Otello non ode le parole, ma riconosce il fazzoletto e, uscito Cassia, informa Jago della decisione di uccidere Desdemona. Jago penserà a Cassio. Frattanto giunge un'ambasceria veneta, la quale reca a Otello l'ordine di ritornare a Venezia lasciando il governo dell'Isola a Cassio. Durante il ricevimento Otello interpreta alcune frasi di Desdemona all'ambasciatore Ludovico come confessioni della sua colpa, e furente l'atterra. Alle smanie di Otello i presenti fuggono inorriditi e Otello sviene mentre Jago pregusta il trionfo del suo malvagio inganno,
Atto 4° - Camera da letto di Desdemona. - Desdemona, invano confortata da Emilia, è angosciata da tristi presentimenti. Licenziata Emilia, prega e si corica. Da una porta segreta entra Otello, il quale contempla la sposa addormentata e la bacia. Desdemona si sveglia. Otello allora la invita a chiedere perdono a Dio prima di morire, l'accusa di essere la druda di Cassio e la soffoca. Intanto Emilia ritoma con la notizia che Cassio uccise Rodrigo; ma udendo gli ultimi gemiti di Desdemona morente, chiama aiuto. Rapide spiegazioni coi sopravvenuti rivelano l'inganno teso da Jago a Otello. Disperato per l'orrendo delitto compiuto, Otello si ferisce con una pugnalata, si trascina al letto di Desdemona, la bacia ancora e muore.
L'arte umana e shakespeariana di Verdi anelava a misurarsi col grande tragedo inglese. Un primo esperimento Verdi aveva già fatto musicando nel 1847 il MACBETH. Non ancora sicura la tecnica, soprattutto non ancora distaccata interamente dalle convenzioni melodrammatiche del tempo, tuttavia questa prova gli permise di misurare le proprie forze e di gettare tra le vecchie forme dell'opera ottocentesca alcuni germi nuovi che non andarono perduti. La novità riguardava specialmente l'approfondimento psicologico dello stile recitativo-arioso, del canto drammatico, che uscì già stupendamente scolpito e illuminato dall'orchestra nel monologo: «Mi si affaccia un pugnal». Ma non questa solo è la pagina nuova e potente dell'opera, e Verdi è così convinto che Shakespeare e lui si intenderanno, e che Macbeth è degno di vivere, che nel 1865, con maturità e sapienza accresciute (ci son stati di mezzo la trilogia romantica Rigoletto-Trovatore-Traviata, il Ballo in maschera e La Forza del Destino), lo riprende e lo porta a maggior perfezione. Cosicchè l'opera appare ancor oggi ricca di pagine di una grande potenza: l'urlo corale e orchestrale terrificante alla scoperta dell'assassinio di Re Duncano; il duetto «Fatal mia donna un murmure», dove si respira l'atmosfera soffocante del delitto e della paura; l'aria di Lady Macbeth «La luce langue», così balenante d'impeto orgoglioso; le fantastiche danze delle streghe e degli spiriti; la scena delle apparizioni dei Re, dal motivo di una concezione prewagneriana; la scena del sonnambulismo piena di tragico stupore e di ossessionante incubo; la «battaglia», impostata su un movimento energico e descrittivo di «fuga»; il dolente coro «Patria oppressa»; il gagliardo finale dall'impronta fra il barbarico e il biblico; e specialmente la scena dell'apparizione di Banco, piena di un raccapriccio pre-mussorgskiano.
Mancò allora a Verdi un librettista-poeta che fosse all'altezza del compito di ridurre la grande tragedia a poema musicale, e che potesse comprendere ciò che Verdi esigeva. Questo librettista-poeta il Maestro lo trovò nel 1880 in Arrigo Boito. Ne uscì allora, ancor più maturata l'esperienza musicale verdiana, ancor. più alata la fantasia creatrice, ancor più armata e decisa la volontà rinnovatrice, il capolavoro: OTELLO.
Con un urlo formidabile dell'orchestra, che esprime lo scatenarsi della bufera attorno alla nave di Otello, Verdi ci porta in piena tragedia e non ci lascia più fino all'ultima nota dell'opera. Vortici e cavalloni di note, sibili e gemiti del vento, cupi fragori, baleni e schianti improvvisi si seguono sotto le esclamazioni concitate, le grida e le preghiere della folla. Ma la nave entra in porto, e Otello sbarca dando l'annunzio della vittoria con quell' «Esultate» che è una delle espressioni più energiche e trionfali della musa verdiana, e che scolpisce mirabilmente il carattere eroico del protagonista. E mentre il popolo inneggia vibrante alla vittoria, o fantastica e scherza attorno ai fuochi di gioia, ecco Jago disporre i primi fili della sua trama.
Sotto le apparenze del buon compagnone la musica ci fa vedere la perfidia mefistofelica in agguato, il «brigante con la faccia dell'uomo giusto», come scriveva Verdi al pittore Morelli. Il suo canto è mellifluo, bonario, ma con flessioni di tanto in tanto bieche e con qualche trillo diabolico. Il carattere si delinea meglio nel brindisi veramente «spavaldo e strambo», dove, fra le pieghe di un canto rumorosamente gaio, si insinuano certe scale cromatiche discendenti che sembrano ventate d'inferno. Il canto si fa poi tortuosamente titubante allorchè, dopo la rissa, Jago espone ad Otello l'accaduto con l'aria più stupita e scandalizzata di questo mondo.
Conviene dir subito che è impossibile rendere a parole la finezza di questo recitativo verdiano ora quasi parlato, ora cantabile, ricco di modulazioni insinuanti e di ambigue incertezze, di frasi avventate e di pause reticenti eppure eloquenti: è tutto un gioco psicologico sottile in cui Verdi spiega un'arte perfetta e una drammaticità profonda.
La poesia di Boito tende a fare di questo personaggio un sosia del suo Mefistofele con qualche tratto enfatico; ma la musica di Verdi rettifica, contiene ogni esuberanza e dà al testo un'interpretazione tutta nervi e forza interiore. E tale questa figura si conserva sino alla fine, con qualche maggiore intensificazione espressiva nei dialoghi con Otello. È stato detto che una concessione al gusto mefistofelico e rettorico boitiano fosse il «Credo» di Jago. Anche in questo caso è da notare che in mano a tutt'altri questo «credo» satanico avrebbe realmente potuto costituire una deviazione dal buon gusto. Ma che cosa ne ha fatto Verdi? Gli squilli introduttivi da «dies irae», quel sobbollimento dei legni come se dall'anima del perfido alfiere pullulasse un putrido umore, quei motivi beffardi ed amari, la tetra meditazione su la morte e il nulla, l'aspra violenza con cui la voce di Jago si compiace di mettere a nudo l'orrendo suo cuore e quasi di ficcare cinicamente le mani nelle proprie piaghe spirituali, hanno una potenza rappresentativa che serve a giustificare l'infame condotta di questo criminale. E la rappresentazione non ha nulla di pletorico e di falso; essa è semplicemente terrificante.
La sottile malvagità di Jago si manifesta poi con altri aspetti nel racconto del sogno di Cassio, sussurrato, quasi sospirato, come una rivelazione misteriosa, dove orchestra e voce creano un senso di incubo incantesimale di una malìa soggiogante. Nella scena con Cassio al 3° atto Jago appare ancora nella veste del buontempone gioviale, che scherza e ride leggero intorno al fazzoletto ricamato che Cassio si è trovato in casa. E qui è un miracolo nuovo di ritmica vivace e di strumentale aereo creati dal genio del settantaquattrenne Bussetano, miracolo che apre le porte alle gaie comari falstaffìane.
Otello, natura balda e generosa, dopo l'esultante presentazione, riappare al momento del duello fra Cassio e Montano per mettere ordine con frasi piene di sdegnata energia. Ma, rimasto solo con Desdemona, i violoncelli preludiano e sostengono poi il canto amoroso di Otello con un calore dolce in cui sembra specchiarsi la serenità della notte, finalmente calma dopo tanta tempesta di nembi e d'uomini. Il duetto d'amore si svolge alternando i tratti fieri a quelli patetici, l'ebbrezza dell'anima e quella dei sensi in un'espressione affettiva alta e nobile, e pure tenerissima, tenuta in un tremore d'estasi purissima e senza il minimo accenno sentimentale. Ma dal 2° atto in poi, Otello è nelle spire del mostro, e invano lotta contro la forza che lo annienta. I «vigilate» che Jago gli soffia sottovoce nelle orecchie, sono pugnalate che gli straziano il cuore; ogni dubbio cade dentro di lui come una goccia di veleno mortale. D'ora in poi il canto d'Otello è una successione di ruggiti e di spasimi di strazio. Sul primo assalto di Jago cade la chiarità della «mattinata» dei popolani a Desdemona, e i loro canti molli sembrano rendere ancor più minacciosa l'ombra che s'addensa sul capo della giovane sposa innocente ed inconscia. Fra i gemiti desolati, i fremiti d'ira e gli urli di belva ferita, Otello sente che la fine dell'amore è il crollo della sua gloria, che egli rievoca con disperato orgoglio nel gagliardo «Ora e per sempre addio, sante memorie». Ma come crede d'aver raggiunte le prove della colpa di Desdemona, prorompe in un tremendo giuramento di vendetta, al quale Jago perfidamente si associa. Nei bassi striscia un motivo cupo mentre le parti acute danno in tremiti e in istrappi laceranti. La situazione scenica è un po' convenzionalmente melodrammatica, ma la musica è di una veemenza apocalittica.
La gelosia «è un'idra fosca», ha detto Jago; e questo motivo s'aggira sinistro nel preludio del 3° atto mentre appunto Jago sta per completare la sua opera infame. L'ironica galanteria con cui Otello accoglie Desdemona è l'ultimo sforzo per celare l'orrenda smania che lo divora; poi sarà il crollo: Desdemona insultata, atterrata; e infine la risoluzione delittuosa e lo svenimento mentre lontano, supremo scherno, le trombe inneggiano ancora alla sua vittoria militare. Ma il furore e il malore sono preceduti da un momento di collasso pauroso. Il crollo del suo amore gli sembra ancor più terribile di quello della gloria. Un motivo precipita giù cupo e greve a scatti, e gemiti affannosi si ripetono su di esso mentre Otello non canta più ma mormora con la voce rotta da tremenda angoscia: «Dio mi potevi scagliar tutti i mali della miseria!». Poi di nuovo il dolore si scioglie in melodioso appassionato rimpianto. Il canto drammatico di Verdi ha raggiunto in questo monologo la sua massima energia espressiva.
Nell'ultimo atto i contrabbassi con le sordine descrivono nel famoso «a solo» l'orrore tenebroso che occupa l'animo di Otello. La frase angosciosa si alterna con un motivo sordamente insistente che esprime l'idea del delitto che Otello sta per compiere; mentre il tema del bacio ci avverte del superstite amore che ancora trema nel fondo del suo cuore. Ma dopo la rapida scena del delitto (la musica è tutta impeto travolgente di ossessione paurosa e di raccapriccio), conosciuto l'errore, ecco di nuovo su le parole: «Niun mi tema», il senso della fine; gloria, amore, vita, tutto sprofonda nei solenni lugubri e pesanti accordi dell'orchestra. Indi un pianto, un lamento dolce e sconsolato che si chiude nuovamente col motivo del bacio, col motivo dell'amore immortale.
Che può fare l'innocente inconscia Desdemona presa in questa bufera infernale? Noi l'udiamo nel duetto del primo atto esalare in un canto melodioso il suo amore ben saldo e fidente. L'udiamo nelle ripetute richieste che rivolge a Otello per la grazia di Cassio esprimersi attraverso a disegni vocali e a colori orchestrali che sono di una purità angelica, come puro e angosciato è il suo pianto allorchè viene dapprima oltraggiata poscia atterrata dallo sposo ormai vittima della bieca suggestione di Jago. E infine cantare la sua tristezza sconfinata nella «canzone del Salce» ed elevare ancora a Dio l'ultima preghiera in una castità rassegnata di note serafiche dove nell'orazione vibra l'accento dell'olocausto.
ALFREDO CATALANI (Lucca 1854 - Milano 1893) - LORELEY: azione romantica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino il 16 febbraio 1890. Libretto di Carlo d'Ormeville e Angelo Zanardini. - L'azione ha luogo in riva al Reno nel 1300 circa.
Atto 1° - Quadro 1° - Scogliera in riva al Reno. - Walter, sire d'Oberwesel che dovrebbe sposare Anna di Rehberg, confessa all'amico barone Hermann di essersi innamorato di una semplice orfanella, Loreley, e chiede a lui consiglio. Hermann, che ama Anna,lo incita tuttavia a mantenere fede alla promessa fattale, Walter incontrandosi poco dopo con Loreley le svela il legame al quale deve obbedire, e fugge disperato. Loreley sviene; Hermann, vedendola, invoca dal dio del Reno che la induca a vendicarsi del tradimento di Walter, promettendo di lasciarsi trasformare in mostro nell'altra vita se sarà esaudito.
Quadro 2° - Sito alpestre in riva al Reno. - Loreley chiede al Dio del Reno di spegnere nel suo cuore l'amore e la pietà e di donarle bellezza e potere di fascino irresistibile. Il dio acconsente purchè essa gli giuri fede di sposa. Loreley accetta, si getta nelle acque, e ricompare sopra un alto scoglio trasfigurata. Ninfe del Reno e Spinti dell'aria si inchinano a lei come a Regina.
Atto 2° - Spianata innanzi al castello del Margravio Rudolfo di Biberich. Nel fondo il Reno, su la sponda opposta del quale si erge un alto scoglio. A sinistra una piccola chiesa. - Anna in abito da sposa finisce di abbigliarsi, e riceve gli omaggi della popolazione. Hermann osa parlarle ancora del suo amore, ed essendo respinto le dice che Walter non rama; ma Anna non gli crede. Giunge poscia il corteo nuziale, ma come Walter si accinge ad entrare con .Anna in chiesa, Loreley appare su lo scoglio, meravigliosamente seducente, e col canto affascina Walter che corre a lei fra I'orrore e la maledizione dei presenti.
Atto 3° - La spiaggia di Oberwesel. Da un lato lo scoglio di Loreley. - Anna è morta di dolore. Hermann si allontana col rimorso di averla uccisa. Walter pure, disperato, vorrebbe gettarsi nel Reno, ma le Ondine lo respingono. Appare poi Loreley alla quale Walter rammenta il passato amore. Ma essa gli dice che Loreley è morta; quella c'hegli vede non è che il suo fantasma. Pure i ricordi del suo amore per Walter la commuovono, ma la voce del Dio del Reno la richiama al giuramento, e Loreley ritorna al suo scoglio. Walter allora si getta nel Reno mentre Loreley dall'alto della roccia prosegue impassibile il suo canto fascinatore.
Catalani, natura di musicista romantico, entusiasta dell'arte wagneriana, si rivolge alle leggende nordiche delle quali lo attrae la misteriosa poesia ch'egli sa rendere con toni delicati di melodia e ricchezza di colore. Il wagnerismo si avverte soprattutto nel gusto degli impasti strumentali, ma egli ha saputo sfuggire al sistema del sinfonismo tematico. Infatti pochi, ampi e non destinati a sviluppi sinfonici, sono i motivi ritornanti, cosicchè non possono essere considerati alla stregua dei grund-motiv di Wagner, e non ne hanno la funzione. La sua melodia, d'altra parte, ha un disegno tutto personale, in cui le tinte malinconiche prevalgono, salvandolo nella maggior parte dei casi dall'imitazione di Wagner. Per questa sensibilità personale del sentimento umano e della poesia fantastica, oltre che per la squisita eleganza della forma, le sue opere maggiori, Loreley e Wally, resistono al tempo.
La passione amorosa di Walter trova accenti toccanti così nel duetto del 1° atto come in quello del 3°, e così pure nel racconto ch'egli fa ad Hermann del suo innamoramento: «Nel verde maggio». Un più fine e delicato canto, per quanto più wagnerianamente atteggiato, è quello di Walter nel 2° atto su le parole «Non t'angosciar se il riso tarda, o fanciulla, ad irradiarmi il viso», canto che Anna raccoglie e conclude con altrettanta finezza.
Loreley non si distingue gran che da Walter nelle espressioni di canto amorose, ma essa incomincia veramente a vivere nell'elemento fantastico, e in particolare nel canto di seduzione «Vieni al mio sen», così caldo e voluttuoso nella sua larga linea melodica. Ma nell'ultimo atto il fantasma quasi riprende corpo e subisce il fascino dell'antico amante che le canta la dolcissima melodia dei ricordi: «Deh, ti rammenta quel dì beato», fino a quando il Dio del Reno non la richiama.
Meno ben delineato, anche per difetto del libretto, è Hermann. Ma anch'egli trova un rilievo più plastico nell'espressione del fantastico; iI quale domina nelle scene finali dei tre atti con gli squilli dei corni e delle trombe, con i motivi guizzanti che caratterizzano il ricordo delle leggende del Reno, i cori supertiziosi del popolo, e le voci che personificano il Dio del Reno. Ma la scena più fantasiosa è quella dell'apparizione di Loreley alla fine del 2° atto, che si conclude con un vibrante quadro in cui tutto spira angoscia e terrore di follia, brivido morboso di voluttà e sinistro fascino malefico. La larghezza della linea, l'indovinato carattere misterioso e cupo delle frasi, la densità della polifonia, le tinte dell'orchestra che si direbbero intrise di porpora e di viola, creano un quadro di leggenda fortemente suggestivo, nuovo alla storia del teatro italiano.
Ma altre cose ancora meritano di essere segnalate per la loro bellezza, anche se si tratti di episodi non strettamente necessari al dramma. Sono, ad esempio, i vigorosi con del 2° atto: quello festoso del popolo: «Alteri ergete le auguste cime», dal ritmo così energico; quello pieno di movimento, anche orchestrale, all'arrivo del corteo nuziale; e l'Epitalamio, anch'esso marcato da una cellula ritmica imitante un giulivo scampanio, che si ripete alternandosi ad autentici squilli di campane, imprimendo alla composizione un'impronta di gioia sacra e robusta insieme, a cui le voci bianche dei fanciulli donano un particolare senso di purità, e che i tenori concludono nelle note acute con bellezza timbrica liricamente penetrante. Un'altra pagina solenne ed austera è la «Marcia funebre» per coro, soli e orchestra in cui Catalani ha saputo sottrarsi alle viete formule delle composizioni ottocentesche di questo genere. «Solenne» e «austera» sono parole che non dicono tutto il senso d'ombra tragica, di mistero e di elevazione che ne formano la maggiore bellezza.
Infine ci sono le danze, nelle quali Catalani ha mostrato un estro e uno spirito di un'eleganza insospettata in un musicista le cui caratteristiche principali sono la malinconia profonda e l'amore del fantastico; ma almeno una di queste danze, quella celebre delle Ondine nell'ultimo atto, rientra appunto nel fantastico. L'altra danza del 2° atto, il «Valzer dei fiori». è tutta irrorata da una molle dolcezza melodica, con tratti scherzosi e popolareschi di un gusto però assai raffinato. La «danza delle Ondine» comprende una prima parte mimica, e una seconda la quale, com'è annotato nella partitura, più che una danza vera e propria «sarà un succedersi di pose eleganti e voluttuosissime». Il movimento è quello di una mazurca lentissima, quasi una sarabanda, ma il suo pregio maggiore consiste, oltre che nell'espressione voluttuosa, nell'aerea leggerezza del disegno e dello strumentale che ne fanno una cosa di sogno.
PIETRO MASCAGNI (Livorno 1863 - Roma 1945) - CAVALLERIA RUSTICANA: melodramma in un atto. Prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio 1890. Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga.
Atto unico - La piazza di un paese di Sicilia, - È Pasqua. Prima che si alzi la tela si ode cantare una «Siciliana». È Turiddu che fa una mattinata a Lola, la bella giovane che Turiddu amava «prima d'andar soldato». Ma tornato, e trovatala sposa al carrettiere Alfio, si è messo a corteggiare Santuzza, l'ha sedotta, e le ha poi promesso di sposarla. Da ultimo però ha preso di nuovo a trescare con, Lola. Questo Santuzza racconta a Lucia, la madre di Turiddu. Incontratasi poi con Turiddu, Santuzza vorrebbe convincerlo ad abbandonare Lola, quando ecco la sposa di Alfio passa per recarsi alla messa, e vedendo Turiddu con Santuzza si lascia sfuggire parole beffarde alle quali Santuzza ribatte. Ma Lola finge di non udire e intonando uno stornello provocante s'avvia in chiesa. Invano Santuzza piange, implora, minaccia. Turiddu si svincola ed entra in chiesa dietro Lola. Santuzza allora, folle di gelosia, gli augura la mala Pasqua; e come vede Alfio gli denunzia i colpevoli. Alfio giura che si vendicherà.
Terminata la funzione, Turiddu offre da bere agli amici; porge un bicchiere anche ad Alfio, ma questi lo rifiuta con sdegno. Turiddu morde allora un orecchio ad Alfio: è questo il segno della sfida mortale, che Alfio accetta. Turiddu prende quindi commiato dalla madre raccomandandole Santuzza qualora egli non tornasse; e poichè la madre non comprende il suo strano linguaggio, si finge ebbro. Ma è da poco uscito che una donna accorre gridando: «Hanno ammazzato compare Turiddu».
L'impeto schietto della melodia, anche se qua e là esuberante ed enfatica, il calore intimo che la sorregge, l'ampiezza della frase, spiegano bene lo strepitoso fanatismo che Cavalleria destò al suo primo apparire. Il «verismo» del soggetto non trova però soverchie aderenze nella musica, la quale obbedisce ad un soffio lirico più libero ed alto, e trascende l'episodio drammatico, che passando dalla novella del Verga al libretto dell'opera si è ridotto a un puro fattaccio di cronaca. Ma la fresca vena mascagnana lo anima di una vita nuova, cosicchè l'opera d'arte è divenuta un'altra; ed è una vena profondamente originale, che conserva il suo fiato robusto, salvo poche soste, da un capo all'altro. Basterebbe il modo come l'opera si apre, a dire l'originalità della fantasia del compositore ventisettenne. È un semplice accordo, ma esso si forma a poco a poco a note alterne che si aggiungono l'una dopo l'altra in discesa, quasi meditando, come se la musica affiorasse da un regno di mistero, creando una specie di incanto che ci afferra subito e non ci lascia più: è la pace del giorno di Pasqua. E subito dopo il preludio, nel quale si addensano i principali motivi dell'opera, e in cui si incastra con originalissima trovata la «Siciliana», ecco, all'aprirsi del velario, lo scampanìo festoso della chiesa, un canto di gioia serena dei violini, il contraccanto pastorale di un violino solo con sordina sul giocoso motivo, anch'esso di gusto pastorale, dei nauti, con risposte echeggianti di oboi, e finalmente le voci e i canti primaverili del coro interno.
Ora questo senso di vita della natura, che non sa di archeologia (non c'è neppure un motivo tratto dal folklore siciliano) e che si scioglie con tale sincera freschezza e con tale bellezza di ispirazione, è una delle cose più alte dell'opera ed è una delle caratteristiche maggiori dell'arte di Pietro Mascagni. La Siciliana «O Lola ch'ai di latti la cammisa», ampia e calda melodia, non ha nulla delle canzoni popolari di Sicilia, nè lo hanno i canti campestri dell'introduzione, nè lo stornello toscanissimo «Fior di giaggiolo», nè il brindisi brillante e un po' balzano e spensierato di Turiddu: «Viva il vino spumeggiante». Ma tutti questi canti sono riscaldati da un calore, illuminati da uno splendore di luce ed ebbri di una molle sensualità, che senza essere più di questa che di quella regione, sono certamente meridionali e mediterranei. E non è di certo nè il modo di cantare dei pastori greci nè del popolo spagnolo, ma fa parte dell'antica e limpida tradizione ariosa e vocale italiana. E questo è un altro carattere fondamentale dell'arte mascagnana, più vocale che strumentale, più lirica che drammatica. Anzi diremo che in quest'opera, come poi nelle successive del Maestro livornese, la drammaticità fa piuttosto difetto.
Ebbero quindi torto, sotto questo aspetto, coloro che lo proclamarono continuatore di Verdi, il quale è principalmente tutto impeto tragico e pessimistica malinconia. Le pagine in cui sarebbe occorso un più forte senso drammatico sono in Cavalleria, le più deboli: come la scena in cui Santuzza svela a compar Alno il tradimento della moglie: troppo cantabile la denunzia di Santuzza: «Turiddu mi tolse l'onore», troppo rozza e goffa la risposta di Alfio: «Ad essi non perdono». Debole anche la scena della sfida, ed esageratamente rumorosa ed enfatica la perorazione finale dell'opera che richiama alla mente certi brutti finali di Ponchielli. Quest'enfasi rumorosa e vuota torna e tornerà poi quasi sempre anche nelle opere seguenti a sostituire e coprire l'assenza di vero sentimento drammatico. Macchiata di bolsa rozzezza, è anche l'entrata di Alfio: «Il cavallo scalpita», come un po' gonfio e poco religioso è il coro «Inneggiamo, il Signor non è morto», specialmente su la fine (ma perchè pregano in piazza quando c'è la messa in chiesa? I registi debbono salvare le apparenze con l'aggiunta di un'assurda processione!), e, a tratti, un poco pletorico è anche il duetto, pur così affocato di istinti, di lacrime e d'ire prepotenti, fra Turiddu e Santuzza, soprattutto nella chiusa.
Ma non è sempre così; ed ecco allora il racconto di Santuzza: «Voi lo sapete, o mamma», bruciante di dolore amaro e di passione; ed ecco in una forma nuova e intensa di emozione, l'addio di Turiddu alla madre, il cui recitativo, a frasi spezzate dall'intimo affanno, si svolge sull'inquieto e commosso movimento dei violini, per lasciar posto a poco a poco a un'espressione sempre più precisa che si concreta nel dolente canto: «Voi dovrete fare da madre a Santa». In questa pagina passa veramente un drammatico presentimento di morte che ha trovato la forma più libera e più spiritualmente vera.
Quanto al celebre «intermezzo» esso non è un brano sinfonico, ma la melodia ha il tipico largo respiro mascagnano, e una calda nobiltà di fraseggio esente da ogni sentimentalismo, che si espande in un'onda di canto e che risponde a un bisogno di pace serena. Melodie di questo tipo sono un'altra frequente e originale caratteristica dell'arte di Pietro Mascagni, e aggiungiamo pure che nessuno dei suoi contemporanei sapeva «cantare» con questo alto e largo fiato melodico.
Ma Cavalleria rusticana ha anche un'importanza storica. È stata una rivelazione folgorante: la rivelazione di una genialità spontanea che, senza opporsi a Verdi, senza chiedere la salvezza alle leggende o al sinfonismo nordico, riesce ad aprire una via nuova al melodramma italiano cercando nel popolo l'ispirazione, lontano dagli eroi piumati dell'Ottocento.
ALESSANDRO BORODINE (Pietroburgo 1834 - ivi 1887) - IL PRINCIPE IGOR: opera in un prologo e 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro .Maria a Pietroburgo il 4 novembre 1890. Libretto dello stesso Borodine, tratto dal medievale Canto sull'esercito di Igor. - L'azione ha luogo nell'anno 1185.
Prologo - Una piazza a Pontivle. - Il Principe Igor si accinge a muovere guerra ai Polovesi. Le acclamazioni del popolo sono interrotte da un eclisse di sole. Il popolo, terrorizzato dal sinistro presagio, vorrebbe che Igor non partisse. Anche la sposa Jaroslawna tenta di trattenerlo, ma egli l'affida al di lei fratello, il principe Galitzky, e parte. Due pavidi soldati, Skulà e Eroschka, gettano nascostamente le armi disertando.
Atto 1° - Quadro 1° - Corte in casa del principe Galitzky. - Mentre il cognato Igor è alla guerra, Galitzky vive fra orge e dissolutezze. Una fanciulla della corte è stata rapita per volontà sua, e invano le compagne ne implorano la liberazione. Approfittando della lunga assenza di Igor, del quale non si hanno notizie, Galitzky sparge intorno oro e favori per conquistarsi l'affetto di traditori e salire al trono. Fra coloro che gavazzano alle spalle di Galitzky sono i due disertori, divenuti menestrelli.
Quadro 2° - Una stanza nell'appartamento di Jaroslawna. - La principessa sospira il ritorno di Igor. Le ancelle vengono a raccontare a Jaroslawna il ratto della loro compagna, ma non osano dirle il nome del rapitore. D'improvviso entra Galitzky che confessa alla sorella di essere lui il rapitore. Alla minaccia di Jaroslawna di rivelare il fatto a Igor al suo ritorno, egli risponde irridendo alla sua fedeltà e incitandola a cercarsi un amante. A tale insulto Jaroslawna lo scaccia imponendogli di liberare la fanciulla. «Sta bene - risponde Galitzky -, ma ne prenderò una più bella». Entrano ora dei Bojardi, i quali recano la notizia che Igor, sconfitto, è stato fatto prigioniero insieme al figlio Vladimiro. Jaroslawna chiede aiuto ai Bojardi, i quali le giurano fedeltà e vanno a preparare la difesa mentre suonano le campane a martello e i bagliori degli incendi appiccati al villaggio dai nemici illuminano tetramente la scena.
Atto 2° - Il campo del Polovesi. - Le ancelle di Kontchakowna, figlia di Kontchak, uno dei due Khan Polovesi, dannano e cantano. Kontchakowna ama, riamata, Vladimiro. L'appassionato colloquio d'amore fra i due giovani è interrotto dal sopraggiungere del Principe Igor. Una grave tristezza pesa sul cuore del prigioniero, preoccupato per le sorti della patria e della sposa lontana. Un soldato polovese battezzato, Ovlur, gli offre di farlo fuggire, ma Igor rifiuta di compiere quest'atto sleale. Incontratosi con Kontchak, questi gli propone di lasciarlo libero, purchè divenga suo alleato. Igor rifiuta. Kontchak, ammirato, gli dice che si consideri d'ora in poi non suo prigioniero, ma suo ospite, e fa svolgere in suo onore dame e canti.
Atto 3° - Campo dei Polovesi. - Gsak, l'altro Khan, ritorna con prigionieri e bottino, accolto festosamente dai Polovesi e da Kontchak. Ovlur ha ubbriacato le guardie e preparata la fuga di Igor e del figlio. Igor, disperato per la grave disfatta subita, accetta di fuggire. Kontchakowna che lo ha saputo, trattiene Vladimiro e dà l'allarme. I Polovesi vorrebbero uccidere Vladimiro per vendicarsi della fuga del padre, ma Kontchak gli fa grazia e gli accorda di sposare la figlia.
[Questo 3° atto di solito non viene eseguito].
Atto 4° - Le mura e la piazza di Pontivle. - Jaroslawna piange la propria sorte e l'assenza dello sposo. Improvvisamente giunge Igor. Il suo ritorno mette in imbarazzo i due disertori, i quali non trovano di meglio che dare l'allarme con le campane. Essi annunziano al popolo e ai Bojardi accorsi il ritorno di Igor, e mutando prontamente il loro contegno se ne mostrano lieti. Tutti acclamano giubilanti il ritorno del Principe.
Rimasta incompiuta per la morte dell'autore, l'opera fu terminata da Nicola Rimsky-Korsakoff che istrumentò il Prologo, gli atti, 1°, 2° e 4°, e la Marcia-Polovese del 3° atto; e da Alessandro Glazunoff il quale ultimò e istrumentò, su gli appunti lasciati dall'autore, tutte le parti rimanenti del 3° atto. A Glazunoff è toccata una parte ingrata, poichè il 3° atto è il più statico e anche musicalmente il più uniforme e meno interessante. Ma egli si è poi rifatto con la sinfonia. Questa era già 'stata composta nella mente dell'autore, ma non scritta. Glazunoff, che l'aveva più volte sentita eseguire da lui al piano, la mise in penna e la strumentò. Essa è costruita con grande sapienza su alcuni fondamentali motivi dell'opera, ed è una delle più belle sinfonie di melodramma.
Ma non minori bellezze ci riserbano i quattro atti e il prologo. Innanzi tutto i cori: così numerosi che, pur non esercitando la folla un'azione decisiva nello svolgersi degli avvenimenti, essa viene ugualmente a trovarsi in primo piano. Ora questi cori potenti (di guerrieri, di popolo, di danzatori e danzatrici, di bojardi, di prigionieri) sono costruiti sopra motivi di canzoni popolari nazionali, ed esprimono, a seconda che sono cantati dagli uni o dagli altri dei suddetti gruppi, e a seconda del momento scenico, le più svariate emozioni: esultanza, imprecazione, preghiera, minaccia, ebbrezza, fierezza, malinconia, inni di glorificazione, umiltà e senso di grandezza.
Poi ci sono le danze: le danze che chiudono il 2° atto (a parte la breve e rapida danza al principio dell'atto), danze tutte a disegni di carattere orientale, o lievi o pesanti, arabescate o massicce, a espressioni languide e sensuali o balzanti e barbariche, anche di espressione più complessa per la sovrapposizione contrappuntistica di differenti motivi, ed anche infine turbinose, dai coloriti sgargianti, in cui è sensibile il pennello di quel grande orchestratore che fu Rimsky-Korsakoff. Sono queste le pagine più belle dell'opera.
Attraverso ai caratteristici melismi, ai cromatismi, agli arcaismi e alle intonazioni melodiche basate su scale differenti dalle nostre, conservano però questo sapore orientale anche altre pagine, come ad esempio la canzone con coro della fanciulla polovese all'inizio del 2° atto e la successiva invocazione alla notte di Kontchakowna, tanto ricche anch'esse di calda sensualità. E così pure il lamento di Jaroslawna al principio dell'atto 3°, che diffonde nell'aria un senso di intensa malinconia; e il canto dei contadini che attraversano la scena lentamente, anch'esso triste di quella caratteristica tristezza nostalgica di certe melodie popolari russe. Un coro questo che nulla ha a che fare con l'azione, ma che è stato opportunamente collocato qui per prolungare e accentuare la malinconia creata dall'effusione lirica di Jaroslawna. Ma mentre nel canto della polovese e in quello di Kontchakowna rivive il mondo orientale, nel canto di Jaroslawna palpita solamente il mondo russo, e più ancora un sentimento umano universale.
A proposito di questa malinconia, che tinge della propria poesia varie scene dell'opera, va ricordato il coro dei prigionieri nel 2° atto, che si svolge su un pedale di mi ribattuto per 43 battute e mette nell'animo un senso di freddo e di pena profondi. Ci sono poi altri canti che conservano il sapore della musica russa perchè legati a cellule melodiche e ritmiche del folklore nazionale. Tali, ad esempio, la canzone di Galitzky: «Se mi si trova degno» (atto 1°, quadro 1°), che ha la spensieratezza del beone gaudente e cinico. Pure legate al folklore russo sono le canzoni dei due disertori; canzoni che fanno di questi personaggi due tipi simpaticamente umoristici nella loro poltroneria: due figure di tutti i tempi e di tutti i luoghi.
È stato già osservato, ed è la verità, che esiste in quest'opera un conflitto fra le espressioni orientali e russe e quelle prettamente occidentali o quasi. Vi sono infatti pagine che potrebbero essere apparse in qualunque altra opera europea. Questo conflitto menoma l'unità di stile del Principe Igor, ma più gli nuoce il carattere episodico e frammentario del libretto, in cui i personaggi sono scarsamente approfonditi e non offrono al musicista materia per un approfondimento maggiore mediante il linguaggio sonoro. Tuttavia anche fra le pagine meno imbevute di color locale ve ne sono talune piene di un sottile fascino melodico. Così, nel prologo, il delicato addio fra Jaroslawna e Igor, teneramente accorato; l'imitazione del piagnisteo delle fanciulle che chiedono la liberazione della compagna rapita, sopra suggestivi disegni cromatici discendenti e accompagnamenti sincopati (atto 1°, quadro 1°); la cavatina di Vladimiro: «Ah vieni, rispondi al mio appel», così patetica nella melodia, e con quel lungo pedale del basso ostinato do-sol nella seconda parte (la-mi nella replica) che produce un senso di ansietà viva. Ci sono inoltre scene che si levano alte per la potenza della costruzione; citiamo il finale del 1° atto con quel disperato suono di campane a martello fra le drammatiche grida d'orrore della folla nel bagliore fosco degli incendi; e lo scampanio festoso e glorioso del finale dell'opera che sbocca nel robusto epico inno in onore di Igor.
Dei personaggi, oltre alle due gustose macchiette dei suonatori di gudok disertori, primeggia il principe Igor, che la musica tratteggia con nobiltà di canti, dei quali specialmente improntato ad eroica grandezza quello del monologo nel 2° atto allorchè rievoca la patria, la libertà e la gloria. Motivo ch'egli ripeterà invano al figlio per farlo fuggire con lui allorchè Kontchakowna cerca di trattenerlo (atto 3°), e che sarà come la voce della patria, mentre la donna gli ricanta il motivo dell'amore creando così fra i due motivi un conflitto drammatico. A questi due motivi contrastanti si aggiunge nel corso dell'opera il contrasto fra il mondo primitivo ma eroico russo e quello più sensuale e barbarico, ma altrettanto sensibile ai moti profondi e generosi dello spirito, dei popoli asiatici. Il conflitto scenico genera ora il cozzo ora la fusione dei due mondi musicali che ci mantiene in una fluttuazione di sentimenti da cui prende vita e vigore l'opera d'arte.
PIETRO MASCAGNI - L'AMICO FRITZ: commedia lirica in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma il 31 ottobre 1891. Libretto di P. Suardon: anagramma di N.[icola] Daspuro, dalla commedia omonima di Emilio Erckmann e Alessandro Chatrian.
Atto 1° - Sala da pranzo in casa di Fritz. - Il giovane e ricco benefattore Fritz Kobus deride il rabbino David per la fissazione di combinare matrimoni. Però bonariamente borbottando gli dà le mille e trecento lire da lui richieste. Uscito David, alcuni amici di Fritz vengono a festeggiarne l'onomastico. Viene anche Suzei, la figlia dal fattore, a offrirgli un mazzolino di mole e a dirgli che il padre l'aspetta alla fattoria. Frattanto lo zingaro Beppe suona una violinata che commuove Suzel, e canta gli elogi di Fritz come benefattore di poveri e di or fanelli. Torna David che, ammirando Suzel, dichiara che presto le darà uno sposo. E poichè Fritz si arrabbia, assicura che darà moglie anche a lui; ma Fritz scommette una grossa vigna che David non vi riuscirà. Mentre gli amici pranzano lietamente, un corteo di orfanelli accompagnati da una fanfara sfila inneggiando al benefattore.
Atto 2° - Cortile nella fattoria di Fritz. - Fritz, che è venuto alla fattoria, è svegliato dal canto di Suzel, e la complimenta per la bella voce. Essa gli offre una primizia: ciliegie. La bellezza della frutta, la grazia di Suzel, la dolcezza della primavera incantano Fritz. Intanto su un calessino giungono anche gli amici, e con essi David. Questi, rimasto solo con Suzel, le fa raccontare la biblica storia di Rebecca alla fonte, e con tale ingenuo mezzo scopre emessa ama il giovane padrone. A Fritz poi dice che ha trovato uno sposo per Suzel. Fritz si incollerisce, e sdegnato ritorna con gli amici in città. All'improvvisa partenza di Fritz, Suzel scoppia in lacrime.
Atto 3° - La stessa scena del 1° atto, - Fritz s'accorge ài essere innamorato di Suzel. Dopo il ritorno dalla fattoria tutto lo attrista e lo irrita, anche la canzone amorosa di Beppe. Ed ecco il rabbino, il quale annunzia a Fritz che il padre di Suzel verrà a chiedergli il consenso per le nozze della figlia. Ma Fritz indispettito dichiara che si opporrà. Viene invece Suzel piangente. Fritz le chiede la ragione del suo dolore, e quando sente che essa non vorrebbe il marito che le è stato proposto, non sa più resistere e le di' chiara il proprio amore. David ha vinto la vigna, che però dona generosamente in dote a Suzel.
Dopo il violento dramma passionale di Cavalleria rusticana. Mascagni volle tentare l'idillio e dette una nuova prova della sua facile ispirata vena. Nell'Amico Fritz l'azione è quasi nulla; e tutto si impernia su un sottile movimento di stati d'animo. Mascagni ha messo da parte la tavolozza a tinte sgargianti e a grandi effetti della Cavalleria ed ha preso i pastelli e i colori più delicati per sbozzare queste graziose figure e chiaroscurare poeticamente e con leggerezza di mano l'ambiente che le circonda. Il color locale alsaziano non è sottolineato che nel 2° atto dal motivo della canzone popolare alsaziana «Es trug das Màdalein», che un oboe espone dietro la scena, e che l'orchestra riprende poi con sentimento non scevro da una dolce malinconia. L'elemento zingaresco e popolano invece è dato soltanto, nelle arie di Beppe e in talune frasi di Suzel, da qualche alterazione della scala. Però nella «violinata» che figura eseguita da Beppe nel 1° atto, il carattere zingaresco non sorge dalle alterazioni tonali, ma unicamente dall'elemento capriccioso sia dei ritmi e dei movimenti continuamente variati, sia dei frequenti cambiamenti dell'espressione. Nell'insieme il pezzo ha un largo andamento melodico che meglio si dispiega nell'effettistico intermezzo.
Ma non in queste cose consiste la maggior bellezza dell'opera, sì bene nell'indovinata impronta idillica, in quel fare da «commedia lirica», come dice l'indicazione del libretto, che non assume mai atteggiamenti enfatici. È stato detto da taluno che il duetto finale tra Suzel e Fritz assurge ad una drammaticità che converrebbe meglio a un soggetto come Gli Ugonotti. Ci sembra che l'affermazione sia per lo meno esagerata. Certo il 3° atto è quello che ci rappresenta il momento culminante della lotta interiore di Fritz, ed è perciò Patto più drammatico. È naturale dunque che, dopo la lunga lotta, allorchè Fritz vince il puntiglio, lo sfogo della passione lo porti ad un estremo opposto, cioè ad un abbandono lirico esuberante. Ma quest'esuberanza non è enfasi e non ha affatto il brivido di terrore che attraversa il duetto degli Ugonotti. Ad ogni modo, fino a questo momento, la musica non esce dai confini di una delicata espressione tra il comico e il sentimentale.
Il primo atto è preparatorio, e però è schizzato via con scioltezza, con garbo, con gusto, dal preludietto gaio e umoristico alla marcetta festosa ma che non cade mai nel marziale eroico. E fra questi due estremi alcune ispirazioni deliziose: Paria di Suzel: «Son pochi fior», così tenera e ingenua; l'estrosa violinata, che però ha il torto di sospendere l'azione; Paria di Beppe: «Laceri, miseri», che anch'essa ha il torto di immalinconire un'altra volta la scena facendo passare in secondo piano tanto Suzel come il banchetto dei «ghiottoni inutili»; e la gaia marcetta finale così da «asilo infantile». Fra tante pagine gentili e motivetti arguti, la sfuriata di David: «Per voi, ghiottoni inutili» è un po' goffa anche nell'accompagnamento che sa di rancido vecchiume.
Ma il 2° atto è un compiuto idillio da cima a fondo. Dopo il preludio rasserenante, la gioiosa scoperta delle ciliegie mature, la nenia pastorale dell'oboe, il coro poetico e un po' triste dei contadini che cantano: «L'amore che lontano se ne va, mai più non tornerà!...» con accenti così toccanti, la canzone di Suzel: «Bel cavaliere», con quell'aria di antica filastrocca innocente, e pure intrisa di così sottile malinconia anche per il contraccanto dell'oboe, eccoci a quel «duetto delle ciliegie» che è il gioiello dell'opera.
L'incanto sensuale della primavera e la poesia serena della vita agreste si danno la mano in questa pagina mascagnana per tendere l'insidia del fascino amoroso a Fritz. Violini, oboe, flauto e corni predominano nello strumentale spandendo una dolce fragranza agreste. Il movimento ondulato cullante dell'accompagnamento infonde un senso di lene riposo, dandoci quasi l'impressione tangibile dell'aria tranquilla, del cielo sereno, dell'ora mattutina. A poco a poco la mite calma primaverile crea il rapimento estatico. Sgorga allora dal cuore («mago che al posto del cuore ci ha un nido donde balzano alate le più fresche canzoni d'un popolo», aveva scritto di lui il Bastianelli) il canto forse più bello di tutta la produzione mascagnana: «Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla». La melodia ha una purità di linea, una così tersa espressione di pace e di mistero, che è quasi mistica. Aleggia in queste pagine uno spirito di poesia virgiliana, così che involontariamente si è tratti a pensare col Poeta: «Deus nobis haec otia fecit». L'idillio non poteva essere più soave e perfetto; e ancora una volta ci chiediamo: chi dei contemporanei di Mascagni avrebbe saputo esprimere con quest'ampiezza di volo e questa limpidezza di canto il sentimento panico del silente mistero primaverile?
A rompere l'incanto giungono gli amici di Fritz, ma il Maestro ha saputo trovare ancora la nota giusta con un arguto e bizzarro motivo. Quindi è la volta del racconto biblico di Suzel: la semplice narrazione quasi parlata della fanciulla riceve l'accento sacro dal motivo che la commenta in orchestra. E man mano che la narrazione si svolge, questo motivo diviene sempre più solenne, fino a concludere con una perorazione trionfale allorchè l'avvenimento biblico risveglia nel cuore di Suzel la coscienza del proprio amore sino allora non confessato. E il vecchio rabbino, che poteva parere prima di questo momento un divertente buon maniaco, grandeggia d'improvviso in questa vampa d'amore sacro per uh miracolo del tutto musicale. Ed ecco che qui abbiamo campo di constatare come nel melodramma chi crea la realtà, chi scolpisce, chi dà vita, chi trasfigura non è la parola ma la musica. Le parole di questi personaggi sono tutte modeste, tanto che il libretto fu, non a torto, criticato per la convenzionalità dei personaggi mal delineati, più abbozzi informi che creature. Ma come si mettono a cantare eccoli prendere ciascuno una fisionomia precisa e riempirsi di una vita insospettata.
Dopo una serie di episodi musicalmente meno interessanti ma rapidi, alla partenza di Fritz, sul pianto di Suzel, l'orchestra riprende il motivo del silenzio campestre e il coro lontano ripete come un'eco dolente: «Mai più non tornerà!». E con questi richiami così semplici Mascagni ha toccato la più delicata commozione.
Il 3° atto, come s'è detto, è il più drammatico. L'amore è già nel cuore di Fritz; ancora una volta gli stornelli agresti che cantano della «bionda molinara andata sposa» gettano su di lui il loro incanto maliardo, avvivano la fiamma che invano vorrebbe spegnere, e lo fanno prorompere nel caldo e largo volo lirico della romanza: «O amore, o bella luce del core», e infine nel vigoroso impeto del denso duetto finale. E di nuovo Virgilio ci suggerisce l'interpretazione giusta di questa musica: «Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori!».
ALFREDO CATALANI - LA WALLY: dramma in 4 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 20 gennaio 1892. Libretto di Luigi Illica, dal romanzo di Guglielmina de Hillern Wally dell'Avvoltoio.
Atto 1° - L'Hochstoff: largo piazzale con tavola; a sinistra la casa di Stromminger. Nel fondo un alto ponte che passa su un abisso dove scorre l'Ache. - Mentre fra canti, danze, vino e gare di tiro a segno Stromminger festeggia il suo settantesimo compleanno, giungono dei cacciatori con a capo Giuseppe Hagenbach, il quale racconta come uccise un orso inferocito. Ma Stromminger lo schernisce e si vanta d'aver percosso un giorno suo padre. Hagenbach s'avventa minaccioso contro il vecchio, ma sopraggiunge la figlia di Stromminger, Wally, che li separa, ed Hagenbach parte coi suoi. Vincenzo Gellner, innamorato di Wally, la chiede al padre, ma Wally, che ama Hagenbach, lo rifiuta. Stromminger allora la caccia di casa, e Wally s'avvia verso l'aspra vetta del Murzoll. L'accompagna Walter, giovinetto suonatore di cetra, che poco prima aveva cantata una canzone composta da Wally, canzone la quale tratta appunto d'una fanciulla che salì la cima del Murzoll per morire d'amore fra le nevi eterne.
Atto 2° - La piazza di Sölden. Da un lato l'osteria di Afra. - È passato del tempo; Stromminger è morto, e Wally è diventata la ricca proprietaria dell'Hochstoff. È giorno di festa, ed anche Wally è venuta a Sölden, ove rincontra con Gellner, che l'ama sempre e che essa schernisce. Gellner allora, sapendola ancora innamoratissima di Hagenbach, la informa che questi è fidanzato ad Afra. Presa da furore geloso Wally insulta Afra. Hagenbach per vendicare l'offesa, scommette che alla «danza del bacio» riuscirà a baciare Wally, la quale si vantava fieramente di non essere mai stata baciata da alcuno. Infatti durante la danza, lasciando credere a Wally che l'ama, vince la scommessa fra le risa degli astanti. Quando Wally s'accorge di essere stata ingannata, incita Gellner ad uccidere Hagenbach, promettendogli di essere sua.
Atto 3° - L'Hochstoff: da un lato la stanza di Wally, dall'altro il ponte sul burrone. - È notte. Wally è pentita dell'ordine dato a Gellner poichè essa ama troppo Hagenbach. Anche questi, pentito dell'inganno teso a Wally, si è acceso dimore per lei, e viene all'Hochstoff per chiederle perdono. Ma Gellner è in agguato e lo fa precipitare nel burrone. Però allorchè ne dà l'annunzio a Wally, questa tenta di ucciderlo. Gellner si libera a stento da lei e fugge. Wally chiama al soccorso, e poichè nessuno osa calarsi nell'abuso, m scende ella stessa e ne riporta il corpo di Hagenbach soltanto ferito e svenuto. Quindi gli rende il bacio ch'egli le aveva rapito durante la danza, lo consegna ad Afra, alla quale dona ogni propria ricchezza, e s'avvia di nuovo verso la vetta del Murzoll.
Atto 4° - Sul Murzoll presso la capanna di Wally. - L'inverno avanza, le valanghe distruggono i sentieri e Wally rimanda al piano il piccolo Walter. Ma rimasta sola ode una voce che la chiama: è Hagenbach che, guarito, avendo saputo di essere stato salvato da Wally, sempre più innamorato di lei, viene a cercarla. Mentre i due amanti si parlano felici, si scatena una tormenta, e una valanga precipita travolgendo l'Hagenbach. Wally allora si getta nel precipizio.
Il personaggio dominante nell'opera è quello di Wally. Tutta la musica gravita attorno ai mutevoli aspetti e ai vivaci e contrastanti atteggiamenti di questa donna, a volta a volta appassionata e ribelle, fiera e languida, pronta al delitto come all'eroismo, orgogliosa e generosa, figura eminentemente romantica. L'arte raffinata del Catalani vi ha lavorato di ispirazione e di cesello mettendone in rilievo ogni lato ed ogni moto della psiche così complessa. Ma soprattutto ne ha posto in luce la sognante e malinconica anima tutta presa dalla poesia delle solitudini alpestri. La prima affermazione di questo stato d'animo è nella canzone da lei composta, e cantata da Walter: «Un dì, verso il Murzoll» che ha il carattere di una ballata, più bizzarra che profonda, ma che tocca la nota dolorosa nella frase: «Quando fu giunta sovra l'alto monte». Però è nella celebre romanza: «Ebben? Ne andrò lontana» che la poesia dell'alpe si illumina di uno splendore di leggenda. C'è malinconia, l'intensa malinconia del Catalani, quasi malata, e ombrata di un pessimismo insanabile, ma c'è soprattutto il senso profondo di una solitudine e di un'altitudine, distaccate ormai dal suolo e dal mondo, e tutte immerse nel candore delle nevi e nelle soffici nubi d'oro. Questo sentimento è tutto permeato da quell'aspirazione al fantastico incantesimale che forma sempre il fondo di ogni concezione poetica della natura nell'arte di Catalani.
Ciò che segue negli atti successivi può incidere meglio, può colorire di più qualche lato minore, ma l'anima romantica e alpestre di Wally è tutta in questa prima romanza. Il senso della solitudine fiera è anche nel canto del 2° atto: «Finor non m'han baciato che i rai del sol e il vento», che ripercuote il sentimento di un'anima che vive in un isolamento orgoglioso, tutt'una cosa con le vette alpine che formano il suo sogno, così come solitario, sdegnoso, rupestre è il suo amore per Hagenbach. Amore che la scuote, la fa fremere come le vette dei pini nella tempesta, la fa cedere, quasi diremmo franare, come una cima colpita dalla folgore, la getta nella tormenta del rimorso, e la sbalza alle stelle nel gesto eroico del salvataggio e nell'ultimo esilio.
Ma il sentimento della natura alpestre non è soltanto nella musica che riguarda il personaggio di Wally; esso è diffuso su gran parte dell'opera, che si tinge di un colore indimenticabile. Alludiamo alla fanfara dei cacciatori, a certi sbalzi nella maniera di modulare i canti, propri dei popoli che vivono nell'alta montagna, riscontrabili in particolare non solo nella canzone del Pedone: «Non v'è maggior piacer», ma anche nel ländler del 2° atto, così balzante e scivolante per quanto tutto stemperato in un cromatismo che esprime il turbamento e la pena dei due giovani avvolti e arsi da una stessa vampa, e che pure non rinunzia ad essere voluttuosamente carezzevole.
Poi viene il preludio del 3° atto: «A sera», dove la serenità del canto si sposa al sottile affanno delle terzine sincopate determinando la sensazione di un pianto lene e sconsolato che si compiace di sè stesso e sembra quasi voler ripetere il leopardiano: «e il naufragar m'è dolce in questo mare». E dopo, ecco la bufera notturna nell'aspra gola selvaggia, che suscita nello spirito la visione di arcane potenze favolose; ed ecco il drammatico preludio del 4° atto, il quale non è solo la rappresentazione di un paesaggio solitario e gelido, ma un poema della morte e della desolazione.
Partecipe di questo dramma della natura è il dramma dei tre cuori che l'amore travolge. Afra non conta; è una figura insignificante che Catalani non ha sentita, e che anzi nel dolce ma frivolo «No! coll'amor tu non dèi scherzar» diventa stucchevole, specialmente perchè l'idea è sciupata nello sviluppo di un prolisso quanto inutile quartetto. Ma l'amore che distrugge è nei canti disperati di Gellner, specialmente nell'abbandono melodico del suo impossibile sogno: «E una lunga carezza, e un'ebbrezza infinita d'eterna giovinezza sarà la nostra vita». Gli altri canti, del pari e forse più gonfi del presentimento della morte, riguardano Hagenbach e Wally, ed affiorano durante la danza del 2° atto, specie nell'incontenibile confessione di Hagenbach: «Perchè, Wally, sei bella», si prolungano nel soave pianto di Wally al 3° atto: «La giovinezza coi suoi sogni ardenti», che cresce di spasimo di battuta in battuta per terminare in un grido di dolore lacerante, ed hanno il loro epilogo nel tragico duetto finale. Qui, dalla patetica frase del violoncello sotto le parole di Hagenbach: «M'hai salvato», fino allo scroscio cristallino, ma troppo puerilmente descrittivo, della valanga, è tutto un crescendo di spasimo appassionato, di tenerezza dolorante, che conduce all'estasi ultima: «Vieni, vieni, una placida vita noi vivremo», mentre nell'ululo del vento che risponde la morte è già in agguato.
Quanto al wagnerismo di cui il Catalani era imbevuto, conviene precisare che nella Wally è rimasto soltanto nella predilezione per particolari impasti e colori dello strumentale. Manca, come in Edmea e in Loreley, ogni tessuto sinfonico a base di temi fondamentali, mentre il canto melodico, sia nelle voci che nell'orchestra, è ancor più personale che nelle opere precedenti e conserva la tipica ariosità del canto italiano, il quale nella dolcezza elegiaca del notturno, che costituisce il preludio del 3° atto, diventa trasparenza lieve ed eterea, ben lontana dalle dense polifonie del Lipsiano.
GIULIO MASSENET - WERTHER: dramma lirico in 3 atti e 4 quadri. Prima rappresentazione al Teatro dell'Opera a Vienna il 16 febbraio 1892. Libretto di Edoardo Blau, P. Milliet e G. Hartmann, dal romanzo I dolori del giovane Werther di Wolfango Goethe.
Atto 1° - A sinistra la casa del Podestà di Wetzlar, a destra giardino. - Luglio 178... - Il podestà sta insegnando una canzoncina di Natale ai figlioletti. Due amici del Podestà vengono a invitarlo a un ritrovo per giocare e bere insieme, ma egli è incerto perchè non sa quando tornerà Alberto, il fidanzato della figlia maggiore Carlona. Partiti Schmid! e Johann sopraggiunge il giovane Werther, venuto a prendere Carlotta per condurla a una festa a Wetzlar. Fra i due giovani si stabilisce subito un reciproco fascino amoroso. Al ritorno dalla festa a sera tarda, Carlotta riprende bruscamente il dominio di sè all''annunzio del ritorno di Alberto, annunzio che lascia desolato Werther.
Atto 2° - La piazza di Wetzlar. - Settembre 178... - Carlotta e Alberto sono già sposi da due mesi: egli è felice; essa chiude in cuore il ricordo incancellabile di Werther. Questi è disperato; pure di fronte alt'amicizia leale che Alberto, consapevole del suo sentimento per Carlotta, gli offre, dichiara di conservare per lei solo un'amicizia pura. Chi si è invece innamorata di Werther, è Sofia, la sorella quindicenne di Carlotta, ma Werther non se ne avvede. Sente invece di aver mentito a sè e ad Alberto dicendo di provare per Carlotta solo amicizia. Egli riparla a Carlotta del suo amore, ma essa dolcemente lo consiglia a partire, e solo lo invita a passare con lei e il suo sposo il Natale, come un amico. Werther allora fugge; Sofìa scoppia in lacrime.
Atto 3° - Salotto in casa di Alberto. - 24 dicembre 178... -Carlotta sta rileggendo una lettera di Werther nella quale le dice che il suo amore è sempre vivo, e perciò a Natale non tornerà. Però egli non ha saputo resistere, e d'improvviso appare. I ricordi del passato si affollano attorno al suo cuore; la vista di un manoscritto gli richiama i versi d'Ossian ch'egli tradusse e che ora ripete. Tutto db riaccende in entrambi l'amore che si sforzano invano di far tacere. Ma Carlotta sente il pericolo che la minaccia e fugge dalla stanza. Werther parte disperato, e di li a poco manda a chiedere le pistole che - scrìve - gli occorrono per un lontano viaggio. Alberto che è rientrato ed ha intuito l'accaduto, ordina a Carlotta di consegnarle al messo. Ma subito dopo essa, presaga della sciagura, corre da Werther.
Atto 4° - Quadro 1° - Wetzlar: la luna rischiara il paesaggio coperto di neve. - Quadro puramente sinfonico, verso la fine del quale si ode un colpo di pistola.
Quadro 2° - Lo studio di Werther. - Werther mortalmente ferito è steso al suolo. Sopraggiunge Carlotta, solo in tempo per raccoglierne le ultime parole e confessargli il suo amore disperato. Da lontano si odono i bimbi cantare la canzone di Natale.
Nella rappresentazione, 3° e 4° atto vengono eseguiti senza interruzione, cosicchè il 1° quadro del 4° atto diventa un interludio orchestrale, e il 2° quadro del 4° diviene in effetto il 2° quadro del 3°.
Dopo Manon, è questa la più bell'opera di Massenet. Ma essa si concentra tutta nei due protagonisti, Werther e Carlotta, chè gli altri personaggi sono figure musicalmente appena abbozzate in maniera da non rilevarne che scarsi aspetti mediante scarsi motivi esteriori. Il Podestà è tratteggiato come una macchietta bonaria, e si confonde un po' coi suoi amici bontemponi Schmidt e Johann, la cui fisionomia principale è data dal tema della canzone «Evviva Bacco, Bacco Evoè!». Amici un po' ingombranti e superflui, le cui scene sono indicate in gran parte dal musicista medesimo come da tagliare.
Più importante è Alberto, che però ci è presentato sempre con un tema insignificante. Forse vuol essere un tema calmo e fidente, ma, chi sa perchè, lo si direbbe il tema sospettoso di un predestinato cornuto. Ed anche la sua aria: «Quale preghiera dal core va» nel 1° atto, è quella di un poeta sbagliato. Vi è in essa una tenerezza borghese che annoia, non ostante l'eleganza che vi ha profuso intorno il compositore. Anche i suoi canti nel 2° atto, per voler essere troppo semplici e affabili sono riusciti melensi. Ma al 3° atto, dopo l'infocato duetto fra Werther e Carlotta in cui si respira solo affanno e delirio estremi, allorchè egli appare sul solito suo motivo viscido, esposto in modo quasi truce, preso finalmente da gelosia, egli diventa quasi ridicolo e odioso, specialmente per quell'improvviso fare da Renato del Ballo in maschera che costringe la donna a un gesto delittuoso.
Sofia, col suo gorgheggiare e saltellare frivolo, riesce anche lei piuttosto stucchevole. Essa è in quella disgraziata età in cui la giovinetta non è già più bambina e non è ancor donna: disgraziata età nella vita, e che l'arte non sa redimere e non sa rendere simpatica per l'ambiguità insanabile degli atteggiamenti. Eppure non è a dire che Massenet non l'abbia circondata di ingenue grazie e di floride eleganze, tanto nell'aria del 2° atto: «Gaio il sol di fiamma ardente», quanto nell'altra del 3°: «Ah! che il riso è gentil».
Aggiungiamo di passaggio che nel finale del 2° atto Massenet ha guastato l'effetto drammatico della situazione per scarsa sensibilità psicologica. Werther è fuggito; Sofia scoppia in lagrime: è il suo primo inganno amoroso; Carlotta è turbata dalle parole di Werther che la sorella riferisce: « Non vuol tornare»; Alberto si è fatto cupo poichè indovina l'amore di Werther per sua moglie; e proprio in questo momento esce fuori gaio, fra acclamazioni ed evviva, il corteo che festeggia le nozze d'oro d'un ignoto pastore protestante, con una marcetta poco nobile, sviando l'attenzione dello spettatore dal dramma dei protagonisti all'inutile giubilo di un personaggio che non ha parte e neppure si vede. Non si può neppure dire che Massenet abbia cercato un effetto di contrasto perchè la gioia di questo sacerdote non ha nessun rapporto col dramma.
Ma la musica di Massenet, come s'è detto, si condensa attorno ai due protagonisti, e qui crea miracoli di poesia. Werther e Carlotta sono immersi in un'atmosfera musicale estremamente romantica: tutta drammatica passione la musica che caratterizza la donna, tutta sognante poesia quella dell'uomo. Un senso di malinconia, che dal romantico abbandono va fino alla tristezza più cupa, li rinchiude dapprima come in una specie di magico cerchio da cui non possono più uscire, e li travolge poi come dentro una bufera senza scampo. I motivi fondamentali del dramma di Werther appaiono già nel preludio: quello sconvolto, quasi delirante, del suicidio, con cui il preludio stesso si apre, e quello della sua sensibilità poetica che segue al precedente e lo conclude. Quest'ultimo, tenue, trasognato, tutto sfumature armoniche e ondulazioni melodiche, ricompare all'entrata di Werther preceduto da una frase a solo del violino imbevuta del più intenso lirismo, una frase che è già tutta trepidazione e sogno, e che si conclude con la larga e ardente invocazione alla Natura.
E qui notiamo che di poesia della natura, nei suoi aspetti incantesimali o pittorici, è tutta ripiena la partitura, e che essa avvolge i personaggi in un velo di mistero quasi fatalistico, e ne domina le azioni e si immedesima fino a divenire una cosa sola con la loro psiche. Ed è l'accenno di danza villereccia festiva allorchè gli invitati entrano nel cortile del Podestà e allorchè ne partono; ed è la grande delicatissima descrizione della sera su là fine del 1° atto, tutta tintinni d'arpa leggeri che accompagnano il canto largo ed estatico dei violini con sordina e del violoncello al ritorno di Werther e di Carlotta dalla festa. È questa forse la pagina più bella e profonda dell'opera, dove il fascino della notte serena (la musica sembra tutta una trasparenza di luce lunare d'azzurro e d'argento) diventa fascino istintivo d'anime innamorate, quasi un'ineluttabile forza naturale. Questo fascino notturno tiene qui le veci del filtro che incatena Tristano e Isotta nell'opera wagneriana. Ed è la suggestiva descrizione del paesaggio nevoso al chiaro di luna che forma il centro dell'interludio dell'atto 3° (o 1° quadro dell'atto 4°). Anche in questa pagina, mentre nell'accompagnamento è un ondeggiare lento uniforme di accordi grigi e nebbiosi, le note lunghe della melodia, che inizia sempre con un accento forte di spasimo per terminare in una lenta discesa di note sfumanti, recano un'espressione desolata che non è solo descrizione di paesaggio, ma interessa la situazione del dramma, la disperata fine di un sogno d'amore.
Gli altri canti di Werther traboccano di una passione romantica, la quale culmina al 3° atto nelle famose «strofe di Ossian», dove la melodia fonde sogno, amore, dolore in una perfezione di linee e in uno slancio interiore di grande irresistibile potenza.
Carlotta è dipinta con tinte affettuose, ma in cui passa pure una velatura di malinconia romantica. Questa malinconia si discioglie in una melodìa carezzevole e amara, in cui tremano lacrime rattenute e pallidi sorrisi allorchè, nel 2° atto, Carlotta chiede a Werther: «Dunque non più v'è una donna quaggiù degna del vostro amore?». La passione contro la quale invano la donna lotta, raggiunge l'espressione massima nel 3° atto, nella elegiaca lettura della lettera, dalle tinte crepuscolari; nell'aria:
«Il pianto che si vuol frenar», in cui è tanto represso dolore e il senso di una resistenza che sta per spezzare il cuore; nella disperata invocazione: «O Signor, seguo il tuo voler», e nell'ultima vittoriosa battaglia contro sè stessa più che contro Werther. La corsa drammatica presso il suicida, l'angoscia mortale e la confessione del proprio amore sono il crollo provocato dalla morte, e l'unico bacio concesso vibra di questo affanno supremo, a momenti con un senso quasi spettrale.
Inutile dire dell'eleganza, della raffinatezza armonica e strumentale tutta massenetiana (anche se qua e là è sfuggito qualche accordo o qualche timbro wagneriano) di questa suggestiva e innegabilmente vitale partitura in cui è tanta poesia di umano dolore.
RUGGERO LEONCAVALLO (Napoli 1858-Montecatini 1919) - PAGLIACCI: dramma in un prologo e 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Dal Verme di Milano il 17 maggio 1892. Libretto dello stesso Leoncavallo.
Prologo - Tonio, commediante, si presenta al pubblico annunziando come l'autore dell'opera abbia voluto rimettere in scena le vecchie maschere, avvertendo però che non finzioni, ma «uno squarcio di vita)) egli ha inteso rappresentare; non lacrime finte, ma vere.
Atto 1° - Piazzale di un villaggio in Calabria. - Epoca fra il 1865 e il 1870. - Giunge un carro di Tespi fra lo schiamazzo festante della folla. Canio, capo della compagnia, annunzio una rappresentazione e invita il pubblico a intervenire numeroso. Tonio, rimosto solo con Nedda, sposa di Canio, le fa proposte amorose; ma Nedda prima lo beffa, poi, com'egli fa ratto di baciarla, gli dà un colpo di frusta sul viso. Tonio, fuor di sè, giura di vendicarsi. Nedda ha un amante in paese, Silvio, col quale combina di fuggire. Tonio, che ha spiato ed udito, va ad avvertire Canio, ma questi giunge troppo tardi: Silvio è già partito. Invano Canio ne chiede minaccioso il nome alla moglie, e poichè essa non vuol svelarlo, si lancia con un pugnale contro di lei, ma è afferrato da Beppe, il quale lo sospinge a prepararsi per la commedia che fra breve deve iniziarsi.
Atto 2° - La stessa scena. Da un lato è stato eretto un palcoscenico. - La folla affluisce per assistere alla rappresentazione. Fra il pubblico è Silvio. All'inizio della commedia Colombina (Nedda) riceve l'amante Arlecchino (Beppe), ma sentendo venire lo sposo Pagliaccio (Canio) fa fuggire Arlecchino. Canio recita a doppio senso domandando il nome dell'amante fuggito. A poco a poco, preso dalla gelosia, dimentica la finzione della commedia e levando un coltello minaccia di uccidere Nedda se non gli dice il nome del drudo. Accortosi che Canio fa davvero, Silvio si avanza, armato di pugnale per difendere Nedda; ma Canio lo scorge, e dopo avere ucciso Nedda, colpisce anche lui. Indi, come istupidito, si lascia arrestare esclamando: «La commedia è finita!».
Anche Pagliacci, come Cavalleria rusticana, con la quale viene quasi sempre unita alle rappresentazioni, è opera della «scuola verista», e l'autore medesimo fa dire nel prologo a Tonio ch'esso «al vero ispiravasi». Ma che cos'è «il vero» in musica? Se non è imitazione materiale bruta, è necessariamente trasfigurazione. Canio dà un ceffone a Tonio; la musica non se ne accorge neppure e seguita a scherzare leggermente attorno agli attori discesi dal carretto. Più tardi Nedda fa fischiare la frusta sul volto di Tonio: l'orchestra non ha un cenno imitativo. Anche le coltellate finali a Nedda e a Silvio passano nel tumulto orchestrale drammatico imposto dalla situazione, senza nessuna veristica traduzione sonora. Ci sono qua e là frasacce più volgari che veristiche, come «sgualdrina», «turpe donna», «il tuo fetido sangue», «meretrice abbietta», ma esse cadono come pesi morti, e non è per esse che la musica si fa verista. Anzi su la frase «meretrice abbietta» la musica di Leoncavallo sale con melodioso lirismo per fermarsi su un acuto tenorile effettistico, ma per nulla «veristico».
Ci sono, sì, difetti, ma questi non appartengono alla scuola verista più che a qualunque altra scuola. Uno è l'enfasi, la gonfiatura di qualche frase fino alla truculenza. Alcune volte sono gli esecutori che guastano in questo senso per grossolana gigioneria, come fanno quasi tutti i baritoni nel finale del prologo prendendo uno stentoreo la bemolle acuto e portando l'intera chiusa della frase all'ottava sopra. Altre volte, come nella citata frase «o meretrice abbietta» è il musicista che sbaglia l'espressione e gonfia la voce fuor di misura. Un altro difetto è l'espressione generica, approssimativa, combinata su uno stampo alla moda d'allora, ma senza vera intimità; e questo si riscontra specialmente nel duetto d'amore fra Silvio e Nedda.
Ma se l'opera piacque e se ancora si regge è perchè ci sono valori lirici e drammatici positivi numerosi. Valori, per esempio, di buon gusto nelle armonie, e valori di piacente ed anche efficace ispirazione melodica. E vi son pure frequenti valori di ritmica marcata e vivace, la quale si afferma subito fino dalle prime battute del prologo, così balzanti e burlescamente originali, e si conserva con effetti brillanti, agili, a volte arguti ed eleganti, in aderenza assoluta con la spigliata originalità dei disegni melodici. Gli esempi più notevoli sono da osservare nell'elastico movimento «come uno scherzo» che segue subito l'annunzio della rappresentazione «a ventritrè ore», nell'indovinato canto pastorale dell'oboe al passaggio degli zampognari, nel successivo coro pittoresco (anche se episodico e scenicamente assurdo) delle campane: «Din, don, suona vespero», nel coro introduttivo del 2° atto, nella «Commedia» in cui i motivi slanciati, galanti, aggraziati, spiritosi si seguono con sciolta spontaneità di trovate e con freschezza di ideazione ammirevoli, fino all'entrata di Canio. Da questo momento finzione comica e dramma vero si mescolano; i motivi eleganti si incupiscono, presentano scatti iracondi, balzi sospettosi, e a poco a poco cedono il posto alla tempesta tragica che conduce alla rapida conclusione.
Tonio è tratteggiato a linee bieche e spietate, qua e là un po' troppo drammaticamente wagneriane. Ma il centro del dramma è, naturalmente, Canio, il cui carattere geloso è fortemente rilevato fino dal cantabile: «Un tal gioco, credetemi, è meglio non giocarlo» che contiene, fra eleganze e sorrisi a denti stretti, tanta amarezza e sì tenebrosa minaccia. Ma dopo la scoperta del tradimento, il contrasto tra la vita e la commedia, la necessità del riso col cuore infranto (come in Rigoletto), eccitano la fantasia del compositore che trova nell'aria: «Vesti la giubba», anche se verso la fìne con qualche enfasi, l'espressione commossa e sincera di uno spasimo disperato.
L'orchestra avrebbe potuto fare a meno del tematismo che, non avendo sviluppi sinfonici, si riduce a ripetizioni piuttosto automatiche; ma i colori, pur qua e là intinti di wagnerismo, sono vivi e ricchi.
ALBERTO FRANCHETTI (Torino l860 - Viareggio 1942). - CRISTOFORO COLOMBO: dramma lirico in 3 atti ed epilogo. Prima rappresentazione al Teatro Carlo Felice di Genova il 6 ottobre 1892. Libretto di Luigi Illica. Edizione rifatta.
Atto 1° - Cortile nel Convento di S. Stefano a Salamanca. -Anno 1487. - Si attende il responso del Concilio su le teorie di Colombo circa la possibilità di andare alle Indie da occidente, attraverso all'Atlantico. Tre Romei cantano la leggenda di San Brandano, e le meraviglie di ignoti lidi lontani. Per avvelenare l'incanto operato dai Romei su la folla. Don Roldano Ximenes, cavaliere, racconta una leggenda macabra in cui si parla di un mostro immane che divora le navi. Intanto il Concilio esce dal Convento: le teorie di Colombo sono state dichiarate sogni d'un pazzo. All'uscita Colombo viene schernito dalla folla aizzata da Roldano, ma Don Fernan Guevara, capitano delle Guardie del Re, lo difende. La folla si disperde: Colombo, avvilito, è preso dal dubbio, ma la Regina Isabella, uscendo dall'oratorio, lo riconosce e lo conforta narrandogli una visione in cui le apparve la nuova terra da lui scoperta.
Atto 2° - La tolda della Santa Maria. Lontano si scorge la Pinta. - Anno 1492. -Colombo, mercè l'intercessione della Regina ha ottenuto tre caravelle per compiere l'audace esplorazione. Su la Santa Maria l'ago della bussola ha deviato, e ciò suscita in tutti il terrore, ma Colombo riesce a tranquillizzare gli spauriti. Però la lunga navigazione ha creato stanchezza e sfiducia. Roldano ne approfitta per sollevare la ciurma; quando a un tratto il grido di «terra, terra!» trasforma l'ira in un'entusiastica gioia di trionfo.
Atto 3° - Presso Xaragua, sulle rive del lago sacro. - Anno 1503 - Per l'avidità dell'oro gli Spagnoli uccidono gli Indiani. È rimasto ucciso un Cacico, che gli Indiani portano alla sepoltura con canti funebri. La Regina Anacoana sa che Roldano congiura contro Colombo e aspetta l'ora della vendetta. Giunge infatti una nave dalla quale sbarca Bobadilla, che dichiara decaduto dal comando Colombo e lo fa incatenare. Frattanto Roldano ha uccisa Anacoana perchè non ha voluto testimoniare contro Colombo: gli Indiani levano le loro lamentose nenie in morte della Regina.
Epilogo. - A Medina del Campo: Oratorio con i sepolcri dei Re di Castiglia. - Anno 1506. - Guevara conduce Colombo, cadente, affranto pei dolori e la lunga prigionia sofferta. Guevara andrà dalla Regina affinchè interceda presso il Re e gli renda giustizia. Durante l'assenza di Guevara un corteo di giovani villanelle entra portando fiori su un tumulo, mentre dei frati recitano preghiere. Interrogate le fanciulle. Colombo apprende che la Regina è ivi sepolta da tre giorni. Questo nuovo grande dolore uccide Colombo che spira, dopo un breve delirio, fra le braccia di Guevara accorso.
Franchetti aveva già affermate le sue forti qualità di musicista con l'opera ASRAEL, datasi al Municipale di Reggio Emilia l'11 febbraio 1888. In essa egli trattò la leggenda di un demonio (Asrael) che viene su la Terra per portare un'anima all'Inferno, e di una beata (Nefta) che scende dal Cielo per salvarlo. La principessa Lidoria di Brabante, essendo stata vinta da Asrael nella lotta degli sguardi che ogni aspirante alla sua mano deve sostenere, si è convinta di avere a che fare con uno spirito infernale e, pratica di magìa, affida un'ampolla d'acqua santa alla gitana Loretta, amante di Asrael. Se la verserà su Asrael, questi dovrà riprendere la sua natura umana. Ma Nefta, travestita da Suora, raccoglie Asrael, riesce a farlo pregare e lo salva, ascendendo con lui al cielo.
L'opera contiene molte bellezze, ed è stata a torto dimenticata. I caratteri fondamentali dell'arte di Franchetti vi sono già chiaramente rivelati: melodia non sempre spontanea, talora contorta, ma ricca sensibilità strumentale, e sapienza costruttiva robusta dove agiscono grandi masse. Le pagine sinfoniche e corali dell'Asrael: il preludio del 1° atto, quello dell'ultimo, la marcia del 2°, le danze e i cori infernali del 1° atto, la violenta lotta fra i demoni e gli angeli nel 3°, l'impetuosa tempesta, l'interludio, il luminoso finale, sono tutte pagine che mantengono all'opera una dignità nobilissima.
Nel CRISTOFORO COLOMBO le qualità rivelate nell'Asrael sono confermate. Lo stile sinfonico si è sganciato dai modelli di Wagner e di Goldmark, sensibili nell'opera precedente, lo stile è più personale, ed anche la melodia, salvo pochi casi, è più fluente e più italianamente limpida.
Alla sua prima apparizione l'opera era in 4 atti ed epilogo, ma fu poi ridotta a 3 e l'epilogo, non tanto per abbreviarne la mole, quanto per sopprimere i ridicolissimi amori di Colombo con la Regina Anacoana immaginati dal librettista, forse nell'intento di dare all'opera anche un contenuto sentimentale, ma col risultato di diminuire la grandezza morale della figura di Colombo. Le modificazioni apportate alla nuova edizione consistono quindi in ampi tagli e in qualche opportuno raccordo per fondere insieme le rimanenti parti degli atti 3° e 4°. L'opera ne ha subito un miglioramento, ma nel complesso il nuovo 3° atto resta il più debole dell'opera.
Qualche elemento atto a dare il color locale è stato tratto da autentici canti di popolazioni selvagge: aria dei Mangingi (Africa ovest), canzone dei Galla (che serve di accompagnamento a una danza la cui melodia è di invenzione del Franchetti). Ma sul color locale il compositore non insiste, mentre la caratterizzazione di Bobadilla appare un po' manierata e truculenta, e quelle della furba Anacoana e della sentimentale figlia Iguamota, con relativo innamoramento di quest'ultima con Guevara, sono piuttosto deboli.
Molto più robusto il 1° atto con la suggestiva canzone dei Romei e la torva leggenda di Roldano, il quale nei disegni striscianti e biechi è il personaggio meglio scolpito dopo Colombo. Poi c'è il solenne corteo del Concilio, la scena in cui la folla schernisce Colombo, il dolcissimo armonioso ringraziamento di Colombo a Guevara che lo ha salvato, uno dei momenti di più felice spontaneità melodica, la mesta meditazione di Colombo, e infine il delicato duetto di Colombo con la Regina, tutto soffuso di etereo incanto nel racconto del sogno di lei.
Ma l'atto più potente, più granitico, è il 2°. Già le ottave sonore di apertura ci spalancano allo sguardo la visione di un'immensità spaziale maestosa: la distesa sconfinata del mare. Le imitazioni del frangersi delle onde la arricchiscono di movimento e di vita. Segue poi l'episodio del terrore per la deviazione della bussola. Il compositore si vale della sua sapienza contrappuntistica per rendere, mediante l'intreccio polifonico vocale, il senso dello smarrimento e dell'angoscia. La serena spiegazione di Colombo e la reazione di gioia che essa determina, espressa in ritmi di danza leggera, formano un efficace contrasto.
Ed eccoci ad una delle scene più poetiche dell'opera. È già notte; la luna è alta. Il tema del mare riappare solenne; da una nave all'altra passano nell'aria canti e ordini di manovre, poi l'orchestra svolge un delicatissimo notturno sul quale si innesta la meditazione commossa di Colombo. Non c'è in tutto il teatro italiano di questo secolo una pagina di uguale finézza e di così intima poesia. Segue quindi un altro episodio robusto: la preghiera a voci scoperte su la quale si sviluppa, con una costruzione magistrale, la rivolta, interrotta all'improvviso dal grido «Terra, terra!». A questo punto una progressione dell'orchestra piena di movimento sostiene l'intreccio polifonico delle voci che ripetono la magica parola dall'uria all'altra delle tre navi, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, diversamente distanziate nello spazio. Il crescendo ha un'ansia, un entusiasmo fremente. Un motivo che ha l'espressione di un inno sacro ed arcano (il motivo della nuova Terra, già presentato nel 1° atto), attacca pianissimo sotto il tremolo luminoso dei violini, e cresce di sonorità fino ad esplodere con un grandioso fortissimo. Esso chiude con solennità trionfale questo quadro di una forza di rappresentazione elettrizzante irresistibile.
L'Epilogo ha tutt'altro colore, ed è altrettanto bello. Si apre con un preludio in cui sono esposti i due motivi principali di quest'ultimo quadro: quello grave e dolce insieme della morte di Colombo (archi) e quello del canto triste e affannoso del pianto per la Regina. Tutto l'atto è ispirato a un'espressione di affranto dolore, di mestizia sconsolata, di sfacelo mortale. Lo stile denso degli atti precedenti cede a forme più semplici e melodiose. Poi è il delirio, col ritorno allucinato di motivi esposti nei momenti principali dell'azione, e infine la morte. Un ondeggiare lento di accordi sotto una nota acutissima dell'ottavino come qualche cosa di etereo che aleggi e vanisca, il rapido glissare di un'arpa in una scala ascendente simile a un volo, quindi la perorazione finale col «tema della nuova Terra» esposto in un crescendo luminoso, come al finale del 2° atto.
GIACOMO PUCCINI (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) - MANON LESCAUT: dramma lirico in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1893. Libretto anonimo, al quale peraltro si sa che collaborarono Marco Praga, Ruggero Leoncavallo, Domenico Oliva, Giulio Ricordi e Luigi Illica, dal romanzo dell'abate Antonio Fr. Prévost.
Atto 1° - Piazzale in Amiens presso la posta di Parigi. - Movimento di folla a passeggio. Il cavaliere Renato Des Grieux, studente, motteggia con alcuni amici, ai quali dichiara di non conoscere l'amore, e indirizza un madrigale alle fanciulle che passano. Giunge poi il cocchio d'Arras: ne discendono diversi viaggiatori, fra i quali la giovane e bellissima Manon Lescaut col fratello sergente delle Guardie del Re, e il vecchio Tesoriere generale Geronte di Ravoir. Mentre Lescaut e Geronte seguono l'oste e la folla si disperde, Des Grieux, che è rimasto affascinato dalla bellezza di Manon, l'avvicina, e fra i due si stabilisce subito una reciproca viva simpatia. Manon confessa che i genitori la mandano in un convento, ma Des Grieux le promette di impedirlo. Anche Geronte s'è invaghito di Manon, e ordina all'oste una carrozza per rapirla, ma lo studente Edoardo ne informa Des Grieux, il quale convince Manon a fuggire con lui su la carrozza ordinata da Geronte. Questi, allorchè conosce l'inganno, strepita, beffato dagli studenti.
Atto 2° - Elegante salotto in casa di Geronte. - Manon ha già abbandonato Des Grieux, attratta dalle ricchezze di Geronte, ma lo ama ancora e al fratello ne chiede notizie. La mattinata di Manon passa fra l'omaggio di madrigali e la lezione di ballo che si svolge alla presenza di invitati in ammirazione. Partiti questi, sopraggiunge Des Grieux che rimprovera sdegnato a Manon l'abbandono; però essa lo placa e lo attira a sè. Li sorprende Geronte, che esce a chiamare la polizia. Lescaut sollecita i due giovani a fuggire, ma Manon perde tempo a riempire d'oro e di gioielli una borsetta, e frattanto Geronte ritorna e la fa arrestare.
Atto 3° - Piazzale presso il porto a l'Havre; da un lato il carcere. - Lescaut ha corrotto una sentinella affinchè faccia venire all'nferriata di una finestra Manon. Des Grieux la mette a parte del piano di fuga combinato da suo fratello. Ma il colpo non riesce; uno sparo di fucile dà l'allarme. Le condannate alla deportazione in America vengono fatte uscire e imbarcate fra la curiosità della folla, Des Grieux tenta di opporsi all'imbarco di Manon; non riuscendo a impedirlo, si getta ai piedi del Comandante e chiede di essere imbarcato come mozzo. Il Comandante, commosso, glielo accorda, e Des Grieux si slancia su la nave, fra le broccia di Manon.
Atto 4° - Una landa sterminata sui confini della Nuova Orleans. - Manon è fuggita con Des Grieux dal luogo di pena. Affranta, esausta dalla febbre, dai patimenti, dalla stanchezza, e arsa dalla sete, è costretta a fermarsi, e spira fra le braccia dell'amante.
Il libretto, laboriosamente messo insieme dai cinque collaboratori che si succedettero nella redazione, alla quale è noto che prese parte attiva lo stesso compositore, non sì potrà dire un capolavoro letterario, ma esso contiene elementi drammatici ricchi di musicalità.
Dopo la balda esperienza de Le Villi (1884) e la molta bella musica sciupata nell'assurdo e stanco libretto dell'Edgar (1889), Manon è la prima solenne affermazione di Giacomo Puccini. In quest'opera il Maestro mostra, o meglio conferma, di possedere una ricchezza nuova di poesia lirica e drammatica, una fluente vena di canto melodioso che si allarga e si accende a contatto con le situazioni più passionali. Il binomio amore-dolore, che resterà per tutta la vita di Puccini alla base della sua arte, è già visibilmente il fondamento su cui si regge l'opera. La forma della sua ispirazione è nella tradizione italiana, anche se qua e là appare la traccia di qualche assimilazione esterna, poichè ogni parola, ogni gesto, ogni commozione in lui si trasforma in canto. Derivazioni da Bizet (per esempio il brillante attacco dell'opera), od anche da Wagner (qualche tristaneggiante armonia dell'ultimo atto) appaiono bene assimilate e non intaccano l'originalità complessiva del musicista. Qualche tratto d'enfasi esuberante ogni tanto appare, ma è difetto giovanile che verrà presto frenato.
Il sentimentalismo di cui fu spesso accusato il Lucchese qui non appare o rimane sfiorato, subito sommerso dall'impeto passionale dell'ispirazione. È questa calda passionalità che distingue l'opera pucciniana dalla sorella massenetiana. Il rapimento amoroso di Des Grieux nell'opera di Massenet è di natura più aristocratica e sognante; in quella di Puccini è più ardente ed espansivo. In Massenet Des Grieux si accosta a Manon con timidezza e signorile riguardo; in Puccini le parla subito con la voce di un innamoramento che non nasconde la propria natura sensuale. E questa natura si chiarisce ancor più nella romanza «Donna non vidi mai», in cui però il musicista, per non arrestare o comunque guastare la linea del canto che gli scorre così sincera, è costretto a ripetere più volte senza ragione le medesime parole. Il Des Grieux pucciniano, ben lontano dal sognare la «piccola casetta bianca in fondo al bosco ner», rivela un carattere facile all'impeto e alle smanie. Grida nel 2° atto a Manon: «Sì, sciagurata, la mia vendetta», e innanzi al Comandante della nave nel 3° atto piange ed implora proclamandosi «pazzo». Non è Manon che va a trovarlo e a sedarlo nel chiostro, è lui che, saputo da Lescaut dove si trovava sua sorella, corre da lei; non lotta a lungo per vincere la passione, ma cade subito nel gorgo dei sensi.
Anche Manon è diversa nelle due opere: tutta grazia e civetteria quella del Francese; più avida di quel calore di carezze ardenti che non trova nel «silenzio gelido mortal» dell'alcova dorata quella dell'Italiano. La Manon di Puccini è una natura più meridionale, quella di Massenet è francesissima. La' stessa ambientazione ha un'eleganza più finemente distinta nella musica di Massenet, un carattere più galantemente roccocò in quella di Puccini.
Non v'ha dunque dubbio che l'opera di Massenet è più vicina, come interpretazione, al romanzo dell'abate Prévost, ma non per questo concluderemo che l'opera di Puccini sia di molto inferiore. Essa è soprattutto diversa, e oseremmo dire che a torto prende il titolo dalla donna poichè l'elemento più attivo e predominante è Des Grieux. Nè vorremmo dimenticare le tante bellezze che l'opera pucciniana contiene, e per le quali essa conserva tuttora così forte vitalità; bellezze appariscenti non solo nei due duetti del 1° atto e in quello del 2° fra i due protagonisti, ma nella calda romanza di Des Grieux; «Donna non vidi mai», nell'aria di Manon: «In quelle trine morbide», nel vaghissimo minuetto, nel languido e civettuolo madrigale di Manon: «L'ora, o Tirsi, è vaga e bella».
Ma una considerazione a parte meritano il 3° e il 4° atto. Il 3° è il più forte dell'opera; ha saldezza unitaria, e un soffio drammatico quale Puccini non ha forse mai più ritrovato. Vi grava un'atmosfera di angoscia funerea e dolente che affanna. Il mesto duetto in cui ritornano motivi già uditi (Puccini fa uso di ampi motivi melodici ricorrenti a significazione generica ed esteriore, di natura non sinfonica) è interrotto dall'originalissima canzone del lampionaio, che nello sfondo cupo, nel silenzio circostante, sembra quasi un presagio di nuova sciagura, e dà uno stringimento al cuore. Ma allorchè, dopo il tumulto provocato dall'allarme, si inizia l'appello delle condannate, il canto si snoda dall'orchestra, sostenuto da sincopati affannosi e punteggiato dai commenti ora pietosi ora ironici e dalle risatine crudeli della folla, gonfio di un intenso dolore che prorompe in accenti di ineffabile strazio alle parole: «ogni pensiero si scioglie in pianto». La disperata invocazione di Des Grieux e la perorazione sonora, quest'ultima, anche se un po' enfatica secondo il modello ponchielliano, tuttavia afferrano e commuovono per la loro sincerità di espressione.
Il 4° atto ha un'intonazione più desolata, la quale culmina in una pagina che ih qualche edizione a torto era stata tolta senza il consenso dell'autore. Si tratta del monologo di Manon: «Sola perduta abbandonata», allorchè Des Grieux è andato alla ricerca di acqua. È un canto di una tristezza smarrita e profondamente sconsolata, al quale la malinconica nenia dell'oboe e la misteriosa aerea eco del flauto interno danno un senso di solitudine mortale.
Sono poi da far notare altri caratteri che avranno un seguito nell'arte di Puccini. Per esempio, c'è in Puccini un senso umoristico che gli permette di schizzare con tratti rapidi ed efficaci la figura del fratello di Manon, giocatore corrotto, pronto a correre dietro al denaro, privo di morale, ma in fondo pieno, a modo suo, di affetto per la sorella. Altrettanto ben riuscita è la macchietta di Geronte, gran signore, pretensioso e donnaiolo, ma d'animo freddamente vendicativo. La figuretta del lampionaio esce pure, attraverso alla sua canzoncina, con una sua fisionomia di una malinconia indimenticabile. E c'è poi l'arguzia del finale 1°, in cui Puccini si vale con malizioso garbo del madrigaletto leggero di Des Grieux: «Tra voi, belle, brune e bionde». Questo finale, quando l'opera fu rappresentata per la prima volta, non esisteva: ve n'era un altro più pesante e confuso. Rifacendolo ne uscì un gioiello di grazia e di fine turlupinatura. Questo rifare è un'altra caratteristica del Maestro lucchese che dipende dalla sua incontentabilità, dal suo costante desiderio di perfezione, cosicchè, tranne Le Villi, non c'è opera sua di cui non si conoscano due ed anche a volte tre edizioni diverse.
GIUSEPPE VERDI - FALSTAFF: commedia lirica in 3 atti e 6 parti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 9 febbraio 1893. Libretto di Arrigo Boito, tratto da Le allegre comari di Windsor e dall'Enrico IV di Guglielmo Shakespeare. - Epoca: Regno d'Enrico IV d'Inghilterra, sec. XV.
Atto 1° - Parte 1a - L'interno dell'Osteria della Giarrettiera. - Il vecchio ed obeso gaudente Sir John Falstaff è invaghito di due donne maritate, Alice Ford e Meg Page, e del loro denaro che gli potrebbe essere utile a sostenere le spese non indifferenti per i suoi lauti pranzi e le copiose bevute. Vorrebbe spedire i suoi due servi Bardolfo e Pistola con due missive amorose alle donne, ma costoro si rifiutano. Incarica allora del recapito il paggio Robin, e scaccia a colpi di scopa i servi, dopo aver fatto loro un cinico predicozzo sul'onore,
Parte 2a - Giardino in casa Ford. - Alice e Meg hanno ricevuto le lettere di Falstaff e decidono di burlarsi di lui. Incaricano l'amica M.rs Quickly di invitare Falstaff ad un convegno presso Alice Ford per poi beffarlo. Nello stesso tempo Bardolfo e Pistola avvertono Ford delle intenzioni di Falstaff. Ford incarica i due servi di annunciarlo a Falstaff con un falso nome: penserà lui a intrappolarlo e poi a suonargliele. Fra i due gruppi degli uomini e delle donne che congiurano, sgattaiolano il giovane Fenton e la figlia di Ford, Nannetta, che si amano segretamente e contro la volontà del padre di lei, che vorrebbe dare la figlia in moglie al Dottor Cajus, beone, anch'egli congiurato insieme a Ford e ai due servi per una lite avuta con Falstaff all'osteria.
Atto 2° - Parte 1a - La scena della ia parte dell'atto 1°. - I due servi mostrandosi pentiti, si fanno riprendere a servizio da Falstaff, e gli annunciano la visita di una donna, È Quickly che invita Falstaff al convegno con Alice «dalle due alle tre», ora in cui il marito è fuori di casa. Essa reca pure i saluti di Meg, la quale si dice anch'essa innamorata di lui, però suo marito «è assai di rado assente». Viene introdotto poi Ford, sotto il finto nome di Fontana. Egli dice di essere innamorato di Alice Ford che lo disprezza. Offre un barile di vino e un sacco di monete a Falstaff affinchè conquisti la donna, sperando che una volta caduta sarà più facilmente sua. Falstaff accetta ed anzi comunica al supposto Fontana che ha un invito di Alice per le due. Mentre Falstaff è andato ad abbigliarsi, Ford dà in smanie credendosi tradito dalla moglie, e giura di vendicarsi; poi, contenendosi a forza, esce con Falstaff.
Parte 2a - Sala in casa di Ford. - Quickly racconta ad Alice e a Meg il risultato della sua missione, e tosto le tre donne si preparano allegramente alla commedia. Solo Nannetta è mesta perchè il padre vuol sposarla al dottor Cajus, ma la madre promette di impedire queste nozze. Ed ecco giungere Falstaff, il quale fa il galante con Alice e vorrebbe abbracciarla, ma Quickly si precipita in scena annunziando l'arrivo di Ford. È l'inizio della burla: Falstaff viene nascosto dietro un paravento. Però Meg accorre gridando che Ford c'è davvero. Esso infatti irrompe con Bardolfo, Pistola, Cajus, famigliari e vicini, e mette a soqquadro la casa in cerca di Falstaff. Mentre Ford e gli altri salgono al piano superiore, Falstaff viene nascosto nella cesta del bucato. Del trambusto approfittano Fenton e Nannetta, che si riparano ad amoreggiare dietro il paravento, ma sono scoperti da Ford che va in furore. Mentre gli scalmanati cercano altrove Falstaff, Alice fa rovesciare dalla finestra nel fossato sottostante la cesta con Faktaff dentro, e chiama Ford a vedere.
Atto 3° - Parte 1a - Piazzale davanti all'Osteria della Giarrettiera. - Falstaff siede e beve, nero di bile per lo scorno e il tuffo subito. Ma gli si presenta Quickly, la quale con astuzia lo persuade che Alice è innocente e disperata, e lo invita a recarsi a un nuovo convegno con lei a mezzanotte nel Parco di Windsor, sotto la quercia di Herne, travestito da «Cacciatore nero». È l'inizio di una nuova burla combinata da Alice insieme a Ford per svergognare Falstaff. Ford prende poi accordi con Cajus per terminare l'organizzata finta tregenda con le nozze sue e di Nannetta. Ma Quickly ha udito e si prepara ad avvertire Alice per sventare la trama.
Parte 2 - Il parco di Windsor. Nel centro la quercia di Herne. È notte. - Alìce interrompe un romantico colloquio di Fenton con Nannetta e prepara la figlia ad evitare le nozze con il dottor Cajus. Suona mezzanotte. Falstaff si incontra con Alice e già spera di possederla, allorchè Meg grida che viene la tregenda. Alice fugge; Falstaff si rimpiatta sotto la quercia. Egli viene investito, punzecchiato, ruzzolato da folletti, spiritelli e diavoli, finchè in uno dei suoi persecutori riconosce Bardolfo. Compresa la beffa, Falstaff contrattacca i beffatori. Ford gli si dà a conoscere, e infine gli perdona. Annunzia poi che si avvicinano due coppie di sposi, ma per il sagace travestimento perpetrato da Alice, Fenton e Nannetta sono insieme, mentre il dottor Cajus si trova ad aver sposato... Bardolfo! Ford deve cedere e benedire le nozze della figlia con Fenton, poi invita 'tutti, Falstaff compreso, a cena.
Verdi ha subìto in quest'opera la più radicale trasformazione. Lo stile si è raffinato, si è fatto penetrante, leggero; eppure la fantasia è sempre alata, l'amore dei contrasti sempre vivo, l'ideazione sempre robusta e calda, la chiarezza sempre limpida. La vocalità è ancora dominante, ma la melodia presenta libera e ricca varietà di movenze; e molte volte lo svolgimento della frase si compie passando da una voce all'altra, od anche dalle voci all'orchestra. Questa poi partecipa con una vita attiva alla commedia facendo scorrere sotto ai dialoghi una serie inesauribile di motivi scherzosi od ironici, senza soste, e con una dovizia di colori strumentali suggestivamente burleschi e satirici. Sempre lieve e trasparente, senza pesantezze sinfoniche, non commenta soltanto ma partecipa essa stessa alla vita della commedia con uno spirito finemente umoristico. Questa parola va tenuta presente da chi ascolta l'opra, poichè Falstaff non è l'opera buffa del primo ottocento. Ci sono, sì, scene buffe, come quella della cesta, quella in cui Falstaff rincorre i servi con la scopa, quella in cui i finti spiritelli ruzzolano il pancione, ma su tutto si stende un sorriso bonario e garbato, un sottile riso senza mordace satira, in cui le debolezze umane sono considerate con arguzia piena di indulgenza. Questo è l'umorismo di Falstaff che pone in disparte e supera l'amara creazione shakespeariana per una creazione nuova, di spiriti limpidamente italiani.
Fanno parte di questo umorismo tratti gustosamente caricaturali e parodistici suggeriti da gesti o da parole: squilli di trombe allorchè il beone Cajus giura di non bere più, o quando Ford dice a Falstaff «voi siete un uom di guerra»; imitazioni del polifonismo sacro palestriniano allorchè i servi cantano «Amen», o di modi chiesastici allorchè nella tregenda i burloni pregano che Dio faccia casto Falstaff; vuoti orchestrali all'idea che Falstaff possa perdere la pancia; volo di flauti al pensiero che l'onore è un parola fatta d'aria; sdilinquimento sentimentale d'un corno inglese alla lettura della lettera amorosa di Falstaff; tintinni gioiosi alla vista del sacchetto d'oro di Ford; una gioconda sfuriata dei violini allorchè Falstaff dà un pugno rabbioso su la tavola, e via dicendo, che l'enumerarli tutti è impossibile. La partitura è quasi tutta un sèguito di questi particolari divertenti che il Maestro ha profuso con una instancabile fantasia e con geniale preziosità armonica e strumentale.
Nel canto non mancano le forme strofiche, come, ad esempio, nello spumeggiante: «Quando ero paggio», in cui c'è tanta snellezza leggiadra da ricrearci davvero innanzi alla fantasia con estrema vivezza un Falstaff senza pancia, agile e smilzo; o come nel madrigaletto di Ford, ripreso da Falstaff: «L'amor che non ci da mai tregua», così garbato, civettuolo e frivolo, specialmente comico su le labbra del trippone; o come nel Sonetto romanticamente sospiroso ed etereo di Fenton: «Dal labbro il canto estasiato vola», che però nelle terzine, rompendo il consueto stampo romanzaiolo, diventa un pensoso dialogo melodico col corno inglese. Recitativo dialogato fra cantante e istrumento solista: nuovo atteggiamento di quel recitativo melodico verdiano che ha raggiunto ora il più alto grado di raffinatezza espressiva, a cui, senza diventare trito, non sfugge nulla, che scolpisce e accarezza, che scava e fiorisce, che mentre par che segua il suono della parola ti canta l'emozione che l'ha fatta scaturire, con una naturalezza che incanta, con una luminosità che abbaglia. E intanto l'orchestra sotto dice il resto, aggiunge finezza a finezza, luce a luce, colore a colore, con una perfetta coerenza che è la vita stessa.
La parte del protagonista è tutta costruita secondo questo stile, che se in Otello aveva raggiunto una forza tragica nuova, ora in Falstaff perviene alla più garbata e ridente liricità. Per commentare la profondità di questo stile bisognerebbe fermarsi quasi ad ogni frase. Basterà qui accennare al monologo del 1° atto in cui Falstaff spiega a modo suo ai due servi furfanti che stanno in sussiego, che cos'è l'«onore». È il «credo» di Falstaff, il quale si rivela musicalmente il fratello comico di quello di Jago. Le frasi cadono ironiche e beffarde tra i commenti più frizzanti ed ilari dell'orchestra, con un discorso che è una rivelazione potente della psicologia cinica di Falstaff.
Un'uguale perfezione d'arte è raggiunta da Verdi nell'altro monologo di Falstaff al 3° atto, dopo che fu gettato nel canale. Il malumore che l'orchestra dipinge con tinte grottescamente cupe, si dissolve in una ripresa di serenità davanti al bicchiere di vin caldo. Ed ecco rinascere col tepore dolce del vino l'ottimismo. L'orchestra è ora un crescendo fragoroso di trilli che sembra dilatarsi fino agli ultimi confini dell'universo con un brillore e una forza soggioganti.
Tutte pagine stupende. Il capolavoro dell'opera però è la ia parte del 2° atto. L'arte, la finezza, l'estrosità con cui si snodano i dialoghi fra Quickly e Falstaff, e poi tra questi e il supposto Fontana, sono soltanto pari alla genialità con cui la musica incide il fare mellifluo e turlupinatorio di Quickly e di Ford, e quello fatuo e vanesio di Falstaff. Segue poi lo sfogo di Ford, dove sotto la sua drammaticità sincera, qua e là volutamente caricata ed enfatica, giuoca un'orchestra che conosce la più umoristica ironia, fino a fargli danzare attorno come un comico spauracchio ossessionante il motivo della frase «dalle due alle tre» e il motivo della cornificazione. Semplicemente meraviglioso è poi il modo come quest'ira grottescamente gelosa (che è la più bella parodia del furore geloso d'Otello) si sgonfia e si allaccia all'elegante e lieve gavottina che accompagna il ritorno di Falstaff incincischiato e infronzolito per il convegno amoroso.
Uomini e donne però hanno un loro interesse artistico anche come gruppi. Negli uomini si direbbe che Verdi abbia voluto parodiare i congiurati del vecchio melodramma tanto l'espressione musicale ne è pedante e grottesca. Ma quando nel 2° atto li scatena alla ricerca di Falstaff, i violini all'unisono attaccano un rapidissimo disegno di «moto perpetuo» pieno di una frenesia che interpreta in modo mirabile la definizione di Falstaff: «Il diavolo cavalca su l'arco d'un violino». Le quattro donne poi sono veramente per l'arguto e brioso cicaleccio, non scevro di maliziosa grazia, le «gaie comari»,
Appartati, sgattaiolando dietro un cespuglio, o approfittando, di un provvidenziale paravento, Fenton e Nannetta vivono il loro amore che la musica ci dipinge pieno di una freschezza giovanile un po' quasi infantilmente giocosa, un po' languida e sentimentale, che non si sa come scaturita con tanta pienezza di vita dal cuore del musicista ottantenne. È uno dei maggiori miracoli dell'opera, e spande attorno un profumo seducente pieno di poesia primaverile e di sole.
L'ultimo quadro ci trasporta in pieno romanticismo fantastico: poesia della natura e poesia fiabesca. Già il finale della parte precedente, con i richiami delle voci che si disperdono, e quell'incielarsi sereno dei violini i cui suoni si dileguano anch'essi in un soffio, ci reca la dolcezza deliziosa della sera tranquilla. Ma i remoti squilli di corno alternati alle armonie dei violini e dei flauti con cui si inizia l'ultima parte, mescolano già l'elemento fantastico alla poesia della solitudine boschiva. Il «sonetto» cantato da Fenton è un soavissimo «notturno» tutto morbidi chiaroscuri sfumati e sospirosa delicatezza di sentimento. L'entrata di Falstaff avviene in un'atmosfera di mistero che la «mezzanotte» con le sue armonie evanescenti, il lungo pedale, i rintocchi lenti, accrescono e circondano di trepidante incantesimo.
Ed ecco la creazione più eterea, più fiabesca che Verdi abbia mai pensato: la «Canzone delle Fate». Mormorio d'archi in sordina leggerissimo, canto che si spande con un senso spaziale arcano, danzetta delle Fate di una mollezza vaporosa, creano una luminosità lunare da paesaggio di sogno estatico. Nuovo ed alto miracolo del vegliardo che ha saputo raggiungere, come disse il Della Corte «un momento ellenico» di assoluta purezza.
La burla fiabesca alterna tratti di un gioco pesante allo scherzo (scherzo anche in senso sinfonico) tutto spumeggiante levità. Al termine della beffa, un elegante minuetto da fare invidia a Mozart e, infine, una chiusura dell'opera che è una colossale burlesca «fuga», quasi una sinfonia corale e strumentale che anzichè aprire l'opera la chiude come un monumentale affresco sonoro; l'ironia della «morale».
Per tutti i caratteri anzidetti il Falstaff di Verdi non è l'ultima opera dell'ottocento, ma già, nello spirito e nella forma, la prima del secolo XX: l'inizio di un verbo nuovo.
ENGELBERTO HUMPERDINCK (Siegburg l854 - Neustrelitz 1921). - HÄNSEL E GRETEL: fiaba musicale in 3 quadri. Prima rappresentazione al Teatro di Corte a Weimar il 23 dicembre 1893. Libretto di Adelaide Wette, tratto dalla nota fiaba dei fratelli Giacomo e Guglielmo Grimm.
Quadro 1° - Povera stanza in casa di Pietro, scopinaio. - Hänsel e Gretel giocano, cantano e danzano spensierati, malgrado la fame, ma non lavorano. La mamma., tornando a casa, li sgrida, e nell'inseguirli rovescia il vaso del latte, unica cena dell'intera famiglia. Esasperata essa manda i bimbi a raccogliere fragole nel bosco. Quando il padre ritorna dalla fiera, un po' alticcio ma contento per avere venduta tutta la sua merce, si preoccupa di quanto ha fatto la moglie. Nel bosco ci sta la strega Marzapane che divora i bimbi. È già sera: lo spavento si impadronisce dei genitori, i quali escono per andare a cercare i figli.
Quadro 2° - Il bosco. - Hänsel e Gretel raccolgono fiori e fragole. Frattanto cala la sera, ed essi non trovano più il sentiero per tornare a casa. I rumori misteriosi del bosco li sgomentano. Ma il nano Sabbiolino sparge su loro la polvere del sonno. I bimbi pregano, e si addormentano. Nel sonno appare loro una scala erta fino al Cielo, dalla quale scendono quattordici angeli che li circondano per proteggerli.
Quadro 3° - Il bosco come nel quadro precedente. La luce dell'alba permette di vedere sul fondo la casa della Strega Marzapane. - Il nano Rugiadoso sveglia i bimbi, i quali incuriositi dall'aspetto della casa e dall'odore che ne emana ne assaggiano dei pezzetti. La strega esce, mette in capponaia Hänsel e ordina a Gretel di osservare il fuoco nel forno; però Gretel finge di non sapere come si fa. La strega allora si avvicina al forno, ma Gretel ed Hänsel, il quale frattanto è uscito dalla stia, la cacciano nel forno. La casa della strega crolla e appare una siepe di bambini viventi, che però non possono muoversi. Gretel, servendosi della bacchetta magica della strega e ripetendo parole che le aveva udito dire, distrugge l'incantesimo che li teneva fermi. Mentre i fanciulli circondano i due liberatori festeggiandoli e ringraziandoli, giungono il padre e la madre di Hänsel e Gretel, felici di aver ritrovati sani e salvi i figli. Dal forno scoppiato viene estratta la Strega trasformata in marzapane.
Lo stile sinfonico di Humperdinck è una diretta derivazione di quello di Wagner. Anche i motivi talvolta arieggiano da vicino taluni temi wagneriani, però con maggiore ampiezza melodica. Ma il tematismo non è così stretto come in Wagner. Vi è inoltre nel sinfonismo di Humperdinck una chiarezza trasparente e un'eleganza aristocratica che meglio s'addicono alla tenue fiaba. I ritmi di danza e la natura delle canzoni ravvivano la partitura di un soffio popolaresco e di una leggiadria che nettamente la distinguono da quanto ha scritto Wagner. Non ci sono sottintesi metafisici, non ci sono simboli reconditi: si respira un'aria di infantile (ma non puerile) gaiezza piena di ingenuo candore, che il sinfonismo orchestrale non appesantisce e non offusca mai.
Anche nei momenti d'apparenza più drammatica il musicista non ingrossa la voce: se la madre rincorre i fanciulli, se il padre narra la leggenda della Strega Marzapane, se i bimbi si spaventano della notte nel bosco o se compare la strega e li minaccia, il volto della musica rimane sereno, il tono si conserva immutabilmente fiabesco e leggendario. Ed è in questo aver saputo schivare così il pericolo della turgescenza wagneriana come del melodrammismo che consiste il maggior pregio dell'opera e la ragione della sua vitalità. Ed è per questo che a ragione Riccardo Strauss ha potuto scrivere che si tratta di un capolavoro.
Quel tanto di religioso che vi introduce il motivo della preghiera dei bimbi nel bosco e il sogno della scala che scende dal Cielo con gli angeli custodi, non ha nessuna pretensiosità mistica, ma si mantiene in una schietta semplicità novellistica. Ed anche la frase che i bimbi dicono d'aver sentito cantare dal padre: «Quand'è più crucciato il cor, la sua man stende il Signor», e che si ripete come una morale della favola alla chiusa dell'opera, non assume toni profetici, ma esce con semplice calore e candore, e solo nel finale si allarga con maggiore solennità conclusiva e affermativa.
I due fanciulli sono felicemente disegnati, non solo attraverso alle canzoncine («Mamma, questo chiasso», con le graziose interruzioni che l'uno fa all'altro e che si innestano così bene nella linea principale; e l'altra del 2° quadro: «Nel bosco c'è un ometto», tolte a motivi popolari) ma anche nei ritmi di danza giocosamente infantili e pure d'intonazione, se non d'origine, popolaresca; nell'ingenua e casta preghiera: «Se mi serbo a Dio fedel», e in una quantità di tocchi di una freschezza talvolta monellesca, talvolta fantasiosa com'è proprio dei bimbi che sognano ad occhi aperti sogni innocenti e sereni.
Mamma Geltrude è un caratterino piuttosto bisbetico e impetuoso, ma in fondo di buon cuore, e dopo la sfuriata contro i bimbi la udiamo piangere dolente invocando un tozzo di pane pei suoi figlioletti.
Babbo Pietro rientra un po' brillo, quel tanto che basta a diventare espansivo e canterino, ma non a perdere la testa; la sua canzone: «Per noi miseri mortali» ha perciò uno svolgimento allegro ma logico. Con il racconto: «Sta laggiù una versiera» il suo canto si stacca dal mondo realistico per rientrare anch'esso in quello della «ballata» leggendaria e fiabesca.
Del mondo magico fiabesco fa parte la Strega, il cui tema, annunziato la prima volta dai timpani col «tema della scopa», è derivazione, forse involontaria, del tema selvaggio dell'Olandese volante nel Vascello fantasma e dei giganti dell'Oro del Reno di Wagner. Gli altri motivi chela riguardano hanno espressione melliflua, o di un diabolico grottesco, od anche d'incantesimo magico, come appunto allorchè la strega incanta Hänsel. La sua più pittoresca rappresentazione (anzi pittorica in senso precisamente fiabesco) è nella ballata; «Su, hopp, hopp, Galopp, lopp, lopp», che essa canta lanciandosi con frenetica gioia a volo su la scopa.
Altre due figurette fragranti di ingenua e gentile grazia sono i due nani, Sabbiolino e Rugiadoso, il cui canto porta nella fiaba musicale accenti lirici pieni di sfumature delicate.
L'elemento favoloso si integra poi con quello miracolistico (discesa degli Angeli a protezione dei bimbi, pagina musicale tutta splendente di una chiarità strumentale luminosa e di una dolcezza mite) e col sentimento misterioso della natura. Quest'ultimo si esprime attraverso a quella specie di «incantesimo del bosco» in cui su motivi scorrevoli pieni di arcana dolcezza si innesta, lontano, il canto del cucù. Fra questi motivi uno ve n'ha, più ampio e patetico, intonato dal como o dal clarinetto, che ha qualche parentela con il motivo della sera nel 2° atto dei Maestri Cantori di Wagner. Sentimento delta notte, del bosco e dei loro misteri paurosi è anche negli echi remoti che rispondono ai richiami de bimbi, e nella scena del loro risveglio, piena ancora di un evanescente sognare e di ammirato stupore.
L'orchestrazione è un gioiello di colori, di impasti, di parti armoniosamente intrecciate, un gioiello in cui si direbbe si fondano insieme la sapienza tedesca e l'eleganza francese.
GIULIO MASSENET - THAÏS: dramma lirico in 3 atti e 7 quadri. Prima rappresentazione all'Opera di Parigi il 16 marzo 1894. Libretto di Luigi Gallet, tratto dal romanzo omonimo di Anatole Trance.
Atto 1° - Quadro 1° - Le capanne dei cenobinti su le rive del Nilo nella Tebaide. - Atanaele, di ritorno da Alessandria, narra la corruzione della città e la scandalosa vita della cortigiana Thaìs. Nella notte in sogno gli appare Thaïs seminuda tra la folla. Destatosi pieno di orrore decide di recarsi di nuovo ad Alessandria per convertirla e, non ostante il contrario parere del vecchio Palemone, parte.
Quadro 2° - Il terrazzo della casa del giovane filosofo sibarita Nicia, - Atanaele ottiene da Nicia, amante di Thaïs, per la quale ha disperso ogni suo avere, di poter parlare alla cortigiana. Fra gli scherni degli adoratori di Thais, Atanaele inveisce contro i piaceri dei sensi. Thaïs, con atteggiamenti di seduzione, lo invita a recarsi a casa sua, egli che sfida l'amore!
Atto 2° - Quadro 1° - In casa di Thaïs. - La cortigiana sente la propria anima vuota, sazia dei piaceri sensuali; ella teme che da un giorno all'altro, lo specchio le scopra i segni della vecchiaia devastatrice della sua bellezza. D'improvviso su la porta appare Atanaele. Egli le parla di un amore e di una felicità che ancora le sono ignoti e della vita eterna. Thaïs è sgomenta; Atanaele le dice che l'attenderà su la soglia fino all'alba.
Quadro 2° - Piazza innanzi alla casa di Thaïs. - Ad Atanaele che aspetta, Thaïs viene a dire che Dio le ha parlato, e Atanaele le annunzia che l'accompagnerà a un convento. Ma prima essa deve distruggere tutto ciò che ricorda la sua vita impura, e dar fuoco alla casa. Nicia, che ha vinto al gioco, torna a chiedere ancora a Thais il suo amore, ma essa è decisa a partire con Atanaele. Invano gli adoratori di Thais tentano di impedirlo scagliando pietre contro Atanaele. Allora Nicia stesso si interpone, e gettando il proprio oro alla folla la trattiene, mentre la casa di Thais arde, e la donna si allontana con Atanaele.
Atto 3° - Quadro 1° - L'oasi. - Thaïs, esausta dal lungo cammino, non è più buona di procedere, Atanaele che prima l'incitava aspramente a proseguire, vedendole i piedi insanguinati prova una viva pietà, la fa sedere e le reca dall'oasi frutta ed acqua per ristorarla. Frattanto giunge con alcune suore l'Abbadessa Albina, alla quale Atanaele affida Thais. Ma vedendola allontanarsi sente una commozione nuova, e una dolorosa angoscia l'opprime al pensiero che non la vedrà più.
Quadro 2° - Scena come al 1° quadro del 1° atto. - Dal giorno che abbandonò Thaïs, Atanaele si strugge di amore per lei. Palemone dolcemente lo rimprovera di non aver ascoltato i suoi consigli. Nella notte egli risogna Thaïs nel suo aspetto più provocante, poscia una improvvisa visione gli annuncia che Thais muore. Atanaele allora fugge disperato per rivederla ancora.
Quadro 3° - Giardino nel monastero di Albina. - Thaïs, circondata dalle suore, stesa sotto un albero, è morente. Al giungere d'Atanaele, le suore rispettose si ritirano. Egli ora dice a Thaïs il proprio amore per lei, amore dei sensi; ma Thaïs estatica non sa che parlare dell'amore celeste ed eterno di Dio, e spira nella visione del Paradiso, mentre Atanaele dà in un grido disperato.
Thaïs non raggiunge la forza espressiva nè la bellezza melodiosa di Manon e di Werther. I caratteri dei personaggi non vi sono così fortemente modellati nè le situazioni drammatiche così profondamente scolpite come nelle due maggiori opere precedenti. Tuttavia essa abbonda di pagine ricche di penetrante lirismo, di efficace evidenza rappresentativa, disegnate, costruite, armonizzate e strumentate con la finezza aristocratica e con il gusto elegante propri del più signorile fra i compositori francesi dell'ottocento. L'atmosfera di calma pensosità, di mistica astrazione del cenobio della Tebaide, che si concreta in accordi larghi, evanescenti, in melodie lineari, in contrappunti meditativi su temi d'espressione sacra, ha un delicato potere di suggestione.
A questo ambiente fa contrasto quello frivolo, tumultuoso, in qualche momento un poco volgare, di Alessandria, la citta corrotta ove Thaïs è sovrana dei piaceri mondani. La quale Thais nella musica necessariamente si sdoppia. Nel 1° atto essa si presenta avvolta dal lascivo calore di motivi molli e languidi: tipici l'introduzione al 2° quadro, gli orientaleggianti melismi di Crobyla e Minale, il nostalgico e delicato duetto con Nicia, e, più voluttuosamente ricca di seduzione, la melodia che chiude l'atto: «Perchè tanto severo» e che si apprende come un'ondata di contagio amoroso alla folla.
Ma nel 2° atto Thaïs è già in crisi. Nelle sue ripetute invocazioni allo specchio; «che son bella dì», passa insieme al desiderio ancor vivo dell'ebbrezza un senso di ignota angoscia e di terrore. E negli atti successivi non resta dell'impudica Thais neppure il ricordo. Tutto si è in lei purificato attraverso a quella «Meditazione» che segna il trapasso dalla vita profana a quella sacra. Il violino accompagnato dall'arpa, e a quando a quando da armoniosi sospiri degli archi, espone una melodia casta e dolcissima, non scevra da qualche ansiosità nella parte centrale. Vi alita un sentimento di aspirazione alla pace di una femminile religiosità. La purificazione della donna appare compiuta nel quadro dell'oasi (1° dell'atto 3°), che è il più bello dell'opera. Una stanchezza e una tristezza mortale è nel breve preludio e nella prima parte del quadro. Ma il duettino: «D'acqua aspergimi» ha il respiro di un idillio biblico e suggerisce le più fresche e monde emozioni spirituali.
Nella scena della morte l'autore abusa alquanto del motivo della «meditazione», ma l'ultima ampia frase alle parole di Thaïs: «Due serafini dall'ali candide», sviluppo della frase di Atanaele (atto 1° quadro 1°): «e dal ciel gli angeli l'affisan», reca un senso di elevazione, un soffio trasfiguratore di nobile grandezza.
Atanaele fino dal 1° atto è dipinto come un temperamento passionale, impulsivo, allucinato. Il suo racconto «Ahimè! fanciullo ancora» è un canto in cui la passione amorosa si cela, pure ammantata da un sentimento di pietà religiosa. Amore sacro e amore profano si mescolano nei suoi accenti, anche nell'entusiastica decisione di partire: «Tu, che a noi la pietade infondesti», di uno slancio melodico troppo caldo ed espansivo perchè sia tutto amore sacro. Atanaele però non se ne rende conto, se non vagamente, come nella palpitante invocazione: «Signor! deh, fa che il suo raggiante viso velato rassembri al mio sguardo» (atto 2° quadro 1°), che è un parlato su una nota sola, ma i lunghi accordi stupiti e la tempesta delle terzine che ribattono anch'esse la stessa nota del canto, dicono il tremito da cui è preso il cuore dell'uomo. Anche l'affermazione: «Ah, sì, t'amo, Thaïs», che vuole alludere a un amore sacro, è troppo fervidamente appassionata per essere animata solo da questo sentimento. Ma dopo che Thaìs è partita con Albina, la rivelazione della verità prorompe nel grido d'angoscia: «Più non la rivedrò!», poi con maggior veemenza di ardore nella confessione fatta a Palemone: «Io non vedo che Thaïs», ed è ormai rovente incancellabile coscienza di colpa nel grido: «Allor qual scopo ha il ciel», e nelle ultime frasi d'amore dirette alla morente che non le comprende più.
Il colore orientale affiora solo nel 2° quadro del 1° e del 2° atto, non solo nei vocalizzi di Crobyla e Mirtale, ma nella scena dalle tinte e dai disegni così lievi e motteggianti in cui le schiave di Nicia, profumano e acconciano Atanaele per il banchetto, ed anche nelle nenie e nelle danze dai ritmi insistenti e marcati, dagli atteggiamenti melici pieni di sensuale languore e pregni di un indefinibile profumo esotico del 2° quadro atto 2°.
PIETRO MASCAGNI - GUGLIELMO RATCLIFF: tragedia in 4 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 16 febbraio 1895. Testo di Enrico Heine; traduzione di Andrea Maffei. - L'azione si svolge nella Scozia settentrionale verso il 1820.
Atto 1° - Stanza nel castello di Mac-Gregor. - Il Conte Douglas, fidanzato della figlia di Mac-Gregor, Maria, venuto per sposarla, racconta come nel bosco di Invernè fu assalito da ladroni e salvato da un giovane sconosciuto. Alla notizia Maria sviene; ritornata in sè e condotta via dalla nutrice, «la pazza Margherita», Mac-Gregor racconta a Douglas come altri due fidanzati di Maria, Filippo Macdonaldo e Lord Duncano, siano stati uccisi il giorno delle nozze. Entrambe le volte, la sera stessa dell'uccisione, Guglielmo Ratcliff, innamorato respinto da Maria, penetrò nella sua stanza e le presentò l'anello dello sposo ucciso. Mentre, rimasto solo, Douglas medita su questi fatti, Lesley, amico di Ratcliff, gli reca un biglietto di questi che lo invita a recarsi al Negro sasso. Douglas fa rispondere a Ratcliff che vi andrà.
Atto 2° - La taverna dei ladri. - Alcuni malfattori dormono sdraiati per terra. Tom, roste, fa recitare il Pater noster al figlioletto Willie, e gli insegna a rubare dalle tasche dei ladri addormentati. Lesley viene ad annunciare a Ratcliff che Douglas accetta la sfida. Gli chiede poi che cosa gli abbia fatto quest'uomo da volerlo morto. Guglielmo gli narra allora come fino da fanciullo spesso gli siano apparsi due nebulosi fantasmi di uomo e di donna che si tendevano amorosamente le braccia, senza potersi congiungere. Allorchè vide per la prima volta Maria, riconobbe in lei una perfetta somiglianza con il fantasma femminile, e subito l'amò; ma essa lo respinse duramente. Egli allora giurò di uccidere chiunque avesse osato fidanzarsi a Maria, e mantenne il giuramento. Per questo ha ora sfidato Douglas. Improvvisamente dà un grido: egli vede i due aerei spettri. Il suo urlo desta i ladri; la visione scompare. Ratcliff esce con Lesley per recarsi al Negro Sasso. È notte alta; i ladri anch'essi si disperdono per il loro lavoro.
Atto 3° - Luogo selvaggio presso «il Negro Sasso». - Ratcliff attende Douglas, che giungendo riconosce in Ratcliff colui che lo salvò dagli assassini e gli chiede amicizia. Ma Guglielmo, saputo che è il conte Douglas, gli dice il proprio nome e lo sfida. Douglas sta per essere vinto; invoca allora gli spiriti di Macdonaldo e di Duncano, i quali apparendo combattono per lui. Ratcliff è atterrato, ma Douglas gli fa grazia della vita in ricambio di avergli prima salvata la sua.
Atto 4° - Camera nel castello di Mac-Gregor. - Margherita sta abbigliando Maria per le nozze e le racconta che sua madre Elisa amava Edvardo Ratcliff, padre di Guglielmo, e che per un dispetto lo rifiutò sposandosi a Mac-Gregor. Anche Edvardo si sposò allora per dispetto con Ginevra Camper, da cui nacque Guglielmo. Ma non potè dimenticare Elisa; e andava aggirandosi attorno al castello di Mac-Gregor, il quale ingelosito l'uccise. Elisa ne morì di spavento. Mentre Margherita così racconta, appare Guglielmo ferito, il quale narra a Maria la propria sconfitta. Maria, presa da improvvisa pietà ed amore, lo benda e lo bada; ma tosto ritorna in sè e gli ordina di partire. In questo momento Margherita si mette a cantare una tetra canzone: la storia di Edvardo e della bella Elisa. Ratcliff a quel canto è preso da sùbita demenza. Maria fugge gridando terrorizzata, ma Guglielmo la insegue nella stanza accanto e l'uccide. Alle grida di Maria sopraggiunge Mac-Gregor che vedendo Ratcliff si avventa su di lui; ma Guglielmo lo trafìgge, poscia va ad uccidersi accanto a Maria. Frattanto la pazza Margherita continua la sua funesta canzone, e scopre a Douglas, agli ospiti e ai servi accorsi i cadaveri di Guglielmo e di Maria.
Malgrado qualche momento sciatto per l'uso di formule viete, e qualche lungaggine per avere il Maestro musicato la tragedia di Heine quasi per intero, è questa l'opera più drammaticamente forte composta da Mascagni. Il poema romanticissimo di Heine, in cui su gli avvenimenti tragici si innestano il soprannaturale fantastico e la follìa, dove ciò che accade sembra predestinato da misteriose forze dell'al di là, le quali creano incubi paurosi e determinano gli atti più violenti dei protagonisti, sembra raggiungere in qualche pagina il grottesco, tanto che ci fu chi interpretò la tragedia come una voluta ironica parodia del romanticismo. Mascagni non ha seguita questa corrente; l'interpretazione musicale è quella che spetta al dramma preso sul serio, anche nelle sue cause metafisiche e metapsichiche.
Ratcliff è un poeta spregiudicato e allucinato, tempestosamente sbattuto fra il suo più profondo sentimento d'amore per Maria, il suo odio per chi gliela rapisce, le allucinazioni spettrali, e la magnetica forza che gli comanda, suo malgrado, di uccidere la sua cara. Il suo lunghissimo racconto del 2° atto ha un alto soffio lirico. Alle parole: «vi sono strane orribili posse a cui soggiaccio», i violini svolgono per la prima volta il largo motivo pieno di mistero, che verrà poi sviluppato nell'interludio del 3° atto allorchè Guglielmo cade sotto la spada di Douglas. Ma subito dopo, all'inizio vero e proprio del racconto: «Quando fanciullo ancora», Mascagni ci dà una delle sue più belle melodie, dal respiro ampio, che ha un fare discorsivo, anzi narrativo e un sentimento penetrante. Il sentimento poetico si slarga e sale ancor più alla frase: «Sul viso avea le rose», che ondeggia fra la calda sensualità e il rapimento poetico, senza false sdolcinature. Poi la musica segue le varie frasi del racconto con calore intimo e nello stesso tempo espansivo. La rievocazione del passato accende a Ratcliff il cuore, dal quale sgorga in piena sincerità la canzone dei ricordi. Non così schietti e forti gli accenti dell'odio, che cadono nell'enfasi.
Più romantici e drammatici i due monologhi del 3° atto; però le melodie hanno sempre quel disegno largo che è tipico del migliore Mascagni, dove il calore è soffio vitale, lontano da ogni sentimentalismo. Fra le cose più profonde del primo soliloquio è la meditazione sul bacio alla bocca dell'arma che potrebbe ucciderlo con un semplice tocco della mano. È una melodia in cui vibra un fascino sottile, un'estasi di sogno ipnotico, quasi l'atmosfera di un mondo d'oltretomba pieno di una pace serena, dolcissima. Ma non è solo l'espressione che qui conta; è anche la finezza elegante e sobria della costruzione e l'abile intreccio di due canti diversi, quello della voce e quello dell'orchestra, che sommandosi aggiungono anima ad anima, colore a colore.
Dopo il duello con Douglas, eccoci al famoso interludio detto «il Sogno di Ratcliff», il cui motivo non ha sviluppi sinfonici (Mascagni sinfonista non è mai), ma si ripete più volte svariando di timbri e di intensità per declinare e svaporare in un lento arpeggio e in un sospiro. «In realtà - scriveva il Bastianelli - è un grande sogno d'amore: un sogno stanco e doloroso come la contemplazione d'un destino che, immutabile, contrasti un amore profondo». Segue un altro lungo soliloquio che, dopo varie alternative drammatiche ed enfatiche, sfocia in un altro canto largo e di forte drammaticità: «Ombra esecrata, nebbia che mi persegui».
La lunga e faticosa parte di Ratcliff, che non solo per la sua lunghezza ma per la sua tessitura alta trova assai difficilmente il tenore che possa reggerla senza sfiatarsi, ci presenta nuove pagine bellissime non solo nel drammatico duetto con Maria, nella stupita e fremente interrogazione: «Un sogno è questo?», dalla linea così nuova ed audace, nel fascinoso raffronto allo specchio: «I tuoi sembianti son più belli», ma nella dolente e stanca ultima frase: « Già della pace le dolcezze pregusto», in cui è un così forte anelito di disperato riposo.
Maria, Mac-Gregor, Douglas, sono al confronto figure musicalmente assai meno importanti, non ostante alcune ispirazioni felici, come, ad esempio, la descrizione che Maria fa nel 3° atto del carattere di Guglielmo da giovane: «D'indole dolce e mansueta», di una melodia tenera e semplice sostenuta da un patetico contraccanto del violoncello. Così pure il racconto animato di Douglas su la vita di Londra nel 1° atto, e il lungo e robusto racconto di Mac-Gregor: «Già corre il sesto anno», in forma di ballata romantica strofìca, solcata da foschi bagliori di tragedia.
Preminente nel dramma e risolutrice di esso è invece «la pazza Margherita», colei che conosce il passato e perciò è presciente dell'avvenire; rappresentazione romantica del Fato e della sua saggezza sotto l'aspetto della follia. Mascagni ha saputo coglierne il volto e l'anima fino dal primo tema enigmatico del preludio, nel quale si innesta la canzone di Margherita: «Uccisa ho la mia cara». I motivi successivi del preludio ripetono quelli della tragica storia di Edvardo e di Elisa, che Margherita narrerà nell'ultimo atto. Il preludio è dunque un anticipo strumentale dell'epìlogo. L'intervento di Margherita allorchè Maria sviene, e la sua canzoncina: «Apri, piccina, bambola mia, gli occhietti cari», che ha una bella vaghezza di lineature e un'espressione di tenero affetto, e il suo scatto impetuoso e allusivo contro Mac-Gregor, disegnano un carattere complesso e denso di significazione drammatica.
Ma dove il personaggio di Margherita assurge ad alta espressione tragica è nel racconto dell'ultimo atto. La musica di esso, come si è detto, è già tutta nel preludio del 1° atto, ma l'alternanza delle frasi melodiche a quelle recitative, quasi parlate, conferisce alla narrazione una grande varietà ed efficacia espressiva. Specialmente potente dove il «parlato» si svolge su note basse, come un vaniloquio freddo ed assente, sprofondandosi sempre più e perdendosi come in un incubo pauroso.
Ma in quest'opera così austera, elaborata anche dal lato strumentale con maggior impegno di quelle precedenti, c'è dell'altro. Non si può non ricordare la caratteristica rappresentazione dell'ambiente in cui si svolge il 2° atto: la taverna dei ladri, con quel candido Pater noster del piccolo Willie che inciampa sempre su la frase: «non lasciarci tentar dal male»; la descrizione ironica e grottesca dei tristi avventori addormentati fatta dall'oste Tom; il loro risveglio e i commenti beffardi mentre un motivo pastorale dell'oboe penetra dalla porta aperta come una ventata d'aria sana e crea un così vivo contrasto con i discorsi dei malandrini.
Infine c'è un gioiello strumentale: l'intermezzo che precede il 4° atto e che descrive la gioia serena della festa nuziale: una delle pagine più belle e schiette che Mascagni abbia scritto. Le melodiose risatine interne delle voci femminili, i lunghi arpeggi, certi atteggiamenti capricciosi, e la flessuosa morbidezza dell'ultimo tempo del valzer lento, donano a questo pezzo una grazia molle e voluttuosa ricca di fascino, peraltro senza languore. È, nella tetra nuvolaglia della tragedia spiritica, un raggio di sole purissimo.
GIACOMO PUCCINI - LA BOHÈME: opera in 4 quadri. Prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896. Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, dal romanzo La vie de Bohème di Enrico Murger.
Quadro 1° - In soffitta: ampia finestra sul fondo; caminetto spento da un lato. - Il pittore Marcella lavora al quadro «Il passaggio del Mar Rosso», mentre il poeta Rodolfo guarda pensoso fuori dalla finestra. Entrambi sono senza un soldo, hanno freddo e fame, e tentano invano di scaldarsi dando alle fiamme un dramma di Rodolfo. Anche il filosofo Colline ritorna a casa a tasche vuote. Ma giunge frattanto il musicista Schaunard con legna, viveri, e denaro ch'egli ha guadagnato da un inglese. I bohèmiens accendono il fuoco e preparano la cena; ma bussa alla porta Benoit, il padrone di casa, per l'affitto. Gli amici lo accolgono cordialmente, ma fattogli confessare che, pur avendo moglie, è stato con una donnetta allegra, lo scacciano fingendosi scandalizzati. È la vigilia di Natale e gli amici pensano di cenare al Quartiere Latino da Momus. Resta solo Rodolfo per terminare un articolo. Mentre scrive, si bussa di nuovo alla porta. È la vicina fiorista. Mimi, alla quale salendo s'è spento il lume; ma si sente male, Rodolfo la soccorre e le riaccende il lume; però, come fa per partire, Mimì si ricorda che le è caduta la chiave della stanza. Il suo lume si spegne di nuovo, ed anche quello di Rodolfo, che al buio trova la chiave e la intasca. Fingendo di cercare incontra la mano gelida di Mimì; la trattiene nella sua per riscaldarla, e intanto le parla di sè. Mimì risponde narrandogli chi ella è e che fa. I due giovani presto si intendono. Gli amici chiamano da basso, e Mimì scende a braccio di Rodolfo dicendogli che l'ama.
Quadro 2° - Crocicchio al Quartiere Latino; da un lato il Caffè Momus. - Venditori e folla d'ogni genere s'aggirano, conversano, gridano. I quattro amici e Mimì si siedono a un tavolo. A un altro vicino càpita Musetta, col suo vecchio e ricco ganzo Alcindoro. Essa fu l'amante di Marcello, e l'ama ancora. Marcello è roso dalla gelosia, essa lo provoca. Alla fine, mentre Alcindoro si è allontanato un istante, essa si getta fra le braccia di Marcello, indi parte con lui, lasciando da pagare ad Alcindoro il conto proprio e quello degli amici.
Quadro 3° - La barriera d'Enfer. Da un lato un Cabarè. -Alba nevosa. Giunge Mimì, sfinita: la tosse non le dà tregua. Essa fa chiamare Marcello al quale narra che Rodolfo è geloso e vuole lasciarla. Mentre parla a Marcello, Rodolfo esce dal Cabarè, e Mimi si nasconde dietro un albero. Di lì sente il colloquio dei due amici e apprende la verità: Rodolfo l'ama, ma vuol lasciarla perchè essa è mortalmente ammalata ed egli non ha mezzi per curarla. I singhiozzi e la tosse svelano a Rodolfo la sua presenza. Egli la rassicura: si divideranno a primavera. Frattanto si ode Musetta ridere sguaiatamente all'interno del Cabarè. Essa civettava con un signore. Fra lei e Marcello si svolge una lite violenta, e si separano lanciandosi insolenze.
Quadro 4° - La scena del 1° quadro. - Marcello e Rodolfo pensano rispettivamente a Musetta e a Mimì, dalle quali si sono separati, e che amano ancora. Indi con Schaunard e Colline si apprestano ad una magra cena, allorchè irrompe nella stanza Musetta. Essa accompagna Mimi che, sentendosi morire, è venuta per ricongiungersi a Rodolfo. Viene adagiata su un letto: Musetta dà a Mar cello i propri orecchini affinchè li venda e comperi medicine e un manicotto per ì ed esce con lui. Colline decide di portare al Monte di pietà la propria vecchia zimarra, indiparte con Schaunard. I due amanti, rimasti soli, rievocano le ore/elici del loro amore. Ma a un tratto Mimì sta male. Accorrono gli amici; Musetta consegna a Mimì il manicotto dicendole che è un dono di Rodolfo. Poste le mani al caldo Mimì si assopisce, ma di lì a poco Schaunard si accorge che è spirata. Con un grido disperato Rodolfo si precipita sul cadavere della donna.
La Bohème, contro la quale per lungo tempo si sono scagliate le ironie della critica, è un autentico capolavoro. Abbondanza di melodia, finezza e chiarezza di stile, suggestiva ambientazione e caratterizzazione dei personaggi, commossa forza di espressione del dramma, squisita fattura di particolari, equilibrio dell'insieme, salda e preziosa struttura armonica, strumentale pieno di buon gusto, sono i pregi fondamentali e indiscutibili dell'opera.
Detto questo possiamo anche accennare alle mende (principalmente due) di cui anche i capolavori non vanno esenti, ma che non infirmano la bellezza totale dell'opera. Alcuni personaggi sono presentati da brevi temi che si ripetono sempre uguali a sè stessi. Sono temi superficiali, senza capacità di sviluppo sinfonico e senza profonde significazioni: la fragile sentimentale ragazza che chiamano Mimi; Rodolfo, il contemplativo dei deli bigi, Schaunard, il rumoroso, Musetta civettuola di buon cuore, i bohèmiens eccentrici e gioviali. La loro stereotipa fisonomia e le ripetizioni meccaniche di questi temi hanno un carattere piuttosto puerile, e se i personaggi appaiono vivi lo debbono a ben altro. Il secondo difetto è una certa tendenza al sentimentalismo dei motivi riguardanti Mimì e Rodolfo; tendenza nella quale il Maestro ricadrà anche nelle opere successive; tendenza esagerata dal cattivo gusto dei divi e, per scopo polemico, dalla critica ostile a Puccini.
Aggiungiamo ancora che l'opera si regge soprattutto per il sentimento lirico delle sue melodie e per la raffinatezza elegante dello stile, che risente qua e là dell'influsso massenetiano. Nell'ultimo quadro, che per Fazione è il più drammatico, la musica raggiunge la necessaria forza principalmente in due momenti: all'entrata di Musetta, su la frase dei violini impetuosa e sconvolta dall'angoscia, che segue la notizia: «Nel far le scale più non si resse»; e dopo la morte di Mimì negli accordi gravi, severi, che dal fortissimo scendono paurosamente al pianissimo con quattro p, seguenti la perorazione in cui la frase «fingevo di dormire» è ripresa dall'orchestra a tutta forza.
Ma in queste ultime scene del 4° quadro Puccini lascia abilmente emergere l'azione, limitandosi a ripetere motivi già uditi nei quadri precedenti; solo, nel ripeterli, vi aggiunge tinte diafane e un senso di estenuazione mortale, facendo leva su la forza di commozione dei sentimenti che testo e musica possono generare. È innegabile che, sia pure seguendo un metodo lirico indiretto. Puccini è riuscito a darci in quest'ultima parte dell'opera quell'atmosfera di morte imminente che avviluppa la scena e per essa i cuori in un velo di tristezza pieno di delicata poesia. Perchè come creatore di atmosfere - come notò anche il Gui - Puccini ha pochi che lo uguaglino. Basterebbe pensare alla semplicità efficacissima con cui egli ci dà l'atmosfera grigia, nevischiosa fredda e uggiosa del paesaggio invernale mattutino all'inizio del 3° quadro: un lungo pedale di quinta bassa (142 battute) in un brusìo confuso di tremolo su cui i flauti lasciano cadere le loro gelide quinte parallele (che irritarono tanto i pedanti!), cui si sovrappongono le grida degli spazzini e la risposta annoiata del doganiere. Da tutto ciò emana una tristezza indefinibile che prepara l'animo ai casi dolenti successivi.
Quanto alla bellezza ed espressività delle melodie di questa opera, esse sono nella memoria di tutti senza bisogno che ci soffermiamo in modo speciale a ricordarle. Sorvolando su «i deli bigi», è soprattutto nel grande duetto del 1° quadro che troviamo le melodie fondamentali dell'amore di Mimì e di Rodolfo, dalla tenerezza della frase «Che gèlida manina», all'espansivo «Talor dal mio forziere»; dalla semplicità affettuosa del «Mi chiamano Mimì», alla sfumatura piena di sottinteso del «Mi piaccion quelle cose che han nome poesia», e a quel sollevarsi dell'anima in un'alata pienezza di vita lirica del: «Ma quando vien lo sgelo». Poi, nel 3° quadro, viene la dolorosa confessione di Rodolfo: «Invano, invan nascondo la mia vera tortura», e la funebre tristezza del «Mimì è tanto malata», seguìta dalla scoperta di Mimì in ascolto e dal nostalgico «Addio, dolce svegliare alla mattina». Su questa nostalgia in cui sono rapiti i due amanti si innesta la petulante civetteria di Musetta e l'ira gelosa di Marcello: quartetto che in realtà, per i tre diversi sentimenti simultaneamente espressi si potrebbe considerare un terzetto, non essendo le voci di Mimì e di Rodolfo che l'integrazione l'una dell'altra nello svolgimento di un unico pensiero melodico.
Nel 4° quadro ancora una bella pagina nel commosso rimpianto nostalgico: «O Mimì, tu più non torni»; e dopo l'arrivo di Mimì, una frase che è un poema di vita, in una progressione ascendente piena di un anelito che rapisce: «Si rinasce!», l'ultimo grido di un'anima che aspira a risorgere e ad amare, e che si smorza tristemente nel commento sottovoce di Schaunard: «Fra mezz'ora è morta». E in questo contrasto è ancora uno dei rari momenti di forza drammatica di Puccini.
Rimasti soli Mimì e Rodolfo, l'amore dà i suoi ultimi bagliori, nella dolcezza della melodia: «Sono andati? Fingevo di dormire», canto lento e un po' stanco, ultimo canto d'amore. Colei che fìnge di dormire, si assopirà (gli estenuati accordi finali dopo l'ultima parola di Mimì: «dormire!») e non si risveglierà più. Il motivo dell'amore proromperà allora con sonorità soggiogante divenendo il canto di morte: la finzione divenuta realtà!
Marcello e Schaunard, sono schizzati più come macchiette che come persone; e così anche Colline, non ostante che acquisti per un momento una profonda umanità nel malinconico e nostalgico addio alla «vecchia zimarra». Già più volte ci è avvenuto di scrivere la parola nostalgia, ed è bene soffermare l'attenzione di chi ascolta la musica di Puccini su questo carattere che è uno dei più profondi e tipici della sua genialità, e che gli ha dettato nella Bohème, come gli dettò nelle opere successive, molte delle sue pagine più poetiche.
Musetta, dalla sua apparizione nel 2° quadro è sempre accompagnata da motivi brillanti, piccanti e civettuoli. Il suo canto passa da frasi di una sensualità provocante a recitativi capricciosi e stizziti, ed esplode poi nel languido e voluttuoso «Valzer lento» le cui linee melodiche flessuose e molli sembrano ripetere atteggiamenti della più procace seduzione.
Se Marcello e Schaunard hanno un rilievo macchiettistico, personaggi perfettamente comici sono Benoit e Alcindoro. La «vita gaia e terribile» della bohème ci presenta in loro il volto gaio, da opera buffa; come del resto da opera buffa sono molte altre scene: l'entrata e il racconto inascoltato di Schaunard, tutto il 2° atto» di una vivacità di movenze e di una ricchezza di colore nuovissime, e la scena che precede l'arrivo di Musetta e Mimì nell'ultimo quadro, con la parodia del pranzo, dei modi aristocratici, delle danze e del duello grottesco. Ed anche questo mescolare il pianto al riso con tanta scioltezza sicura e spontanea di modi, come nella vita, costituisce uno dei segni di grandezza di quest'opera.
PIETRO MASCAGNI - ZANETTO: opera in un atto. Prima rappresentazione al Teatro Rossini di Pesaro il 2 marzo 1896. Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla commedia «Le Passant» di Francois Coppé.
Atto unico. - Un parco presso Firenze davanti alla palazzina di Silvia. - La cortigiana Silvia è triste, scontenta della propria vita che è la negazione del vero amore. Giunge frattanto Zanetto, un giovane nomade cantore. La donna è presa da un sùbito fascino per lui e lo interroga. Al sentire che voleva conoscere Silvia, di cui aveva sentito decantare le grazie, essa lo sconsiglia dal cercarla. Ma ora Zanetto, anch'egli affascinato dalla bellezza della ignota, le chiede di poter restare con lei. Silvia è sul punto di obbedire al sentimento nuovo che rinveste, ma si fa forza e con dolcezza lo allontana da sé. Zanetto fugge disperato; Silvia scoppia in lagrime esclamando. «Sia benedetto Amore! Posso piangere ancora!».
È un delicato minuscolo idillio musicale, in cui Mascagni ha profusa la sua facile e appassionata vena melodica. Ed è una partitura esente da quei difetti di pletora e di enfasi canora che talvolta si incontrano nelle opere mascagnane. Armonizzazione semplice e chiara, strumentazione leggera, canto largo, aperto, scorrevole, tra il tenero e l'appassionato, velato di malinconia e di dolcezza. Tutto si intona alla poesia del dialogo, e la musica rende bene così la trepidante emozione della donna cui è precluso l'amore e che sente tutta l'amara delusione della propria esistenza perduta nei facili e vani piaceri, come la balda e audace aspirazione alla vita e all'amore del giovinetto. Vanno segnalate, fra le pagine migliori, il lieve e melodioso coro lontano senza parole che apre l'opera, la patetica e dolente canzone di Zanetto «Cuore, come un fiore», e il commosso canto di Silvia «No, non andar da Silvia», che nel suo ritmo quasi di danza lenta contiene una soave tristezza, carezzevole e dolente ad un tempo.
UMBERTO GIORDANO (Foggia 1867-Milano 1948) - ANDREA CHÉNIER: dramma in 4 quadri. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 26 marzo 1896. Libretto di Luigi Illica.
Quadro 1° - La gran serra nel castello dei Conti di Coigny. - Il servo Gérard mentre dispone i mobili per una festa, inveisce contro la nobiltà, ma non può sottrarsi al fascino della confessino Maddalena. Alla festa partecipa anche il poeta Andrea Chénier che, schernito da Maddalena perchè si era rifiutato di recitare versi «per monaca o per sposa», risponde improvvisando un'ode nella quale egli dichiara la vecchia società estranea ad ogni sentimento d'amore, e invita Maddalena a non irridere a questo sentimento divino. Le invettive contro la nobiltà e il clero producono scandalo fra i presenti, e il poeta esce sdegnosamente. Si dà quindi inizio alle danze, ma Gérard introduce un corteo di poveri affamati. Gérard viene scacciato; la gavotta riprende.
Quadro 2° - Incrocio di strade presso il ponte Peronet a Parigi. - Chénier è caduto in sospetto del Governo rivoluzionario. L'amico Roucher vorrebbe ch'egli partisse, ma Chénier rifiuta. Ha ricevuto un appuntamento da un'incognita e vuol sapere chi è. Infatti poco dopo viene avvicinato da Maddalena, la quale, uccisale la madre e perseguitata da Gérard, che l'ama ed è ormai uno dei capi rivoluzionari, gli chiede protezione. In entrambi l'amore si accende. Maddalena è sorvegliata da un «Incredibile» il quale avverte Gérard. Questi sorprende gli amanti a colloquio: Maddalena fugge; Gérard si batte con Chénier e resta gravemente ferito. Allora, con uno scatto di generosità Gérard avverte Chénier di fuggire perchè già segnalato al Tribunale rivoluzionario, e gli raccomanda di proteggere Maddalena. Il popolo accorre, interroga il ferito, ma questi dichiara di non conoscere il feritore.
Quadro 3° - Vasto stanzone, sede del Tribunale rivoluzionario. - Gèrard guarito dalla ferita, per avere nelle mani Maddalena ha fatto arrestare Andrea Chénier, Ora egli stende contro di lui l'atto di accusa, ma la sua coscienza lo rimorde, ed egli deplora la viltà in cui è caduto e l'indirizzo sanguinario preso dalla rivoluzione. Ma ecco Maddalena che viene a fare appello alla sua generosità affinchè salvi Chénier. Gèrard è commosso, sacrifica ogni basso istinto, ritratta innanzi al Tribunale l'accusa, e difende Chénier. Ma l'accusatore pubblico Fouquier Tinville fa proprie le accuse di Gèrard, e condanna a morte Chénier.
Quadro 4° - Il cortile nelle prigioni di San Lazzaro. - Riuscito vano ogni tentativo per salvare Chénier, Maddalena riesce coll'aiuto di Gèrard a sostituirsi a una condannata di cui assume il nome, e viene condotta al supplizio con Chénier.
L'arte di Umberto Giordano non ha l'originalità di quella degli altri maestri suoi coetanei appartenenti alla cosiddetta «scuola verista». Essa è piuttosto composita, risultando dalla fusione di diverse correnti e di varii stili non sempre sufficientemente assimilati, e perciò riconoscibili. Tuttavia non mancano le pagine in cui la sua personalità riesce a liberarsi dalle scorie e ad esprimersi con sincera e schietta immediatezza. Andrea Chénier è appunto una delle opere in cui questa sincerità depressione è più generalmente diffusa e l'ispirazione tocca più alte mète. Eleganza e sapienza di orchestratore e di contrappuntista vanno di pari passo con il calore comunicativo della melodia vocale, quasi sempre aderente al testo e alle situazioni drammatiche.
L'ambientazione è efficace e pronta. Si pensi, ad esempio, all'inizio brillantissimo dell'opera che ci introduce di colpo così gioiosamente nel dorato salone e nello spirito della festa galante; al gusto così settecentescamente sospiroso del coretto: «O Pastorelle, addio», alla ventata di miseria e di minaccia che penetra nell'aristocratico ambiente spezzando la pomposa ed elegante gavotta. Ancora: si pensi al ritmo sordo e sinistramente misterioso che commenta il passaggio delle pattuglie, a cui si sovrappone la canzone della «Carmagnola», nel 2° quadro; e, subito dopo, al poetico ripetuto sospiro dei violoncelli allorchè giunge Maddalena: sospiro della quiete notturna e sospiro d'ansia amorosa insieme. Poche battute di accordi gravi e pesanti bastano al Maestro per ambientarci nei riguardi del truce Tribunale della rivoluzione al 3° quadro, e allo stesso modo, ma con maggiore angoscia e tristezza, nel 4° quadro, il musicista ci introduce nel carcere ove il poeta meditando attende la morte.
Pure felicemente, salvo qualche momento d'enfasi melodrammatica straripante, sono tracciati i caratteri dei personaggi principali. Fra questi Carlo Gérard è forse il più convenzionale: i suoi monologhi,, quello del 1° quadro e quello del 3°, sono pensosi ed amari, ma gli scatti d'ira cadono talvolta nel tono da predica, come quando moraleggia gridando «Tal dei tempi è il costume» oppure: «Razza leggiadra e rea, figlio di servi, e servo qui giudice in livrea, ti grido: È l'ora della morte!», frase in cui il vociamento rettorico soverchia la vera forza drammatica. Così dicasi del monologo: «Esito dunque?», là dove Gérard trasforma il sogno umanitario e sociale, «Fare del mondo un Pantheon» con quel che segue, in una stentorea perorazione oratoria da comizio. Ma queste ridondanze sonore, che seducono facilmente le folle in piazza, le seducono anche in teatro. Lo stesso difetto notiamo nell' «Improvviso» di Andrea Chénier, pur così ricco di poesia spontanea, in quella parte centrale dove, perdendo il senso poetico prende a pretesto «le lacrime dei figli» per fare dell'oratoria comiziale di pessimo gusto (dal lato artistico) con relativo urlo plebeo. Difetti insiti nel libretto, che però il musicista non ha saputo nè schivare nè attenuare; anzi, poichè la musica possiede una forza naturale di esaltazione, i difetti del testo attraverso alla musica vengono esagerati.
Ciò non ostante il personaggio di Chénier è dal lato musicale uno dei meglio tratteggiati e dei più coerenti. È un poeta: così nell'«Improvviso» (a parte l'episodio anzidetto) come nei duetti del 2° quadro con Roucher e con Maddalena. Il fermo recitativo: «Credo a una possanza arcana» dal tono così fatalista; il sognante: «Io non ho amato ancor»; il patetico: «ora soave», sono tutte espressioni d'un'anima di poeta. Il quale non si smentisce nell'ispirato: «Passa la nave mia», nel commosso: «Come un bel dì di maggio», e infine nell'ultimo sospiro d'amore: «Vicino a te s'acqueta», nell'entusiastico canto di morte: «La nostra morte è il trionfo dell'amor!», e nel rapimento dell'invocazione: «Ah viene come l'aurora» su cui passano rapidi gruppetti simili a brividi d'ebbrezza. Tutte queste citazioni corrispondono ad altrettante melodie nuove ed espressive che fluiscono con una vena limpida e penetrante.
Maddalena vive anch'essa una vita lirica robusta nel 2° quadro, nell'evocazione così ricca di movenze appassionate: «Eravate possente»; e più ancora nel racconto del 3° che, preceduto dal doloroso «a solo» del violoncello, il quale ripete lento il motivo dell'amore di Maddalena con un accento di pianto sconsolato, si svolge con mestizia rassegnata per prorompere, come in un sogno che purifica e sublima, nella melodia: «E dice: Vivi ancora!».
Attorno ai tre protagonisti è tutto un mondo di figure minori dalla mulatta Bersi, musicalmente un po' troppo generica, all'«Incredibile» troppo frivolo per una spia, alla vecchia Madelon dal racconto della quale fiorisce uno dei più patetici e melodiosi episodi dell'opera, fino al sanculotto Mathieu detto «Populus», macchietta indovinatissima di plebeo fanatico e ignorante.
Quanto allo sfondo della rivoluzione, con citazioni della Marsigliese, della Carmagnola e del Ça ira, esso è un poco superficiale e scenografico, ma non scevro di colori appropriati. Del resto il musicista ha avuto il buon senso di non portarlo in primo piano. Andrea Chénier è un dramma d'amore; la rivoluzione e la folla non hanno che un interesse di ambientazione generale e di contorno episodico.
PIETRO MASCAGNI - IRIS: opera in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Costanzi in Roma il 7 ottobre 1898. Libretto di Luigi Illica.
Atto 1° - La casetta e il giardino ove abita Iris col vecchio padre cieco. Sul fondo un ruscello. In lontananza il Fusijama. - Il giovane e ricco Osaka si è invaghito della bellezza di Iris, e incarica Kyoto, proprietario di una casa di piacere e mercante avido e senza scrupoli, di rapirla. Infatti, mentre il cieco prega al sole e Iris cura i fiori del giardino, Kyoto ritorna in veste dì burattinaio con Osaka e con alcune commedianti e danzatrici. Una folla di mousmè che lavavano al ruscello si affollano attorno al teatrino, ed anche Iris assiste alla commedia. Finita la quale tre Guèchas svolgono alcune danze. Iris, che affascinata si era avvicinata, viene isolata e, nascosta dai veli delle danzatrici, rapita da Kyoto. Questi lascia su la soglia della casa del denaro e un biglietto in cui è detto che Iris è volontariamente andata al Yoshiwara, la casa di piacere di Kyoto. Il cieco addolorato e furente chiede di esservi accompagnato per maledire la figlia.
Atto 2° - Stanza al Yoshiwara. - Iris svegliandosi si crede morta. Osaka invano tenta di condurla alle sue brame; essa riconosce nella sua voce quella di Jor, il figlio del Sole nella commedia dei burattini, ma rimane insensibile alla sua seduzione e al suo bacio. Osaka parte indignato, e Kyoto fa abbigliare la fanciulla e la espone al pubblico. Il cieco, guidato dai clamori di ammirazione della folla, si avvicina; Iris ignara lo chiama; ma il vecchio la maledice e le scaglia in volto del fango. Iris con un urlo di terrore si precipita da una finestra che sovrasta un precipizio,
Atto 3° - Fondo di un precipizio. - È notte; alcuni cenciaiuoli rovistando nella fogna scoprono il corpo di Iris che credono morta. Ma poichè essa rinviene da un lungo svenimento e si muove, i cenciaiuoli presi da supersizioso spavento, fuggono. Il sole si leva; Iris delira e muore in una trasfigurazione di luce e di fiori.
Secondo le intenzioni del librettista, l'opera avrebbe dovuto avere un significato simbolico, ma per fortuna questo significato non fu raccolto dal musicista. La fanciulla che traduce «il linguaggio della luce in bontà», che allorquando apre gli occhi su le brutture del mondo «si trasforma in energia e volontà», il cui spirito sfuggendo agli egoismi umani «ritorna all'armonia della luce», è rimasta nella musica di Mascagni una semplice ingenua fanciulla vittima di un'orrenda brutalità. Anche l'altro aspetto simbolico, pel quale Iris è l'Arte che sfugge alle sozzure del basso mondo e s'inciela, lo si può, se fa piacere, pensare, ma non trova nessuna significazione precisa nelle note del Livornese. Ed anche l'ambientazione esotica è rimasta indifferente al compositore. Infatti egli non ha fatto nessun tentativo di dare alla propria musica un qualsiasi colore orientale, se se ne toglie la nenia autentica giapponese che una Guècha canta a bocca chiusa, accompagnandosi con le «Campanelle giapponesi» all'inizio del 2° atto. È vero che in orchestra figura, oltre alle «campanelle», anche il «giuoco di Tam-tam» giapponese, istrumento da non confondere col comune «grande Tam-tam» o «Gong» - anch'esso istrumento giapponese - che percosso dà un profondo ronzìo metallico. Il «Gioco di Tam-tam» ha invece un suono sinule a quello di grosse campane.
C'è piuttosto in quest'opera il più bel Mascagni dalle ampie melodie vocali, dal vivo sentimento della natura, pieno d'interesse e di gusto per tutto ciò che è caratteristico e anche bizzarro, dal teatro dei burattini ai lugubri frugatori delle fogne. E c'è soprattutto una straripante sensualità canora che per bocca di Osaka si diffonde su tutta l'opera sommergendo qualunque altro interesse drammatico. Nel 2° atto questa sensualità riempie di sè ogni nota: è nell'ammirazione di Osaka, nei commenti di Kyoto, emana inconsciamente dal fragile e flessuoso corpo di Iris, e si apprende alle folle in un delirio di desiderio vertiginoso. Anche la sensibilità di Iris per la luce del Sole e per la bellezza dei fiori, i suoi terrori dei draghi, i paurosi sogni di «volanti chimere e di striscianti colubri», tutto si traduce in immagini musicali sensoriali. Lo stesso «Inno del Sole» è una interpretazione sonora della potenza sensuale della luce, e nell'istesso tempo conclama questo fondamentale carattere della musica mascagnana.
Il melodismo vocale di Mascagni è sempre abbondante come nelle prime opere, ma si è fatto più intimo e fine; però raffinandosi esce con una impronta di più penetrante voluttà. Eppure in questa espressione nulla di lubrico e di volgare, ma un sentimento panico della vita, una specie di inno alle energie fecondatrici dell'universo. Nel bacio di Osaka c'è un languore che contiene soprattutto un intenso desiderio di annientamento, l'aspirazione a una beatitudine immateriale. E lo stesso Kyoto, il triste mercante di bellezze femminili, avido solo di gemme e di denaro, privo d'ogni scrupolo morale, è trattato dal musicista più che altro come una grottesca macchietta.
Nell'Iris quello che più conta è il calore umano della melodia mascagnana, che fece dire a un critico severo come il Bastianelli: «In quest'opera c'è l'anima», e quest'anima ci si svela subito nell'«Inno del Sole», il quale, non ostante la tendenza rettorica, è pieno di movimento e di fuoco. La tendenza rettorica consiste nella sua divisione in parti, il cui simbolismo rimane del tutto esteriore; esse sono: La notte, I primi albori, I fiori, L'aurora, I primi raggi. Il Sole. Ma lo schema è riempito di materia viva. Dopo il buio motivo iniziale della Notte (contrabassi) il cielo si fa opalescente alla dolce carezza dei Primi albori (violoncelli), poi l'aria si profuma dell'olezzo dei Fiori (violini nelle note sovracute), l'Aurora manda il primo tepore luminoso (corni) con un tema che anche se di derivazione wagneriana, è pieno di una calma solenne. Coi Primi raggi un nuovo vigore di vita sale dall'orchestra e dal coro uniti, per prorompere in un movimento sempre più animato e luminoso all'apparire del Sole, con la ripresa del tema dell'Aurora portato alla più folgorante e soggiogante sonorità (fortissimo con cinque f). Non si può negare che l'effetto, non solo teatrale ma artistico, è stato raggiunto con sapienza di mezzi ben dosati, anche se la chiusa richiama alla mente il finale del prologo del Mefistofele.
La figuretta di Iris è delineata con coerenza di stile nella sua natura innocente, infantile, sia che racconti il sogno pauroso, o che parli alla bambola, o al Sole, sia che innaffi i fiori, o che si intenerisca all'ingenua storia burattinesca di Dhia e di Jor. Le melodie hanno sempre una nuova e limpida spontaneità di commozione. Non altrimenti è della scena del 2° atto allorchè Iris, pur ammirando le proprie vesti trasparenti, se ne vergogna; o quando prova a suonare e a dipingere e non vi riesce, e si crede morta. Oppure quando ascolta rapita la voce di Osaka senza comprendere il senso delle sue parole, o quando incantata dal pupazzo di Jor ne ripete la serenata senza più rendersi conto di quanto le accade. Si comprende come in questo stato di innocenza e di puerile ingenuità il ricordo del bonzo che descrisse il piacere come un'immane piovra, determini uno dei rari momenti drammatici della sua esistenza, il maggiore prima della maledizione paterna. Mascagni l'ha colto con un ondeggiare ansioso di accordi e con una coloritura livida di spavento, su cui il canto ansima anch'esso spaurito con disperazione. I suoi stessi vaneggiamenti durante l'agonia, il ricordo della sua casetta e dei suoi fiori, l'ignoto mistero della sua sorte e l'entusiastico saluto al Sole che sorge e nel cui bacio muore, non sono che nuovi aspetti con cui la musica approfondisce la coerenza di un'anima che palpita in una inconsapevole purità di idillio.
Osaka è tutto nel suo ardore di godimento: voce acuta, squillante, melodie di una molle sensuosità come la Serenata di Jor, o come lo stupito e voluttuoso canto: «Oh, come al tuo sottile corpo s'aggira», o come il trepidante languore del supremo tentativo di seduzione: «Or dammi il braccio tuo», che si conclude nell'abbandono quasi tristaneggiante del bacio.
Il cieco ha l'austerità di un bonzo, ma nell'ultima scena del 1° atto il suo dolore di padre soverchia anche il suo egoistico sdegno, e l'implorazione: «Una carezza al vecchio cieco», e quel misto di ira e di pianto che combattono nella sua anima, sono resi dal musicista con rara potenza drammatica d'accenti, anche se qua e là passa qualche ridondanza.
L'elemento caratteristico è rappresentato non solo dall'originalità, talvolta anche dalla bizzarria (però non mai eccentrica e forzata) di qualche andamento della melodia, dell'armonia o dello strumentale, ma principalmente da tre scene, nuove nella storia del melodramma: il coro delle lavandaie, la scena dei burattini, e quella dei cenciaiuoli. Il coro delle lavandaie ha uno sfondo orchestrale pieno di scorrevole e fresco movimento che, senza voler essère materialmente descrittivo, richiama però alla fantasia fluidi gorgogli d'acqua, mentre il chiacchierio delle donne diffonde un senso di gioia giovanile. Al coro si intercala un canto semplice e dolce di Iris, che innaffia i fiori, mentre sotto di esso il cieco prega. Con una trovata nuovissima la preghiera del cieco è puramente recitata, senza perciò disturbare il canto della giovinetta; fusione intelligente di melologo e di melodramma.
La scena dei burattini è schizzata con brio caricaturale ricco di umorismo. L'arrivo del teatrino è annunziato da un motivo sincopato e saltellante di sapore campagnolo su ballonzolanti quinte base ribattute, e intercalato da un veloce ritornello allegro dell'ottavino: e la commedia si svolge fra trovate spiritose e con intercalata la Serenata di Jor. «Il Mascagni della popolare «Siciliana» della Cavalleria - scrive il Bastianelli - in essa risuscita con nostra grande gioia».
Alla commedia succedono le danze delle Guèchas: «La bellezza», «La Morte», «Il Vampiro», in cui l'elemento descrittivo ha destata la più fantasiosa e pittoresca ispirazione del Maestro, sia nei ritmi che nel colore.
Quanto alla scena dei cenciaiuoli, siamo di fronte a un quadretto impressionistico, di un colore sinistro e grottesco insieme, temperato dalla romantica canzone alla luna, e tessuto su un procedimento tonale che diventerà la base del sistema armonico di Debussy, che pertanto Mascagni ha qui genialmente precorso.
Mascagni, che non è mai apparso, anche nelle opere posteriori a questa, un grande orchestratore, per l'Iris ha avuto intuizioni di squisita bellezza ed efficacia. Citiamo ancora una volta il Bastianelli: «I colori orchestrali si impastano con delicati e quasi direi fulminei contrasti; e ora scivolano glaciali e striati come pelle di serpi, e ora ondeggiano come nebbie leggermente iridate». Per tutto ciò Iris appare l'opera più compiuta uscita dalla fantasia del fecondo e geniale musicista.
FRANCESCO CILEA (Palmi [Calabria] 1866 - Varazze [Liguria] 1950). - L'ARLESIANA, dramma lirico in 3 atti. Prima rappresentazione della seconda edizione in 3 atti al Teatro Lirico di Milano il 22 ottobre 1898 (ia rappresentazione della prima edizione in 4 atti allo stesso teatro il 27 novembre 1897). Libretto di Leopoldo Marenco dal dramma di Alfonso Daudet.
Atto 1° - Cortile di antica e signorile fattoria a Castelet in Provenza. - Il pastore Baldassarre sta raccontando la triste istoria di una capretta divorata da un lupo all'Innocente, un figlio scemo di Rosa Mamai, del quale l'intelligenza va risvegliandosi. Ma Rosa è preoccupata per l'altro figlio, Federico, il quale, innamoratosi di una ragazza di Arles di moralità dubbia, vorrebbe sposarla. Anche Vivetta, la figlioccia di Rosa, che ama segretamente Federico, è inquieta. Sopraggiunge Federico, che confessa alla madre il suo amore per l'Arlesiana; ma non ostante le buone informazioni dello zio Marco, il guardiano di cavalli Matifio informa Rosa che la ragazza amata da Federico fu sua amante. A conferma delle sue affermazioni consegna a Rosa due lettere che l'Arlesiana gli scrisse. Le lettere vengono fatte leggere a Federìco che ne è colpito e disperato.
Atto 2° - Le rive di uno stagno. - Rosa scongiura Vivetta di salvargli col suo amore il figlio. Federico dichiara al pastore che non può dimenticare l'Arlesiana, e che soffre di gelosia e ha desiderio di morire. Invano Vivetta gli confessa di amarlo. Rosa allora, temendo per la vita del figlio, gli permette di sposare l'Arlesiana. Il grande amore della madre sembra far rinsavire Federico, il quale stende le braccia a Vivetta.
Atto 3° - Una grande sala della fattoria: nell'angolo destro una scaletta di legno conduce alla torretta del fienile. - La casa è in festa per le prossime nozze di Federico e Vivetta. Anche Federico è lieto, e si illude di aver trovato nel nuovo amore per Vivetta l'oblio dell'Arlesiana. Metifio, tornato per riavere le sue lettere, annunzia al pastore che rapirà l'Arlesiana, della quale è sempre innamorato. Federico lo sente, il vecchio amore non sopito si ridesta in lui. Egli si getta furente contro Metifio per ucciderlo; ma Rosa, sopravvenuta, si interpone e conduce Federico nella sua stanza. L'Innocente, la cui intelligenza si è risvegliata, avverte poco dopo la madre che Federico si è addormentato, e che egli veglierà su lui; ma poi anch'egli si addormenta, mentre invece Federico si risveglia. L'immagine dell'Arlesiana è più che mai viva nel suo cuore e il tormento non gli dà tregua. Come impazzito sale rapido la scaletta del fienile e si getta nell'aia sottostante.
Opera che si è imposta lentamente L'Arlesiana di Cilèa, eppure è da capo a fondo di una melodiosità lineare e di una delicata tenerezza facilmente accessibili. Forse si canta troppo, e non sempre questo canto ha un rilievo adeguato alla drammaticità dell'azione. Forse questa musica è in qualche momento troppo generica, resta alla superficie, accarezza ma non scolpisce abbastanza, non ha una muscolatura sufficientemente robusta per stati d'animo così tesi e violenti. Per esempio, il motivo che si ode in orchestra al momento in cui il pastore espone a Rosa qualche dubbio su la fanciulla di Arles amata da Federico, motivo che ritorna in vari altri momenti dell'opera, non esprime con bastante vigore l'ansia e l'apprensione dolorosa che sconvolge»la madre, e che è come un presagio di vicina sventura. Meglio quando, passato nei bassi, pulsa cupamente minaccioso alla fine del 2° atto.
Forse ha nuociuto anche l'incomprensibile assenza dalla scena della protagonista. Poiché, infatti, l'Arlesiana non appare mai: se ne parla spesso, è presente in ispirito, ma non come forza di un fascino femminile ineluttabile, piuttosto come un incubo malefico. Eppure la presenza scenica di questa donna avrebbe potuto determinare contrasti di particolare potenza drammatica, ai quali però la morbida e nostalgica vena del Maestro sarebbe forse risultata impari. Certo non era soggetto da stendere, come nella prima versione, in 4 atti. Condensato in 3, la vicenda corre con minore monotonia.
L'armonizzazione è sempre elegante, talvolta anche audace per espressivi incontri e insolite modulazioni. Lo strumentale pure colorito e signorile, pieno di buon gusto. Nulla però di così caratteristico dal punto di vista dell'ambientazione provenzale, come nelle celebri musiche scritte da Bizet per lo stesso dramma di Daudet. Tuttavia l'ambientazione, anche se non provenzale, pastorale, si afferma fin dalle prime note, e si conserva per gran parte dell'opera; e i canti popolari sono ben ritmati e vivi.
Delle persone sceniche, quella di Vivetta è forse la più debolmente delineata: entra su un motivo leggero e soavemente aggraziato che la presenta nella sua gentilezza affettuosa, ma i suoi canti d'amore sono un po' generici, e raramente si accendono di vampe appassionate. Il che avviene specialmente al 2° atto, nella calda frase: «Se, come amo, sapessi farmi amar», che si afferma con più tenera espansione nel finale dell'atto, il quale si chiude col ricordo del motivo pastorale e col gorgheggio primaverile degli uccelletti.
Più sicuramente delineati, in pochi tratti, sono la bonaria e perspicace figura del pastore, specie nell'aria così serena del 2° atto: «Vieni sui monti», e quella dell'Innocente. Il fluido motivo che apre l'opera, acquista in un successivo movimento più calmo un carattere pastorale, e accompagna appunto il racconto del pastore all'Innocente. Dal suo ritorno nell'ultimo atto pare ch'esso debba riferirsi soprattutto all'Innocente, e (specie nell'Interludio dolcissimo del 3° atto) al suo risveglio intellettuale.
Lo zio Marco, che appare solo un momento nel 1° atto, è figura di stolido presuntuoso schizzata con ironica e arguta comicità. Metifio ha, soprattutto nel 3° atto, un racconto ritmicamente robusto; e la scena seguente, con Io scatto omicida di Federico si svolge pure su un ritmo veemente e tempestoso.
I personaggi musicalmente meglio definiti sono indubbiamente Federico e la madre Rosa. Di Federico, il compositore, dopo i primi momenti di gioia e l'esultante canto: «Nel colmo del piacer», esprime soprattutto il violento turbamento dell'animo e l'assillo doloroso che culmina nel 2° atto col giustamente famoso lamento «Anch'io vorrei dormir così», sfogo liberatore dell'anima, ricco di pathos e di angoscia nostalgica. La madre è in preda continuamente a un'agitazione ansiosa da cui sgorga impetuosa e agitatissima la ia scena del 2° atto, e che sfocia nel 3° atto (a contrasto col festoso coro lontano: «Ferve la danza») nel drammatico racconto: «Esser madre è un inferno». Solo una breve sosta (ma anch'essa piena di superstiziosa ansia e di rattenuto pianto) si ha nel tenerissimo saluto all'Innocente già ridesto alla luce del pensiero: «Tu pur sei figlio mio».
Queste ultime scene dell'opera, il folle risveglio di Federico, così tragicamente contrastante con l'illuminato risvegliarsi dell'anima dell'Innocente, la rapida decisione e attuazione del suicidio, mentre l'orchestra ripete in uno spasimo di delirio il tema dell'amore fatale per l'Arlesiana, costituiscono forse le pagine più vigorose che Cilèa abbia scritto; e, certo, di così forti non ne riscontreremo neppure nella 'più patetica Adriana Lecouvreur.
UMBERTO GIORDANO - FEDORA: dramma in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano il 17 novembre 1898. Libretto di Arturo Colautti, tratto dal dramma omonimo di Vittoriano Sardou.
Atto 1° - Salotto elegantissimo in casa del conte Vladimir o Andrejevich a Pietroburgo. - La principessa Fedora Romazov viene a cercare il fidanzato Vladimiro, turbata per non averlo veduto in tutta la giornata. Mentre essa contempla amorosamente il suo ritratto, Vladimiro mene portato gravemente ferito. Subito la polizia inizia le indagini dalle quali emerge che il colpevole è il Conte Loris Ipanov che abita nel palazzo di fronte. Si va subito per arrestarlo, ma non lo si trova. Frattanto Vladimiro muore, e Fedora giura di vendicarlo.
Atto 2° - Salone in casa della principessa Fedora a Parigi. - Fedora ha scoperto a Parigi Ipanov, il quale si è innamorato di lei. Fedora lo ha invitato a una festa con l'intenzione di interrogarlo e farlo confessare, ma anch'essa prova simpatia per Loris. Dopo la festa Loris ritorna da lei per darle le spiegazioni richieste. Frattanto Fedora, che lo crede un nichilista, ha dato ordini alla polizia di arrestarlo, e manda a Pietroburgo una lettera denunciando come nichilista, su un semplice indizio, anche il fratello. Ma Loris può provare a Fedora ch'egli assassinò Vladimiro per legittima difesa, avendolo trovato con la propria moglie, ed essendo statò da lui aggredito. La prova del tradimento di Vladimiro fa crollare l'amore di Fedora, mentre la simpatia ch'ella nutriva per Loris si muta in amore ardente; ed essa lo trattiene per impedirgli di cadere nelle mani della polizia in agguato.
Atto 3° - Giardino nella villa di Fedora nell'Oberland Svizzero. - Loris riceve una lettera dalla quale apprende che suo fratello fu arrestato ed è annegato in carcere per uno straripamento della Neva. Sua madre, alla notizia, è morta di crepacuore. Il contegno di Fedora lo insospettisce; interrogandola egli scopre che fu lei a denunziare il fratello, e allora la maledice. Folle di disperazione Fedora si avvelena e muore perdonata fra le braccia di Loris.
Fedora ha meno ala e minor quantità di motivi dell'Andrea Chénier; tuttavia i motivi belli sono ancora così numerosi ed hanno un tale calore da giustificare a sufficienza la popolarità dell'opera. Lo stile è sempre signorile, chiaro, con netto predominio, come del resto anche nello Chénier, dell'espressione vocale su quella strumentale, per quanto non manchino elementi ed episodi strumentali che tale espressione integrano e rafforzano.
La figura della protagonista, Fedora, si impone fino dall'inizio col suo motivo dell'amore per Vladimiro: motivo caldo a patetico, al quale si intercala la soave romanza: «O grandi occhi lucenti di fede!», il cui tema è suggestivamente preannunziato nelle piccole frasi dell'orchestra mentre Fedora osserva curiosamente la stanza del fidanzato. Motivo che durante l'inchiesta si ripete con un concitato nervosismo. Un altro tema che caratterizza la psicologia di Fedora è il suo solenne giuramento: non solo di vendetta, ma di «castità perenne». Cosicchè le sciagure di Fedora accadranno per la violazione (sia pure giustificabile) di questo voto; e perciò il tema del giuramento chiuderà il 1° atto e l'opera, e si aggirerà tortuoso mentre Fedora dà ai poliziotti gli ordini per l'arresto di Loris e scrive la denunzia contro suo fratello Valeriano.
Ma nel 2° atto incomincia il fascino di Loris, cosicchè l'intermezzo che ripete più pensosamente e infine con più concitata passione il motivo dell'aria: «Amor ti vieta di non amare» ha un significato. La lotta tra l'amore di Vladimiro che crolla nel disprezzo e l'amore per Loris, non ha in realtà nulla di drammatico, poichè esso è già inconsciamente nel sogno intimo della donna. Il motivo di Vladimiro e quello dell'amore di Fedora per lui, ricompaiono ancora fugacemente mentre essa legge la lettera che le dà la prova del suo tradimento. Poi, d'improvviso, è la nuova vampa dell'amore di Fedora per Loris, che prorompe nella stupenda e ardente melodia: «Lascia che pianga io sola».
Nel 3° atto l'amore avrà altri accenti: quelli della disperazione (a Dio di giustizia», «Loris, io ben ti conosco»), e ritornerà anche il motivo del nuovo amore, ma spezzato, sconvolto. Poi, dopo l'avvelenamento, il saluto estremo: «Tutto tramonta», calmo, di una dolcezza rassegnata e di una letizia quasi trasumanata. Su un estremo ritorno del motivo di: «Amor ti vieta», Fedora muore; il tema del giuramento conclude in una breve drammatica perorazione.
La figura di Loris, dopo la insinuante melodia dell'«Amor ti vieta», emerge nel 2° atto, nel dialogo con Fedora, dapprima calmo poi agitato, che si svolge in forma recitativa sul «Notturno» per pianoforte suonato da Lazinski. «Notturno» e dialogo appaiono nell'azione come due fatti simultanei ma distinti; in realtà l'espressione della Sonata si fonde, come per caso, e interpreta i sentimenti e le emozioni dei due che parlano sottovoce e appartati. È una trovata nuova, di rara efficacia drammatica.

Figura: 13: Scena di Mantovani per La Walkiria di Wagner.

Figura 14: Scena di Vellani Marchi per il Falstaff di Verdi.
Altra cosa è il racconto dell'uccisione di Vladimiro, che Loris fa nella seconda parte dello stesso atto. Incomincia con la sognante evocazione della madre nel castello lontano, su un movimento ondulato, crepuscolare; poi la narrazione si fa sempre più animata, interrotta qua e là da brevi interrogazioni e commenti di Fedora; sale di intensità drammatica e prende andamento vieppiù agitato mano mano che Loris si avvicina al momento tragico. I temi violenti già apparsi nel 1° atto mentre la polizia tenta di ricostruire il dramma, si ripresentano; in qualche momento la voce è lasciata sola e l'orchestra si limita a qualche rapida strappata. Non c'è più posto per ampi commenti strumentali: i fatti corrono rapidi, le parole cercano la via più breve; talvolta la stessa intonazione del Canto si affida più all'efficacia della recitazione che a quella della musica, fino all'accorato abbandono del: «Vedi io piango», che sfocia nell'appassionata risposta di Fedora: «Lascia che pianga io sola». È una scena condotta con fermezza di disegno magistrale e con senso drammatico robusto.
Nell'ultimo atto la rivelazione che Fedora fu la delatrice del fratello e la causa della morte di questi e della madre, getta l'espressione musicale del personaggio di Loris su un terreno più frammentario, accidentato, con qualche caduta nel verismo degli insulti urlati, fra cui taluno ben volgare come la frase «Sirena da forca». Qui, dopo qualche pagina di forte impetuosità drammatica. l'arte esula perchè la materia ha un peso troppo brutale, la musica lascia il posto alla cronaca.
Delle altre persone non loderemo la figurazione di Olga, troppo frivola e sdolcinata. Ci ha colpa, naturalmente, il suggerimento librettistico, ma la musica la rende ancor meno simpatica, la fa cadere talora nel banale. Più interessante la fisionomia musicale di De Siriex, non solo per la bella canzone autentica russa: «La donna russa», così calda e vivace, ma specialmente per il tragico racconto dell'ultimo atto: «Quel truce sgherro». Questo racconto si svolge paurosamente lento sul cupo originalissimo commento dell'orchestra, dove la ripetizione di una stessa formula (un breve disegno sinistro, simile allo snodarsi d'un mostruoso serpe) reca un brivido d'apparizione spettrale.
Del resto, pagine belle e particolari preziosi sono disseminati con signorile arte un po' dovunque. Vanno ricordati fra l'altro in special modo il ritmato e giocoso dialogo dei servi all'inizio del 1° atto, l'ansioso e fluttuante disegno degli archi all'arrivo di Vladimiro ferito, il triste e misterioso motivo dei bassi durante l'inchiesta della polizia, l'aspro tema del delitto, che si sviluppa in un fugato febbrile durante la ricerca della lettera. Poi, al 2° atto, il balzante Valzer, lo scorrevole movimento, simile a un mormorio di sgomento (l'autore ha segnati sei p) mentre la folla abbandona la sala dopo l'annunzio dell'attentato allo Czar. Nel 3° atto sono particolarmente felici l'introduzione con gli squilli del como, l'eco del flauto, il coro idillico: «Dice la capinera», che formano un'indovinata ambientazione alpestre. L'elegiaca melodia di Olga: «Sempre l'istesso verde!» è invece in contrasto troppo forte con l'annoiato e ironico discorso di lei. Più fresca l'«aria della bicicletta» dove la gioia sportiva è giovanilmente vissuta, ed elegante il terzetto Olga-De Siriex-Fedora: «E voi più non tubate», che ricorda le più eleganti movenze dello Chénier.
GIULIO MASSENET - CENDRILLON: fiaba in 4 atti e 6 quadri. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 24 maggio 1899. Libretto di Enrico Cain, dalla favola di Carlo Perrault.
Atto 1° - Stanza in casa di Madama de la Haltière. - Mad.a de la Haltiére, le figlie Noemi e Dorotea e il marito Pandolfo si preparano per recarsi a un ballo dal Re, il cui figlio, il Principe Gentile, dovrà scegliere la sposa. Mad.a de la Haltière sogna una delle proprie figlie regina; ma Pandolfo è dolente di dover lasciare a casa la propria figlia Lucietta, soprannominata Cendrillon, poichè essa è disprezzata dalla matrigna e dalle sorellastre, Cendrillon resta malinconica presso il focolare e si addormenta. Ma ecco la Fata con uno stuolo di folletti che vengono a vestire riccamente Cendrillon e a trasportarla alla reggia su un carro fatato. Però la Fata si fa promettere che al suono della mezzanotte essa rincaserà subito.
Atto 2° - Sala nel palazzo del Re. - Il principe ascolta malinconico e pensoso un concerto. Invano cortigiani e dottori cercano di distrarlo. Egli alfine congeda tutti e rimane solo col suo sogno d'amore per un'ignota. Il Re viene ad annunziare al figlio l'arrivo delle nobili damigelle fra le quali dovrà scegliere la sposa. Giunge anche Pandolfo con la famiglia. Si svolgono danze pittoresche. Ma il Principe è distratto e sembra in attesa. Quand'ecco entrare, fra la meraviglia di tutti, Cendrillon: è la bellezza sognata dal Principe il quale, rapito, le parla con sùbito amore. Ma allorchè suona la mezzanotte, Lucietta fugge rapidamente lasciando il Principe disperato.
Atto 3° - Quadro 1° - La stessa scena del 1° atto. - Cendrillon rincasa. Nel fuggire ha perduto una pianella. Al giungere dei famigliari corre a svestirsi. Madama de la Haltière e le figlie sono indignate contro l'ignota. Raccontano a Cendrillon che il Principe fu ben lieto ch'essa se ne fosse andata. A tal notizia Lucietta sviene. Ripresi i sensi e rimasta sola, delibera di andare a morire sotto la Quercia della Fata.
Quadro 2° - Pianura in fiore; in fondo il mare; nel mezzo la Quercia della Fata. - Da lati opposti giungono il Principe e Lucietta per morire sotto la Quercia della Fata. Essi sono separati da un'alta siepe di rose, cosicchè possono udire i loro lamenti senza vedersi. Essendosi così riconosciuti alla voce, implorano dalla Fata di potersi ritrovare. La Fata acconsente; essi si gettano l'uno nelle braccia deoll'altro; poscia la Fata li assopisce in un sonno magico, cullati dalla voce degli Spiriti.
Atto 4° - Quadro 1° - Terrazzo in casa di Cendrillon. - Sono passati diversi mesi da quando Lucietta fu ritrovata inanimata presso un ruscello. Le cure di Pandolfo l'hanno risanata. Essa si chiede se tutto il passato non fu che un sogno, e in questa opinione sembra confermarla il padre. Ma ecco che un araldo del Re annuncia che il Principe riceverà le Principesse che vorranno provare la pianella perduta nella sera del ballo. Cendrillon esulta: non fu sogno il suo;e invoca l'aiuto della Fata.
Quadro 2° - La Reggia, - Le principesse sfilano innanzi al Principe Gentile. Giunge finalmente accompagnata dalla Fata anche Lucietta che il Principe riconosce e dichiara senz'altro sua sposa. Con un comico voltafaccia Madama de la Haltière si precipita ad abbracciarla chiamandola: «Mia figlia!».
Fra le opere minori del Massenet è questa una delle più gentili e lievi. Opera gaia, sentimentale e fiabesca, a cui però mancano, com'è naturale, i forti accenti drammatici del Werther, che qui sarebbero stati fuori luogo. E le mancano anche gli slanci lirici e il rilievo melodico che si trovano in altre opere sue. Ma la consueta finezza e leggiadria di stile proprie di Massenet qui è ridotta a una trasparenza quasi incorporea, specie nella descrizióne dell'elemento favoloso. La partitura orchestrale è tutta pennellate soffici e colori delicati, solo qua e là resi più intensi dove l'azione si ravviva.
La comicità è impersonata specialmente da Madama de la Haltière, di cui la musica, fino dal primo tema dell'introduzione. dipinge la presuntuosa e pomposa vacuità. Gustosissimo è pure per l'intonazione bonariamente caricaturale, l'episodio dell'abbigliamento delle tre donne che stanno per recarsi dal Re (atto 1°). Si impernia su un movimento ritmicamente spiritoso, elegante, giocondo, di grande leggerezza e leggiadria. Altrettanto grazioso per l'umorismo con cui è schizzato è il pettegolo e dispettoso chiacchierio delle donne di ritorno dalla festa. Pure umoristica e pittoresca, ed anche un po' da commedia garbata di marionette (in fondo questi personaggi di favola sono anche talvolta marionette più che persone vive) è la «Marcia delle Principesse» nel 4° atto.
Fini e lievi come ricami aerei sono poi le scene e gli episodi in cui entrano in giuoco gli elementi fiabeschi, fra i quali è, deus ex machina, la Fata, trattata musicalmente come un uccelletto, tutto trilli e svolazzi, solo talvolta un po' troppo contrappuntisticamente strumentali.
I momenti sentimentali dell'opera sono invece affidati a Cendrillon, a suo padre Pandolfo, e al principe Gentile. Dei tre la figura più debolmente tratteggiata ci sembra quella del Principe, che pure ha al suo attivo qualche buon momento, come, ad esempio, la scena in cui appare assorto in una ignota magia amorosa, mentre un concertino di liuto, flauto e viola d'amore, diffonde attorno un velo di sognante mistero e di molle incanto. Citiamo ancora il lamento del 2° atto: «Cor senza amor», e, migliore assai, l'estatico: «Tu che a me apparisti», che apre il duetto delizioso fra il Principe e Cendrillon, dove la frase di lei: «Voi siete il mio prence Gentil», raccolta e variata dall'orchestra diffonde una serena dolcezza sui due innamorati.
Pandolfo ha momenti paternamente patetici nell'aria del 1° atto: «Ah quanto soffro», ed anche nel tenero: «Questa città noi lascierem» (atto 3°). Ma la figura più artisticamente accarezzata è quella di Cendrillon, della quale va segnalata la canzone malinconica del 1° atto: «Povero grillo al focolar», canto lieve «come il respir d'un fior», come esattamente commenta la Fata. E non importa se questa scena ricorda, in tono minore, la scena in cui Manon ha un analogo desiderio del lusso e del divertimento (in Manon in senso più civettuolo) e una simile rassegnazione alla rinunzia. Accanto a questa scena si colloca il saluto poeticissimo:
«Addio miei sovvenir» (atto 3°), profondamente nostalgico, seguìto dagli unici accenti drammatici dell'opera che commentano la fuga di Cedrillon dalla casa e il suo proposito di morire.
GIACOMO PUCCINI - TOSCA: melodramma in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Costanzi in Roma il 14 gennaio 1900. Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma omonimo di Vittoriano Sardou. - Epoca: giugno 1800.
Atto 1° - Interno della chiesa di Sant'Andrea della Valle a Roma, A destra la Cappella Attavanti; a sinistra un'impalcatura che sostiene un quadro non ancora finito, - Cesare Angelotti, console della spenta Repubblica romana, fuggito dal carcere, si rifugia nella Cappella Attavanti di cui la sorella gli ha lasciata la chiave presso la pila dell'acqua santa. Il pittore Mario Cavaradossi, scopertolo, vorrebbe salvarlo, ma il suo proposito è interrotto dal giungere della cantante Floria Tosca. Essa viene per fissare un convegno amoroso con Mario, ma, gelosissima, si insospettisce per il ritardo frapposto ad aprirle e per il quadro che riproduce l'effige dell'Attavanti, ritratta da Mario mentre la dama, fingendo di pregare, predisponeva la fuga del fratello. Rassicurata, si allontana, e Angelotti viene allora condotto in salvo da Cavaradossi nella propria villa. Ed ecco il Capo della Polizia, Barone Scarpia, che viene a ricercare il fuggiasco. L'inchiesta porta alla scoperta di un ventaglio col quale Scarpia riesce a riaccendere la gelosia di Tosca, di nuovo sopraggiunta. Mentre si intona il «Te Deum» per la presunta vittorio su Napoleone a Marengo, Scarpia medita di conquistare Tosca, e di far impiccare Cavaradossi.
Atto 2° - La camera di Scarpia a Palazzo Farnese. - Spoletta, agente di Polizia, non avendo trovato l'Angelotti, ha arrestato il pittore. Questi nega ogni accusa, e mene portato nella camera di tortura. Giunge frattanto anche Tosca, invitata da un biglietto di Scarpia, il quale le propone di salvarle ramante se si concederà a lui. Tosca rifiuta inorridita, ma non resistendo alle grida del torturato, svela il nascondiglio di Angelotti. Rimasta sola con Scarpia, finge di cedere al suo desiderio, e ottiene da lui che la condanna di Mario sia tramutata in una fucilazione simulata: «Come facemmo pel Conte Palmieri» aggiunge Scarpia con intenzione a Spoletta. Indi Tosca si fa dare un salvacondotto per fuggire con ramante, e quando finalmente Scarpia le si avvicina per abbracciarla, gli pianta un coltello nel cuore.
Atto 3° - La piattaforma di Castel Sant'Angelo. - È l'alba. Cavaradossi scrive il suo ultimo addio a Tosca, ed è assalito dal ricordo dell'amore e della felicità che non torneranno mai più. Tosca viene a recargli la notizia della morte di Scarpia e della sua liberazione dopo una finta fucilazione. Giunge il plotone d'esecuzione;Tosca raccomanda all'amante di fingere bene la morte. Allo sparo del plotone Mario infatti cade, ma per non levarsi mai più. Accortasi dell'inganno, mentre gli sbirri che hanno trovato il cadavere di Scarpia salgono per arrestarla, Tosca disperata si getta nel vuoto.
Il violento soggetto nelle sue scene veriste non ha trovato sempre un'adeguata rispondenza nell'ispirazione del musicista; cosicchè le scene più tragiche, quelle della tortura di Cavaradossi e della uccisione di Scarpia nel 2° atto, e quella della fucilazione di Cavaradossi nel 3°, sono riuscite musicalmente le più deboli. Nel 2° atto, al posto di una asciutta tragicità c'è l'urlo enfatico di Tosca e dell'orchestra. I motivi di quest'atto, privi di vera forza espressiva, vivono tutti di questo espediente. Unico momento veramente efficace è quello in cui da lontano si ode il rullo del tamburo che guida i condannati al patibolo: sul rullo che si allontana tetro l'orchestra non ha che deboli dissonanze e un pizzicato cupo dei bassi simile a un palpito di spavento.
Il racconto che nel 3° atto Tosca fa dell'uccisione di Scarpia ripete in sintesi i vuoti e le enfasi della lunga scena del 2°. Anche l'arrivo del plotone d'esecuzione e la fucilazione sono commentati da un motivo stanco e senza carattere, e non basta certo il ripeterlo marcatissimo dopo lo sparo per fargli acquistare la necessaria espressione tragica. Il suicidio di Tosca si conclude poi in un modo convenzionale, ripetendo con tutta forza come perorazione il motivo della romanza «O dolci baci, o languide carezze», ma è anche questa una maniera rettorica ponchielliana di cattivo gusto.
Eppure non mancano nell'opera altri momenti drammatici efficaci. Per esempio: l'opera si apre col «tema di Scarpia»: pochi accordi biechi e violenti che fanno grandeggiare immediatamente la triste figura causa del dramma. Segue poi un vivacissimo e veemente movimento sincopato che descrive l'affanno e il terrore di Angelotti fuggente. Tutto questo ha una nervosa e concisa drammaticità, superiore ai rumorosi vociamenti e agli urli orchestrali della scena fra Tosca e Scarpia al 2° atto, e della melodrammatica (in senso peggiorativo) e stentorea sfida di Tosca «avanti a Dio!» prima di gettarsi da Castel Sant'Angelo.
Ma c'è tutta la parte lirica che è invece bellissima. Di Cavaradossi non sarà la chiassosa bravata comiziale: «L'alba vindice appar» che toccherà il cuore, ma la poetica contemplazione: «Recondita armonia», avviluppata in una squisita eleganza e morbidezza di suoni; certe frasi e melodie del duetto d'amore; ed anche, preannunziato dal nostalgico timbro del clarinetto sotto la recitazione del tenore, e preceduto dal meditativo a solo dei violoncelli, il rimpianto dell'ultima romanza: «O dolci baci», anche se su la fine il convenzionale e teatrale desiderio dell'acuto guasta un po' l'effetto. Poi le tenere e delicate melodie dell' «O dolci mani», e del più commosso: «Amaro sol per te m'era il morir», che preziose armonie circondano di soavi aromi.
Anche per Tosca è la stessa cosa; non i suoi strilli di fronte alla brutalità di Scarpia, ma il seducente invito a «la nostra casetta», l'appassionato impeto della melodia d'amore: «Sì, lo sento, ti tormento», il pianto accorato dell' «Ed io venivo a lui tutta dogliosa», il sospiroso e sconsolato: «Vissi d'arte», e in generale le molte frasi patetiche del duetto d'amore del 1° atto e di quello del 3°. Il quale ultimo finisce malauguratamente con l'unisono fra tenore e soprano, senza orchestra: «Trionfai, di nuova speme», che vorrebbe essere entusiastico ed è, al solito, vuota magniloquenza. Eppure questo stesso motivo quando nell'introduzione dell'atto è intonato dai corni, ha un carattere fantasioso molto suggestivo.
Anche Scarpia soffre di plettora teatrale, e la sua foia libertina non trova nella sensibilità del musicista, volta al poetico e al sentimentale, un'espressione efficace. Tutto è, si direbbe, volutamente addolcito e ammorbidito.
Ma ci sono altre cose deliziose nell'opera. Anzitutto la gustosa macchietta del Sagrestano, dove anche un tic nervoso è musicalizzato in modo umoristico; il colloquio mellifluo di Scarpia con Tosca al 1° atto, in cui è sfruttato melodicamente il suono delle campane; e il solenne finale che si dilata nella grandiosità del «Te Deum» per chiudere sul tema prepotente e altisonante di Scarpia. E c'è infine la più grande pagina dell'opera: il preludio del 3° atto. Lo apre il fantastico motivo di corni anzidetto, seguito da un disegno tenue e misterioso dei legni e dalla espansiva canzone romanesca del pastorello lontano: «Io de' sospiri te rie rimanno tanti». È l'alba di Roma. L'orchestra ora è tutta sfumature armoniose d'archi contrappuntate dai rintocchi vicini e lontani delle campane dell'Urbe, con un gioco di echi e di risonanze che dilata lo spazio e crea una vera e propria atmosfera sonora di una trasparenza opalina. In questa pagina è l'anima di un grande poeta.
GUSTAVO CHARPENTIER (Dieuze [Lorena] 1860) - LOUISE: romanzo musicale in 4 atti e 5 quadri. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 2 febbraio 1900. Libretto in prosa dello stesso Charpentier.
Atto 1° - Una camera di soffitta in una casa d'operaio. - Luisa, figlia di un povero operaio, amoreggia con il pittore Giuliano che abita di fronte. La madre di Luisa la sorprende a parlargli dalla finestra e la rimprovera aspramente. Il padre, rientrato per la cena, ha una lettera di Giuliano, il quale gli chiede in isposa la figlia. La madre, che è informata delle idee libertine e della scioperataggine di Giuliano, mostra un'opposizione decisa, ma il padre dichiara che assumerà nuove informazioni.
Atto 2° - Quadro 1° - Un crocicchio alla «Butte Montmartre».- È l'alba. Passano venditori ambulanti, e un nottambulo, simbolo del Piacere di Parigi. Giuliano confida a un gruppo di amici, bohèmiens e scioperati come lui, l'intenzione di rapire Luisa. La giovinetta intanto si reca alla sartoria ove lavora, accompagnata dalla madre. Partita questa. Giuliano invita Luisa a seguirlo, facendole balenare una vita di piacere, ma Luisa, pur combattuta, non cede alla lusinga.
Quadro 2° - Interno di un laboratorio di sartoria. - Le giovani lavoratrici conversano e cantano; solo Luisa tace assorta nella propria passione. D'improvviso dalla strada sale la voce di un cantore: è Giuliano. Il suo canto è un fremente invito all'amore. Luisa non resiste, e corre a raggiungere Giuliano fra le risa ironiche delle compagne di lavoro.
Atto 3° - Casetta con giardinetto al sommo della «Butte Montmartre». - Giuliano e Luisa vivono insieme. Giuliano inneggia all'amore libero ed esalta la bellezza di Parigi, la città in cui il piacere stende i suoi mille tentacoli. La sera scende, la città si illumina; sul colle con i bohèmiens e le griséttes giunge una folla di curiosi per la festa carnevalesca dell'«Incoronazione della Musa», La Musa è Luisa; ma allorchè la festa ha raggiunto il suo apice, compare la madre di Luisa. Essa viene a pregare la figlia di tornare a casa presso il padre gravemente ammalato; promette di lasciarla tornare con Giuliano quando il padre sarà guarito. E Giuliano acconsente alla partenza di Luisa.
Atto 4° - La scena del 1° atto. - Il padre di Luisa è assai migliorato, per quanto ancora debole; e Luisa ricorda alla madre la promessa fatta a Giuliano di lasciarla ritornare. La madre la rimprovera duramente per la vita condotta con Giuliano. Il padre tenta di toccarle il cuore parlandole con tenerezza del suo affetto e della sua vita di bimba; ma Luisa rimane fredda ed assente: il suo cuore non ha palpiti che per Giuliano, Parigi e il piacere. E, in un parossismo d'esaltazione, invoca ramante che la tolga alla triste prigione. Sdeguato e offeso il padre la scaccia; ma poscia pentito la richiama. Essa è fuggita e non risponde più; e il vecchio, accasciato dal dolore, impreca alla città e al suo fascino malefico.
Lo stile di Charpentier è un connubio fra l'arte di Massenet e quella di Wagner. Dal primo assimila l'ampia ed appassionata cantabilità delle frasi. L'eleganza signorile del disegno melodico, reso più energico, e il fine cesello dello strumentale. Da Wagner prende l'uso dei grund-motiv, dei temi fondamentali, per evocare personaggi e idee, azioni e sentimenti. Il loro impiego sinfonico però non è molto vasto nè profondo, e i temi stessi, brevi ma plasticamente ben rilevati, hanno più un'efficacia coloristica che psicologica, sensoriale più che meditativa, e il loro significato risulta prontamente dalla comparsa dei personaggi e dall'azione loro.
Il colore in quest'opera esercita un fascino preponderante. Non si parla qui tanto del colore orchestrale, anch'esso ricco di tinte vivaci, quanto del colore ambientale ottenuto attraverso alla sapiente fusione dei timbri orchestrali con gli elementi vocali. A questo proposito va ricordato soprattutto il 1° quadro del 2° atto. «Parigi si risveglia»: è questo il titolo del preludio. Quando anche ne avessimo elencati i temi denominandoli, come «la città tentacolare» (è una definizione data dall'autore medesimo), «la voce della speranza», «il piacere di Parigi», «il grido di trionfo», «il richiamo al piacere», noi non avremmo dato che un catalogo freddo e inespressivo. Queste etichette, usate dagli esegeti analitici anche per le opere di Wagner, non lasciano affatto sospettare quella ch'è la forza viva d'arte (rappresentazione, evocazione, trasfigurazione che sia) che si sprigiona dai temi stessi.
Con l'architettura sinfonica di questi temi e con il colore strumentale, l'autore ha saputo creare una misteriosa atmosfera. Aspirazioni vaghe, emozioni imprecise o volitive, passioni che affiorano con forza di seduzione arcana, dilagano'da questo breve preludio e indirizzano il nostro animo verso una zona di sensazioni crepuscolari. Nelle prime scene dell'atto 2° le voci dei venditori ambulanti che si succedono suggestivamente musicalizzate, su un tessuto fluttuante di ritmi e di timbri, accentuano questa impressione di un mondo che si desta alla vita. Quasi diremmo che è, più che un mondo umano, il mondo delle cose; più che il mondo degli affetti quello delle sensazioni. Ma una delle sensazioni si afferma fino dal primo istante su le altre, dominante: la sensazione della voluttà, la voce del piacere, per bocca del Nottambulo, e accende di sé l'aria che si rischiara ai primi bagliori dell'alba.
Un'altra pittura ambientale viva è quella del laboratorio di sartoria col canto gaio ed esuberante delle giovani sartine, il chiacchierio garrulo, le malignità, le confidenze, i frizzi e le risate che si snodano su un leggero e rapido ritmo staccato di terzine che sonorizza il ticchettio delle macchine da cucire. È una scena di una freschezza e naturalezza nuove, ben al di sopra, per esempio, del convenzionale coro delle filatrici del Vascello fantasma di Wagner.
Il 3° atto ci presenta altre due vigorose pitture. Una è l'invocazione a Parigi dei due amanti mentre scende la notte, la città si illumina, e il cielo si riempie di stelle. Il preludio reca per titolo «Verso la città lontana»: i temi dell'amore dei due giovani e della loro felicità ne formano il nucleo. Il primo di essi diverrà il simbolo del trionfo dell'amore libero, al quale Giuliano leverà un inno; il secondo formerà l'inizio dell'aria: «Da quel giorno che a te mi son data», nella quale Luisa canta la propria felicità. L'invocazione alla città incomincia sul motivo elastico di un voluttuoso valzer che si salda col tema simbolico del piacere e con un altro tema tratto dal grido di un venditore ambulante, che assurge a significazione della «speranza». Un crescendo di entusiasmo guida i motivi verso una più ampia e calda melodia, quella dell'amore di Luisa (già udita nel 1° atto), qui allargata con espressione quasi mistica, anch'essa legata all'impetuoso tema del «desiderio» con cui si apre l'opera. Anche qui, a parte i significati dei temi, di natura più o meno intellettualistica, il quadro s'impone per le sue tinte accese, cosicchè sembra che allo splendore delle luci lontane risponda un più luminoso .splendore delle anime inebriate d'amore e di libertà.
A questo quadro segue quello dell' «Incoronazione della Musa», di un colore ancora diverso. Tamburi, campane, fanfare accompagnano l'entrata dei bohèmiens, delle grissettes e della folla di popolo che partecipa od assiste alla mascherata. La musica, forte, ritmata, alterna il motivo di fuoco del «desiderio», il tema del «piacere», enunciato con vibrante energia dagli ottoni, con i motivi sguaiati dei bohèmiens, di una «canzone di Montmartre», e della popolare anarchica «Ravachole». Il Papa dei pazzi (il quale non è altri che il Nottambulo, ossia la personificazione del «Piacere») incorona di fiori Luisa, mentre l'orchestra intona come una marcia trionfale il canto del Piacere, e successivamente il Valzer gioioso e balzante che col Piacere stesso si identifica. Ora, questa scena è tutta una specie di pirotecnia musicale abbagliante, un getto continuo di tinte sgargianti e violente, qua e là inframezzate da più delicate sfumature, un misto di volgarità e di bellezze che coglie nel vivo l'elemento pittoresco di una festa popolare, anche se più nell'esteriorità che nel fatto psicologico.
L'elemento lirico amoroso si concentra tutto nei due personaggi di Luisa e di Giuliano, i cui canti, quelli di lei specialmente, hanno accenti del più frenetico delirio. A contrasto con questa coppia sta quella formata dal padre e dalla madre di Luisa, in cui si raccoglie l'elemento drammatico. La madre è rappresentata con un carattere iroso e violento, forse troppo. Essa non ha una sola frase amorosa per Luisa, se non quando è troppo tardi; e i suoi modi, che la musica rende ancor più taglienti e sarcastici, sembrano fatti più per esacerbare e indispettire la figlia che per condurla alla ragione e calmarne l'esaltazione. Il padre è invece disegnato con motivi stanchi ma pieni di bontà. Nell'ultimo atto la stanchezza si è fatta greve e si unisce a una desolata tristezza. Lo scatto di collera determinato dal contegno provocante della figlia, allorchè nell'urlo furente di tutta l'orchestra la scaccia di casa, cede subito alla più opprimente disperazione.
L'opera dunque consta di elementi disparatissimi, e tenta un connubio fra il verismo brutale del dramma e il romanticismo dell'interpretazione musicale che non sempre appare riuscito, anzi talvolta determina urti inconciliabili e talune gravi manchevolezze. Tale la scarsa o nessuna umanità di Luisa, la quale non vive che per il piacere erotico, ma il cui amore non ha slanci di sublimità; e anche il gretto egoismo della madre è senza un palpito di tenerezza.
La figura più sentita è il padre, e la sua meditazione: «Allevar una bimba», e la berceuse: «Resta, e ti riposa» nell'ultimo atto, tinte di un'amara malinconia profondamente toccante, sono le pagine più belle e sincere dell'opera.
[Torna all'indice]
IV.
Novecento (1901-1952)
ANTONIO SMAREGLIA - OCEÀNA: commedia fantastica in 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 22 gennaio 1902. Libretto di Silvio Benco. L'azione si svolge in Siria nell'epoca patriarcale.
Atto 1° - Nei campi di proprietà di Vadar, capo della tribù di Neat. - Mentre si miete, giunge cantando Nersa, giovane nomade amata da Vadar. Le mietitrici irate le si avventano contro, ma si interpone Ers, genio marino. Le donne fuggono impaurite. Ers dice a Nersa di essere inmato dal proprio Re per condurla a lui in isposa. Hareb, fratello di Vadar, li sorprende, ma Ers lo accusa come ladro ed avido delle ricchezze di Vadar, e quindi si allontana con Nersa. Hareb avverte Vadar della fuga di Nersa. Vadar si dispera, ma ecco che, accompagnata dal vecchio Uls, altro genio del mare, Nersa ritorna. Fra gli agricoltori si levano voci minacciose, ed Uls si dichiara pronto a punire la ragazza lasciandola per tre giorni fra gli scogli del mare. Vadar vorrebbe trattenerla; ma Nersa non vuol restare, e riparte con Uls fra i commenti ironici degli agricoltori.
Atto 2° - Spiaggia del mare. - È notte: Ers si bisticcia con Uls il quale ha raccolto Nersa in un momento in cui Ers l'aveva abbandonata, ed ora vuol presentarla al dio del mare Init come trovata da lui per avere in premio la grande perla promessa. Ma poi Uls si addormenta accanto a Nersa proprio quando giunge il Dio col suo corteo di divinità marine. Ers gli consegna Nersa e riceve la perla in premio. Uls si sveglia e strepito, ma a un tratto appare una vela sull'orizzonte: è Vadar. Init da ordine alle Sirene di cantare, ma Nersa, impietosita, si raccomanda a Uls che salvi Vadar. Uls getta un sasso nell'acqua e spaventa le Sirene. La navicella approda; ne sbarca Vadar che fugge con Nersa.
Atto 3° - Corte rustica innanzi alla casa di Vadar. - È il giorno destinato alle nozze di Vadar con Nersa, ma questa è triste: la nostalgia del mare l'assale., Ed ecco comparirle innanzi Init, al quale essa si abbandona nuovamente. Sopraggiunge Vadar, che vedendo Nersa fra le braccia di Init si dispera, e chiede al Dio di renderlo folle invece del fratello Hareb, già reso demente dalle Sirene. Allo scongiuro del Dìo una nuvoletta gira attorno ad Hareb che riacquista la ragione, e attorno a Vadar che la perde. Hareb, che si trova divenuto ricco quale erede di Vadar, è giubilante. Init e Nersa esultano. Intanto gli agricoltori preparano il festino per le nozze del Dio.
La favola sconclusionata ha scarsi elementi umani; incerto è il carattere di Nersa, odiosa la freddezza con cui accoglie il sacrificio di Vadar; ancor più odiosa la figura di Hareb il quale non ha una parola di compianto per la sorte del fratello, ma anzi gioisce per essere divenuto padrone d'ogni suo avere. La musica però sorvola Su questi episodi, volta a dipingere l'elemento fiabesco con rutilanti colori, anche se spesso l'onda dello stile wagneriano ne attenua l'originalità. Però su questo wagnerismo dello Smareglia si è esagerato: c'è/senza dubbio, e talvolta si impone nel disegno dei motivi, nelle modulazioni, nello strumentale, che sembrano ricalcati su analoghe espressioni delle opere di Wagner. Ma accade anche spesso che questo wagnerismo male assimilato non riesca a mascherare il calore e la limpidezza di una fantasia prettamente italica, che talora anche prevale su tutto con prepotente e vigorosa sincerità. Allora anche i motivi sinfonici acquistano un carattere di vocalità proprio della fantasia operistica nostra. Ci si può anche dolere dello scarso rilievo plastico dei motivi smaregliani; e ciò, insieme al diffuso wagnerismo e al poco interessante libretto, costituisce un'altra causa della nessuna fortuna arrisa a quest'opera, che peraltro non manca di pregi. Tali sono l'ossatura sinfonica robustamente costruita, la fluidità del discorso musicale, la vivezza della tavolozza orchestrale, e certe effusioni liriche animate da intimo calore.
A parte la bella sinfonia, dalla vivace e sapiente architettura, formata con gli elementi tematici principali dell'opera, l'atto migliore ci sembra il 2° che contiene la suggestiva pittura marina dell'introduzione, la gustosa baruffa fra Ers e Uls, la berceuse delicata di questi, il trionfale arrivo del Dio Init, l'appassionato, arioso duetto d'amore fra Init e Nersa, la conquista della perla e il risveglio di Uls. Peccato che il successivo canto delle Sirene e il finale riecheggino troppo motivi e armonie della scena fra Sigfrido e le Ondine nel Crepuscolo di Wagner.
Va pure segnalata nel 3° atto la melodiosa limpidezza totalmente italiana del quintetto fra Nersa, Init, Vadar, Ers ed Uls; italiana anche nella sobrietà della costruzione; ed anche il finale dell'opera, per quanto richiami alla mente il finale de I Maestri Cantori.
ALBERTO FRANCHETTI - GERMANIA: dramma lirico in un prologo due quadri e un epilogo. Prima rappresentazione alla Scala di Milano l'11 marzo 1903. Libretto di Luigi Illica.
Prologo - Epoca: 1806. - Vecchio mulino nei dintorni di Norimberga. - Sotto la veste di mugnai, studenti universitari cospirano contro il dominio napoleonico per la libertà della Germania, e stampano alla macchia pubblicazioni di propaganda politica. Ricercato dalla polizia, nascosto nella povera casupola della vecchia mendicante Lene Armuth, il tipografo Giovanni Filippo Palm dirige il lavoro; lo studente Carlo Worms è la mente ispiratrice. Questi, nell'assenza di Federico Loewe, abusò della sua fidanzata, Ricke. Ora giunge notizia del ritorno di Federico; Ricke vorrebbe denunziare l'onta subìta, ma Worms, minacciando di uccidere Federico se essa parla, la costringe al silenzio. Federico giunge con l'annunzio che la lega del Tugendbund è un fatto compiuto; sono con lui i rappresentanti delle Università tedesche. Körner, Lütsow, gli Schlegel, Humboldt, Fichte, Weber, ed altri. Alla vista di Weber gli studenti intonano la sua «Wilde Jagd». Ma d'improvviso giunge la polizia; tutti si dileguano rapidamente; i finti mugnai riprendono l'apparente lavoro. Il capo della polizia ha indicazioni precise in base alle quali Palm viene scovato e tratto in arresto. Mentre lo trascinano via, sommesso si leva ancora il canto della «Wilde Jagd» a salutare il martire che va a morte.
Quadro 1° - Rossa casupola di boscaiolo nella Selva Nera. - Qui si è rifugiato Federico dopo la sfortunata campagna del 1806. Il pastore Stapps viene a celebrare le nozze di Federico e Ricke. Questa, vinta la propria tristezza, si abbandona nelle braccia dello sposo, allorchè giunge Worms, che era stato creduto morto. In realtà, com'egli racconta, fu ferito gravemente; pure, il desiderio di riprendere la lotta gli diede la forza di fuggire. Egli avverte Federico che a Königsberg avrà luogo una riunione del Tugendbund; Federico sarà uno dei capi. Ma quando questi gli annunzia le sue nozze con Ricke, il ricordo del fallo commesso lo decide a ripartire. Mentre Federico lo accompagna, Ricke, sconvolta, risolve di fuggire. Al ritorno Federico trova un biglietto di lei dal quale apprende la sua fuga. Intanto si è scatenato un furioso temporale. Jane, la sorellina di Ricke, spaventata corre in cerca di lei. Federico raccontandole la sua partenza con Worms, riesce a sapere dalla fanciulla particolari che lo illuminano su gli avvenimenti passati. Decide allora di andare a Königsberg per insultare Worms ed ucciderlo.
Quadro 2° - A Königsberg: nei sotterranei della «Luisebund», diramazione segreta del Tugendbund. - I «Fratelli» si adunano. Al tavolo detta presidenza è Worms con altri capi. Viene introdotto il giovinetto Jebbel, nipote della mendicante Armuth, il quale si accusa di avere denunziato Palm per dell'oro, spintovi dalla pietà per la miseria della nonna. Ora il rimorso lo induce a consegnare l'oro del tradimento. I «Fratelli» vorrebbero per lui la pena di morte, ma Lützow lo salva arruolandolo. Poi è la volta del Pastore Stapps, il quale reca un fazzoletto intriso nel sangue del figlio, fucilato per avere attentato alla vita di Napoleone. Mentre Worms esalta il sacrificio dell'eroe, un uomo mascherato si leva ad accusare Worms di viltà. Worms lo sfida, ma riconosciuto in lui Federico Loewe, si umilia e gli chiede perdono. Federico lo schiaffeggia; allora egli si rassegna a una morte ingloriosa; ma Lutzow, al momento di dirigere lo scontro, getta la spada disgustato, disperando dell'avvenire. In questo istante compare su la soglia la Regina col giovane Principe erede. Tale apparizione desta un fremito di entusiasmo; anche in Federico e Worms l'idea della Germania libera riprende il sopravvento su la loro personale rivalità, e si abbracciano gridando: «Morire per la Patria!».
Epilogo. - La piana di Lipsia dopo la battaglia, il 19 ottobre 1813. - Ricke e Jebbel si aggirano fra i cadaveri in cerca di Federico. Lo ritrovano alfine morente. Riconosciuta Ricke, Federico le impone di cercare Worms, caduto poco lontano da lui con la bandiera stretta al petto, e di perdonarlo. Un rumore sordo lontano attrae l'attenzione ài Federico e di Ricke: su l'estremo orizzonte nel rosso tramonto appare la visione dell'esercito napoleonico disfatto, in ritirata, Federico con un ultimo sforzo si leva per vedere, e gridando «O libera Germania!» ricade spento.
Le migliori qualità di costruttore e di sinfonista possedute da Alberto Franchetti si adunano in Germania, che è anche l'opera sua più pervasa da un'abbondante e calda vena di melodia; quella in cui il fraseggio drammatico incide con più pronta efficacia. Un senso eroico robusto sorregge da capo a fondo questa musica, sommergendo anche la tragedia amorosa di Ricke, Federico e Worms, che si sviluppa soprattutto nel 1° quadro. Per quanto Ricke, col suo motivo faticoso, appaia figura ben rilevata nel tormento perenne del dolore per l'onta subìta e pel silenzio a cui è costretta, e Federico abbia canti felici di tenerezza amorosa che si espandono specialmente nel dolcissimo: «No, non chiudere gli occhi vaghi» e nelle ardenti frasi successive del duetto d'amore; e impeti d'ira e disperazione irruenti, sia allorchè apprende la fuga della sposa, sia quando a Königsberg provoca Worms per; ucciderlo, la musica è principalmente carica dell'atmosfera di epopea grandiosa in cui i personaggi si muovono. Epopea che il musicista ha saputo porre in primo piano ed esprimere e illuminare con nobiltà e forza d'accenti, con ampiezza vigorosa di canti, e con un alato irrompere di slanci corali che sollevano il sentimento dell'amore di patria con un soffio di entusiasmo trasfiguratore.
Sono imbevuti di questa luce epica il largo cantabile di Federico nel Prologo: «Studenti, udite, o voi», la cui melodia, ora in maggiore ora in minore, ora con energia d'accenti, ora come un pianto accorato, riappare nei momenti fondamentali dell'opera. E lo sono i movimenti corali del Prologo e soprattutto del solenne finale del 2° Quadro. Ma non sono da passare sotto silenzio neppure il coro dei falsi mulattieri: «Lieve balza», e quello dei finti mugnai: «Gira, gira» nel Prologo per le loro espressioni caratteristiche e suggestive. Il Franchetti ha saputo anche sfruttare, sempre nel Prologo, il motivo di una canzoncina dell'epoca, «Tante stelle son splendenti», il lieder che Lene insegna al piccolo Jebbel affinchè vada a cantarlo in giro per guadagnare qualche povera elemosina; e la superba «Wilde Jagd» di Weber, la cui esplosione segna uno dei culmini d'entusiasmo epico del Prologo, e che, cantata da Worms al suo giungere, nel 1° Quadro, è per Ricke come la voce del passato che travolge per sempre il sogno d'amore in cui sperava di rinascere redenta a nuova vita.
Worms è veramente la figura centrale e monumentale della tragedia. Egli si dibatte tra il rimorso per la violenza usata a Ricke, che egli tuttavia rievoca entro un alone di poesia nel sognante «Tu m'eri innanzi nel morente giorno» del Prologo, e il suo eroico amore di patria, che ha i momenti più fortemente espressivi nell'amaro sarcasmo dell'«Io pure una visione», sfociante nello scettico canto goliardico «Gaudeamus igitur» (Prologo), e soprattutto nel drammatico racconto del 1° Quadro: «Ferito, prigionier», col suo ritmo funebre e leggendario nella prima parte. La seconda si apre col largo commosso canto: «Appena il suolo santo», che sarà ripreso dal coro nel finale del 2° Quadro, e da Federico nell'Epilogo allorchè inviterà Ricke a cercare il cadavere di Worms e a perdonargli. Invece, al momento in cui Worms deciderà di farsi uccidere in duello da Federico in espiazione del proprio fallo, ritornerà, in minore e lentamente, il baldanzoso «Studenti udite» che Federico stesso intonò come canto di fraterno amore nel Prologo.
Accanto ai tre personaggi principali ne vivono molti altri secondari, fra i quali due emergono per maggiore compiutezza lirica. Uno è Jebbel, ben disegnato nella breve dolorosa confessione del suo tradimento (Quadro 2°), e nel drammatico racconto della battaglia attorno al Thonberg. L'altro è Jane, gentile figuretta di fanciulla spaurita e sperduta con la sua innocenza nell'immane tragedia domestica e politica. Essa esce dall'ombra con lineamenti di più commossa umanità alla fine del Prologo, quando, per salutare Palm che s'avvia verso la morte, intona con la sua esile voce la «Wilde Jagd»; poi nel 1° Quadro quando interroga tristemente stupita Ricke piangente nel giorno delle nozze («La sorellina che mi fa da mamma»), e alla fine del Quadro stesso nell'ingenua narrazione («Sempre piangeva») del doloroso tormento che travagliava l'anima di Ricke al mulino, narrazione che è per Federico una tragica rivelazione. Un po' greve nei suoi canti il Pastore Stapps, e di una comicità un po' forzata lo studente Crisogono.
L'orchestra, commentatrice ricca di colore, ha anch'essa momenti di più accesa espressione sinfonica, specialmente nell'interludio del 1° Quadro descrivente la dolcezza della sera nella foresta (che il Franchetti tolse da un'impressione sinfonica che si intitola appunto «Nella foresta»); nella scrosciante descrizione successiva del temporale; poi nell'Intermezzo sinfonico precedente l'Epilogo, che descrive il campo di battaglia, coi gemiti dolorosi degli agonizzanti, la tetra visione dei morti, l'aleggiare fantastico di una leggendaria cavalcata di eroi e il misterioso coro che inneggia ai vincitori caduti. Infine alla chiusa dell'opera, nella breve cupa descrizione della ritirata dell'esercito vinto fra i bagliori sanguigni del tramonto.
CLAUDIO DEBUSSY (Saint-Germain-en-Laye [Parigi] 1862 - Parigi 1918). - PELLÉAS ET MÉLISANDE: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 28 aprile 1902. Dramma di Maurizio Maeterlinck.
Atto 1° - Quadro 1° - Una foresta. - Il principe Golaud, nipote di Arkël Re di Allemonda, inseguendo a caccia una belva si è perduto nella foresta. Ivi s'incontra con Mélisande, bellissima fanciulla, essa pure smarritasi. È fuggita, forse per non subire nozze a lei sgradite, ma rifiuta di rivelare ogni suo segreto. Una corona le è scivolata in fondo all'acqua di una fontana, ma non vuole ch'essa sia raccolta. Invitata da Golaud a seguirla, se ne va con lui senza opporre resistenza.
Quadro 2° - Un appartamento nel castello di Re Arkël. -Genoveffa, madre di Golaud e di Pelléas legge ad Arkël una lettera in cui Golaud racconta a Pelléas come trovò Mélisande, da sei mesi sua sposa. Teme l'opposizione del Re e chiede che se questi acconsente alle sue nozze, faccia accendere una lampada su la torre che guarda verso il mare. Arkël dà il suo assenso.
Quadro 3° - Davanti al castello. - Mélisande e Golaud sono giunti. Mélisande osserva con tristezza l'oscurità di cui la densa foresta circonda il castello, ma Genoveffa le indica la chiarità del mare da cui giungono i richiami di marinai e barcaioli. Genoveffa l'affida poi a Pelléas, mentre essa va a vegliare Yniold, il piccolo figlio della prima moglie di Golaud.
Atto 2° - Quadro 1° - Una fontana nel parco. - Mélisande è con Pelléas; essa lancia in aria per gioco l'anello nuziale, che cade nella fontana, troppo profonda perchè lo si possa raccogliere.
Quadro 2° - Una stanza nel castello. - Golaud è in letto ferito; nello stesso istante in cui l'anello di Mélisande cadeva nell'acqua, il cavallo di Golaud si adombrava gettandolo a terra. Mélisande lo assiste: è triste e piange. Golaud prendendole le mani s'accorge che non ha più l'anello. Essagli dice che le è caduto dentro una grotta vicino al mare. Golaud vuole che essa vi si rechi subito con Pelléas per ricuperarlo prima dell'alta marea.
Quadro 3° - Davanti a una grotta. - Pelléas e Mélisande entrano nella grotta per obbedire a Golaud, pur sapendo bene dov'è caduto l'anello. Essi vi scorgono tre poveri, addormentati. Mélisande ne è impressionata e riparte con Pelléas.
Atto 3° - Quadro 1° - Una delle torri del castello. - Mélùande a una finestra sta ravviandosi i lunghi capelli. Nello sporgersi per parlare con Pelléas i capelli si rovesciano su di lui, che li afferra e li bacia in uno slancio di ebbrezza. Mélùande sente alcuno avvicinarsi; vorrebbe ritirare i capelli ma Pelléas per ischerzo glieli ha legati ad un ramo. Golaud sorprende Pelléas e Mélùande così; li rimprovera per il loro giuoco fanciullesco e si allontana ridendo nervosamente.
Quadro 2° - Un sotterraneo del castello. - Golaud mostra al fratello l'abisso ove ristagna un'acqua cupa. Egli lo tiene stretto per un braccio su l'orlo del precipizio ma nella sua mano la fiaccola trema. Pelléas se ne accorge ed è preso da un senso vago di terrore.
Quadro 3° - Una terrazza all'uscita del sotterraneo. - Golaud invita Pelléas a non scherzare con Mélisande. Ella sarà presto madre; anche la più piccola scossa può nuocerle. Golaud ha qualche sospetto su i rapporti del fratello con la sposa ma crede che basti averlo avvisato. Stia lontano da lei, ma con naturalezza.
Quadro 4° - Davanti al castello. - Il piccolo Yniold interrogato dal padre gli dice come Mélisande e Pelléas siano sempre insieme, ma non sa spiegargli ciò che essi dicono. Un giorno li ha visti baciarsi. Golaud solleva il fanciullo perchè guardi dentro alla stanza di Mélisande. Vi è anche Pelléas; entrambi guardano la lampada e tacciono. Il piccolo ha paura e il padre insiste invano perchè egli guardi ancora.
Atto 4° - Quadro 1° - Un appartamento del castello. - Pelléas deve partire; ma vuol prima parlare un'ultima volta a Mélisande e le dà un appuntamento per la sera nel parco. Frattanto Golaud, sempre più persuaso della colpevolezza della sposa, perde ogni ritegno: la insulta, l'afferra pei capelli, la costringe a inginocchiarsi e la minaccia con la spada. La lascia solo quando Arkël accorre in sua difesa, ma pronuncia ancora oscure parole contro di lei.
Quadro 2° - Il parco presso una fontana. - Yniold cerca di sollevare una grossa pietra, troppo pesante per le sue forze. Un gregge di pecore passa. «Dove vanno esse», chiede al pastore, ma questi non risponde. Viene sera; Yniold rientra. Giungono ora Pelléas e Mélisande, i quali si confessano il loro reciproco amore. Ma li sorprende Golaud. Nell'istante del pericolo i due amanti si abbracciano e si baciano perdutamente. Golaud che li spiava dietro gli alberi si precipita su di loro con la spada; uccide Pelléas e ferisce Mélisande che fugge.
Atto 5° - Una camera nel castello. - Mélisande è morente. Essa ha dato alla luce una bimba. Ma non del parto prematuro nè della lieve ferita essa muore. Golaud è disperato pel gesto compiuto, tuttavia è tormentato dal dubbio. Rimasto solo con lei le chiede se è stata colpevole, ma Mélisande delira e non risponde a tono. A un tratto entrano nella stanza i servi e s'inginocchiano; una campana rintocca lenta in distanza. «Essi hanno ragione!» esclama il medico; Mélisande è morta.
Impossibile, esponendo per sommi capi l'azione del dramma, rendere conto della finezza di un dialogo che è tutto intessuto di frasi e parole dietro alle quali si celano significazioni che vanno molto al di là della loro espressione verbale. Il linguaggio simbolico maeterlinckiano non si riassume. Eppure in questo linguaggio sta tanta parte dell'espressione musicale. Non che quella del Pelléas et Mélisande sia una musica a doppio senso, chè l'arte dei suoni non può far questo; ma il linguaggio strumentale di cui Debussy circonda i personaggi di Maeterlinck crea un'atmosfera di mistero che suggerisce questo «al di là» delle parole. I personaggi sono essi stessi dei simboli, e ci appaiono velati e quasi irreali. Questa Mélisande, chi è? donde viene? Che cosa le è accaduto? Tutto è incerto. «Noi non vediamo mai che il rovescio del destino», dice Arkël. Accadono infatti inesplicabili coincidenze misteriose di avvenimenti; ad esempio, la caduta da cavallo di Golaud nello stesso istante in cui l'anello di Mélisande cade nell'acqua. Pelléas et Mélisande, spinti come sono da forze misteriose l'uno verso l'altra, sono essi colpevoli? La colpa suppone una coscienza del male; ma Pelléas e Mélisande agiscono come sonnambuli in uno stato di perfetta incoscienza. Perciò la colpa sembra essere più del fato che di loro stessi. Tutto è mistero nelle loro anime e attorno a loro; e questo senso di mistero, di fatalità, di felicità irraggiungibile, di poesia dell'indefinito, è nella musica di Debussy, ricca di chiaroscuri, di sfumature, di penombre, di intimità arcana.
Per raggiungere. questa espressione Debussy ha eliminata la modellazione ampia e quadrata della melodia; specialmente della melodia vocale. Egli si attiene ad un recitativo che aderisce così al suono come al peso delle parole, alla particolare musicalità del linguaggio come alla significazione simbolica di esso; un recitativo che si avvicina a quello della Camerata fiorentina, ma che ha in più la profonda risonanza dell'oscuro mondo ulteriore da cui le parole nascono e del mistero al quale tendono. Il più tipico esempio di questo recitativo si ha nella lettura della lettera di Golaud (atto 1°, quadro 2°). Le parole sono appena intonate musicalmente, e tuttavia con inflessioni profondamente suggestive, piene di mistero, di sentimento e di drammaticità, sopra un diafano tessuto di accordi e di fugaci accenni tematici che creano un'atmosfera pensosa e trasognata. Nulla di più semplice e di più poeticamente efficace! Per questo legame stretto del linguaggio musicale debussyano al linguaggio parlato, assai più stretto che non in Wagner, l'opera è intraducibile. Cantata in altre lingue, essa perde assai più che non qualsiasi altra opera francese o tedesca o italiana.
Attorno al recitativo, che senza diventare mai melodia acquista tuttavia di tanto in tanto accentuazione melica, che senza diventare mai grido sale però ad effetti di intensa sonorità, l'orchestra crea un alone di suoni, di armonie, di timbri vivamente suggestivi.
Non mancano alcuni temi, come quello di Golaud che appare la prima volta alla quinta battuta del preludio, o come quello più frequentemente ripetuto, e di una delicatezza aerea, di Mélisande; ma più che essere legati alle persone, essi fanno parte dell'atmosfera che le circonda. Infatti l'orchestra di Debussy, col suo svariare di armonie esacordali, sfuggenti ogni cromatismo, coi suoi impasti strumentali morbidi che non annullano le voci dei singoli strumenti, con il vago fluttuare di accenni tematici e di ondeggiamenti ritmici, con le nuances di colori e di intensità sonore, ha lo scopo non di scendere nel cuore dei personaggi o di precisarne l'azione, ma di creare attorno a ciascuno di essi e a ciascun momento del dramma un'atmosfera di impressioni fuggevoli ed evanescenti. Ricorderemo a questo proposito l'ultima scena del 1° atto, dove le armonie sfumate, i richiami lontani dei marinai, il dialogo pieno di incantamento .tra Pelléas e Mélisande, ci avvolgono in una suggestione lunare di sogno. Ricordiamo ancora l'atmosfera tutta brusii e chiaroscuri della scena innanzi alla caverna, in cui la poesia dell'ambiente si sposa alla tristezza prodotta dalla vista dei tre mendicanti addormentati; e l'atmosfera cupa e greve del sotterraneo col profondo abisso pauroso, e la freschezza luminosa dei vasti arpeggi allorchè Pelléas e Golaud ritornano alla luce; più che impressioni di paesaggio, impressioni di un'oscura minaccia mortale e susseguente senso di liberazione e di vita. Ancora: l'ingenua contemplazione di Yniold al passaggio del gregge, di un candore liliale; e infine quell'atmosfera di miracolo allorchè i servi cadono a un tratto in ginocchio nel momento in cui Mélisande muore, mentre le campane rintoccano lente e remote, quasi suonassero da un altro mondo, sullo stupefatto sordo mormorio dei bassi.
Questi alcuni dei momenti fondamentali, ma quasi ogni parola ha un suo alone sonoro in cui respira e vive. Si potrà affermare che nelle tinte usate dal musicista predomina con soverchia uniformità il grigio; che questa uniformità, unita all'uniformità pallida del recitativo, quasi sempre sottovoce, finisce per generare una certa monotonia. Sono questi, in realtà, i difetti maggiori della partitura, ai quali si può aggiungere il timore verecondo, e talvolta spinto fino all'assurdo, dell'abbandono canoro. Ma non si può sfuggire alla poesia che emana da tutto l'insieme. Chi ascolta deve aver presente che l'espressione lirica del dramma sta tutta nell'evocazione impressionistica creata dalle evanescenti fluttuazioni armoniche, talvolta morbosamente estenuanti, in cui passano come richiami incantesimali le brevi frasi tematiche dai contorni spesso indecisi, suggerite momento per momento dalle parole del dialogo. E deve inoltre ricordare che il dialogo non ha valore musicale se non in quanto si intona alle parole stesse, al loro «al di là» e all'atmosfera creata dall'orchestra, che tale «al di là» realizza in un mondo fatto più di sogno che di realtà.
Se qualcosa dell'impressionismo di Debussy deriva da altri bisogna pensare a Mussorgski; non a quello dei quadri violenti di rivolta o di allucinazione, ma a quello della scena del convento, o a quello dei commenti musicali alle nenie dell'Innocente nel Boris. Debussy rifugge da ogni eccesso e da ogni violenza brutale; ama la penombra e il silenzio. Nel momento in cui Pelléas e Mélisande si confessano il loro amore, il musicista per paura di lasciarsi prendere da uno slancio entusiastico del cuore, e da un conseguente balzo canoro e sonoro che potesse sembrare anche lontanamente enfasi, fa tacere l'orchestra, e i due mormorano la parola «t'amo» a voce bassissima, come se fossero presi da un ignoto terrore. Pelléas commenta: «Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde!... Je ne t'ai presque pas entendue...» Ma poco dopo, allorchè Pelléas esclama: «On dirait que ta voix a passe sur la mer au printemps!», l'orchestra finalmente di abbandona ad un'ampia frase piena d'incanto, di tenerezza e di profumo. Nè mancano frasi e disegni di estrema delicatezza; e non è detto che tutto ciò che è vaporoso e sfumato manchi di passione, come insegna non solo tutto questo duetto del 4° atto (diciamo duetto per intenderci, anche se questo termine qui non sia preciso), ma anche l'altro del 3° allorchè Pelléas giuoca coi capelli di Mélisande, specie alle parole: «Je les noue, je les noue (si noti la ripetizione delle parole come nei duetti dei vecchi melodrammi) aux branches du saule...», e il musicista segna su la musica: «progressivement animé et passionné». Il grigiore qui si illumina di bagliori fulgidi, e il canto spesso si abbandona ad accenti in cui freme una ebbrezza trepida. E le armonie, in entrambi questi duetti, passano per dissonanze che il musicista ha saputo rendere morbide di languore o preziosamente cariche di aromi e di voluttà.
Tutto ciò non deve far credere che manchi il dramma; tutt'altro. Ne fa fede la scena in cui Golaud trascina Mélisande per i capelli; la musica è tutta solcata da un tempestoso movimento di terzine e da duri incontri armonici, mentre Golaud in un impeto di geloso furore, grida aspramente: «Vos longs cheveux servent enfìn a quelque chose!». Un'altra scena fortemente drammatica è quella finale del 3° atto, nella quale Golaud solleva il bambino affinchè guardi dalla finestra ciò che accade tra Pelléas e Mélisande. Anche in questo caso Golaud grida al fanciullo: «Regarde! regarde!», mentre su un minaccioso motivo del basso l'orchestra freme convulsa e chiude l'atto in estremo tumulto. Anche nel momento in cui Golaud ferisce a morte il fratello (finale del 4° atto), questi stringe Mélisande gridando come in un delirio d'amore e di morte: «Ta bouche!... ta bouche!...», mentre in orchestra vibra luminoso il motivo dell'amore inseguito da un breve tema inquieto e cupo che si arresta su alcuni accordi tragicamente laceranti, segnati fortissimo con tre f!
Sono questi i momenti in cui le pallide figure del dramma, sempre avvolte da un alone di mestizia profonda, escono dalla penombra di un mondo trasognato alla luce della vita reale, palpitanti di vera e intensa umanità.
FRANCESCO CILEA - ADRIANA LECOUVREUR: opera in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano il 6 novembre 1902. Libretto di Arturo Colautti, tratto da una commedia-dramma di Eugenio Scribe ed Emesto Legouvé.
Atto 1° - Il foyer della Comédie Francaise. - Michonnet, maturo direttore di scena, è segretamente innamorato della giovane attrice Adriana Lecouvreur, ma quando sta per palesarle il suo affetto, essa gli confida di essere innamorata di tale Maurizio che crede alfiere del Conte di Sassonia, ma che in realtà altri non è che il Conte medesimo, pretendente al trono di Polonia. Con lui Adriana poco appresso ha un colloquio, durante il quale gli dona un mazzolino di violette. Frattanto il Principe di Bouillon, amante geloso dell'attrice Duclos, avendo intercettato un biglietto nel quale essa invita un altro innamorato a un convegno nel villino del Principe, e sospettando in Maurizio il rivale, gli fa recapitare il biglietto, ed invita tutta la compagnia ad una festa nel villino, ove conta di sorprendere gli amanti.
Atto 2° - Salotto nella villa del Principe. - Maurizio, venuto alla villa in seguito al biglietto ricevuto, vi trova la Principessa di Bouillon della quale era ramante. Egli vorrebbe sciogliersi da questo vecchio legame, ma la Principessa, gelosa e sospettosa, si fa consegnare da lui il mazzolino di viole datogli da Adriana. Giungono frattanto il Principe Bouillon e l'abate Chazeuil, persuasi di sorprendere Maurizio con la Duclos (la Principessa ha appena il tempo di celarsi nella stanza accanto), e giungono i comici. U Abate vorrebbe vedere la donna nascosta (che crede la Duclos). Maurizio scongiura allora Adriana (che ormai sa chi egli sia) di far fuggire la donna senza che alcuno la veda, poichè si tratta - afferma - di affare politico segreto. Nel colloquio che, al buio, ha luogo tra le due donne, esse, pur senza potersi riconoscere, si scoprono rivali. Mentre Adriana chiama i servi con lumi, la Principessa fugge. Michonnet le narra poi ch'essa è fuggita con Maurizio.
Atto 3° - Salone nel palazzo del Principe di Bouillon. - Vi è ricevimento per la rappresentazione di un balletto. La Principessa vuol sapere chi sia la nuova fiamma di Maurizio e appunta i suoi sospetti su Adriana. Le due donne si lanciano frasi nascostamente mordaci. Finito il balletto, Adriana, invitata a recitare, declama un brano della Fedra rivolgendone una frase atrocemente offensiva alla Principessa, la quale giura fra sè di vendicarsi.
Atto 4° - Stanza in casa di Adriana. - Nel giorno della sua festa Adriana riceve un cofano contenente le violette ch'ella aveva donato a Maurizio. Come lo apre, essa è colta da violenta vertigine poichè nei fiori è racchiuso un veleno: è la vendetta dell'oltraggiata Principessa. Poco appresso Maurizio torna a lei per offrirle la mano di sposo; lo gioia rinasce nel cuore di Adriana, ma troppo tardi: il veleno aspirato la uccide.
A compensare il difetto di drammaticità della musica; sta la sua aristocratica e fine eleganza. Sono melodie affettuose, anche appassionate; forse un po' fragili nella loro grazia gentile, e un po' troppo ripetute, ma sono ricche di un delicato soffio di poesia. Questa eleganza risente della galanteria settecentesca e della signorilità francese, senza assurde imitazioni e senza false affettazioni. Anche lo strumentale, con le sue tinte morbide e trasparenti, e la semplicità della struttura armonica e di tutta la costruzione, solida pur nella sua esile apparenza, contribuiscono ad accrescere il sottile fascino di questa partitura.
Lo stile non si distoglie da quello della commedia musicale, se non in pochi e fuggevoli istanti di più intensa espressione drammatica. Ma non sono questi ultimi i momenti migliori. Il nostro animo si lascia vincere invece commosso dalle schiette e soavi pagine liriche, quali, ad esempio, nel 1° atto, la presentazione di Adriana: «Io son l'umile ancella», la breve aria di Maurizio: «La dolcissima effigie», e specialmente il monologo di Michonnet: «Bene! benissimo!», in cui è ripreso orchestralmente il motivo della presentazione di Adriana, seguìto da recitativi concitati e dal motivo patetico dell'amore di Michonnet. Ma in questo primo atto, che è forse il migliore dell'opera, sono da ammirare anche la brillante festosa scioltezza dell'inizio, e il tema nervoso che sottolinea come una minaccia la fine della perorazione orchestrale dopo che Adriana ha consegnato a Maurizio le violette, e che diverrà infine, logicamente, il tema della gelosia della Principessa e del veleno.
Altri momenti felici sono quelli in cui il canto si tinge di una tenera e nostalgica malinconia, come al 2° atto, nell'aria di Maurizio: «L'anima ho stanca». Malinconia che avvolge gran parte dell'ultimo atto e che culmina nell'aria di Adriana: «Poveri fior», su un motivo il cui spunto ricorre qua e là negli atti precedenti ogni qual volta si accenna alle violette, e ampiamente sviluppato nel preludio del 4° atto. Nella romanza «Poveri fior» il motivo è accompagnato da due note lentamente oscillanti, la cui monotonia insistente accresce la malinconica tristezza del quadro. Ma più oltre la malinconia si spiritualizza nel canto di Adriana: «No, la mia fronte», e nell'altro, che poi chiude l'opera come una trasfigurazione angelica: «Ecco la Luce».
UMBERTO GIORDANO - SIBERIA: dramma in 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 19 dicembre 1903. Libretto di Luigi Illica.
Atto 1° - Rotonda nell'elegante palazzina regalata dal Principe Alexis alla mondana Stephana. - È quasi l'alba, e Stephana non è ancora rientrata. Gleby, che laidamente specula su Stephana, svia Alexis e gli amici sopraggiunti affinchè non s'accorgano ch'essa è assente, prima improvvisando una «mattinata» alla bella ch'essi credono ancora in letto, poi portandoli in altra stanza a giocare. Stephana rincasa: essa ama un giovane ufficiale, Vassili, il quale non sa chi ella sia; e prova in questo amore disinteressato e sincero un senso di purificazione. Vassili, prima di partire per la guerra, viene a salutare la nutrice Nikona, cameriera di Stephana, e così si incontra con questa, e viene a sapere chi è. L'amore gli fa tuttavia superare la disillusione; ma Alexis li scopre, insultao la donna, si batte con Vassili e ne resta ferito.
Atto 2° - Alla frontiera fra la Siberia e la Russia. La Poloo-tappa fra Omsk e Kolyvan. -Giunge la catena dei forzati. Fra essi è Vassili. Mentre si distribuisce la posta giunge una troika: è Stephana che ha ottenuto di poter raggiungere l'amante e di seguirne la sorte in Siberia, per redimersi.
Atto 3° - L'interno della «Casa di forza» nelle miniere del Trans-Baikal. - È il Sabato Santo. I forzati preparano una rappresentazione. Anche Gleby è stato mandato in Siberia. Egli insegna a Stephana un segreto passaggio per uscire dal campo dei forzati e l'invita a fuggire con lui, ma Stephana rifiuta sdegnata. Gleby, irritato, racconta allora ai condannati storie infamanti sul conto di Stephana, ma questa, di fronte a Vassili e ai compagni di pena, smaschera senza pietà il miserabile. Frattanto le campane del lontano villaggio annunziano la Pasqua; indi tutti si recano alla rappresentazione. Approfittando della momentanea solitudine, Stephana tenta di fuggire con Vassili per la via indicatale da Gleby', ma costui se ne accorge e li denunzia. Una sentinella fa fuoco; Stephana, colpita, muore, felice di aver data la vita per amore di Vassili, e redenta dal sacrificio.
Se consideriamo Siberia dal punto di vista della sua «teatralità», cioè del fascino che può esercitare sul pubblico, non v'ha dubbio che Siberia è inferiore non solo a Fedora, ma specialmente all'Andrea Chénier, e ciò non solo per le minori attrattive che presenta il libretto, ma, nei riguardi dello Chénier, anche per la minore abbondanza di motivi. Non diremmo però che le resti al di sotto per la qualità dei motivi, che sono di un'ispirazione felice oltre che aderente al testo, mentre supera tutte le altre opere precedenti di Giordano per la robustezza drammatica di qualche scena e per lo stile. Infatti, armonia, contrappunto e strumentazione in Siberia sono curati con un interesse che va oltre al semplice scopo dell'immediatezza operistica per mirare alla raffinatezza e all'eleganza propria della musica sinfonica.
Il libretto però reca situazioni e stati d'animo così esasperati da costringere l'orchestra e le voci a impennarsi in accenti di grande violenza; e di ciò si è fatto un appunto all'autore. Non bisogna tuttavia dimenticare che Siberia è un dramma «verista» e che perciò le situazioni tese e violente ne sono necessariamente una caratteristica. Bisogna dunque distinguere tra il grido enfatico, a vuoto, e il grido di spasimo; tra la ridondanza rettorica e truculenta e l'impeto canoro che nasce da uno stato d'animo disperato. E perchè mai ciò che ogni giorno accade nella vita dovrebbe essere proibito nell'arte? Perchè mai gesti o parole veementi dovrebbero essere falsati attenuandoli nell'espressione musicale? Naturalmente, non si dice qui che tutto in Siberia sia oro colato. Vi sono ineguaglianze sensibili di ispirazione, non solo fra i due atti estremi e il 2°, che è il più forte ed è tutto alto e compatto, ma anche fra pagina e pagina di uno stesso atto. I caratteri poi non sono bene differenziati: Stephana e Vassili sono sommersi da un'unica vampa di passione che quasi li identifica, e se Stephana si differenzia un poco, è solo per quel suo sogno di redenzione che trascina con lei la musica in una sfera più pura ed alta. Ma la malvagità e la volgarità di Gleby non trovano nella musica il necessario rilievo. Dei due caratteri indicati, la volgarità è forse più evidente della malvagità, per quanto anche Gleby non manchi di tratti eleganti, com'è nella piacente «mattinata» del 1° atto. La sua figura cinica e bassa è meglio disegnata nel racconto del 3° atto: «La conobbi quand'era fanciulla» in cui la parola trova nella musica (specie in orchestra) movenze di una ironia penetrante.
L'amore di Vassili si afferma subito come qualcosa di travolgente e di indomabile nel concitato: «T'incontrai per via», che è il motivo dominante del finale 1°. Nell'ultimo atto questa passione cambia di colori, ma non di energia; si fa tenera con anima nell'arioso: «Ed ha fin la mia sciagura», drammatica nel tormentoso sfogo: «Fiele! da un'ora! Contro te! Contro me!», dolorosa nell'implorazione: «No, Stephana! Taci, ah! Taci!» che segue all'amaro pianto di Stephana: «Ah, se il fango della terra».
Stephana vive di un sogno puro di redenzione, che se trova un'espressione ancora morbida e velata nella confessione del 1° atto: «Nel suo amore rianimata», si fa abbandono rapito al 2° atto nella dolcezza della melodia: «È qui con te il mio destin», per salire a un canto di liberazione e di purificazione al 3° nell'espansivo: «Qui vivo e sento sole e fiori».
Uno dei momenti drammatici più robusti lo troviamo al 2° atto, dopo il delirante incontro dei due amanti, nel racconto di Vassili: «Orride steppe», il cui motivo pieno di una tristezza desolata, forma il perno del pure drammaticissimo intermezzo, e si ripeterà nei più tragici momenti dell'azione nel 3° atto, giuocato in varie maniere, anche sotto forma di anelante fugato allorchè i soldati inseguono gli amanti. Pieni di intensa ed esasperata drammaticità sono anche il duetto fra Stephana e Gleby nel 3° atto, e l'accusa di Stephana: «Tu vuoi saper costui chi è?», su un impetuosissimo movimento di terzine simile a un vento di bufera.
Qua e là, disseminati per l'opera, alcuni canti russi, sapientemente elaborati e usati con alto intendimento, portano la nota caratteristica e inconfondibile del colore locale. Fra essi i più importanti sono la «canzone del Volga» che la «catena vivente» canta come un lamento che sale fino alla disperazione, o vanisce in una tenebra di morte, e il canto delle campane di Pasqua che, su un vellutato mormorio degli archi, crea una mistica oasi di pace nella violenza del dramma che precipita.
Non sapremmo dunque perchè a quest'opera dovrebbe negarsi il diritto alla vita, mentre è anche certo che poche volte Giordano seppe essere così personale e nuovo sotto ogni aspetto, inventivo e tecnico.
GIACOMO PUCCINI - MADAMA BUTTERFLY: tragedia giapponese in 2 atti e tre parti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904. Ritoccata e di nuovo presentata al Teatro Grande di Brescia il 28 maggio dello stesso anno. Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa dalla tragedia di John L. Long e David Belasco.
Atto 1° - Collina presso Nagasaki. Casa giapponese con terrazzo e giardino. - Il sensale di matrimoni Goro mostra a Franklin Beniamin Pinkerton, ufficiale nella Marina da guerra degli Stati Uniti di America, la casetta affittata per lui e per colei che sarà fra poco sua sposa. Infatti Pinkerton si deve sposare con Cio-Cio-San, detta Madama Butterfly, ex gheisa; matrimonio all'uso giapponese, da potersi sciogliere non appena il marito abbandoni la moglie. Sharpless, Console degli S. U. a Nagasaki, bonariamente sconsiglia l'amico da un simile inganno ad una fanciulla ingenua che crede di contrarre un matrimonio per davvero e l'ama seriamente. Ma Pinkerton se ne ride e brinda al giorno in cui prenderà una vera sposa americana. Intanto Butterfly giunge con i parenti e gli amici; e un commissario imperiale giapponese celebra le nozze. Ma sopraggiunge uno zio di Butterfly, bonzo, il quale rivela che Butterfly ha rinnegata la religione degli avi, e perciò la maledice. I parenti e gli amici fuggono. Pinkerton, rimasto solo con la sposa, la conforta e, ardente di desiderio, la conduce nella casetta.
Atto 2° - Parte 1a - Interno della casetta di Butterfly, -Da tre anni Pinkerton è partito; la misèria batte alla porta, e Goro consiglia invano Butterfly a prendersi in isposo il principe Yamadori che l'ama. Ma Butterfly crede ancora al ritomo di Pinkerton e respinge il ricchissimo pretendente. Il Console viene a leggerle ma lettera di Pinkerton, nella quale annunzia il suo ritorno con una moglie americana. Ma Butterfly non lo lascia finire; crede che torni per lei. Sharpless allora le dice bruscamente che Pinkerton non tornerà mai più. A tale notizia Butterfly risponde mostrandogli il figlioletto biondo. Alla vista del bimbo il Console si commuove, e promette di avvertirne il padre. Partito il Console un colpo di cannone annunzia l'arrivo della nave di Pinkerton. Butterfly, delirante di gioia, adorna di fiori la stanza e si prepara, col bimbo e la serva Suzuki, ad attendere lo sposo.
Parte 2a - La stessa scena. - La notte è trascorsa in un'attesa vana. Affranta dalla stanchezza e dalla delusione Butterfly si decide ad andare a riposare. Il Console frattanto ha informato Pinkerton della nascita del figlio, e viene con lui e la nuova sposa Cate a pregare Susuki affinchè convinca Butterfly a consegnarglielo. Appena partito Pinkerton, Butterfly, che ha sentito parlare, entra precipitosa credendo di trovarlo, e si incontra invece con la sua giovane moglie. Compreso il suo abbandono e quanto si vuole da lei, promette di consegnare il figlio a Pinkerton se verrà a prenderlo. Ma partiti il Console e Cate, pone una bandierina americana in mano al bimbo e ritiratasi dietro un paravento si uccide. All'arrivo di Pinkerton essa ha appena il tempo di indicargli con un gesto il fanciullo, e muore.
Com'è noto, Madama Butterfly fa accolta la prima sera alla Scala con fischi sonorissimi. L'autore la ritirò, vi apportò qualche taglio, modificò qualche motivo, divise il 2° atto in due parti, e tre mesi dopo a Brescia l'opera ebbe una rivincita trionfale. Divenne da quel momento, accanto a La bohème, l'opera più popolare di Puccini; ma una parte della critica continua a dire tuttora che questa popolarità è dovuta soltanto alla banalità e al sentimentalismo delle sue melodie. Crediamo che questa critica sia ancora una volta ingiusta. Difetti non ne mancano, ma non sono forse quelli che si è creduto di scorgervi.
Madama Butterfly ha la consueta ricchezza di motivi linci, e la solita debolezza di espressione drammatica; ma nella parte lirica c'è rilievo plastico di melodia, c'è vita ritmica, c'è anima, c'è colore strumentale, c'è poesia. La poesia è, sì, tenue; investe le piccole cose, coglie le sfumature del sentimento, tocca i lati più delicati della sensibilità femminile; ma che perciò? Forse che la poesia delle piccole cose, le emozioni che attraversano l'anima d'una donna innamorata fino al sacrifìcio eroico della vita, sono fatti di trascurabile interesse per l'arte? Ora, nella musica di Puccini l'anima della sventurata Butterfly è tratteggiata, accarezzata, illuminata con una finezza e una profondità maggiore di quanto il Maestro abbia fatto per Manon, per Mimì e per Tosca. Qualche volta, è vero, rincorre le minuzie e divaga, come quando nel 1° atto giocherella, pure con grazioso umorismo, attorno ai ninnoli innumerevoli che Butterfly estrae dalle maniche; o come quando nel 2° atto sosta su le numerose interruzioni, talvolta un po' troppo ingenue ed oziose, alla lettura della lettera di Pinkerton. Ma anche in questi momenti, tra le chincaglierie e il cicaleccio superfluo, si insinuano tocchi profondi, come là dove Butterfly ricorda la propria povertà con sincerità serena, o racconta di essere stata alla Missione, o nasconde con religioso pudore il coltello col quale il padre si uccise per invito dell'imperatore; o dove porta su la bocca e sul cuore la lettera di Pinkerton, o ripete addolorata la frase della lettera stessa: «Non mi rammenta più!». E i tocchi sensitivi della musica pucciniana seguono passo passo parole ed azione dell ingenua vittima facendone risplendere con penetrante amore ogni aspetto, dalla romanza «Un bel dì, vedremo», che è il canto della sua fede, al commosso pianto: «Che tua madre dovrà prenderti in braccio», alla festosa esuberanza del duetto con Suzuki, allorchè spargono fiori nella stanza in attesa di Pinkerton; dal coro lontano a bocca chiusa, voce misteriosa che ripete il motivo della lettura della lettera e che sembra salire dal cuore medesimo di Butterfly come la voce della sua speranza, al disperato saluto estremo al figlio: «O a me, sceso dal trono dell'alto Paradiso», in cui non più il cuore della sposa ma quello della madre si apre al sacrificio sublime.
Non possiamo seguire ogni momento di questa rivelazione della squisita femminilità di Butterfly, ma vogliamo ancora ricordare il motivo desolato che si ripete come un acuto spasimo allorchè alle preci di Suzuki essa risponde: «Pigri ed obesi son gli Dei Giapponesi». E lo spasimo si acuisce, diventa tortura intollerabile allorchè Suzuki esprime dubbi sul ritorno di Pinkerton; e ritoma allorchè Goro le parla di Yamadori, quando Butterfly domanda se Pinkerton potrà scordare il figlio, e nell'ultimo atto allorchè esclama: «Abbandonar mio figlio!», sempre come un assillo tremendo; ed è una delle poche volte che Puccini usa un motivo tematico con un significato così profondamente espressivo. Ma nei momenti più drammatici, allorchè Butterfly vede Cate e comprende il crollo del suo amore e di tutta la sua vita, la musica quasi tace e lascia che la situazione tragica s'imponga da sè. E quando Butterfly fa i preparativi lugubri per uccidersi non sa dirci che il tema dell'arma patema, un po' tetro, se vogliamo, ma anche grottesco. Durante la scena del suicidio l'orchestra ci ripete solo coi frammenti del motivo del figlio la ragione del gesto supremo; e, dopo la morte, piomba in un'enfasi catastroficamente rumorosa, troncando il motivo e l'opera - chi sa perchè - su un accordo sospeso.
Pinkerton è assai meno rilevato. Nel 1° atto il suo canto: «Dovunque al mondo», e le strofette: «Amore o grillo» ce lo presentano spensierato senza cinismo, soltanto uomo dal comodo e «facile vangelo», desideroso di appagare ogni godimento, senza scrupoli. E questo desiderio di godimento sensuale vibra in tutto il duetto d'amore del 1° atto, che, per il calore che palpita nelle sue melodie, è uno dei più belli e sinceri che Puccini abbia scritto. Ma l'ultima romanza di Pinkerton, «Addio, fiorito asil», contiene, si, un dolce rimpianto, ma non ha l'accento dello «strazio atroce» di cui Pinkerton parla.
Molto meglio le figure umoristiche, fra le quali il Bonzo e Goro appaiono le più riuscite. Quanto all'ambiente il Maestro ha pensato di darcelo costruendo molti motivi su la scala giapponese di cinque note senza il terzo grado, e inserendo nell'opera frammenti di motivi giapponesi autentici, compreso l'inizio dell'inno imperiale, ed anche di quello degli Stati Uniti. Per verità scala e motivi appaiono così bene assimilati da creare un colore sui generis che se non è proprio giapponese, dà tuttavia all'opera un'intonazione abbastanza originale. A ciò va aggiunto qualche tratto armonistico di marca debussyana, e una strumentazione che è una delle più raffinate che fino a questo momento si siano udite in opere teatrali, per ricchezza e varietà delicata e caratteristica di timbri e di sfumature.
FRANCO ALFANO (Napoli 1876) - RISURREZIONE: dramma in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro Vittorio Emanuele di Torino il 30 novembre 1904. Libretto di Cesare Hanau, tratto dal romanzo omonimo di Leone Tolstoi.
Atto 1° - Stanza in una casa di campagna di Sofia Ivanovna. - Il principe Dimitri Nekludoff pernotta nella casa della zia Sofia prima dipartire per la guerra contro i Turchi. Qui ritrova la giovane Katiusha, orfanella raccolta dalla zia quand'era bambina. L'amore sbocciato in passato fra i due fanciulli che giocavano insieme, ora rinasce più forte fra i due giovani. Il fascino della notte di Pasqua e i primi effluvi della primavera concorrono a vincere il cuore di Katiusha, che si abbandona all'amante.
Atto 2° - Stagione in una borgata della Piccola Russia. - Katiusha, rimasta incinta, è stata cacciata di casa da Sofìa Ivanovna. Ora essa attende alla stazione Dimitri, il quale tornato ferito dal campo e poscia guarito, deve ripartire. Ma Dimitri giunge con un'altra donna. Katiusha tenta di slanciarsi verso di lui, ma un ferroviere glie lo impedisce.
Atto 3° - Stanza spaziosa nella prigione delle donne a Pietroburgo, - Katiusha è stata condannata, innocente, per veneficio. Per stordirsi beve acquavite. Dimitri, pentito del suo oblio, viene a cercarla e le promette di salvarla, ma essa, semiubbriaca, gli risponde con cinismo sfrontato, gli ricorda la notte in cui l'attese alla stazione, e gli dice del figlio suo, morto. Dimitri, roso dal rimorso le promette di sposarla, ma Katiusha gli ride in faccia. Dimitri prima di partire le regala una fotografia ch'egli le fece nel giardino della sia. Katiusha si addormenta contemplando la fotografia che le ricorda il suo passato felice, e nel sonno piange.
Atto 4° - Accampamento di deportati in Siberia. A sinistra la tenda di Katiusha. - È la Pasqua. Dimitri segue Katiusha nel viaggio verso la Siberia. Simonson, un condannato, confessa a Dimitri che ama Katiusha e gli chiede che parta. Dimitri promette di interrogare Katiusha; se anch'essa ama Simonson partirà. Frattanto vien recapitata a Dimitri una lettera con la notizia della grazia concessa a Katiusha. Dimitri glie ne dà l'annunzio e le pone il dilemma: sposare Simonson o lui. Katiusha risponde che sposerà Simonson; ma tosto si pente e confessa che il suo amore per lui non si è mai spento, ma non vuol seguirlo perchè se ne sente indegna. Solo nella suprema rinunzia sarà per lei la redenzione. E mentre le campane suonano e le voci inneggiano a Cristo risorto, Dimitri parte dopo averla baciata in fronte, e Katiusha si inginocchia a pregare.
Risurresione è opera che appartiene per le forme alla cosiddetta «scuola verista» o «giovane scuola italiana». L'autore la scrìsse tra i 27 e i 28 anni, e perciò si capisce come lo stile e il gusto risentano l'influsso dei principali maestri italiani suoi contemporanei; e non manca qualche cromatismo wagneriano. Ciò non ostante la personalità del musicista ha modo di affermarsi in più punti con evidente chiarezza, per una vena lirica che è tutta sua e che si impone per il calore comunicativo.
La bellezza e la profondità del romanzo tolstoiano sono necessariamente sacrificate in molti punti dal libretto, nè la musica ha sempre potuto supplirvi. L'opera perciò appare disuguale, specialmente più debole nell'ultimo atto; ed anche i caratteri dei due protagonisti, Dimitri e Katiusha, non sono scolpiti con uguale rilievo. Dimitri è un tenore che canta pagine affettuose. Nel 1° atto ad esempio, l'aria «No, non temere» ha un calore di sincerità che afferra; e la bella melodia sarà ripetuta nel 3° atto come ricordo nostalgico alle parole: «Pensa a quel dì lontano». Ma si può dire che Dimitri è tutto qui.
Katiusha si prestava ad una maggiore ricchezza di accenti che il compositore non si è lasciato sfuggire. Nel 1° atto il suo amore fidente, l'ansiosa attesa e la disillusione nel 2°, l'amaro cinismo nel 3°, il sacrificio e la redenzione nel 4° sono stati resi con sensibilità nella musica dell'Alfano anche se con disuguale efficacia. I momenti lirici di più intensa espressione nati da questi vari momenti psicologici si trovano specialmente nel 1° e 2° atto; nell'espansivo a due: «Qui sul mio cor», nella rievocazione, di tinta un po' wagneriana, del: «Dimitri m'ha amata tanto», piena d'anima, e nella preghiera «Dio pietoso», il cui motivo trabocca di un'intensa angoscia e di un disperato dolore, e che chiude con commossa drammaticità il 2° atto. Nel 3° è da ricordare il malinconico interludio dopo l'appello delle prigioniere; interludio che sviluppa ampiamente, con lievi modifiche, un motivo dell'amore di Dimitri, già apparso nel 1° atto alle parole: «Cara, mi sembra oggi quel giorno».
Qua e là qualche pennellata di color locale data da motivi popolari russi; e pennellate che dimostrano la sensibilità del Maestro per la poesia, della natura, come, ad esempio, nel 1° atto, allorchè Katiusha si affaccia alla finestra esclamando: «Che silenzio! Che pace!», o come quando, poco dopo, anche Dimitri è colpito da questa stessa pace della notte primaverile: «Oh! che languor, che silenzio!».
RICCARDO STRAUSS (Monaco di Baviera 1864 - Garmisch 1949). - SALOMÈ: dramma musicale in un atto. Prima rappresentazione al Teatro dell'Opera di Dresda il 9 dicembre 1905. Dramma di Oscar Wilde.
Atto unico - Ampia terrazza nella reggia d'Erode. Verso il fondo, una cisterna che immette, nel carcere ov'è rinchiuso il profeta Jokanaan. - Il tetrarca Erode ha fatto arrestare Jokanaan, il quale inveiva contro di lui e la sposa sua Erodiade, ma per un superstizioso terrore non vuole che sia ucciso. Salomé, figlia di Erodiade, udendo Jokanaan profetare dalla cisterna la venuta del Redentore, convince un giovane capitano, Narraboth, che l'ama, a condirglielo. Salomé, vedendolo, è presa da perversa concupiscenza; ma Jokanaan la respinge con orrore e ridiscende nella cisterna, mentre Narraboth desolato si uccide. Frattanto Erode, la consorte e gli ospiti, escono dalla reggia ove si è tenuto un festino. Erode si è invaghito della figliastra, alla quale chiede di danzare, giurando di concederle qualunque cosa essa chiederà. Salomé acconsente, e scioglie una danza piena di atteggiamenti provocanti, levandosi a poco a poco sette veli, e rimanendo quasi ignuda. Indi chiede in ricompensa ad Erode la testa di Jokanaan. Invano Erode, preso da folk spavento, le prométte i più ricchi doni; essa insiste con morbosa ostinazione nella propria domanda. Costrettovi dal giuramento. Erode deve cedere, e poco dopo la testa di Jokanaan viene presentata su un piatto d'argento a Salomé. Arsa da mostruosa lussuria essa si precipita su la sanguinosa testa del morto profeta rivolgendole ebbre parole d'amore e baciandola su la bocca. A tale vista, inorridito. Erode ordina ai soldati di schiacciare Salame, e i soldati la sopprimono sotto il peso dei loro scudi.
La tecnica wagneriana è portata in quest'opera alle estreme possibilità, con in più una libertà di incontri armonici e una scioltezza di parti che costituivano, quando Salomé apparve, un'audacissima novità. Anche se i temi non hanno la potenza di quelli di Wagner, la ricchezza dei colori strumentali di cui si ammantano, li rende abbacinanti. Un vento di follìa squassa da cima a fondo l'orchestra che sembra ardere di una febbre prodigiosa, in un'architettura polifonica possente. Attorno a Erode violini e legni scatenano vortici tempestosi e sinistri di note che donano ad ogni suo gesto e pensiero l'aspetto di un'allucinazione malefica. Anche i gruppi degli ebrei, farisei, sedducei e nazzareni gettano in quest'orgia di suoni le cacofonie della loro disputa vana con la percussione di un tema che insiste con un'ostinazione esasperante. SÌ ha l'impressione di una vera babele, con un senso umoristico piuttosto pesante per la densità massiccia della costruzione. Questa densità orchestrale qualche volta predomina e soverchia in modo da soffocare il canto e la personalità delle figure sceniche, concentrando in sé ogni interesse con sonora prepotenza, come in un grande poema sinfonico. Essa finisce per esprimere; il dramma più dal lato fisico, sensoriale, e quindi esteriore, che non da quello intimo e spirituale.
Salomé è un'isterica presa da una morbosa passione erotica per il bel corpo di Jokanaan, passione che si trasforma alla fine in necrofilia libidinosa. Un po' è così anche nel dramma di Oscar Wilde, ma la musica di Strauss centuplica in infiniti modi e con straordinaria potenza questa espressione. La musica del dialogo di Salomé con Narraboth, in cui la principessa convince il giovane che l'ama a condurle innanzi Jokanaan, è già un capolavoro di sottile raffinatissima seduzione. Vi si respira già un alito di corruttrice sensualità dietro cui si nasconde il soffio tragico annientatore. Ma nell'espressione musicale del dialogo successivo cori Jokanaan passa una più intensa vibrazione afrodisiaca, un più pungente spasimo di voluttà. La ripetuta frase «Quel labbro vo' baciare, Jokanaan», è nella musica già un grido in cui Salomé pregusta l'ebbrezza di questo bacio; e tutto il duetto tra Salomé e Jokanaan è un vertigine dei sensi, alla quale si contrappone il solenne ma un po' compassato motivo del Battista, e finisce in un tumulto di delirio. È un miracolo se, in mezzo a questa bufera, passa per un istante la candida immagine di Cristo che erra sul mare di Galliea predicando ai discepoli, su un'improvvisa luminosa chiarità di suoni calmi e ondulati, come un sogno celeste. Ma questo sogno non tocca Salomé; essa non vede che il bel corpo di Jokanaan; più che vederlo lo sente con fremiti di voluttuoso ardore, e la sua voce tiene testa al sinfonismo colossale di Strauss, ne è la prima parte, ed emerge con accenti di un'indicibile bramosia fisica.
La «danza dei sette veli» è il prolungamento di questo erotismo esasperato, che si manifesta con un'onda di suoni molli, di cromatismi procaci, di disegni flessuosi, di ritmi elastici o languidi eccitanti, di movimenti frenetici, di colori strumentali sfolgoranti e provocanti. Quésto insieme di elementi esercita un fascino sensuale carico di un'ebbrezza che snerva ed esalta insieme.
Una parte grandissima giuoca nell'espressione del dramma l'aggressività di uno strumentale fatto di impasti o di contrasti che determinano colori soffocati o barbagli violenti, portando gli istrumenti in registri disusati o sforzandone le caratteristiche. L'effetto dei contrabassi che imitano con brutale verismo il rumore della sega su le vertebre del collo di Jokanaan è uno degli esempi più vistosi, ma tutta la partitura è un continuo balenare di timbri strumentali accesi o lividi, di sonorità soggioganti o estenuanti, di pennellate sgargianti e affocate, o molli e vellutate, con una rapidità di contrapposizioni da scuotere il sistema nervoso più che l'anima dell'ascoltatore.
E dopo oltre un'ora di questo continuo choc, Strauss dà il colpo di grazia ai nostri sensi con la snervantissima scena finale in cui la libidine giunge alla perversione macabra più orripilante. I temi principali della protagonista si avvicendano come smorfie di spasimo in cui odio ed amore, desiderio e rimpianto, ribrezzo e voluttà fanno ressa diffondendo nell'atmosfera un languore di morte. Il tema della seduzione non è più che un palpito funebre di timpani, mentre un lungo trillo acuto si spande come il brivido di un bacio estenuante, senza fine.
ERMANNO WOLF-FERRARI (Venezia 1876 - 1948) - I QUATTRO RUSTEGHI: commedia musicale in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Municipale di Monaco di Baviera il 19 marzo 1906. Libretto di Giuseppe Pizzolato, dalla commedia di Carlo Goldoni. - L'azione si svolge in Venezia nell'anno 1800.
Atto 1° - Quadro 1° - Camera in casa di Lunardo. - È carnevale. Margarita e Lucieta lamentano l'orsaggine del loro rispettivo marito e padre Lunardo. Questi, entrando poco dopo, annunzia che pranzeranno in compagnia di Sior Maurizio, Sior Simon, Sior Cancian e delle loro mogli. Comunica poi in segreto alla moglie che ha trovato il marito per la figlia: Filipeto, figlio di Maurizio; ma non vuole che nessuno lo sappia, e non vuole che i due giovani si vedano prima delle nozze. Lunardo e Maurizio poi si accordano pel matrimonio dei loro figli secondo i loro gusti e le loro idee di burberi antiquati ed avari.
Quadro 2° - Terrazza in casa di Simon. - Mentre Marina, moglie di Simon, è intenta a stendere la biancheria, giunge suo nipote Filipeto, il quale le racconta che lo vogliono sposare alla figlia del Sior Lunardo, senso ch'egli possa neppur vederla. Marina gli promette aiuto, ma arriva Simon, il quale non vuol parenti in casa, e manda via sgarbatamente Filipeto. Partito questi, Sior Simon comunica alla moglie che pranzeranno fuori, ma non vuol dirle nè dove nè con chi. Giungono frattanto Siora Felice col nutrito Cancian e il cavalier servente Conte Riccardo. Felice svela a Marina che pranzeranno insieme da Sior Lunardo, e Marina le narra quanto ha saputo da Filipeto. Le due donne combinano di far incontrare i giovani conducendo Filipeto mascherato in casa di Lunardo.
Atto 2° - Camera grande in casa di Lunardo. - Lunardo sorprende Margarita e Lucida che si abbigliano per il pranzo, e le rimbrotta. Arrivano Marina e Simon; i due burberi, rimasti soli, lodano i costumi dei tempi antichi, ma il sopraggiungere di Siora Felice con Cancian interrompe il filo dei loro nostalgici ricordi, e irritati la piantano bruscamente in asso. Margarita, Marina e Felice festeggiano la «novizza» la quale chiede notizie di Filipeto. Ed ecco che giunge in maschera il Conte con Filipeto travestito da donna. Questi è subito incantato della grazia di Lucieta. Marina con un pretesto gli leva la maschera, e vedendolo anche Lucieta resta affascinata. Mentre i due giovani si parlano timidi, entrano Lunardo, Simon e Cancian. Filipeto e il Conte sono spinti entro uno stanzino laterale. Lunardo annunzia a Lucieta che è fidanzata con Filipeto, ma il padre di questi entra agitato dicendo che suo figlio è stato visto uscire col Conte Riccardo. Cancian si lascia scappare alcune frasi offensive sul cavaliere. Riccardo che ha udito esce dal nascondiglio e dichiara che Filipeto è con lui. Ne nasce un finimondo.
Atto 3° - Camera di Lunardo. - Lunardo, Simon e Cancian vorrebbero punire le loro mogli, ma non sanno come. Sora Felice affronta coraggiosamente i tre burberi, li fa tacere e li persuade della loro stolidaggine. Trascina con sè Margarita, Marina e Lucieta a chiedere comicamente grazia, e finalmente Lunardo acconsente di nuovo al matrimonio. Ma come vede i fidanzati, lo riprende l'ira e ritira il consenso. Le donne inviperite si rivoltano, mentre Lucieta e Filipeto gemono. Lunardo, sopraffatto e un po' anche pentito, chiama a sè Lucieta e le chiede se vuoli sposarsi; Maurizio, che intanto è sopraggiunto, fa altrettanto con Filipeto e invita i giovani a darsi la mano benedicendoli. I «rusteghi» sono finalmente commossi e s'avviano a pranzo asciugandosi una lagrima; dietro loro Lucida e Filipeto si baciano.
Quando si parla delle opere di Wolf-Ferrari, e in particolare de I quattro rusteghi che è la migliore, bisogna ricordare che esse non sono vere e proprie «opere buffe». Non hanno nulla a che vedere con la tradizione alla quale si ricollegano L'elisir d'amore e il Don Pasquale di Donizetti o Crispino e la Comare dèi fratelli Ricci, e fino a un certo punto anche il Falstaff di Verdi. I quattro rusteghi sono una cosa totalmente nuova e rappresentano la «commedia di caratteri» goldoniana. Perciò sotto altro aspetto rientrano nella tradizione; anche per la loro vocalità melodiosa, per l'armonica proporzione delle forme, per il colore veneziano luminoso, per la festosità serena e per quello spirito fine e malizioso, aggraziatamente signorile che non è nell'indole dei popoli nordici ma di quelli mediterranei. Nelle vecchie opere buffe il carattere più in vista è quello del personaggio buffo principale, e gli altri personaggi non hanno in generale che scarso rilievo perchè ciò che conta, oltre alle arie ai duetti e alle scene in cui predomina il «buffo», sono le «situazioni» comiche e amorose di contorno. Ma nei Rusteghi i caratteri di tutti i personaggi assurgono a importanza musicale di primo piano. Non solo la musica di Wolf-Ferrari ci presenta con garbata caricatura le figure dei «quattro», ma anche, con uguale interesse, quelle delle loro tre mogli (Maurizio è vedovo).
Ciascuno dei «rusteghi» ha una fisionomia propria, più o meno burbera e autoritaria; eminentemente brontolona in Lunardo, più rozza e pedante in Simon, irritata in Maurizio, nelle pochissime scene in cui figura, con l'aria scontrosa e seccata di una vittima in Cancian.
Le scene culminanti, per quello che riguarda la più completa e approfondita espressione di questi caratteri, sono il duetto del primo atto fra Lunardo e Maurizio, e il terzetto dell'ultimo in cui Lunardo Simon e Cancian meditano su la punizione da infliggere alle mogli. Ma fra queste due scene ve n'è una terza che completa il quadro psicologico di questi retrivi, una scena che ci dimostra come in fondo la loro non è pura prepotenza e cattiveria, ma piuttosto l'esasperato e nostalgico sogno di un antiquato focolare domestico del quale non comprendono l'anacronismo; sogno che è alimentato dall'affetto che essi, non ostante le apparenze contrarie, realmente portano alle loro mogli, e la cui impossibile realizzazione li rende egoisti. È il duetto del 2° atto fra Lunardo e Simon: «La dona de un tempo la gera un zogelo», ed è una pagina musicale che aureola i «rusteghi» di una certa poesia pure lasciandone intatto il carattere nei suoi lineamenti fondamentali burbero-comici. Questa nostalgia poetica di una donna dolce e mansueta secondo i loro gusti rancidi, riaffiora nell'altro malinconico e tenero canto dell'ultimo atto; «Mo parcossa le done tute quante no è impastade de zucaro e de miel?».
Delle tre mogli Margarita è la più «rustega», Marina è più donna, con la sua canzone bonariamente vanitosetta: «El specio me ga dito che son bela» piena di un molle e sensuale abbandono non svenevole. Questa canzone, per il suo fare civettuolo ed arguto diventa poi in seguito il tema delle tre donne; come pei tre uomini il tema sarà quello comicamente grave e pomposo che si ode la prima volta all'entrata di Maurizio nel 1° atto. Il carattere di Marina non è però chiuso nello spirito della sua canzone. Essa è pronta a rispondere con una «ciacola» che non finisce più se il mal garbo del marito la offende, ed è pronta in caso estremo all'estrema minaccia: «Mi vago in leto!». Felice è la più signorile e la più astuta delle tre mogli; Cancian non è come gli altri un commerciante, ma un ricco borghese, ed essa si tiene al fianco un nobile cicisbeo. Il suo burbero ma in fondo innocuo marito essa lo domina pienamente; gli vuol bene, e nonostante il cicisbeo, gli è fedele. Il cicisbeo è una moda alla quale una donna del suo rango non può sottrarsi, ma Felice è una donna onesta, e all'ultima scena Cancian medesimo lo riconosce: «la xe po una gran dona de garbo». La sua parlantina facile e piacevole dà alla musica toni lustri ed eleganti che nella filippica dell'ultimo atto acquistano uno scintillìo da girandola pirotecnica» un calore e un fervore che annichila i «rusteghi» e li conduce abilmente dal loro burberismo a «fifar» di commozione. Personaggio femminile che la musica di Wolf-Ferrari riveste di una brillantezza vivida e di audaci slanci lirici.
Al centro di questi due gruppi sta Lucieta; figurina candida e fresca, di cui la pienezza di vita, il naturale desiderio d'amore e di gioia, le innocenti vanità di giovinetta e una fine aria da «furbeta» senza malizia fanno una creatura di una grazia inimitabile. Il suo tema è l'ampio motivo così semplice, tranquillo, sereno che apre l'opera, e che poi essa o l'orchestra cantano in vari momenti e in vari modi. Un'altra aria tutta sua è quella ch'essa canta all'inizio del 2° atto: «I me vol zirar» in cui passa tanta ingenua e intima allegrezza. Anche nei recitativi con la madre, col padre, con le comari, e nel breve dialogo con Filipeto essa conferma queste caratteristiche squisitamente femminili e giovanili; caratteristiche che fanno esclamare ai vecchi burberi con grottesca commozione: «oh che bona fia!».
A proposito dei quali recitativi, come di quelli degli altri personaggi, conviene sottolineare l'abilità con cui Wolf-Ferrari ha saputo sfruttare le melodiose cadenze del dialetto veneziano, le quali dànno alla parlata musicale un garbo, un'eleganza, una scorrevolezza e a volte un tono di giocosa arguzia del tutto nuove e piene d'interesse artistico, di poesia. Nel dialogo dei vecchi «rusteghi» il recitativo è invece sempre pedante e comicamente goffo o grottescamente ruvido.
E Filipeto? È un'altra figurina schizzata con fine gusto comico-sentimentale, sia ch'egli sospiri: «Lucieta xe un bel nome», o che rincorra fanciullescamente la giovinetta gridandole: «Vara che te ciapo eh!», o che tubi fra sè: «Ghe son cussi darente, ma caro quel viseto».
L'opera è prevalentemente vocale, di una vocalità aperta e chiara, aderente alle inflessioni verbali in quanto queste aderiscono al sentimento e all'indole dei personaggi. Ma non meno aderente è l'orchestra; essa completa il canto o lo commenta con abbondanza di trovate timbriche, ritmiche e melodiche, sia che si tratti di fare il verso o di porre in caricatura i quattro brontoIoni, o di colorire con deliziose pennellate sentimentali i due fidanzati, sia che getti scrosci di gioviali risate attorno alla burla immaginata da Siora Felice, o che dipinga gesti umoristici, fra i quali impagabile quello di Lunardo quando nel 3° atto immagina di tirare il collo a sua moglie come si fa con un pollo. Nel giuoco brillante, vivido, sapido delle pitture e dei commenti orchestrali, gli strumentini hanno una delle parti principali, specialmente i fagotti, gli oboi e i flauti. Nè mancano i quadretti d'ambiente, come quell'intermezzo al 2° atto, intessuto su la canzone veneziana «El specio me ga dito che son bela» che di solito viene legato al 1° atto e gli serve di chiusa poeticissima. E nulla poteva essere più adatto ad esprimere la soave malinconia di un tramonto veneziano. Per un momento i «rusteghi» e la commedia sono messi da parte per farci respirare l'aria sottile e lo spirito elegante e canoro della Venezia fine del secolo XVIII: mondo elegante ormai tramontato, che rivive liricamente in questa pagina dalle lineature delicate e dai colori morbidi e suadenti.
Ben altra cosa è il finale del 2° atto, allorchè Lunardo ha scoperto in casa sua il Conte con Filipeto. Il vecchio tipo del concertato-baraonda qui è abbandonato per accostarsi piuttosto al modello, attenuato, della baruffa con cui si chiude il 2° atto de I Maestri Cantori di Wagner. Le voci sono disposte con naturalezza di intreccio polifonico, mentre passano così nel canto come nell'orchestra, a frammenti, alterati nei ritmi e in movimento animatissimo, con sottile ironia comica i motivi della frase: «Oh che bona fìa», quello delle donne: «El spedo me ga dito» e, violentemente negli ottoni, il motivo, esso pure alterato, che appare la prima volta nel 1° atto allorchè Lunardo in difesa dei suoi amici «rusteghi» canta: «Quando un omo xe serio e prudente», più un gaio tema del XVII secolo, già usato da Schumann nella Marcia dei «Davidsbündler» del Carnaval. Questo insieme raggiunge un effetto di burlesco pandemonio, in una chiarezza di forma veramente magistrale.
PAOLO DUKAS (Parigi 1865 - ivi 1935) - ARIANNA E BARBABLEU: leggenda in 3 atti. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 10 maggio 1907. Testo di Maurizio Maeterlinck.
Atto 1° - Salone ad emiciclo nel castello di Barbableu. Una gran porta sul fondo che mette all'esterno, e ai lati di questa sei piccole porte d'ebano con serrature d'argento. - Le cinque mogli prese da Barbableu sono scomparse una dopo l'altra senza che si possa sapere se sono morte o imprigionate. Ora sta per giungere la sesta. Arianna, e la folla dei contadini s'accalca fuori minacciosa per impedirne l'entrata. Ma l'opposizione è vana: Arianna giunge con la Nutrice. Essa afferma che le precedenti spose di Barbableu non sono morte, e si propone di liberarle. Barbableu le ha consegnato un mazzo di chiavi: sei d'argento e una d'oro, vietandole di usare quest'ultima. La Nutrice apre ad una una le sei porte minori, dalle quali rotolano cascate di ametiste, zaffiri, perle, smeraldi, rubini, diamanti. Dietro a onesti ultimi è la settima porta che Arianna apre con la chiave d'oro. Dalla cavità piena d'ombra sale un canto fioco di donne: sono le cinque mogli sepolte da Barbableu perchè gli disobbedirono aprendo la porta vietata. In questo istante entra Barbableu che rimprovera Arianna; fra loro si svolge una discussione serrata. Barbableu vuole condurre con sè Arianna; la Nutrice allora spalanca la porta centrale e i contadini irrompono minacciosi, ma Arianna li allontana dolcemente e rinchiude la porta.
Atto 2° - Vasta sala sotterranea. - Arianna è discesa con la Nutrice per salvare le prigioniere. Trovatele, lacere, smunte e spaurite, Arianna le conforta; indi spalanca le imposte di un'ampia finestra che appare chiusa da una vetrata. Spezzata questa con una pietra, Arianna trascina le dònne fuori dal carcere nella luce del sole.
Atto 3° - La stessa scena del 1° atto. - Le mogli di Barbableu liberate da Arianna stanno adornandosi con le gemme rimaste sparse al suolo dopo che la nutrice aveva aperto le sei porte d'ebano. D'improvviso la Nutrice entra annunziando il ritorno di Barbableu, gettando in grande sgomento le donne. Ma i contadini sono accorsi armati incontro a Barbableu; lo feriscono, lo legano e vengono a consegnarlo alle mogli. Queste impietosite lo curano, e Arianna lo libera dalle corde. Indi Arianna lo bacia in fronte e s'avvia per partire, chiedendo alle donne chi vuol seguirla, ma nessuna si muove. Allora Arianna esce, seguita dalla Nutrice. Le rimaste rinchiudono la porta.
La poetica leggenda di Maeterlinck ha trovato nella musica di Dukas un'espressione di carattere impressionistico differente da quella usata da Debussy per il Pelléas et Mélisande, in quanto il Musicista si studiò di renderla più aderente al suo simbolismo. I motivi usati dal Dukas hanno contorno nitido, rilievo plastico, e sono usati non come temi-atmosfera, ma come veri e propri temi-simboli. Sono temi che si differenziano da quelli wagneriani per la loro mutevolezza ritmica, per la quale, pure rimanendo fisso il significato simbolico fondamentale, cambia l'espressione psicologica, ecambia, mediante le mutazioni dello strumentale, il colore. In questo modo Dukas tende a dare all'impressionismo debussyano un altro indirizzo. Egli, ad esempio, non fa uso del sistema esacordale se non a tratti, ma usa dell'armonizzazione con grande libertà nella ricerca di effetti suggestivi, in unione allo strumentale vario e ricchissimo. Ne esce una musica la quale non ha la vaporosità sfumata di quella di Debussy, eppure crea l'ambiente e determina quanto vi è di misterioso e di realistico nell'azione e nei personaggi con limpida chiarezza poetica. Il discorso vocale non è anch'esso più, come in Debussy, un semplice recitativo quasi parlato e d'intonazione uniforme, ma si flette in ampi e precisi atteggiamenti melici.
Arianna è il personaggio dominante, ed è in scena di continuo, dall'inizio alla fine dell'opera. Barbableu è presente in ispirito, ma non appare su la scena che per dire poche parole alla fine del 1° atto, e in veste puramente mimica alla fine del 3°. Anche la folla dei contadini agisce come una forza alleata ad Arianna, e si fa sentire solo come una voce di minaccia al di là della scena. La nutrice non è che un simbolo dell'indecisione, in contrapposizione alla volitiva Arianna; e le cinque mogli di Barbableu figurano come immagini di contorno, con scarso rilievo. La loro personificazione più decisa è tutta nella fatalistica «canzone delle figlie d'Orlamonda» che sale con un senso di mistero e di dolore dall'oscurità della settima porta, e i cui spunti diventano più che i loro temi personali, quelli della loro liberazione. Figure esili e diafane che prenderanno vita solo nell'ultimo atto come riflessi della luce che Arianna proietta su di esse con i motivi delle gemme e quelli di una tenera affettuosità. Ma è specialmente nel finale del 2° atto che il motivo delle «figlie d'Orlamonda» trionfa in una sonorità splendente, in un impeto di trasporto sublime, allorchè Arianna spezza le vetrate ed esce con la donne finalmente libere. L'orchestra è a questo punto un tripudio di suoni lucidi, un mare di fresca gioia e di entusiasmo inebbriante.
L'assenza di una voce tenorile e il quasi esclusivo dominio delle voci femminili generano una certa monotonia che si aggrava nel 2 atto per la mancanza d'azione, nella quale non interviene neppure il coro, per il recitativo più amorfo, e per l'oscurità della scena, persistente fino quasi alla fine. È dunque sul personaggio di Arianna che si riversa quasi tutta la musica dell'opera, e il suo tema vi giuoca una parte essenziale, presentato in dieci diverse forme ritmiche. Arianna è la donatrice di bellezza, di luce, di libertà. È dunque naturale che il suo tema, dalla penombra misteriosa in cui ci è presentato alla dodicesima battuta del preludio, si accenda di uno sfolgorìo di luce sempre più vivo, allorchè dalle sei porte spalancate escono torrenti di gemme sfavillanti. E ad ogni porta che si: apre le gemme sono diverse, e il ritmo del motivo si trasmuta e brilla, anche per il diverso scintillio dei timbri orchestrali, di luci e di colori differenti, ora dolci, ora accesi, ora diacci, ora sgargianti. In questa scena la fantasia ritmica e strumentale del compositore ci traccia sei quadri di un colorismo pieno di una vita che si riverbera su lo spirito in tante ondate di gioia sempre più alta.
Sono ancora frammenti del tema gioioso di Arianna che sottolineano a quando a quando le sue parole piene di promesse ridenti, di fulgide speranze, vibranti di gioia e d'amore, che ella va dicendo alle prigioniere per farle rinascere al senso della vita. Ed altre modificazioni ritmiche ed armoniche di questo stesso tema innondano tutta la scena dell'abbigliamento nel 3° atto, in cui Arianna, dopo aver resa la libertà e la vita alle pallide spose, sprigiona dai loro corpi la bellezza.
Un altro tema che offre pure numerosissime e suggestive variazioni ritmiche è quello che esprime la minacciosa ira della folla, che rugge nei bassi fino dalla terza battuta del preludio, e trasformandosi assume una violenza sempre maggiore durante l'arrivo d'Arianna, e acquista un'espressione selvaggia nel 3° atto allorchè i contadini assalgono Barbableu (una delle scene più potenti dell'opera). Ma quando un contadino s'avanza, impacciato dalla timidezza per consegnare ad Arianna il tiranno legato, allora questo stesso tema si fa dolce e mite come il sorriso di un fanciullo.
A questo punto si svolge un'altra delle scene più sentite, quella in cui le cinque mogli, dimentiche della prigionia e delle sofferenze che Barbableu ha fatto loro subire, con dolce pietà gli curano le ferite, e, invitate da Arianna a partire con lei, si rifiutano di abbandonare il tiranno, che assiste muto, impotente e ormai ammansato dalla bontà delle donne. Le figure, da simboli che erano, diventano finalmente esseri umani, e la musica si addolcisce anch'essa passando dal regno della fantasia coloristica a quello del cuore. Poscia Arianna parte, e con gesto simbolico Igrana e Ballangère chiudono di nuovo la porta; gli accordi iniziali dell'Opera ritornano avvolgendola come dietro un velario di cupo mistero.
RICCARDO STRAUSS - ELETTRA: tragedia in un atto. Prima rappresentazione al Teatro dell'Opera di Dresda il 25 gennaio 1909. Libretto di Hugo von Hofmannsthal, dalla tragedia di Sofocle.
Atto unico - La corte interna della reggia di Micene. - Le ancelle commentano il frenetico furore da cui è perennemente invasata Elettra, Al loro partire questa appare: essa rievoca l'uccisione del padre Agamennone compiuta dalla moglie Clitennestra e dall'amante suo Egisto, e sogna il giorno della vendetta. Invano la sorella Crisotemide tenta disarmare il suo odio. Alla madre che le chiede quale vittima dovrà uccidere per scacciare i sogni molesti, Elettra, rinfacciatole di aver cacciato di casa Oreste e di avere tentato di farlo morire, le dice che il sangue che dovrà scorrere sarà il suo. D'improvviso giunge un'ancella che reca segretamente a Clitennestra una notizia che le produce visibile gioia. Ed ecco giungere Crisotemide gridando che due forestieri hanno recata la nuova che Oreste è morto. Elettra decide allora di uccidere ella stessa Clitennestra ed Egisto; invoca l'aiuto della sorella, ma questa rifiuta e fugge inorridita. Elettra dovrà agire da sola. Mentre scava per riprendere la scure che uccise Agamennone, da lei nascosta, compare Oreste. Dapprima egli dice di essere uno straniero venuto a recare notizia sicura della morte d'Oreste, ma riconosciuta Elettra si manifesta a lei. Elettra esulta, mentre Oreste afferma di voler vendicare il padre. Un'ancella introduce Oreste presso Clitennestra, e poco dopo si ode l'urlo di questa, colpita a morte. Frattanto giunge Egisto; Elettra gli va incontro ossequiosa. Egli, insospettito, corre in casa, ma tosto riappare alla finestra urlando che lo assassinano. Accorrono Crisotemide e i servi festanti per il ritorno di Oreste e la morte dei tiranni; Elettra danza una danza di vittoria, fino a che per l'emozione cade a terra svenuta.
Nella frenetica tragedia di Hofmannsthal, Strauss ha trovato pane pei suoi denti. Il suo polifonismo orchestrale ridondante e spregiudicato, la sua audace armonistica, il suo esuberante colorismo, tutta la sua arte di sinfonista, talvolta barocco, talvolta pletorico, sgargiante sempre, e sempre teso verso lo spasimo e l'urlo, investono l'intera azione. Il personaggio esasperato di Elettra, quello disumano di Clitennestra, e gli altri minori, sono immersi in un'atmosfera arroventata in cui vagola incerta e spaurita la fragile Crisotemide. Ma tutta la musica converge su Elettra, che è in scena dalla prima scena all'ultima, con una tensione di nervi che rende allucinante come un'incubo di follia il suo canto e il sinfonismo che lo sorregge. Il senso incombente e pauroso del Fato, pel quale appaiono così alte e solenni le tragedie greche, qui è assente. Un torbido spirito di delirio aleggia su tutto e crea nei motivi, nelle sonorità, nelle dissonanze un'ossessione febbrile terrificante. Posseduta dal ricordo del cadavere sanguinoso del padre e da un odio veemente per i due regicidi, Elettra è in ogni suo accento musicale, più una creatura felina che un essere umano. Non il poema, e neppure la musica ci lasciano intravedere nel suo animo il minimo dubbio, il minimo dramma al pensiero di uccidere la madre.
È naturale che in tale stato di perenne parossismo morboso più di un accento ricordi la maggiore sorella Salomé. Specialmente la scena in cui Elettra tenta di convincere Crisotemide a compiere con lei il matricidio ha qualche punto di contatto con la scena in cui Salomé tenta di sedurre Jokanaan. Ed anche i motivi di danza hanno qualcosa di morboso e di snervante che richiama analoghi movimenti ritmici e melodici delle danze di Salomè. In mezzo alle vertiginose spire, agli aspri urti sonori, ai balzi vocali e ai ritmi spezzati che caratterizzano la musica di Elettra la scena fra Elettra e Crisotemide, la selvaggia danza finale, e soprattutto l'espressione di gioia entusiastica di Elettra dopo il riconoscimento di Oreste, stanno come gemme più luminose, in cui la melodia si spiana in ampie volute, e l'armonia si addolcisce in un'onda morbida e gioiosa. Ma queste pagine più chiare non debbono far dimenticare altre pagine di musica superba come quella piena di cupo tremore e di fascino funereo che commenta l'entrata e l'inchiesta di Clitennestra; musica simile a un'onda purpurea che sembra intonarsi al colore del manto che ricopre la malvagia regina e all'orrore del sangue che si respira da un capo all'altro della tragedia.
Di temi ve ne sono diversi; più importanti per la loro insistenza e per i loro sviluppi quello violento di Agamennone ucciso, che forma il pensiero dominante dell'opera, e che infatti l'apre e la chiude; quello di Elettra vendicatrice, che appare varie volte durante il dialogo delle ancelle, e in modo minaccioso poco dopo allorchè Elettra invoca «Agamennon!», e poi frequentemente durante lo svolgimento dell'azione; e l'altro più melodiosamente espansivo che appare anch'esso verso la fine dell'invocazione e svilupperà il suo fascino nel duetto con Crisotemide e nella danza finale, e che sembra esprimere il sentimento della celebrazione sacra del ricordo paterno. Vi sono anche altri temi, ma la loro identificazione non ha importanza per gustare la musica di Elettra; e del resto anche se il loro significato espressivo non è sempre logicamente chiaro, non mancano tuttavia di esercitare una suggestiva efficacia drammatica.
ERMANNO WOLF-FERRARI - IL SEGRETO DI SUSANNA: Intermezzo in un atto. Prima rappresentazione al Teatro Reale di Monaco (Baviera) il 4 dicembre 1909. Libretto di Enrico Golisciani.
Il Conte Gil ha in orrore il fumare. Malauguratamente in casa sua l'odore del fumo c'è. Ma chi osa fumare contro il suo divieto? Interroga i servi, ma non mene a capo di nulla Gli nasce allora il sospetto che la giovane moglie Susanna riceva, quando egli è assente, un amante fumatore. Il sospetto è avvalorato dal fatto che dianzi gli parve di riconoscere fuori la moglie (mentre sa bene che, per suo divieto, sola non esce), e che attirandola a sè ha sentito su la sua persona l'odore detestato. Vuol far confessare la moglie, e questa ammette di avere...un segreto! Ciò basta per mandare fuor di sè Gil, il quale si dà a fracassare ciò che gli viene sotto mano, ed esce furibondo. Rimasta sola, Susanna, non sa spiegarsi l'ira del marito, nè sa resistere al vizio di fumare segretamente. Era infatti uscita poco prima per comperarsi delle sigarette; ora ne accende una. Ma improvvisamente Gil ritoma col pretesto di aver dimenticato l'ombrello. Susanna spegne e nasconde prontamente la sigaretta. Egli tuttavia avverte più acuto l'odore del fumo; cerca dovunque, ma non scopre nessuno. Esce di nuovo furente minacciando. Susanna riaccende la sigaretta; ma Gil di nuovo rientra. Susanna questa volta non ha fatto in tempo a spegnere la sigaretta, che tiene celata dietro la schiena. Gil nel prenderle la mano si scotta. La scoperta fa cadere d'incanto ogni gelosia; egli anzi se ne confessa ridendo con Susanna, acconsentendo, felice, ch'essa fumi. Farà di più: fumerà anche lui!
Quest'operina è un gioiello di comica festevolezza. Il soggetto, se vogliamo, è un po' scemo. Ma non è il caso di insistere su le tante inverosimiglianze dei caratteri dei due protagonisti e dell'azione, dato che la musica freschissima e piacente di Wolf-Ferrari si incarica di salvare ogni cosa. L'opera si apre con una «Ouverture in miniatura» su quattro temi che scorrono vivacissimi, inseguendosi e sovrapponendosi, originando anche un burlesco fugato, perfino con un tema rovesciato, in un giuoco agile e snello pieno di grazia e di humor.
La gelosia sospettosa di Gil è sottolineata da temi comicamente rabbiosi; mentre l'innocenza di Susanna ci è ben presto, diremmo, quasi «documentata» dal delicato motivo di cembalo ch'essa suona, e che si ripete nell'interludio a rasserenare l'atmosfera dopo la ridicola sfuriata di Gil. Esso si ripeterà alla fine dell'opera per chiuderla serenamente in un «a due» riconciliativo. La figurina di Susanna, che quasi quasi ama più il fumo che il marito, tanto si affretta a mettersi a fumare non appena egli è uscito, senza preoccuparsi, se non assai di sfuggita e superficialmente, delle sue stravaganti escandescenze, ha appunto i suoi momenti musicalmente più significativi nelle pagine che illustrano il suo «vizietto profumato», o puzzolente, a seconda dei gusti. Ecco allora il largo motivo dell'Adagio quando Susanna si mette a fumare, che il Musicista non si fa scrupolo di far precedere dal richiamo delle sensuali e snervanti scalette cromatiche ascendenti e discendenti che aprono l'Après-midi d'un faune di Debussy; come non si è fatto scrupolo precedentemente di introdurre nel giucco umoristico un accenno al tempestoso finale del 1° tempo della Va Sinfonia di Beethoven, al termine della più violenta contesa fra i due sposi, nè si farà scrupolo poi di introdurre in modo burlesco un frammento del temporale della Sinfonia Pastorale dello stesso Beethoven allorchè Gil ritorna all'improvviso per cercare ramante di Susanna.
Naturalmente, anche l'amore ha il suo posto, quel minimo che basta a non rendere antipatica la fumatrice. C'è, infatti, fra una burrasca e l'altra, un minuscolo duettino d'amore fra Susanna e Gil, con la rievocazione dei primi giorni del loro affetto, tutto sospiri e trilletti d'uccellini. Esso ha inizio con una espansiva frase di Gil («V'uguaglio, o cara, al giglio»), che viene bruscamente interrotta dall'improvviso ritorno dell'ira di Gil all'odore del fumo ch'egli avverte abbracciando la sposa. E c'è finalmente anche un tentativo, da parte di Susanna, di ammansare l'inferocito marito nell'aggraziata e sentimentale implorazione: «No, così non mi lasciate».
Dopo l'ultima e definitiva pace, l'opera chiude su un ritorno dei quattro temi arguti della sinfonia, che sembrano accennare a una vecchia morale: «tutto è bene quel che finisce bene».
NICOLA RIMSKI-KORSAKOW (Tikvin [Novgorod] 1844-Liubensk [Pietroburgo] 1908). IL GALLO D'ORO: racconto fiabesco in 3 atti. Prima rappresentazione postuma al Teatro Privato Zimin a Mosca nel 1910.
Libretto di Vladimir Bieisky, tratto dalla tragicomica novella del poeta Alessandro Puschkine.
Atto 1° - Prima che il sipario si levi, l'Astrologo viene ad annunziare una favola a maschere fondata su una morale lodevole. -Levatosi il sipario la scena rappresenta una vasta sala nel Palazzo di Dodone, Re di tutte le steppe della Russia meridionale. - Il vecchio Re ha adunato il Consiglio della Corona per avere suggerimenti nell'imminente pericolo di un assedio nemico. Mentre i figli del Re e i cortigiani disputano su ciò, entra l'Astrologo. Egli offre al Re un Gallo d'oro: se incomberà un pericolo, il Gallo starnazzando le ali griderà: «Occhi aperti, in guardia sta!». Il Re riconoscente pel regalo prezioso, giura di donare all'Astrologo ciò ch'egli domanderà, Poscia, avendo il Gallo cantato ch'egli può dormire tranquillo, licenziata la Corte, si addormenta. Ma d'improvviso il Gallo getta il grido d'allarme: il Re si desta e ordina al suo generale e ai figli di partire subito per la guerra. Però il Gallo ricanta il riposo, e il Re si riaddormenta esogna una bellissima fanciulla. Quand'ecco il Gallo lanciare ancora il segnale del pericolo. Il generale accorre e annunzia che la battaglia volge male per l'esercito del Re. Ancora assonnato, e indispettito per l'amoroso sogno interrotto, il Re si arma e sostenuto dai servi parte per la guerra, non senza essersi assicurato che il cavallo è tranquillo come un agnello e che al campo vi sono viveri per tre anni.
Atto 2° - Stretto sentiero fra rocce dirupate. - È notte. Giunge lentamente l'esercito di Re Dodone. Fra i cespugli giacciono i cadaveri dei figli del Re, uccisisi fra loro. Mentre il Re piange la loro sorte, da una tenda esce la bellissima Regina di Scemaka e, canta un inno al Sole che si leva. Interrogata dal Re, essa confessa di essere venuta senza esercito per sottomettere il suo regno con la sola virtù della propria bellezza. I suoi due figli si uccisero per lei. Essa affascina il Re e lo fa danzare fino a farlo cadere estenuato. Infine il Re offre alla Regina il proprio impero, ed essa parte con lui verso la capitale.
Atto 3° - Una via della capitale. - Davanti all'entrata del palazzo del Consiglio, al sommo d'un'asta, è issato il Gallo d'oro. Innanzi al popolo ammirato sfila il corteo fiabesco della Regina di Scemaka: personaggi con un sol occhio in mezzo alla fronte, nani e giganti, etiopi, uomini cornuti o con teste di cane, paggi con vesti orientali sfarzose, e infine il Re e la Regina su un carro dorato. L'Astrologo chiede al Re, quale compenso per il Galh d'oro, di donargli la Regina. Inutilmente il Re cerca di offrirgli oro, gemme preziose e perfino metà del regno; alfine, perduta la pazienza il Re l'uccide con un colpo dello scettro sul capo. Allora il Gallo d'oro vola verso il Re e con un gran colpo di becco sulla testa lo stende morto. Il cielo si oscura, scroscia un fulmine, la folla è terrorizzata. Nel silenzio che segue s'ode il riso tranquillo della Regina; ma allorchè la luce ritorna, la regina e il Gallo sono scomparsi. Innanzi al cadavere del Re la folla si prosterna levando alti lamenti. Calato il sipario, l'Astrologo appare a proclamare che in un regno di fantasmi gli unici esseri umani erano la regina e lui.
Rimski-Korsakow, attratto particolarmente dai soggetti in cui i caratteri più grotteschi dei popoli orientali antichi si fondono con l'elemento fiabesco, conoscitore del folklore musicale russoasiatico più tipico e significativo, scrisse per il Gallo d'oro, come del resto per le altre opere sue, una musica densa di colori brillanti, eppure non pesante, anzi gustosamente aggraziata e signorilmente elegante. La sua perizia di contrappuntista e di strumentatore gli permise di sovrapporre disegni variamente coloriti e ritmati in efficaci contrasti espressivi e decorativi. La sua ispirazione, tendente ad associare gli elementi favolosi a quelli puramente umani, fa oscillare l'anima dell'ascoltatore fra il mondo della fantasia e quello della realtà. Gli spunti delle canzoni popolari sono come trasportati in una sfera di pura immaginazione poetico-fìabesca, mentre gli elementi più estranei alla realtà sono umanizzati dal sentimento ìnsito nel canto. A ciò s'aggiunge la sottile malizia di interpretazioni che vanno dall'umoristico al grottesco, dal poetico leggendario al più acceso verismo sensuale, dalle tinte sgargianti, proprie di un mondo incantesimale, al descrittivismo ritmo-strumentale che trae i propri elementi da una forte sensibilità poetica dei fenomeni naturali, lasciandoci sempre sospesi fra terra e cielo come in un sogno.
Gli elementi umoristici, satirici e caricaturali, quali l'indolenza del Re di fronte all'invasione nemica, il suo afflosciarsi sotto il peso dell'armatura, la sua paura che il cavallo non sia abbastanza mansueto, la supina acquiescenza ai capricci della Regina che lo fa cantare e ballare, la stessa balorda fatuità della sua canzone, sono messi in rilievo con una pittura, se vogliamo, più esteriore che intima, ma non per questo meno briosa e divertente.
Altrettanto dicasi per gli imbelli consigli dei figli, per le adulazioni dei cortigiani, per la ruvida militaresca rozzezza del Generale Polkan, per la fifa dei soldati che hanno paura di sparare una cannonata, e via dicendo. Alla creazione di questo mondo contribuisce specialmente, come dicemmo, la perizia di strumentatore, veramente prodigiosa, di Rimski-Korsakow, che gli permette di creare aloni sonori carichi di luce e di colore, sfumati o scattanti dalla penombra vellutata al più abbagliante splendore, in cui i toni caldi e i cromatismi impregnati di molle e languida sensualità che accompagnano sempre i canti e l'immagine della Regina, imprimono del loro fascino tutta l'opera. In questo sfarzo strumentale prevale un senso decorativo molto frequente nell'arte russa e in generale nell'arte dei popoli orientali, i quali spesso annettono a questa sensibilità un significato quasi religioso.
Il motivo dell'allarme del gallo, e l'altro della Regina (quest'ultimo basato su le consuete scale orientali di cinque note col quarto intervallo aumentato) sono quelli che nell'opera, sotto vari travestimenti ritmici e strumentali, hanno il più largo e significativo sviluppo. Del motivo della Regina anzi il compositore sembra perfino abusare, nell'intento evidente di creare attorno al personaggio un'atmosfera di malìa languida e di magìa strana. I modi orientaleggianti sembrano infatti allontanare questo personaggio e la sua azione così nello spazio come nel tempo mantenendogli attorno un profumo di mistero. Non si tratta naturalmente di «temi» nel senso wagneriano, ma di immagini sonore che servono di richiamo ben preciso a due elementi essenziali della vicenda. Il motivo della Regina acquista addirittura forma strofica nell'ampia e fascinosa melodia della preghiera al Sole, cantata dalla Regina nel 2° atto, che nella struttura e in qualche figurazione ricorda la «canzone indù» dell'opera Sadko; e insieme al motivo del gallo forma l'ossatura dell'umoristica e pittoresca descrizione del corteo nel 3° atto.
ERNESTO BLOCH (Ginevra 1880) - MACBETH: dramma lirico in un prologo, 3 atti e 7 quadri. Prima rappresentazione all'Opéra-comique di Parigi il 30 novembre 1910. Libretto di Edmondo Fleg, dalla tragedia omonima di Guglielmo Shakespeare.
Prologo - Una brughiera battuta dal vento. - Alcune Streghe profetizzano a Macbeth che sarà Thane di Cawdor e Re, e a Banquo che sarà padre di Re. Macbeth si stupisce perchè il Thane di Cawdor e il Re vivono; ma ecco che sopraggiunge Macduff e annunzia che Re Duncano ha mandato a morte il Thane di Cawdor, ed ha eletto in sua vece Macbeth. A tale annunzio Macbeth è preso da orrore e da ambizioso desiderio insieme.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala nel castello di Macbeth. - Lady Macbeth, udita la profezia delle Streghe, incoraggia lo sposo ad agire se vuol conquistare il regno. Il Re Duncano giunge ospite al Castello di Macbeth, e Lady Macbeth persuade lo sposo, riluttante, ad uccidere il Re nel sonno.
Quadro 2° - Cortile interno nel Castello di Macbeth. - Macbeth va ad uccidere il Re, e ne torna con l'animo turbato da sgomento. Lady Macbeth riporta nella stanza il pugnale e imbratta di sangue le guardie addormentate. Macduff entrato nella stanza del Re per svegliarlo scopre l'assassinio e, posto in sospetto, fa fuggire Malcolm, il figlio di Duncano.
Atto 2° - Quadro 1° - Una sala di cerimonia nel castello reale di Macbeth. - Macbeth incarica due sicari di assassinare Banquo e suo figlio Fleanzio, ma quest'ultimo riesce a fuggire. Macbeth va poi per assidersi a banchetto con nobili Signori e Dame, ma crede di vedere il suo posto occupato dallo spettro di Banquo, ed è assalito da folle terrore. Gli invitati credono ad un malore del Re e abbandonano la sala. Macbeth non si sente sicuro e pensa di uccidere Malcolm, Macduff, sua moglie e i suoi fanciulli.
Quadro 2° - Giardino davanti al castello di Macduff. - I bimbi di Macduff giocano con la madre, allorchè un assassino inviato da Macbeth entra furtivamente, si getta su di loro e li uccide. Macduff di ritorno, alla vista dell'orrendo massacro, giura di vendicarli.
Atto 3° - Quadro 1° - Una caverna tenebrosa. Nel mezzo una grande caldaia su un bracere. - Macbeth viene a chiedere alle Streghe quale sarà il suo avvenire. Dalla caldaia esce un'apparizione che lo avverte di guardarsi da Macduff;poi appaiono Banquo e una serie di Re suoi discendenti; un'ultima apparizione gli profetizza ch'egli non sarà vinto se non quando si muova contro di lui la foresta di Birnam. Macbeth allora esce, pieno il cuore dì orgogliosa gioia e sicurezza.
Quadro 2° - Una sala nel castello di Macbeth con loggia dalla quale si vede la foresta di Birnam. - Il rimorso ha reso Lady Macbeth sonnambula. Ella stimola in sogno il coraggio dello sposo, e parla delle proprie mani lorde di sangue, che non riuscirà mai a lavare. Viene poi annunziato a Macbeth che diecimila nemici marciano contro il suo esercito. Macbeth fa suonare l'allarme, sicuro della vittoria; neppure l'annunzio della morte della Regina lo scuote. Ma un servo entra d'improvviso e annunzia che la foresta di Birnam si muove. Tutti fuggono terrorizzati: Macbeth si getta allora nel combattimento da solo e viene ucciso in duello da Macduff. La folla inneggia alla Scozia e a Malcolm suo nuovo Re.
La musica di quest'opera è foggiata su lo stile impressionistico debussyano, pure conservando una propria individualità per una più plastica figurazione tematica e per il maggior numero e il più frequente impiego dei temi. Questi non conservano sempre il carattere di temi-atmosfera proprio dell'arte impressionistica, ma acquistano in molti casi la fisonomia di veri e propri grund-motiv di tipo wagneriano anche se non ne raggiungono mai la profonda e possente incisività. Il sistema armonico è prevalentemente esacordale, ma non esclude l'elemento cromatico ed altri stilemi armonistici anche più moderni. L'orchestrazione ha una grande ricchezza coloristica, con preferenza delle tinte cupe, come vuole il carattere del soggetto, il quale dal principio alla fine è di una tragicità violenta e tetra.
I personaggi si muovono in un clima soffocante non solo per l'indole dei loro delitti, ma per quella fatale catena di sangue non allentata dal rimorso, che pure è presente come un incubo opprimente, ma ribadita dalla paura e dall' ambizione. Questi caratteri avevano già pesato su l'opera di Verdi, e non potevano nè possono essere evitati. Ne nasce dunque una musica che, nella sua febbrile angoscia, spesso allucinante, dove anche l'elemento diabolico favoloso acquista il carattere di incubo fatalistico, toglie il respiro e sembra opprimere il cuore come sotto il peso di una montagna.
Sul tessuto tematico che si svolge in orchestra si basa principalmente l'espressione della tragedia, poiché il canto, esclusivamente recitativo, per quanto segua fedelmente l'intonazione del linguaggio e le emozioni che lo accompagnano, non ha tuttavia particolare rilievo e non basta a caratterizzare distintamente i personaggi. Macbeth però trova in più d'una scena accenti che lo disegnano con vigore. Specialmente notevole è il monologo del 2° atto dopo l'apparizione di Banquo, «Ah! lascia pur l'universo crollare», dove il dolore e lo smarrimento raggiungono un'espressione disperata in un recitativo che assume flessioni più largamente melodiche e piene di spasimo, anche se in qualche momento si ricorda la disperazione di Tristano nel 3° atto dell'opera wagneriana. Ma forse più penetrante ancora è quanto ci dice di lui l'ultimo intermezzo dell'opera, in cui è tanto affranto dolore e tanto desolato abbandono.
Ma vi è talvolta, non solo nel recitativo, ma anche nel commento orchestrale, un'espressione scamita e fredda propria di chi è rimasto un po' estraneo al dramma. L'armonia e la ritmica diventano allora uniformi, grigio il colore strumentale, cosicchè la musica si affianca in questi momenti ai personaggi, alle loro parole, ai loro gesti, senza compenetrarli, senza vivificarli, senza crearli essa stessa in una manifestazione nuova, com'è delle opere d'arte riuscite. Altre volte invece la musica si approfondisce con chiaroscuri potenti, con aloni pieni di poesia, od anche con altorilievi scultorei. Le dissonanze diventano esse stesse spasimo d'orrore e delirio di sanguinaria demenza, cosicchè giustamente il Liuzzi definiva questa del Bloch «musica lampeggiante e sinistra!».
Un carattere poi che emerge da questa musica del Macbeth è che, malgrado certe violenze atroci del soggetto, Bloch si tiene lontano da quanto può suonare estremamente barbarico. C'è bensì in questa musica qualche cosa di primitivo, di guerresco, di epico, che s'intona all'ambiente, all'epoca e alla psicologia delle persone sceniche e crea un colore fondamentale inconfondibile e di grande appropriatezza, plumbleo e affocato. Lontananza dei tempi, sfondo magico, senso della fatalità ineluttabile, smisurata altezza di sogni imperiali a cui corrispondono altrettanta immane ferità di delitti e orrore di rimorsi, bagliori violenti di guerra e di congiura, folle travolgente ambizione, solennità eroica di propositi, trovano nella musica di Bloch colori e rilievi suggestivi. E su tutto ciò si spande un senso di estasi, di stupore magico, di meditazione e di nostalgico dolore. Il tema che apre l'opera crea subito l'atmosfera misteriosa e fatale in cui si svolge la tragedia, e col suo frequente ripetersi perseguiterà come un malefizio occulto i personaggi.
Talvolta la preoccupazione del testo mortifica l'ispirazione musicale, ma dove questa se ne può rendere indipendente, come negli intermezzi, allora si leverà irradiando di un palpito vivo il dramma.
Foschi bagliori di spavento e di orrore si sprigionano anche nel finale del 1° atto, dopo la scoperta dell'uccisione di Duncano, tutto percorso da ritmi nervosi e da dure armonie; e in quello del 2° atto dopo la scoperta dell'assassinio di Lady Macduff e dei figli, dove l'urlo della vendetta elevato all'unisono dalla folla ha un'irruenza singolarmente tragica. Anche il finale dell'opera è costruito su un'architettura dalle linee neramente vigorose.
In mezzo a tanto orrore non mancano le pagine in cui la greve atmosfera si rarefà e una blanda luce si spande con un palpito di tenerezza. Così all'arrivo di Duncano nel Castello di Macbeth, così nella parte centrale dell'interludio fra il 1° e il 2° quadro dell'atto 1°, e nella scena fra Lady Macduff e il figlioletto: oasi serene nel tenebrore tempestoso della tragedia.
GIACOMO PUCCINI - LA FANCIULLA DEL WEST: opera in 3 atti. Prima rappresentazione al teatro Metropolitan di New York il 10 dicembre 1910. Libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini dal dramma di Davide Belasco. - L'azione ha luogo in California, in un campo di minatori; epoca 1849-50.
Atto 1° - L'interno del bar detto la «Polka». - Minatori rientrano dal lavoro e vengono a svagarsi al bar, dove li attrae specialmente Minnie, la giovane e bella proprietaria della «Polka», che fa loro un po' da madre e da maestra. Ma più d'uno di loro aspira a sposarla; fra questi anche lo sceriffo Jack Rance, la cui dichiarazione riceve però da Minnie un cortese rifiuto. Giunge frattanto Mister Ashby, agente della Compagnia di trasporti Wells Fargo. Egli sta dando la caccia al temuto bandito Ramerrezz, e alla sua banda. Per lettera l'avventuriera Nina Micheltorena, amante del bandito, si offre di indicargli dove si nasconde. Ed ecco giungere uno straniero che si qualifica come Dick Johnson. Rance si insospettisce di lui, ma Minnie, che lo conobbe in passato, sta garante per Dick. In realtà non è altri che il bandito Ramerrez (Minnie non lo sa), venuto per tentare un colpo su l'oro che i minatori depositano alla «Polka»; ma anch'egli preso dal fascino di Minnie, per la quale fino dalla prima volta che la vide provò simpatia viva, la tranquillizza, le chiede il permesso di andarla a salutare nella sua capanna, ed esce senza rubare.
Atto 2° - Stanza di Minnie, alla quale sovrasta un solaio. - Johnson viene a salutare Minnie; la loro conversazione accende sempre di più i loro cuori. Ben presto l'amore divampa e Minnie gli concede un bacio. Ad un tratto si ode bussare; Minnie nasconde Johnson e va ad aprire. È Rance che è sulle tracce del bandito di cui Nina gli ha dato un ritratto. Minnie riconosce in esso Johnson, e partito lo sceriffo, rinfaccia a Ramerrez il suo inganno e, pure ascoltandone le giustificazioni, lo scaccia. Ma Rance è in agguato e lo ferisce con un colpo di rivoltella. Johnson cade contro la porta della capanna; in Minnie l'amore la vince sul risentimento: essa lo raccoglie e lo nasconde nel solaio. Lo sceriffo ritorna, certo d'averlo colpito. Una goccia di sangue che gli cade su la mano dall'alto glielo fa scoprire. Vorrebbe ucciderlo; Minnie allora gli propone di giocare l'amante e se stessa a pocker, e per salvarlo bara. Rance, sconfitto, esce precipitoso.
Atto 3° - Lembo estremo della selva californiana. - I minatori stanno dando la caccia a Ramerrez, che, già guarito dalla ferita, voleva partire per darsi a una nuova vita di redenzione. Riescono a prenderlo, lo legano e, stimolati dallo Sceriffo, si accingono ad impiccarlo, allorchè giunge trafelata Minnie. Essa, facendo appello all'affetto dei minatori e ricordando loro i sacrifizi da lei compiuti a loro beneficio, riesce a impietosirli, si fa consegnare Ramerrez, e parte con lui.
Puccini ha saputo far tesoro dell'impressionismo francese, assimilandone quanto a lui conveniva per arricchire i propri mezzi espressivi, senza peraltro rinunziare alla sincerità melodica e senza snaturarla. L'orchestrazione anch'essa, accanto alla più moderna e sciolta armonizzazione, si è raffinata, così nelle sfumature delicate come nelle sonorità soggioganti. Il fondo spirituale dell'ispirazione è però sempre il medesimo da cui nacquero le opere -precedenti.
La folla dei minatori e degli avventurieri dipinta con tinte forti e ritmica vivave, forma un quadro gagliardo e pittoresco. Ma il compositore ha un bel segnare «Allegro brutale» e accumulare dissonanze aspre mentre la folla grida «Al laccio» contro il baro Sid, o mentre Sonora spara contro Rance; la musica, robusta e dura, resta ben lontana dal presentare quel carattere primitivo e selvaggio che la situazione richiederebbe. Uno squarcio invece pieno di fantasiosa vigoria è quello strumentale e corale della caccia al bandito nel 3° atto, se pure anche questo più decorativo che drammatico. Lo stesso Rance, descritto come biscazziere, rotto al vizio e alla violenza, è nella musica di Puccini una figura sdegnosa e quasi dolente. Su l'aria «Minnie, dalla mia casa son partito» è scritto «con voce aspra e tagliente», ma nell'orchestra scorrono armonie piene di una morbida amarezza, tutta chiaroscuri sfumati.
Allo stesso modo, nei momenti più drammatici, la fantasia de] musicista non sempre risponde. Nella scena della partita a poker, in cui si giuoca la vita di un uomo, Puccini lascia le voci più scoperte che può in un recitativo appena intonato (egli ha cura di scrivervi sopra «quasi parlato») con brevi accenni di commento strumentale. L'unica trovata veramente notevole è quella cupa palpitazione dei contrabassi di efficacia innegabilmente affannosa. Il musicista ha lasciato fare al dialogo piuttosto che guastare, e l'effetto è raggiunto, ma, come giustamente osserva il Rinaldi, «sarebbe difficile dire se si assista ad un dramma a forti tinte o ad un'opera lirica». Così dicasi per quel motivetto quasi marziale ed eroico delle trombe e dei tromboni punteggiato da rulli di tamburo, allorchè Johnson sta per essere impiccato.
La parte viva dell'opera è, come sempre nelle opere pucciniane, quella lirica. La pagina più alta per la commossa poesia che vi respira è la «canzone della nostalgia», lineare, semplice, tutta svolta su un motivo pieno di una dolente e trasognata dolcezza, che si dilata attraverso agli interventi del coro e attanaglia il cuore. Il temuto Ramerrez è in verità un brigante molto per bene. Un motivo vibrato e allarmante ce lo presenta al suo ingresso; ma come Johnson riconosce in Minnie la fanciulla che già gli aveva fatto sognare dolcezze d'amore e redenzione, la sua voce si fa dolce e mite. Del brigante rimane soltanto il tenore di grazia da cui escono melodie fra le più gentili della lirica amorosa pucciniana. Nella sua bocca il banale valzeruccio dei minatori diventa la trepidante melodia: «Quello che tacete me l'ha detto il cor», già sospirata teneramente dall'oboe, in un duetto che è tutto un ansioso susseguirsi di sincopi e di frasi carezzevoli.
Un maggior calore si sviluppa dal duetto del 2° atto, dove il bandito confessa finalmente la fatale orrenda eredità lasciatagli dal padre, in un canto che alterna gli accenti amari a quelli di un'impotente ribellione, quelli del suo sogno d'amore e di redenzione infranto a quelli di una triste e cupa disperazione: racconto veramente sentito e anche drammatico. Non possiamo dire altrettanto bene della stanca romanza dell'ultimo atto: «Ch'ella mi creda libero e lontano». Qui il sentimentalismo ha preso la mano al musicista e l'ha condotto all'effetto puramente teatrale del si bemolle su la fine della melodia, la quale si ripete implacabilmente uniforme per una seconda strofa.
Come sempre, la figura più intimamente espressa è quella femminile: Minnie. La frase entusiastica con cui essa fa la sua entrata ha uno slancio energico che incide con tratti rapidi ma sicuri il carattere franco e generoso della fanciulla. Momenti di squisita femminilità, di gentile bontà e momenti di forza temperata di grazia si succedono ad ogni passo, espressi non solo attraverso alle intonazioni vocali del canto, sempre di natura melodica anche nei recitativi, ma nei commenti strumentali. E questo se non è un fatto proprio nuovo, è certo un ampliamento e uno sviluppo di accenni che si trovano in opere pucciniane precedenti. La poesia dell'anima di Minnie esce così da una più fattiva collaborazione dell'orchestra col canto.
Ne troviamo delicate riprove nella scena della lezione; nel racconto: «Laggiù nel Soledad», che sbocca nella calda e larga esclamazione: «S'amavan tanto!», racconto pieno di così intenso fervore d'aspirazione; nella frase del duetto d'amore: «Ma il primo bacio debbo darlo ancora», dove insieme a tanto casto orgoglio è tanto desiderio di amore che quasi fa pregustare la gioia di questo bacio; nella confessione così piena di semplicità innocente: «Io non son che una povera fanciulla», anche questa sboccante nell'aspirazione di un'ascesa: «Su, su, come le stelle», che porta l'espressione dell'amore in un mondo di eccelsa e purissima spiritualità.

Figura 15: Figurini di Cito Filomarino per la Salomé di Strauss.

Figura 16: Figurini di Caramba per il Fra Gherardo di Pizzetti.
La femminilità di Minnie prorompe ancora nel 2° atto in quell'ingenua civetteria del: «Voglio vestirmi tutta come in giorno di festa», dai disegni e timbri orchestrali così vellutati e leggeri.
L'amante e l'eroina sono nell'acre richiamo a Johnson dopo che ha saputo chi è; nel grido: «Sei l'uomo che baciai la prima volta», dopo ch'è stato ferito, cui segue l'angoscioso e faticoso motivo mentre lo sospinge in salvo su la soffitta; motivo che diventerà uno squillo disperato di trionfo allorchè dopo la vittoria a poker esclama: «Ah! è mio!». L'eroina e la donna emergono infine nel suadente suggerimento; «Anche tu lo vorrai», al 3° atto, allorchè suscitando ricordi cari al cuore, riuscirà a vincere l'odio, il risentimento e anche la gelosia dei minatori, e a trarre in salvo Johnson verso «la via di redenzione», mentre la canzone della nostalgia la segue come un pianto dolce e buono.
RICCARDO STRAUSS - IL CAVALIERE DELLA ROSA: commedia in tre atti. Prima rappresentazione al Teatro Reale di Dresda il 26 gennaio 1911. Libretto di Hugo von Hofmannsthal.
Atto 1° - La camera da letto della Maresciallo, Principessa Wardenberg. - Approfittando dell'assenza del marito, la Marescialla ha ricevuto nella sua stanza l'amante Ottavio. L'arrivo del cugino della Marescialla, barone Ochs di Lerchenau, interrompe il colloquio amoroso. Ottavio si cela nell'alcova e si traveste da donna. Il Barone è venuto ad annunziare il suo fidanzamento con Sofia di Faninal, e a chiedere un consiglio circa il cavaliere che, secondo l'usanza, dovrà recare alla fidanzata la tradizionale rosa d'argento. Frattanto Ottavio, travestito da cameriera, è uscito dall'alcova, e il barone subito se ne invaghisce. La Marescialla propone che Ottavio (un suo cugino, dice essa) rechi la rosa a Sofia. Per qualche tempo nella stanza è un via vai di fornitori, postulanti e servitori. La Marescialla, rimasta ancora sola con Ottavio (il quale si riveste degli abiti maschili) gli espone i suoi timori d'essere abbandonata da lui. Offeso da tale dubbio, Ottavio fugge, vanamente inseguito da alcuni servitori. Tale fuga, unita al primitivo timore, lascia la Marescialla in uno stato di profonda malinconia,
Atto 2° - Sala in casa Faninal. - Ottavio viene a portare la rosa d'argento alla fidanzata del Barone Ochs, ma come i due giovani si vedono si stabilisce, inconsciamente per entrambi, una corrente di sottile fascino. Sopraggiunto il Barone, questi urta Sofia con i suoi modi volgari, mentre Ottavio ne freme e stenta a contenersi. Il grossolano contegno e la canzone sguaiata del Barone irritano la fidanzata, la quale, rimasta un momento sola con Ottavio, gli dichiara di non volersi più sposare. I due giovani si accorgono ora del loro amore reciproco e si abbracciano, ma sono sorpresi da due servi del Barone, Rys Galla e Zephyra, i quali si mettono a gridare. Accorre il Barone, che viene insultato e ferito leggermente da Ottavio. Curato e poscia lasciato solo, si consola bevendo e canticchiando, quando Zephyra gli recapita un misterioso biglietto della «cameriera» della Marescialla, che gli fissa un appuntamento. Zephyra reclama però invano un compenso; e irritata pel rifiuto, fa segno che si vendicherà.
Atto 3° - Stanza separata d'un ristorante, con alcova. - Giunge il Barone Ochs con Ottavio travestito da donna, ma da ogni lato appaiono teste d'uomini che ossessionano e terrorizzano il Barone. Giunge poi travestita Zephyra, la quale si finge moglie del Barone e lo accusa di adulterio in faccia a una folla di persone sopraggiunte. Quattro bimbi irrompono chiamando «papà» il Barone. Questi allora invoca a gran voce dalla finestra la polizia, ma il Commissario intervenuto lo mette con le sue inchieste ancor più in imbarazzo. Mentre Ochs tenta di far passare Ottavio travestito per Sofia, il Signore di Faninal entra con la figlia e lo smentisce. Giunge intanto la Marescialla: il Commissario, da lei persuaso, se ne va; Ottavio ricompare in vesti da uomo; una folla di inservienti reclama di esser pagata dal Barone. Questi alfine comprende la sua situazione e fugge; e la Marescialla compie il supremo gesto di rinunzia, congiungendo Ottavio a Sofia.
Strauss usa nelPopera il consueto stile dei suoi poemi sinfonici, ove il fascino maggiore è dato dallo splendore dello strumentale polifonico, stupendamente esuberante di colore. Il cromatismo wagneriano è sviluppato con un'espressione che ha sapore di forte sensualità. Gli abissi delle dissonanze create spesso per mezzo di ritardi o di anticipi, su cui l'animo rimane di tanto in tanto sospeso, sono subito spianati per le pronte e gradevoli risoluzioni armoniche. Si vaneggia verso la perdita della tonalità per subito ritrovarla: in questo gioco nessuno è più abile maestro di Riccardo Strauss.
Tale preziosità di colori strumentali e armonici caleidoscopici, usata con superiore sapienza e gusto, trasforma anche gli elementi melodici più banali in materia aurea. E gli elementi banali, voluti o no, sono numerosi, specie nei ritmi del valzer viennese, di cui l'autore abusa specialmente nel 3° atto. Ma avviene pure assai spesso che le modulazioni a tonalità inattese si sposino a rara eleganza di disegni melodici. L'elemento tematico wagneriano si fonde felicemente con modi propri del recitativo e del canto operistico antico. Perciò lo Strauss non rifugge dall'unire due o più voci simultaneamente, e talvolta anche in trame polifoniche vocali piene di movimento e di forza. E non rifugge neppure dal fare la caricatura di musiche serie, come quella dell'inno nuziale del Crepuscolo degli Dei allorchè nel 2° atto il Barone Ochs si presenta pomposamente in casa della fidanzata.
Il personaggio del Barone è quello che la musica meglio dipinge nei suoi tratti salienti di fatuità boriosa, di avarizia, e soprattutto di uomo dall'educazione grossolanamente volgare, e dalle pretese di vecchio donnaiolo libertino cinicamente incosciente. Il Barone fa la peggior figura su la fine del 2° atto e nel 3°; tuttavia il 1° atto, dall'impetuoso e caldo preludio al soave languido e sensuale duetto d'amore fra Ottavio e la Marescialla, all'indovinata aria di tenore, il cui testo in lingua italiana musicalmente echeggia con signorilità il modo arioso delle cavatine settecentesche italiane, finemente modernizzato nel gusto e nell'espressione (che è più appassionata di quanto convenga al puro settecento), al racconto vivace delle imprese dongiovannesche del Barone, alla malinconica e tenera chiusa, è il più bello e vario di tutta l'opera.
A proposito dell'aria del tenore, lo Strauss ebbe una intenzione caricaturale, che però risulta completamente fallita perchè la melodia ampia e fluente è bella e produce un senso gradevole anzichè quello del ridicolo. Il maggior difetto del 1° atto è dato da qualche prolissità, difetto che non manca neppure negli atti successivi. Ma anche nel 2° e 3° atto sono da segnalare pagine geniali, quali il delicato e affettuoso (forse anche questo un po' troppo sensuale) duetto fra Ottavio e Sofia (atto 2°), il- vivacissimo preludio fugato del 3° atto, il terzetto su la fine dell'atto tra la Marescialla, Ottavio e Sofia, di un patetico pieno di poesia, e l'ultimo duetto fra Ottavio e Sofia, che oscilla vagamente .tra le espressioni aggraziate di Mozart e quelle più moderne ma imbevute di settecentismo di Wolf-Ferrari.
A ben guardare, le pagine di maggior valore non appaiono, dal punto di vista musicale, quelle comiche e buffe, ma quelle proprie della commedia sentimentale: l'amore coi suoi languori e le sue estasi, i suoi sospiri e i suoi rapimenti, le sue gioie e le sue malinconie.
Specialmente viva l'impressione di contrasto fra l'alba felice dell'amore giovanile di Sofia e di Ottavio, e il tramonto nostalgico dell'amore della Marescialla, che sorregge e vivifica il terzetto dianzi ricordato dell'atto 3°, anche se innanzi alla mente dell'autore è passato il ricordo (e non il ricordo soltanto) di un altro grande esemplare, e cioè del terzetto Sachs-Walter-Eva nel 3° atto dei Maestri Cantori, che si svolge su una situazione analoga: la rinunzia di Sachs e il trionfante amore di Walter e di Eva.
PIETRO MASCAGNI - ISABEAU: leggenda drammatica in 3 parti. Prima rappresentazione al Teatro Coliseo di Buenos Aires il 2 giugno 1911. Libretto di Luigi Illica. - Epoca: anno 1200.
Parte 1a: Il Mattino - Gran sala rotonda, a porticati aperti, nella reggia di Re Raimondo. - Isabeau, figlia unica del Re, torna da un pio pellegrinaggio. Il Re ha bandito una «tenzone d'amore» per dare uno sposo alla principessa; e, per consiglio del Ministro Cornelius, le impone di presentarsi senza il manto che essa porta per estrema castità. Ma Isabeau rifiuta, e il padre vinto da questo sentimento di religioso pudore, non insiste. Frattanto giunge alla corte una vecchia contadina, Giglietta, la quale prega la reginetta di accettare come falconiere il proprio nipote Folco, Si svolge poi la «tenzone», ma nessuno dei concorrenti e accettato da Isabeau. Il popolo inneggia a Isabeau, e il Re sdegnato, gli impone gravi balzelli e angherie. Isabeau interviene in favore del popolo. Allora il Re ritira la condanna e, accogliendo il perfido suggerimento di Cornelius, ordina alla figlia di cavalcare nuda per la città nel pieno meriggio, Isabeau accetta il sacrificio per liberare il popolo dalla condanna,
Parte 2a: Il Meriggio - Gli spalti del Castello. - Il popolo ottiene dal Re l'ordine che nessuno possa assistere alla cavalcata di Isabeau. Chiunque vi assista sarà accecato. Ma Folco, innamoratosi senza speranza della reginotta, getta fiori dall'alto degli spalti al passaggio della vergine ignuda. Scoperto, viene imprigionato. A Isabeau dichiara di avere trasgredito all'ordine del Re «per morire».
Parte 3a: La Sera - Il lato del Castello innanzi alla prigione. - La vecchia Giglietta implora Isabeau di salvargli il figlio. Isabeau si fa condurre innanzi Folco e lo interroga. Udito che l'ama, e presa anch'essa da amore per il giovane, corre dal Re a chiederlo in isposo. Solo in questo modo potrà salvarlo, poichè lo sguardo dello sposo non è colpevole. Ma Cornelius che ha compresa Intenzione di Isabeau, lascia Folco nelle mani del popolo furente, che lo acceca. Isabeau, tornando, intuisce quanto accade, si getta fra la folla e rimane ferita a morte insieme a Folco.
Il libretto presenta stranezze inverosimili: un Re di cartapesta, troppo facile a flettersi ai più ripugnanti consigli di un cosiddetto Ministro, e altrettanto facile a pentirsene; un Ministro che non fa altro che suggerire e attuare crimini, non si capisce a che scopo. Una principessa la quale, divotissima e casta come ci viene descritta, dichiara con frase procacemente sensuale di voler difendere i suoi «misteri biondi», e si lascia poi dire da Folco che a contemplarla nuda non le fece ingiuria; e dopo essersi bevuta una simile affermazione senza batter ciglio, non trova miglior mezzo per salvarlo che di chiedere al padre di lasciargli sposare il giovane falconiere, col facile pretesto che «gli occhi dello sposo non dànno offesa nè ingiuria»! Ma a che scuola laica ha imparato tutto ciò la casta e divota Isabeau, che al mattino rifiutava perfino di togliersi il mantello?
Anche Folco, il quale, con una morale da perfetto libertino, dà dei vili a coloro che, per un senso di rispetto verso la loro principessa, non osano andarla a vedere nuda, e alla giovane che si dice offesa dal suo sguardo risponde impudico «tu senti che menti!», è fuori da ogni verosimiglianza.
È un libretto ben stravagante questo che Illica ha manipolato per il musicista, e che deforma e deturpa la bella leggenda poetica della Lady Godi va di Tennyson. Ma il Musicista ha trovato appunto nell'erotismo diffuso di questi strani personaggi e nella loro più strana psicologia, un buon stimolo pel suo estro sensuale.
Mascagni usciva da due esperienze: Le Maschere (1901) e Amica (1905). L'opera LE MASCHERE, rappresentata nella stessa sera in sette teatri, e caduta clamorosamente in sei, era un tentativo di riportare sulla scena la commedia dell'arte coi suoi tipi popolareschi caratteristici. Riuscì un misto di luoghi comuni e di pagine liriche ispirate, e fra queste principalmente la nota spigliatissima e geniale sinfonia, i teneri duetti amorosi tra Florindo e Rosaura, la scena dei sospiri, le danze (Pavana e Furlana), il finale del 2° atto. Opportunamente sfrondata e alleggerita di tutto quanto contiene di pletorico, di convenzionale e anche di superfluo (Mascagni praticò alcuni tagli, ma non bastano) la commedia musicale graziosa meriterebbe di rivivere.
In AMICA Mascagni aveva tentato, e non sempre male, l'innesto del ceppo sinfonico tedesco su quello melodico italiano. La storia dei due fratelli che si contendono una fanciulla, la quale per seguire uno dei due precipita in un burrone e muore, presentava aspetti che il compositore seppe far suoi e rendere vivi. «Mascagni con Amica - scriveva il Pannain - non solo ha saputo nobilitare la forma, dar consistenza e finalità al melodramma, ma ha sintetizzato così bene i vari aspetti dell'ambiente da farci scorgere nell'opera sua qualche elemento di poema». Se l'opera non si rappresenta è forse per la povertà del soggetto e per qualche enfasi canora e strumentale, ma non bisognerebbe dimenticare che vi sono pagine di robusta vita musicale e poetica, come la descrizione dell'alba al suono dei campàni delle mandre, la villica «monferrina» dal ritmo cosi balzante (è sempre il musicista dei quadri naturali che qui s'impone), il delicato racconto di Giorgio: «Tutti i dì la vedevo passare», il finale del 1° atto con quell'invito di Rinaldo: «Più presso al ciel, più lontan dalla terra» in cui la musica spicca il volo con il senso lirico solenne dell'altitudine alpestre, l'intermezzo drammaticamente denso e robusto, anche se qua e là truculento, l'implorazione di Rinaldo: «Se tu amasti me», che contiene la straziante frase: «Son io che qui piango», e il finale dell'opera nel rombo della tempesta, che è insieme tempesta del ciclo e delle anime (altra pagina naturalistica assai forte di Mascagni).
In ISABEAU Mascagni è pure alla ricerca di uno stile rinnovato, ma staccandosi dal sinfonismo di Amica lo cerca nelle contorsioni di un'armonizzazione perennemente e spesso duramente modulante. Così, ad esempio, nel? intermezzo, dove la melodia che dovrebbe glorificare il sacrifìcio di Isabeau si svolge senza naturalezza su un tormentoso perenne cambiare di tono, mentre le campane suonano per conto loro e non si innestano con la sinfonia orchestrale se non come semplice episodio. Molti poi sono i momenti enfatici, a cominciare dal vacuo e tronfio motivo del Re, andando fino al delirio declamatorio di Folco mentre getta fiori su Isabeau.
Non è da pensare alla caratterizzazione dei personaggi: la musica non può dare nessuna consistenza a figure così inconsistenti e balordamente contradditorie. L'opera va ascoltata per il calore di alcune scene e la poesia di vari episodi. Notiamo, ad esempio, nel prolisso 1° atto (prolisso e monotono specialmente nella scena della tenzone) la villetta che accompagna il ritorno di Isabeau dal pellegrinaggio, di una dolcezza pastorale ben degna del Mascagni idillico, quale conoscemmo già nelle migliori opere precedenti. Ancora: l'umile e commossa difesa che Isabeau fa del proprio manto, specie nello slancio purissimo della chiusa; l'entrata di Giglietta con Folco, tutta intessuta su vaghissime armonie, di intonazione anch'essa pastorale, e la spiegazione del sogno fatta da Folco, specie nell'ispirato: «È Dio che con carezza d'aria». E aggiungiamo la «canzone del falco», fatta di grida e di voli impetuosi, e il concitato coro: «Onde di polve» che descrive l'arrivo del popolo per assistere alla tenzone (anche se tormentato dalle continue modulazioni e progressioni). Poi, nel 2° atto, è tutta indovinata la prima scena, con l'agitato coro in cui il popolo chiede al Re di mutare l'editto, seguìto dall'esultante coro unisono delle donne: «La Vergine cavalchi senza velo»; nè mancano frasi commosse anche nel monologo di Folco prima di gettare i fiori su la principessa.
Il meglio dell'opera è forse nel 3° atto, dove troviamo, anche se episodio non necessario, la soave preghiera così dolce e di intonazione vagamente arcaica delle due damigelle: «A Te umilmente», il poeticissimo episodio del coprifuoco, e, perla dell'opera, la malinconia dolcissima del canto di Isabeau: «I tuoi occhi», di un'onda fra le più cariche di sentimento doloroso, in un'ampiezza di linea anch'essa tipica del migliore Mascagni.
MANUEL DE FALLA (Cadice 1876-Alta Gracia [Cordova] 1946) - LA VITA BREVE: dramma lirico in 2 atti e 4 quadri. Prima rappresentazione al Casino Municipale di Nizza il 1° aprile 1913. Libretto di Carlo Fernandez-Shaw. - L'azione si svolge a Granata: epoca attuale.
Atto 1° - Quadro 1° - Cortile in una casa di gitani nell'Albaicin di Granata. A sinistra una fucina, - Dalla fucina vengono i canti dei gitani e il suono dei martelli su le incudini; dalla ma grida di ambulanti. Salud, fidanzata al ricco Paco, è in attesa di questi, grandemente ansiosa per il suo ritardo. Invano la Nonna cerca di calmarla: Salud teme d'essere abbandonata. Ma Paco giunge, e Salud cede alla gioia del proprio amore. Lo zio però ha saputo che Paco l'indomani sposerà un giovane ricca, e lo confida alla Nonna.
Quadro 2° - Vista panoramica di Granata dal Sacro Monte.- Scende la sera. Voci e canti si disperdono lontano.
Atto 2° - Quadro 1° - Una piccola via di Granata. Da un lato la casa di Carmela e di suo fratello Manuel. Dalle ampie finestre aperte si intravvede la festa per gli sponsali di Carmela con Paco. - Avvertita dallo zio, Salud giunge e disperata scopre il tradimento. Essa entra allora con lo zio nella casa di Carmela.
Quadro 2° - Corte nella casa di Carmela e di Manuel, ove ha luogo la festa. - Mentre si svolgono le danze, Salud e lo zio entrano. Paco si turba, ma alle accuse di Salud oppone un diniego e la scaccia; e Salud cade ai suoi piedi uccisa dal dolore.
L'opera, composta nel 1904-5 e rappresentata solo otto anni più tardi, è tenue, perchè tenue e povera d'interesse è l'azione, ma limpida, espressiva e colorita. Essa costituisce uno dei momenti più notevoli e felici dell'indirizzo nazionalista del teatro musicale spagnolo. Certamente non va trascurato ciò che essa ci offre dal punto di vista della passionalità, come ad esempio il duetto fra Paco e Salud che chiude il 1° quadro dell'atto 1°, di un largo e caldo respiro vocale melodico. Questo duetto però potrebbe anche appartenere ad un'opera della scuola cosiddetta «verista» italiana o francese per l'intonazione generale del suo lirismo canoro e per l'esuberante slancio sentimentale, tuttavia ingentilito dalla finezza di una cesellatura di gusto massenetiano. Altrettanto si dica della scena in cui Salud scopre il tradimento di Paco nel 2° atto, e della scena finale dell'opera. Il linguaggio musicale usato per queste scene non aggiunge nulla di nuovo al linguaggio melodrammatico già noto; è sempre nobile, comunicativo, senza durezze armoniche e commosso, anche se qua e là qualche tocco ricorda Massenet e Wagner, e se manca del colore locale e della forza drammatica che nasce dall'intima fusione tra la parola e il canto, e che un francese usò già in un'opera il soggetto spagnolo: intendiamo dire il Bizet della Carmen.
Tutto quello che di nuovo e di tipicamente iberico l'opera presenta si aduna pertanto negli episodi, spesso assai lunghi, e negli elementi decorativi che nulla hanno a che fare propriamente con il volgare inganno di Paco e con il dolore che arresta i battiti del fragile cuore di Salud. E sono le canzoni e le danze «alla maniera andalusa», i cori dei gitani, la descrizione della sera a Granata; canzoni e danze dai ritmi languidi o piccanti, dalle melodie voluttuose, dalle cadenze piene d'ebbrezza, dai colori strumentali accesi o misteriosi. Così la canzone disperatamente triste: «Sventura a chi nasce sotto cattiva stella», che un gitano canta nella prima scena dell'opera, che si ripete come una minaccia drammatica fatale su la fine del duetto d'amore fra Salud e Paco, e che Salud stessa ricanterà nell'ultimo atto sotto le finestre della casa in cui si festeggiano le nozze di Paco e di Carmela; la canzone malinconica di Salud: «Vive chi ride, muore chi piange!»; i «Soleares» andalusiani e popolareschi del «Cantaòr» con i suoi pomposi gorgheggi, e le danze eleganti e slanciate divenute ormai famose attraverso alle esecuzioni concertistiche.
Un quadro di colorita potenza evocativa è quello che apre l'opera con le esclamazioni dolenti e i canti amorosi dei gitani al modo delle canzoni andaluse, fra il ritmico squillare dei martelli su le incudini e i richiami dei venditori ambulanti su la via. Quadro di vita che si svolge fuori della scena. E ancora fuori della scena sono i canti che si sperdono lontano mentre scende la sera su Granata, e che su i ritmi e i colori suggestivi dell'orchestra occupano l'intero 2° quadro del 1° atto; vero poemetto sinfonico-vocale interamente inutile all'azione, ma pervaso da una sottile ebbrezza, in un'atmosfera di mistero punteggiata di voci canore che richiamano ai nostri sensi ondate di tiepidi profumi, eccitanti e snervanti ad un tempo. Sono queste le pagine più personali e più belle dell'opera, anche se riecheggiano l'impressionismo francese e se estranee al dramma e di intralcio al suo svolgimento. Masi direbbe veramente che il futile soggetto e la sua magra consistenza scenica siano stati scelti appositamente per offrire al compositore un pretesto per questa musica di una così deliziosa malìa coloristica.
ITALO MONTEMEZZI (Vigasio [Verona] 1875 - ivi 1952). - L'AMORE DEI TRE RE: tragedia in tre atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 10 aprile 1913. Poema di Sem Benelli. - L'azione si svolge «nel medio evo in un remoto castello d'Italia quarant'anni dopo un'invasione barbarica».
Atto 1° - Spaziosa sala di un Castello. - È notte, e il vecchio e cieco barone Archibaldo non potendo prender sonno s'aggira, guidato dal servo Flaminio, in attesa del figlio Manfredo, che deve tornare dal campo; e intanto narra a Flaminio il ricordo ancor vivo della sua prima discesa in Italia. Poi Archibaldo si allontana col servo. Avito e l'amante sua Fiora, sposa di Manfredo, escono da una stanza, ma sentendo ritornare Archibaldo, Avito fugge. Fiora non fa a tempo a seguirlo: il cieco l'ha udita. Vorrebbe sapere chi era con lei; egli sente che Fiora tradisce lo sposo, ma Fiora afferma che era sola. Intanto s'è fatto giorno, e giunge Manfredo. Mentre, dopo i saluti, s'avvia con Fiora nella sua stanza, Archibaldo invoca da Dio di farlo «cieco» anche nell'intelletto.
Atto 2° - Terrazza sulle mura del castello. - Manfredo deve ripartire; dolcemente rimprovera Fiora pel suo animo chiuso, e la prega di agitare dal terrazzo un velo in segno di saluto mente egli si allontana. Ed ecco, appena partito Manfredo, comparire Avito, che Flaminio ha travestito come una guardia del castello affinchè possa passare senza essere conosciuto. Egli invoca un bacio da Fiora, mentre essa agita il velo. Dopo breve resistenza, Fiora cade nelle braccia dell'amante. Ma li sorprende Archibaldo. Avito fa per gettarsi col pugnale contro il vecchio, ma, fermato da Flaminio, si allontana. Archibaldo però ne ha sentito il passo; ghermisce alla gola Fiora affinchè gli dica il nome dell'amante; e siccome essa rifiuta, Archibaldo la soffoca. Frattanto Manfredo, che ha visto scomparire d'improvviso il velo, è tornato per sapere che cosa è accaduto. Archibaldo gli dice che ha ucciso Fiora perchè lo tradiva; non sa chi sia ramante, ma lo scoprirà.
Atto 3° - Cripta nella chiesa del castello; nel mezo è il cadavere di Fiora. - Gente del popolo leva un alto compianto attorno all'estinta. Come i popolani si allontanano, giunge Avito. Invoca piangendo Fiora e si china a baciarle la bocca; ma tosto sente un gran dolore al cuore. Archibaldo ha avvelenato le labbra di Fiora per conoscere e punire l'amante, certo che l'avrebbe baciata. Manfredo, sopraggiunto, si getta anch'esso su Fiora per cogliere sulla sua bocca la morte. In quest'atto lo ghermisce Archibaldo, che crede d'avere sorpreso il traditore; ma prorompe in un grido d'orrore allorchè si accorge che il morente è suo figlio.
Questa è senza dubbio l'opera migliore del Montemezzi, quella nella quale gli elementi assimilati da varie fonti, di cui le principali appartengono alla giovane scuola italiana e a Wagner, sono meglio dominati da una personalità ormai matura e ricca di esperienza oltre che di sapienza. Della scuola italiana c'è l'espansiva ed anche, in qualche momento, enfatica cantabilità; di Wagner c'è il cromatismo sensuale. Non manca neppure qualche tocco impressionista, senza che la fusione di questo con gli altri elementi crei dissidi troppo forti di stile. C'è qua e là una certa tendenza oratoria che è in gran parte dovuta al testo poetico, il quale si diffonde spesso in verbosità ridondanti. Così, ad esempio, nel racconto della prima discesa in Italia di Archibaldo, per quanto il compositore vi stenda sopra un'aureola di gloriosa cantabilità, e vi aggiunga l'impeto concitato di un ritmo di cavalcata. Questo ritmo è una specie di «tema» drammatico che non solo accompagna il sospettoso e spietatamente feroce Archibaldo, ma compare anche come un'ombra in altre scene dell'opera, insinuandosi come il fantasma minaccioso di un'implacabile persecuzione perfino nelle stesse scene d'amore.
Il personaggio di Manfredo, scialbo nella poesia, poco acquista dalla musica; mentre Avito e Fiora vivono per il loro amore appassionato, che la musica accarezza con voluttuosa dolcezza e con slanci di ebbrezza febbrile. Ed è in questo amore il meglio dell'opera. Quella di Manfredo è una tenerezza non priva di calore, ma che non fa presa sull'animo. Tutt'altra cosa è l'amore colpevole di Avito e di Fiora, che assume un alto grado di liricità con toni di spasimo ardente e di languore estatico, di rapimento e di sognante delirio. L'ampia frase di Avito al 1° atto: «Dammi le labbra e tanta ti darò di questa pace!», che poi verrà ripresa nel maggior duetto del 2° atto, è veramente un canto dal quale si sprigiona un fremito ardente di desiderio. La parte tragica, l'uccisione di Fiora, non ha forse un sufficiente rilievo tematico, e forse è ancora troppo cantante pur nel suo cupo orrore. Orrore canoro che ha il suo epilogo su uno sfondo funereo di preghiere nel rapido 3° atto.
RICCARDO ZANDONAI (Sacco [Rovereto] 1883 - Pesaro 1944) - FRANCESCA DA RIMINI: tragedia in 4 atti. Prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino il 19 febbraio 1914. Poema di Gabriele D'Annunzio, ridotto da Tito Ricordi.
Atto 1°- Una corte nelle case dei Polentani a Ravenna contigua a un giardino che brilla di là da una chiusura di marmi traforati in guisa di transenne. - Ostasio da Polenta, dietro suggerimento del Notaio Ser Toldo Berardengo, ha disposto che le nozze della sorella Francesca con Giovanni Malatesta lo sciancato avvengano per procura, lasciando credere a lei che lo sposo sia Paolo il Bello. Francesca è trepidante nell'attesa di incontrarsi con lo sposo, quand'ecco le fanti annunziano l'arrivo di Paolo. Essa lo vede al di là del cancello; è subito presa dalla sua grazia, e gli porge una rosa.
Atto 2° - La piazza d'una torre rotonda merlata nel castello dei Malatesti a Rimini, - Francesca, salita su la torre, vi si incontra con Paolo, che l'ama, mentre incomincia la battaglia contro i Parcitadi, Francesca gli rimprovera l'inganno mediante il quale è divenuta sposa di Gianciotto. Questi sale pure su la torre e annunzia a Paolo la sua nomina a Capitano del Comune di Firenze. Frattanto vien recato svenuto Malatestino, gravemente ferito a un occhio; ma come ritorna in sè, il feroce giovinetto si fa bendare e corre di nuovo al combattimento.
Atto 3° - Camera di Francesca in casa dei Malatesti. - È calendimarzo. Paolo è tornato anzitempo, non resistendo alla lontananza da Francesca. La schiava Smaragdi lo introduce presso Francesca, alla quale Paolo svela il proprio tormento. Francesca tenta invano di sviarne il discorso. Su un leggio Paolo vede il Romanzo di Lancillotto; incomincia a leggerlo e fa continuare la lettura a Francesco. Come giunge al bacio che Ginevra dà al Cavaliere, Paolo si china a baciarla ed essa gli si abbandona fra le braccia.
Atto 4° - Parte 1a - Sala ottagona in casa dei Malatesti. - Malatestino è invaghito di Francesca, e le propone di avvelenare Gianciotto; ma poichè essa lo respinge con orrore, Malatestino mostra di essere al corrente della sua tresca con Paolo e vagamente la minaccia. Incontratosi poi con Gianciotto, per vendicarsi di Francesca denunzia il tradimento di questa col fratello, e gli promette di farglieli scoprire insieme le notte medesima.
Parte 2a - Camera come nell'atto 3°. - Gianciotto ha finto di partire per Pesaro, e Francesca fa entrare Paolo nella propria stanza. Ma Gianciotto improvvisamente ritorna, li sorprende e li uccide.
L'uso frequentissimo di armonie minori e diminuite delle quali Zandonai fa uso, crea attorno ai personaggi della tragedia dannunziana, e specialmente attorno ai due protagonisti, un'atmosfera di languore mortale e di sensuale malinconia che rende quasi fatale la colpa. È stato notato che nella tragedia di D'Annunzio i due cognati scivolano nell'adulterio senza lotta interiore; innamorati l'uno dell'altro fino dal primo vedersi, si direbbe che cerchino di proposito ogni occasione per cadere. Zandonai, abbiaano sentito questo lato debole, circonda i due amanti di una malìa suggestiva di suoni che si leva dalle situazioni e dall'ambiente per agire su la volontà di Paolo e di Francesca e paralizzarne ogni resistenza. La prima volta è con la trovata della «viola pomposa» e del piffero che cantano la primavera nel momento in cui Paolo arriva alla casa dei Polentani e Francesca gli dà una rosa.
Ora, i due motivi principali di questo canto strumentale, unitamente a un breve tema che più strettamente si riferisce a Paolo, e che sorge spontaneamente dalla intonazione commossa con cui Francesca pronuncia questo nome, intonazione piena di abbandono e di sogno, perseguiteranno come un insistente assillo la donna, specialmente nel 3° atto prima del bacio. Sono i motivi-atmosfera, i motivi-suggestione che avviluppano come una vampa Francesca e la sospingono senza scampo verso l'adulterio. La fresca ballata di calendimarzo (dallo spunto stranamente simile a quello del valzer dei minatori nella Fanciulla del West di Puccini) con i richiami primaverili del piffero, rinnova nell'aria il fascino d'amore che continua la sua suggestione anche quando Francesca è rimasta sola, in un breve interludio carico di un alito d'incantesimo che prepara alla caduta finale.
Ed anche le gravi risposte di Smaragdi nelle note basse alle domande di Francesca su lo sparviero ruggito: «Dama, non toma!», e la promessa di fattuccheria: «O dama, non ti disperare», in cui trabocca un senso di allettante e paurosa magìa nella voce oscura del canto e nel mistero del disegno melodico e delle armonie, contribuiscono a rendere più affocata quest'atmosfera dove l'anima di Francesca respira l'amore e si perde senza speranza di salvezza. Il duetto successivo tra Francesca e Paolo si svolge tutto sotto questa specie di incantamento e di malìa alla quale i due amanti non sfuggiranno. Ed ecco allora riaffiorare nel momento del bacio la melodia della viola pomposa e di lontano rispondere le voci del coro femminile, quasi voci della natura: «Primavera 1».
Ma già nel 2° atto Zandonai approfitta dell'episodio della battaglia col suo rombo veemente, con le urla dei combattenti, con le fiamme degli incendi, per creare musicalmente attorno agli amanti un incendio rovente in cui la loro passione avvampa incontenibile. Tutto questo non è di D'Annunzio ma di Zandonai, ed è commento di una sensibilità profonda, ricco di una poesia che solo la musica può creare attorno alla poesia letteraria, perchè essa sola può rivelare l'al di là delle parole, le forze arcane che conducono alla fatalità dei nostri atti. Zandonai arriva a questo risultato con la semplicità di un fraseggiato che, pure essendo sempre largamente melodico, non cessa per questo di essere vero ed efficace. Così in quest'opera la tradizione del canto italiano si fonde intimamente al commento sinfonico, nel quale passano temi che scolpiscono con immediatezza i personaggi principali.
Se Francesca è presa da una trepidante ansia d'amore fino dal suo primo dialogo con Samaritana, Paolo vive in un ardore febbrile di vertigine. Gianciotto è invece tutto in quel suo breve tema rude e zoppicante, come Malatestino nei duri accordi martellati, e nei biechi raggiri del canto. Le due scene del 4° atto con Francesca prima, e con Gianciotto poi, mettono a nudo con grande forza tragica quest'anima perfida e violenta, accanto alla quale anche il rozzo ma leale Gianciotto, che ama veramente la sposa (si noti la bellissima frase del 2° atto; «È dolce cosa rivedere la vostra faccia», piena di una così forte e sincera tenerezza), si accende della sinistra luce di furore geloso che nel suo animo proietta il triste guercio. Un ritmo affannoso ora cupamente soffocato, ora stridente di rabbia, domina tutta questa parte prima del 4° atto con un senso di tragedia imminente, alla quale accrescono orrore gli urli del Montagna, che Malatestino va ad assassinare. La seconda parte è immersa in un'ombra di malinconia languente e in uno spasimo di desiderio che sa già di agonia, e che prepara alla rapida conclusione, in cui i temi di Gianciotto e di Paolo si intrecciano con tragica concitazione.
ALBERTO FRANCHETTI - NOTTE DI LEGGENDA - Tragedia lirica in un atto. Prima rappresentazione alla Scala di Milano nel gennaio 1915. Libretto di Gioacchino Forzano. L'azione si svolge sul Mugello ai primi del 1600.
Atto unico. - Sala terrena del castello Aldovrandi. - Un vecchio uomo d'armi, Neri, racconta ai paggi del castello come il Conte Aldovrandi una notte scoprì la propria sposa con un amante e l'uccise. Vuole la leggenda che nel giorno della prima neve lo spettro dell'uccisa ricompaia a recare morte, soffocando l'amore di un'altra Aldovrandi. La prima neve è caduta, e lo spettro, dice Neri, è ricomparso. Vanna, la giovane figlia del Conte, conosce la leggenda e ne è terrorizzata; ma il padre non può tranquillizzarla: egli sa che due volte lo spettro ha soffocato nella morte l'amore di due Aldovrandi. Vanna gli confessa che ama, ma il padre non riesce a farle dire chi è. Fuori i contadini cantano festeggiando la prima neve. Il Conte, per allontanare da sè e dalla casa il terrore della leggenda atroce, fa dare una festa. Il principe Gualberto Vismundi giunge con musici, travestito da giullare. Egli ama Vanna e fu prima da lei amato; ma ora essa lo respinge. Il conte confida al creduto giullare che Vanna ama, e lo incita a scoprire chi sia, affidando a Neri l'incarico di ucciderlo. Egli pensa che troncando con la violenza l'amore di Vanna la salverà dalla morte.
Rimasta sola, Vanna fa entrare l'innamorato, Gilfredo dei Vaschi, da una porta segreta, e decide di fuggire con lui quella stessa notte. Il sopravvenire del padre col finto giullare e con Neri costringe Gilfredo ad allontanarsi. Ma Gualberto, seguendo le tracce d'una rosa sfogliata, scopre l'uscio segreto pel quale Gilfredo è fuggito, e con Neri si precipita ad inseguirlo, però invano. Tuttavia un guanto con uno stemma, trovato da Gualberto gli permette di riconoscere l'amante di Vanna. Giungono intanto alla festa invitati, i quali evocano ridendo e cantando la tregenda degli spettri. La luna illumina uno spettrale abete; Gualberto chiede al Conte il permesso di farlo abbattere. La leggenda dice che chi gli darà il primo colpo ne farà la propria bara, ma Gualberto ne ride e vuol essere proprio lui a dare il primo colpo d'accetta. Ritornato in sala, mentre i contadini continuano l'opera di abbattimento iniziata da Gualberto, si incontra con Vanna. Cerca di ridestare in lei l'antico amore, e la invita a fuggire con lui. Alle sue ripulse l'avverte che denunziò a suo padre il nome dell'amante, e la minaccia di mostrargli le lettere ardenti ch'ella scrisse a lui, Gualberto, al tempo del loro amore. Vanna allora finge di assecondarlo per strappargli di mano le lettere. Riuscito vano il tentativo, stacca dalla parete una pistola e lo colpisce. Si affaccia alla finestra per chiamare Gilfredo, e vede che è stato ucciso. In questo momento suona mezzanotte e l'albero crolla: Gualberto muore, Vanna impazzisce.
C'è, malgrado l'uso frequente delle scale e delle modulazioni cromatiche, intese a colorire l'elemento spettrale, una certa semplicità di canto e di struttura sinfonica, maggiore che in altre opere del Franchetti, ed evidentemente intesa a chiarire e a dare impressioni più immediate agli uditori. Tendenza a porre il canto in un piano uguale e talvolta superiore a quello sinfonico. Qua e là la solita difficoltà di trovare il motivo che si svolga naturalmente, soprattutto per voler tener fermo il basso modulando le armonie, o per rapide modulazioni a toni lontani che turbano la spontaneità del canto. Ottima la melodia della «leggenda»: «Come è sereno il ciel», ripresa poi largamente da Vanna nell'aria: «Paggi, cantate il canto di sventura» con un senso di amarezza fatale e quasi magica. Buoni anche gli spunti di ballate, così frequenti nell'opera, ad andamento popolaresco, come, ad esempio, il racconto di Neri: «Tutte un baglior d'argento». Delicatamente ispirata la berceuse del Conte (ripresa poi dalla figlia): «Dormi, dormi». Indovinata per il colore biecamente giocoso la canzone di Gualberto: «Madonna conosce la mia valentia!», con disegni e terzine cromatiche che ricordano le donne-fiori del Parsifal. Spontanea e felice la canzone di Gilfredo: «Se sceso è già del gelo il bianco manto». Il duetto Vanna-Gilfredo tra varie alternative stentate trova un accento finalmente caldo e appassionato nella frase di Vanna: «Prendi tutto il mio cuor, l'anima mia», che forma il nucleo del duetto, ma perde un po' della primitiva espansività fra le tormentate modulazioni e progressioni tristaneggianti, senza una conclusione; anzi la linea è troncata alla domanda di Gilfredo: «Chi minaccia?». Qualche ballata ha un carattere grottesco diabolico che si riallaccia a quello del 1° atto di Asrael.
L'ultima scena col duetto fra Vanna e Gualberto, in cui riappaiono in nuova elaborazione alcuni dei più appassionati e felici motivi dell'opera, con lo sfondo del canto interno di Gilfredo e dei cori, è una delle costruzioni in cui Franchetti mostra la sua consueta perizia, e chiude efficacemente l'opera.
ILDEBRANDO PIZZETTI (Parma 1880) - FEDRA: tragedia in 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 20 marzo 1915. Poema di Gabriele D'Annunzio.
Atto 1° - Atrio nel palazzo di Pitteo a Trezène. - Le madri dei sette eroi atterrati su le porte di Tebe piangono i loro figli. È con loro Etra, la madre di Tèseo. L'arrivo di una nave con le vele nere fa. temere che anche Tèseo sia morto, ma Fedra rampogna le piangenti: Tèseo vive. Eurìto d'Ìlaco con la notizia della vittoria di Tèseo reca le ceneri dei sette caduti. Egli porta doni per Ippolito da parte del Re Adrasto: un cratere d'argento, un cavallo, una schiava tebana: Ipponòe. Fedra, arsa da un torbido amore pel figliastro, avvampa d'ira contro la schiava. Dopo avere imprecato orrendamente contro Afrodite, interroga sul futuro Ipponòe, avendo saputo dal Messo ch'ella è indovina. Ma poichè il suo è vaticinio di morte, accecata dalla gelosia la trafigge.
Atto 2° - Il peristilio che precede la dimora delle donne. - Ippolito entra dove le donne lavorano e dove Fedra giace cupa ed insonne. Egli ha rincorso il cavallo Arione, donatogli da Adrasto, insofferente del morso. È stanco di cacce, vuole navi e schiere per combattere, e vuole la bellissima Elena, figlia di Leda e del Cigno, promessagli dal padre per consolarlo della perdita della schiava uccisa da Fedra. Le donne sono uscite, e Ippolito è rimasto, rapito nel suo sogno; Fedra coglie questo istante per baciarlo su la bocca. Ippolito ritorna in sè, e pieno d'orrore leva la scure contro Fedra, ma tosto la depone e fugge mentre entra Tèseo. Fedra, allora, folle di passione e d'ira, narra allo sposo che Ippolito le usò violenza. Tèseo, sdegnato, prega il Dio Poseidone che «innanzi sera egli discenda all' Ombre!».
Atto 3° - Selvaggio anfratto nella marina di Limna. - Il coro piange Ippolito, vittima del cavallo indomito che lo precipitò contro un macigno e ne fece scempio coi denti. Eurìto d'Ìlaco narra la scena atroce cui assistette impotente, ma Tèseo si accusa di avere ucciso Ippolito col voto alzato a Poseidone. Sopraggiunge Fedra la quale proclama la purità di Ippolito, confessa di averlo incolpato innocente e cade spenta da un veleno dianzi bevuto, presso il cadavere del giovane.
Con la Fedra Pizzetti si accingeva ad attuare una riforma dell'opera staccandosi dalla tradizione operistica sette-ottocentesca per riallacciarsi all'indirizzo della Camerata fiorentina. La musica deve nascere dalla parola, cioè deve esteriorizzare il sentimento da cui la parola stessa sorge. Ma questa esteriorizzazione non deve avvenire attraverso al canto melodico, il quale per la sua stessa natura rallenta o arresta il movimento del dramma. Essa è affidata all'orchestra che è la vera creatrice del dramma a cui le parole ritmate e sonorizzate dànno un significato logico.
Mettiamo in chiaro subito che, a parer nostro, quando un musicista compone un'opera in musica egli non deve integrare la poesia, ma darci una creazione nuova, musicale, in cui la poesia sia assorbita, trasfigurata in canto e per così dire annullata. La Camerata fiorentina voleva invece tutt'altro: essa dava vita a un doppione in cui la musica serviva a esaltare la parola declamata, in cui la musica diveniva ancella della poesia. Creava così un'opera letteraria con commento o, al più, con un'atmosfera musicale, obbedendo ad un concetto di Platone, il quale aveva insegnato che la parola viene prima e il suono poi. Opera, dunque, squisitamente letteraria, e solo secondariamente musicale. È questo un preconcetto archeologico dei Cameratisti, pei quali il canto (chiamiamolo così) non ha più valore per sè stante, ma solo unito alla parola. Così nella Fedra non c'è più una frase del canto che si possa vocalizzare melodicamente; non ci sono che parole e frasi intonate musicalmente.
A questo principio va unito l'altro pizzettiano, che nulla deve rallentare, turbare o arrestare il corso, o meglio la corsa del dramma. Niente, quindi, effusioni liriche vocali, «arie» e simili, niente elementi statici. Nella Fedra, infatti, le effusioni sono ridotte a qualche brevissima frase sfuggente; la drammaticità preme e incalza di continuo. Il sistema però, applicato nel canto troppo rigidamente, conduce talvolta a risultati opposti a quelli desiderati, per l'uniformità delle formule recitative che per voler lasciare emergere la parola rinunziano a qualunque afflato lirico e rilievo drammatico. E poichè l'espressione musicale del dramma è scesa dal palcoscenico nell'orchestra, a questa si volge necessariamente il maggior interesse dell'uditore il quale così finisce per trascurare proprio quella parola su la quale il compositore voleva attirare principalmente l'attenzione. Questo è forse il più sensibile inconveniente del sistema pizzettiano.
Strano che, volendo perseguire un tale indirizzo, il musicista abbia scelta una tragedia di D'Annunzio nella quale (per quanto ridotta di mole) la verbosità ingombrante, la pletora lagorroica, creano stasi paludose e inceppamenti ad ogni passo all'azione drammatica; strano soprattutto perchè il temperamento asciutto e antirettorico del Pizzetti avrebbe dovuto portarlo al polo opposto del dannunzianismo. I personaggi frenetici, specialmente quello eroticamente morboso di Fedra, potevano indurre il musicista ad una involontaria imitazione dello stile straussiano, fargli fare della Fedra una specie di Salomé, e di Ippolito un epigone di Jokanaan. Per fortuna la forte personalità di Pizzetti lo ha salvato dal pericolo. C'è nella musica di questa Fedra quanto basta per caratterizzare la passione sensuale, lo spasimo e la febbre voluttuosa della Pasifaea, peso di un'eredità di folle lussuria e di criminale demenza, la morbosa tragicità dell'atmosfera e il casto orrore d'Ippolito» senza cadere nei parossismi vorticosi delle sonorità orchestrali di Strauss. C'è invece talvolta qua e là il colore impressionistico debussyano, e, più sensibile ancora, il cromatismo languido, tristaneggiante, di Wagner, specialmente nella scena del bacio al 2° atto, che ciò non ostante è una delle più suggestive ed efficaci.
Lo scarno linguaggio vocale è illuminato da un ricco ma trasparente tessuto polifonico orchestrale, in cui i temi non rappresentano, secondo quanto avviene pei grund-motiv wagneriani, cose. persone e particolari stati d'animo. Essi sono concepiti essenzialmente come espressione di sentimenti elementari, e destinati, mediante i loro innumerevoli sviluppi sinfonici, a creare l'atmosfera musicale in cui vive l'azione. Questi temi sono brevi cellule che si ripercuotono con insistenza, formando col loro susseguirsi e intersecarsi l'ordito sinfonico espressivo, tinto di volta in volta dei colori che l'orchestra getta su di essi. Alcuni dei principali si odono già nel preludio del 1° atto; chiamiamoli, per intenderci, con un nome: «tema dell'amore di Fedra», «tema persecutorio d'Afrodite», «tema del lamento delle Supplici». I modi greci, usati dal Pizzetti, non tanto perchè il soggetto dell'opera sia greco, quanto per ottenere una maggiore varietà nelle armonie e nei disegni melodici, conferiscono allo stile un sapore arcaico che allontana da noi nel tempo la leggenda tragica in un mondo primitivo ed eroico.
Sopra questi schemi si svolge la musica pizzettiana della Fedra, che acquista vita di atto in atto. Già fortemente incisiva nel 2° atto, austeramente dolente nella costruzione puramente vocale della trenodìa per Ippolito, di un dolore che ha qualche cosa di statuario, tanto è calmo e senza atteggiamenti sentimentali, l'espressione della musica cresce di intensità drammatica durante il concitato racconto dell'Auriga, i cui ritmi sembrano scandire i passi grevi della Morte che avanza inesorabile. Culmina alfine di orrore tragico nella scena della rivelazione della menzogna e nella morte orgogliosa di Fedra.
Notevole poi è dovunque il disinteresse per qualsiasi episodio, descrittivo che poteva portare il compositore su le vie di un malinteso verismo. Questo evitare ogni materialità, perfino nell'ebbrezza dei sensi e nella violenza degli atteggiamenti tragici, alza la musica in una sfera superiore a quella della consueta bassa passionalità umana, dandole un'impronta di alata religiosità.
PIETRO MASCAGNI - LODOLETTA: dramma lirico in 3 atti. Prima rappresentazione al Costanzi di Roma il 30 aprile 1917. Libretto di Gioacchmo Forzano, dal romanzo «I due zoccoletti»di Ouida (pseudonimo di Luisa De la Ramé). L'azione si svolge nel 1853.
Atto 1° - A destra la capanna di Lodoletta, dietro la quale è un pesco fiorito, in un villaggio olandese. A sinistra una fila di casette; in un tabernacolo del muro di cinta m è una tavoletta su cui è dipinta una Madonna. - È primavera; il giorno compleanno di Lodoletta. Il vecchio Antonio, chel'ha raccolta «in m cestin di fiori», sta insegnando a dei bimbi a cantarle una «Serenata delle Fate». Ma la prova è interrotta dall'arrivo dell'esule pittore francese Flammen. Egli osserva la Madonna e dà ad Antonio una moneta d'oro affinchè gliela presti per copiarla; verrà a ritirarla più tardi. Antonio con quel denaro corre al paese a comperare due zoccoletti rossi da regalare a Lodoletta. Intanto giunge Lodoletta, festeggiata da tutte le amiche e dai bimbi che cantano la «Serenata». Torna anche Antonio che regala a Lodoletta gli zoccoletti, indi sale sul pesco per staccarne ramicelli fioriti.; ma un ramo cede, e Antonio cade rimanendo tramortito. È portato all'ospedale dove si constata che è morto. Flammen, tornando a sera per prendere la Madonna, trova Lodoletta sola e piangente e la consola, lasciandola poi assopita dal dolore e dalla stanchezza.
Atto 2° - La stessa scena del 1° atto. - È novembre. Flammen finisce un quadro in cui ha preso a modella Lodoletta. La permanenza del pittore nel villaggio e la sua intimità con Lodoletta hanno fatto diffondere malignità sul conto di lei, e le comari non permettono più che i loro bimbi la frequentino. Anche il buon Giannotto, che l'ama inutilmente, la rimprovera con dolcezza. Quand'ecco, Flammen riceve la notizia della sua grazia. Ora egli si accorge di amare Lodoletta, e vorrebbe rimanere con lei, ma Lodoletta sente il pericolo del disonore, e lo costringe a partire.
Atto 3° - A sinistra la villa di Flammen a Parigi; dinnanzi il giardino. - È l'ultima notte dell'anno: le finestre della villa sono illuminate. Flammen ha invitato amici e donne per una festa; ma l'amore per Lodoletta è come una spina nel suo cuore. Un suo amico torno in Olanda per cercarla, ma essa era partita. Ed ecco infatti che essa giunge in cerca di lui, lacera, assiderata, affranta. Vedendolo attraverso le finestre insieme ad altre donne, il suo cuore non regge. Flammen uscendo inciampa nei suoi zoccoletti, riconosce il cadavere di lei, e disperato se la stringe al cuore invocandola.
Composta nel 1913, su poema drammatico di D'Annunzio, PARISINA, opera di grande mole e di alte aspirazioni. Mascagni ritorna con Lodoletta alla semplicità delle sue opere migliori. Nocquero a Parisina la verbosità dannunziana, per colpa della quale l'opera diventò enormemente prolissa, e l'esasperata psicologia di Ugo, che trascinò il compositore verso l'urlo enfatico. Inoltre la suggestione di D'Annunzio ha condotto il musicista a smarrire spesso la propria personalità nelle maglie pesanti del tessuto sinfonico e del cromatismo wagneriani.
Tuttavia, dove il Maestro riesce a liberare la propria vena canora dalle influenze esteriori, allora ci dà pagine di grande respiro. Tali sono ad esempio, il lamento della Verde: «Ohimè grido il mattino», il coro delle fanti: «Sapete perchè grido guerra guerra?», e l'altro: «Che foco è questo ch'arde e non consuma?», entrambi imbevuti di una malinconia poetica soave e nostalgica; il tenero canto di Stella: «Ugo, figlio mio dolce», l'arrivo dei cacciatori, col coro villereccio: «Non dormite, o cacciatore», le preghiere del 2° atto, coi richiami e gli squilli di buccine lontani, l'angoscioso monologo di Parisina: «Commessa fu la mia colpa», e soprattutto la scena in cui Nicolò cerca e scopre Ugo nella stanza di Parisina, tutta pervasa da un soffio tragico vigorosissimo. Cosicchè vien fatto di pensare che una vasta e intelligente potatura (Mascagni aveva già praticato ampi tagli, fra cui tutto l'ultimo atto, perfettamente superfluo, ma non bastano) potrebbe concentrare utilmente l'azione all'essenziale e darci un'opera vitale.
LODOLETTA è opera di tutt'altro tipo. Il soggetto lieve (in qualche momento - specie nel 2° atto - anche troppo) porta il Maestro a diradare la trama orchestrale, a rinunziare quasi sempre all'enfasi, a dipingere con tinte chiare e trasparenti, ad abbandonarsi ad un'ispirazione candida, quasi idillica, lineare spesso anche nei momenti più tragici. I caratteri non sono molto rilevati, ma le situazioni e l'ambiente trovano nella musica una realizzazione adeguata. La levità della struttura si avverte fino dall'inizio nella graziosa descrizione del gioco dei bimbi, ma che dà un senso di vuoto all'entrata di Flammen con l'amico Franz e alla inutile nenia della Pazza. Il tono si alza alla gentile «Serenata delle Fate», e dopo la caduta di Antonio dal pesco trova disegni e colori che esprimono con efficacia lo sgomento e lo smarrimento dei presenti. Indi, mentre Antonio vien trasportato all'ospedale, una melodia larga e mesta (forse troppo ripetuta) si svolge a modo di trenodìa, appena punteggiata dai pizzicati dei bassi. Nel successivo duetto tra Flammen e Lodoletta che chiude il 1° atto, le ingenue e infantili domande di lei, le fiabesche risposte di Flammen, fino all'assopimento di Lodoletta, rievocano la più delicata musa idillica di Mascagni.
Nel 2° atto l'azione fiacca ha snervato anche l'ispirazione del musicista. Ma qualcosa di fresco ne ha toccato la fantasia: una immagine gentile: «Ah I se fossi una vera lodoletta»; e la musica ha volato leggera verso la finestra della stanza ove sogna Flammen. Più forte ancora è stato lo stimolo determinato dalle olandesine che portano il latte nell'alba di novembre grigia e mesta, mentre le campane di San Guido le richiamano vivacemente al lavoro. E il quadretto è balzato con una scioltezza franca, pieno di suoni aerei di campane e di agili disegni sottolineanti il verso: «vola con la brezza mattutina, l'ala al pie'». Un altro momento commosso si ha allorchè i bimbi ammirano il ritratto di Lodoletta.
Il 3° atto è bello tutto: la festa in casa del pittore con amici bohèmiens e donnine allegre ha avuto un'espressione ricca di colori strumentali accesi, di ritmi ora languidi ora scapigliati, di canzoni nostalgiche ed anche sguaiate, cui si alterna uno slanciato movimento di valzer. Il quadro è indubbiamente di una efficace e realistica vivacità. Segue un debole duetto, debole per colpa dell'amico Fritz che è la figura più stupida del libretto, cosi stupida che non ha saputo destare neppure un po' di interesse comico nel musicista. Ma la romanza di Flammen: «Ah! ritrovarla nella sua. capanna» ci reca una delle più sentite effusioni liriche mascagnane. Su un lungo pedale di re corre una intensa onda di malinconia dolorante che stringe il cuore.
L'arrivo, la breve agonia e la morte di Lodoletta ci portano verso i modi espressivi del canto di Iris, ma sono modi spontanei, personali, e pieni di una forte emozione lirica. La gioia per aver ritrovato la casa di Flammen è appena illuminata da un pallido sorriso, soffocata, com'è dallo sfinimento della fanciulla per il lungo cammino pieno di stenti; e pur tuttavia si espande nell'appassionato canto: «Flammen, perdonami!». Ma dopo che Lodoletta ha visto Flammen in mezzo all'orgia, un senso di freddo e di stanchezza disperata piove dalla musica con un'espressione di rassegnato dolore, con un'impressione di affievolimento della vita, la quale si estingue su funerei e fiochi rintocchi di campana. Il realismo si trasfigura in poesia; la ricomparsa dei motivi dell'orgia e poscia la disperazione di Flammen chiudono l'opera con uno scorcio tragico efficace per la sua rapidità.
FERRUCCIO BUSONI (Empoli 1866 - Berlino 1924). - TURANDOT: favola chinese in 2 atti. Prima rappresentazione al Teatro Municipale di Zurigo l'11 maggio 1917. Testo dello stesso Busoni, tratto dall'omonima commedia di Carlo Gozzi.
Atto 1° - Quadro 1° - Davanti alla reggia di Altoum. - La principessa Turandot, figlia di Re Altoum, ha deliberato di non sposare se non colui che saprà sciogliere tre enigmi da lei proposti. A colui che fallisce la prova sarà tagliata la testa. Il principe di Samarcanda non vi è riuscito e, come i sei che lo precedettero, viene ucciso. La madre del principe sdegnata getta a terra e calpesta il ritratto di Turandot. Il principe Kalaf lo raccoglie e tosto si innamora della principessa. Sordo ai consigli del fedele Barak, entra nel palazzo reale deciso a tentare la sorte. Barak che vorrebbe seguirlo mene fermato dalle guardie e bastonato.
Quadro 2° - Sala del trono nel palazzo reale. - Truffaldino, capo degli Eunuchi, mentre fa preparare la sala per la nuova gara, loda il proprio stato che gli evita i peggiori guai. Entra la Corte e il Re Altoum accompagnato dai ministri Pantalone e Tartaglia. Kalaf non vuol rivelare il proprio nome e rifiuta il consiglio del Re di rinunziare alla gara. Alla vista di Kalaf, Turandot prova un turbamento arcano, ma facendo forza alla propria emozione, propone gli enigmi, che Kalaf spiega esattamente. Vinta, Turandot tenta di uccidersi, ma ne è impedita. Kalaf allora propone alla principessa di dirle il proprio nome: se lo indovina sarà libera ed egli partirà.
Atto 2° - Quadro 1° - La stanza di Turandot. - La principessa lotta tra l'ira per l'essere stata vinta e il nascente amore per Kalaf. Truffaldino, ch'era stato incaricato di ricercare il nome dell'ignoto, confessa che, nonostante l'uso di un'erba magica, non riuscì a saperlo. Altoum reca a Turandot la notizia che egli conosce il nome del principe; ma di fronte alla sprezzante superbia della figlia, se ne va senza rivelarglielo. Però la schiava Adelma, che, anch'essa figlia di Re, conobbe da giovinetta il principe e ne è segretamente innamorata, volendo vendicarsi di lui perchè un giorno rise del suo amore, ma soprattutto nella speranza di conquistarlo a sè, ne svela il nome a Turandot.
Quadro 2° - Sala del trono. - Davanti al Re suo padre e alla Corte, Turandot dice il nome del principe straniero. Kalaf, vinto, fa per partire, ma Turando! lo richiama, e fra lo stupore e il giubilo di tutti, dichiara di amarlo.
La Turandot di Ferruccio Busoni è, più della omonima opera pucciniana, aderente alla commedia di Carlo Gozzi, e mantiene i personaggi e la loro vicenda entro uno spirito di fiaba, forse con qualche tendenza a un simbolismo ironico un po' manierato; Turandot» caricatura di una femminilità crudele e senza amore; Kalaf, e i principi decapitati che lo precedettero, satira delle innamorature-lampo e della testardaggine che solo per caso (quello di Kalaf) riesce ad essere fortunata; le tre maschere: l'eunuco sciocco (Truffaldino), la prudenza (Pantalone), il cuore (Tartaglia).
A vedere superficialmente la divisione dell'opera in scene, arie, quartetti, ecc., si potrebbe pensare all'uso di vecchi stampi melodrammatici ottocenteschi. In realtà la forma musicale è sciolta e libera, anche se disposta in pezzi chiusi, con una strumentazione brillante ma non pesante. L'armonizzazione denota una sensibilità nuova dei rapporti fra le successioni degli accordi, pure mantenuti su la base della tonalità, per quanto fondata su scale formate da intervalli dissueti. Accordi spesso alterati (per effetto delle medesime scale) in modo ricercato e senza una ragione vera apparente, allo scopo evidente di allontanarsi da quanto può sembrare consueto. Accade così talvolta che tolta la vernice luccicante dello strumentale e la stranezza, e spesso la durezza degli accordi, si veda che sotto non resta nulla o ben poco di consistente. Da ogni nota emerge una volontà precisa di antitradizione e di antisentimentalismo di natura moderatamente polemica, però contenuta, garbata, ed equilibrata da un forte senso della forma. Con Arlecchino la polemica diverrà caustica e astiosa.
La ricerca dell'ironia e del fiabesco, che però non diventa mai smorfia grottesca, e lo scarso senso di umanità, fanno dei personaggi di quest'opera più dei burattini e delle maschere che delle creature vive. Di tanto in tanto, allorchè il linguaggio diviene più realistico o banale, la musica cessa, e i personaggi si esprimono solamente parlando. L'antiromanticismo, dell'autore si traduce non solo in antisentimentalismo, ma in una diffusa assenza di passione, di calore, di abbandono e di rapimento. Talvolta, anche, c'è troppo distacco tra la musica e l'azione, procedendo ciascuna per vie parallele senza raggiungere la necessaria fusione dei due elementi; e perciò la musica tende a divenire più decorativa che psicologica, più musica pura che drammatica. Comunque i personaggi principali sono presentati da motivi che li caratterizzano in modo inconfondibile, così l'altezzosa Turandot come il volitivo Kalaf, l'austero e malinconico AJtoum come il fatuo Truffaldino. Quanto all'ambientazione, il Maestro, malgrado l'uso che in vari momenti fa di alterazioni di sapore orientale della scala, non ci dà nulla che richiami alla mente piuttosto la Cina che un qualsiasi altro paese del mondo.
Pagine più notevoli nel 1° atto sono: la Pantomima e Finale del 1° quadro, pomposi più che grandiosi, con un ritmo potente e minaccioso di timpani acuti, che ritorna più volte nel corso dell'opera, e sempre con significato di minaccia; l'arietta arguta e burattinesca, ma non troppo stecchita, e lieve come uno scherzo strumentale, di Truffaldino; l'entrata solenne di Re Altoum sul motivo di una vecchia canzone turca; l'entrata di Turandot, grave e funerea, intercalata da durezze armoniche e lamenti.
Ma, non ostante le intenzioni ironiche e caricaturali, in qualche momento (per esempio nella scena degli enigmi) Busoni non ha potuto sottrarsi alla drammaticità dominante, perchè, in fondo, Kalaf, sia pure con una testardaggine pazzesca e una cottura fenomenale, gioca la vita! In questa scena degli enigmi sono interessanti i temi bassi è gli accordi cromaticamente striscianti con un senso veramente enigmatico e di smarrimento. La soluzione vittoriosa dell'ultimo enigma porta la musica verso un'espressione cantabile ricca di liricità.
Graziosissimo e lieve il Lied e coro con cui si inizia, a sipario calato, il 2° atto, che reca un senso di festevolezza serena. Le Danze e coro successive con le loro alterazioni tonali, il monotono ripetersi dei ritmi e il languore della melodia e dello strumentale, ci recano il profumo d'oriente. Quindi il Recitativo e Aria di Turandot: «Nel seno il core infuria palpiti» con la sua irrequietezza tonale e il suo agitato movimento esprime efficacemente l'intima lotta della donna tra l'orgoglio e l'amore già nato e non confessato. Anche in questo momento il dramma ha preso l'anima del compositore, cosicchè Turandot cessa per un istante di essere caricatura e simbolo per diventare donna. È una situazione psicologica sfuggita al librettista della Turandot di Puccini, poichè essa avrebbe condotto a una più chiara e convincente soluzione del dramma.
L'Intermezzo misterioso non è che uno sviluppo dell'Aria di Turandot, la quale poco dopo entra su un ritmo di marcia funebre segnato cupamente dai timpani sotto una nenia desolata, del tipo delle nenie africane, intercalata da gemiti del coro. Il funerale del suo orgoglio o quello del suo amore, o una finzione per trarre in inganno su le sue vere intenzioni? È, comunque, una trovata indovinatissima che lascia perplessi su la decisione che la principessa sta per prendere. Ma la conclusione lieta della vicenda e la confessione inattesa (ma non del tutto) dell'amore di Turandot fanno scaturire dalla fantasia del Maestro un disegno popolaresco e fresco di gioia in cui non c'è traccia di enfasi e che ci riporta nel mondo leggero della fiaba ove anche principi e principesse sono creature di sogno e di giuoco infantile.
Alcune delle migliori pagine dell'opera (che in una prima versione era in 3 atti) sono state riunite in Suite per orchestra, e vengono di frequente eseguite in concerti.
GIACOMO PUCCINI - IL TABARRO: tragedia in un atto. Libretto di Giuseppe Adami, da «La Houppelande» di Didier Gold. - SUOR ANGELICA: dramma in un atto. - GIANNI SCHICCHI: opera comica in un atto. Libretti di Gioacchino Forzano. Prima rappresentazione delle tre opere al Metropolitan di New York il 4 dicembre 1918.
IL TABARRO - Un angolo della Senna a Parigi, dov'è ancorato il barcone di padron Michele, - Vari operai stanno caricando merci sul barcone di Michele che deve andare a Rouen. Mentre la giornata sta per finire, Giorgetta, moglie di Michele, offre da bere agli operai, e al suono d'un organetto balla con Luigi, col quale amoreggia segretamente. Rimasta sola un istante con questi, Giorgetta gli dà un appuntamento per la sera. Il segnale ch'egli può venire sarà l'accensione di un fiammifero. Michele sente che la moglie non lo ama più come un tempo; ha il sospetto che lo tradisca; però nulla dice, e solo tenta di risvegliare in lei l'antico sentimento, ma invano. Giorgetta scende nella stiva, mentre Michele rimane sopra coperta meditabondo. Accende la pipa. Vedendo brillare la fiammella. Luigi accorre. Michele lo afferra, lo fa confessare e lo strozza, avvolgendolo poi nel proprio tabarro. Al rumore della rissa Giorgetta accorre: non vede nulla, e presa da paura si accosta a Michele che aprendo il tabarro le fa rotolare ai piedi il cadavere dell'amante.
Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi sono stati concepiti da Puccini come tre quadri di un unico trittico ispirato alla morte: la morte per omicidio nel Tabarro la morte per suicidio in Suor Angelica, la cinica e burlesca truffa alle spalle del morto col Gianni Schicchi.
Il Tabarro è un drammaccio veristico da «Grand Guignol» in cui Puccini ha ancora una volta fuso lo stile impressionistico con il suo innato melodismo dai periodi larghi, cantabili e passionali. L'impressionismo domina nelle prime scene, in cui il musicista descrive il fluire dell'acqua del nume e il movimento dei trasporti, suoni di sirene e d'automobili, via vai, vociare e canzoni di scaricatori. Tutta la prima parte dell'atto si muove in quest'ambientazione impressionistica, nello svariare degli episodi, in verità troppi e non tutti indispensabili a creare l'ambiente, nè tutti ugualmente interessanti e riusciti. Taluno anzi frivolo ed anche puerile, come quello della Frugola con la storia del suo gatto e il sogno della casetta. Ma ve ne sono di graziosissimi: quello, per esempio, dell'organetto stonato; non solo per l'imitazione perfetta del timbro dei vecchi organetti di Barberia, ma per l'umorismo gustosissimo delle stonature che si seguono in modo da far accapponare la pelle. Pieno di poesia anche l'episodio del cantastorie che vende la canzonetta con la storia di Mimì (e Puccini commenta citando il tema della fiorista nella Bohème).
Sono tutte piccole miniature, scenette della vita colte dal vero, ma appena sbozzate e sfumate con mano leggera, fra le quali si insinua lentamente il dramma. Più enfatiche e un po' troppo evidentemente sotto l'influsso di Charpentier, la bravata socialistoide di Luigi e l'esaltazione di Parigi fatta da Giorgetta.
Impressionistico è anche il duetto d'amore fra Luigi e Giorgetta, tutto percorso da un tormento ansioso, accentuato dal palpitare di un tema ostinato del basso, e da un altrettanto insistente motivo del canto. L'uno e l'altro dànno un'espressione febbrile al colloquio furtivo. E la febbre trova sfogo finalmente nella espansione melodica della frase: «E baci senza fine», e nell'altra, cantata anche dai violoncelli: «Io voglio la tua bocca». Ma un canto altrettanto caldo, se pur meno sensuale, è quello di Michele: «Resta vicino a me!», dove l'accumularsi dei pensieri e dei sentimenti è espresso con una specie di cànone fra i violini da una parte e un corno e il clarone dall'altra. Poi, dalla meditazione di Michele: «Nulla, silenzio», è un seguirsi di pagine fortemente drammatiche: le più fortemente drammatiche scritte da Puccini, fino alla cupa tragica conclusione.
SUOR ANGELICA - L'interno di un monastero: la chiesetta e il chiostro. L'azione ha luogo verso la fine del 1600. - Suor Angelica, rimasta orfana di padre e di madre, e affidata, insieme alla sorella, alla tutela della Zia principessa, fu da questa reclusa in un convento per un suo amore illecito dal quale nacque un figlio. Ora la zia, dopo sette anni di duro silenzio, viene a farle sottoscrivere una carta di divisione del patrimonio che si è resa necessaria per l'imminente matrimonio della sorella. Dalla zia. Suor Angelica apprende che suo figlio è morto da due anni. E la vecchia Principessa si allontana senza una parola di pietà per l'infelice, ma anzi avendone ribadita la condanna morale. Il dolore per la morte del bimbo turba la mente di Suor Angelica, che raccolte alcune erbe e fattone un infuso si avvelena. Subito pentita del gesto colpevole compiuto, invoca disperatamente perdono dalla Madonna; ed ecco gli Angeli rispondere dal ciclo al suo appello, e in un nimbo di luce apparire alla morente la Vergine, la quale sospinge verso di lei il suo figlioletto.
La tenue trama di quest'atto vive anch'essa per tutta la prima parte di episodi in cui viene lumeggiato l'ambiente, con mistico fervore, e qua e là anche con rispettoso e delicato umorismo.
La parte mistica è data dall'«Ave Maria» accompagnata da campane e organo, mentre nell'aria gorgheggia un uccellino: poesia gentile della natura e della fede, tratteggiata con dolcezza e serenità. Anche il sole che entra a illuminare la fontana e il giardino del convento è sentito misticamente ed espresso con un motivo pieno di una calma gioia, se pure vellutato da una lieve sensorialità.
Fra gli episodi mistici ed umoristici insieme c'è il mansueto e tenero desiderio di un agnellino espresso da Suor Genoveffa: una melodia idillica, di sapore quasi settecentesco. Poi c'è l'episodietto futile (soppresso) dalle armonie asprigne della vespa che ha punto una suora, e un ultimo episodio nettamente umoristico: il ritorno delle suore cercatrici, con l'imitazione del raglio dell'asino e i commenti della golosetta Suor Dolcina.
Miniato così, più che dipinto, attraverso a tutti questi episodi (forse troppi) l'ambiente, un motivo misterioso ed ansioso ci porta nel vivo del dramma; l'arrivo della Zia Principessa. La musica ne incide l'aspetto con tratti di una severità dura e fredda, a cui fa contrasto la breve frase calda di un'appassionata agitazione, che si ripete insistente come uno spasimo che non ha tregua, e che esprime l'amore e il desiderio di Suor Angelica per il fìglioletto. Le pagine seguenti del monologo di Suor Angelica sono doloranti ed esaltate. Non crediamo che l'interludio, che ripete strumentalmente queste melodie vocali, aggiunga nulla di più all'atmosfera tragica che si è addensata. Ma dal momento in cui Suor Angelica, dopo aver bevuto il veleno, invoca disperatamente il perdono della Vergine, il motivo del figlio col suo impeto spasmodico, il canto interno «Regina Virginum» accompagnato dalle trombe lontane, poi il largo canto già udito prima: «La grazia è discesa dal cielo», ripreso ora su le parole: «O gloriosa virginum», su i vasti arpeggi del piano che sono come ondate di luce, e finalmente il crescendo di sonorità durante il rivelarsi del miracolo, portano la musica in una sfera di sfolgorante esaltazione mistica di grande forza suggestiva.
GIANNI SCHICCHI - La camera da letto di Buoso Donati. L'azione si svolge in Firenze nel 1299. - Attorno al letto dell'estinto Buoso i parenti levano piagnistei caricati, ma soprattutto si preoccupano di trovare il testamento, poichè corre voce che il defunto abbia lasciate tutte le sue considerevoli ricchezze a un convento di frati. Trovato il testamento, i parenti desolati constatano che la voce era vera. Ma il giovane Rinuccio, innamorato di Lauretta, la figlia di Gianni Schicchi, pensa che quest'uomo astutissimo con una sua trovata possa trarli d'impaccio, e lo manda a chiamare. Gianni Schicchi esamina il testamento e, saputo che nessuno ancora conosce la notizia della morte di Buoso, pensa di rifare il testamento fingendosi Buoso. Giunge intanto il dottore; Gianni fa portare altrove il cadavere di Buoso, e postasi nel letto, ne imita la figura e la voce cosicchè il medico non si accorge dell'inganno. I parenti sono esultanti; si manda a chiamare il notaio, al quale Schicchi detta un testamento in cui lascia i beni migliori al suo «devoto e affezionato amico Gianni Schicchi». I parenti non osano scoprire la frode per timore della grave pena a cui la legge condanna chi falsifica testamenti e ai complici. Ma partito il notaio, si leva un coro di proteste e di imprecazioni. Gianni Schicchi però caccia di casa i parenti di Donati, e dichiara di aver compiuta la frode per amore della figlia, la quale, felice, sposerà Rinuccio.
Azione e musica del Gianni Schicchi corrono rapidi con un umorismo aggraziato, alternando il riso e la caricatura alle espansioni sentimentali dei due giovani inamorati. Puccini non era nuovo al genere comico, e macchiette sapide appaiono in ognuna delle opere precedenti. Egli perciò sa con pochi tratti sicuri schizzare figure piene di vita e di spirito. Così avviene che i parenti di Buoso siano rappresentati, pure tra il falso piagnisteo generale, ciascuno con una propria fisonomia musicale inconfondibile. Ma più che isolatamente essi hanno valore come gruppo; in un primo momento per i loro lamenti esagerati, e dopo per l'interesse all'eredità, interesse che si manifesta prima coi prudenti consigli del vecchio Simone, poi con la febbrile ricerca e la lettura avida del testamento e con la reazione di collera e di sdegno contro il morto per la beffa subìta.
La musica segue gli avvenimenti prima con farsesca lamentosità, poi con irritata nervosità, e infine, durante la lettura, con solenne sostenutezza. Un brevissimo spunto burlesco, che appare fino dai primi accenni alle dicerie di Signa, si impone con frequenza e vigoria crescente: è il tema della turlupinatura, dell'eredità lasciata ai frati. E come la diceria appare realtà, l'ira si sfoga dapprima con commenti sommessi, indi con un'esplosione di risa amare, di imprecazioni e di scherni all'indirizzo dei frati su la base di goffe dissonanze. Poi subentra la riflessione, il consiglio di Rinuccio e la sua lirica lode di Firenze, della «gente nova» e di Gianni Schicchi.
Ed ecco il tema del protagonista presentato con ritmica vivacità: un tema «motteggiatore, beffeggiatore»! Schicchi è accolto male e vorrebbe andarsene, ma Lauretta implora, e Puccini le affida la facile e ingenua melodia: «O mio babbino caro». Ora Schicchi studia il testamento, il cui tema saltella malizioso mentre i due amanti cantano con espansività il loro amore e le loro speranze. Il trasporto della salma di Buoso dà luogo a una grottesca marcia funebre; la visita del dottore permette al musicista di disegnare con gusto la macchietta pretensiosa di questo ignorante, commentandola con dei vacui disaccordi fantomatici, non senza qualche tocco buffonescamente veristico. La scena in cui Schicchi spiega come dovrà essere truccato per renderlo irriconoscibile al Notaio dà origine a uno dei più spiritosi e umoristici ariosi dell'opera: «In testa la cappellina!», pieno d'un piglio beffardo che conclude in una cadenza sonoramente pomposa in lode della «matta bizzarria». L'entusiasmo dei parenti è al colmo, e i loro baci e abbracci mentre esclamano «com'e bèllo l'amore fra i parenti!» è commentato con piccante ironia dalle più aspre e ridanciane dissonanze.
Segue la scena del travestimento, che scorre su una musica ormai armoniosamente affettuosa e divertita, dove anche il tema del testamento ricorre come uno spauracchio reso armai innocuo. Viene quindi la raccomandazione di Schicchi sul silenzio, e il ricordo della pena comminata per chi falsa i testamenti, dove la minaccia si trasforma in una canzonetta finemente maliziosa. Ed ecco infine la scena del testamento, su una musica solenne, quasi religiosa, con le interruzioni dei parenti tosto soffocate.
Uscito il Notaio, si scatena la breve tempesta contro Schicchi; il motivo cantato prima: «Com'è bello l'amore fra i parenti» torna in orchestra, aspro e duro, mentre Gianni li scaccia. Non trionfa che l'amore di Rinuccio e Lauretta» il cui motivo raggiunge la massima espansività.
La commedia è finita; Schicchi ora si rivolge recitando al pubblico: ricorda la condanna dantesca, si difende e chiede gli applausi. Il suo motivo scatta brillante e festoso, e chiude l'opera con energica baldanza.
FRANCO ALFANO - LA LEGGENDA DI SAKÙNTALA opera in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro Comunale di Bologna il 10 dicembre 1921. Libretto dello stesso Alfano, tratto dal dramma del poeta indiano Kalidàsa (V sec. dopo Cr.).
Atto 1° - Nella foresta. - Presso il vecchio eremita Kanva, che l'ha raccolta e la protegge, vive Sakuntala, nata dal potente asceta Kaussika e da una ninfa. A caso entra nella foresta per cacciare il giovane Re; egli vede Sakuntala e tosto se ne innamora. Vinta dal fascino incantevole essa gli si dona; e prima di partire il Re le pone in dito un ricco anello.
Atto 2° - Il recinto dell'Eremo. - Non avendo Sakuntala risposto all'appello del Santo Durvasas, che voleva entrare nell'eremo, è da lui maledetta: «Chi ti amò, ora ti oblierà». Poi mitigando la sentenza aggiunge: «Solo un gioiello mostratogli ti potrà salvare». Kanva profetizza la gloria del figlio di Sakuntala, che egli invia, insieme alla madre, alla reggia.
Atto 3° - L'interno della Reggia. - Due asceti guidano Sakuntala alla presenza del Re, ma questi, sotto l'influenza della maledizione di Durvasas, non la riconosce. Sakuntala vorrebbe mostrargli l'anello donatole, e si accorge di averlo perduto. Si allontana perciò disperata. Ma l'anello caduto nel fiume, è stato rinvenuto da un pescatore, e portato al Re gli ridona la memoria. Egli fa richiamare Sakuntala, ma gli viene annunziato che la fanciulla è miracolosamente scomparsa in un nimbo di fuoco. Il Re sviene; allora lo spirito di Sakuntala gli parla del figlio, che gli viene consegnato dagli eremiti.
La leggenda di Sakuntala è opera della piena maturità dell'artista. Se in Resurrezione, che pure contiene pagine bellissime, si nota ancora l'aderenza allo stile delle opere di Puccini e Giordano, e in generale di quella che venne detta su la fine dell'ottocento «la giovane scuola italiana», ne La leggenda di Sakuntala il distacco da essa appare completo e la personalità del Maestro si rivela interamente. Ma chi ascolta quest'opera non deve cercarvi i motivi da orecchiare e da cantare uscendo dal teatro. L'opera intera non vive che per l'incanto delle sue tinte armonico-strumentali, in cui ogni altro elemento si dissolve. Ciò che più affascina nella sua musica è l'intenso colore esotico e leggendario che si rivela attraverso a un'orchestrazione carica di pennellature vive e di disegni sfumati, di ritmi nuovi, di armonie tormentose e tormentate, spesso preziose, e di ornamentazioni splendenti.
Specialmente nei primi due atti la musica crea un paesaggio remoto e sognante, ricco di suggestiva poesia. L'evocazione dell'ambiente è raggiunta già subito nelle prime scene del 1° atto, con un senso di vita contemplativa che felicemente si innesta sui carichi aromi e la lussureggiante vegetazione del paesaggio indiano creato dalla smagliante orchestrazione. Anche se i contorni sono imprecisi e i disegni si disciolgono in un alone sonoro ora delicato per la finezza dei chiaroscuri, ora sgargiante di sfarzo, una sottile malìa si sprigiona dalla musica e ci avvince.
Fra le pagine più notevoli, alle quali l'uditore deve maggiormente prestare attenzione, segnaliamo nel 1° atto l'episodio dell'ape che minaccia Sakuntala, per il vivace impressionismo delle immagini che richiamano il fastidioso ronzìo dell'insetto e la paura della fanciulla; e tutta l'ultima parte del duetto fra il Re e Sakuntala, così carico di languida sensualità nelle armonie evanescenti e morbosamente ricercate.
Nel 2° atto va ricordata l'invocazione di Sakuntala alla nuvola, ove su un perenne oscillare e fluire dell'orchestra lieve e soffice come la stessa nube, triste come il cuore di Sakuntala abbandonata, scorre il canto melodioso di lei con una tenerezza accorata e nostalgica piena di verità, tutta sospiro e sogno, cui aggiungono fascino di poesia le misteriose voci lontane del coro interno. È questa forse la più bella pagina dell'opera. Nel 3° atto il momento in cui il Re si ricorda di Sakuntala è uno dei pochi frammenti di totale abbandono alla schietta liricità vocale.
ADRIANO LUALDI (Larino [Cambobasso] 1887). - LA FIGLIA DEL RE: Tragedia lirica in 3 atti. Prima esecuzione al Teatro Regio di Torino il 23 marzo 1922. Libretto dello stesso Lualdi.
Atto 1° - Nell'India: una vasta spianata presso la città di Kampylia. - Mentre i Kuru e i Pandu si apprestano a solennizzare la vittoria contro i Pancàla, d'improvviso giunge il guerriero Drona, riuscito a liberarsi dai nemici che l'avevano fatto prigioniero. Egli annunzia che i Pancàla si preparano per un ritorno offensivo. Allora Ariuna proclama una legge secondo la quale sarà punito di morte chiunque tenti di dare sepoltura al Re dei nemici estinto. Frattanto una donna nemica è stata presa. La sua bellezza affascina i due Capi, Ariuna e Svarga, pei quali essa danza. Però i due Capi ben presto si dispongono ad un duello mortale per lei. Ariuna nel combattere incespica e cade. Svarga gli è sopra con la clava per finirlo, ma la donna si interpone e lo salva. indi scoppia in pianto risovvenendosi che aveva giurato sulla memoria del padre estinto di uccidere Ariuna. Il combattimento è ripreso, ma viene tosto interrotto dall'annunzio del sopravvenire dei nemici. La donna vien fatta legare da Svarga, che sospetta di lei. Drona la riconosce: è Damara, la figlia del Re Drupada, ucciso in battaglia. Ne avverte Ariuna che, sorpreso, gli dice: «Taci!»,
Atto 2° - Davanti alla tenda di Ariuna. - Svarga e Ariuna giuocano a dadi Damara, che è stata legata a un palo. Ariuna vince, e lo sconfitto Svarga si allontana con ira. Ariuna slega Damara e le dice il suo amore. Essa però ha giurato di ricercare il cadavere del padre e di arderlo sul rogo. Ariuna, combattuto fra la legge da lui proclamata e l'amore per Damara, finisce per acconsentire al desiderio della fanciulla, e si allontana per togliere dal campo le sentinelle. Il sacerdote Tahana sopraggiunge furtivamente per ricordare a Damara che essa ha giurato di uccidere Ariuna. Ella ne annuncierà la morte tracciando nell'aria con una fiaccola due cerchi di fuoco nella notte. Al segnale gli eserciti usciranno da Kampylia e piomberanno sul nemico. Damara, che già ama Ariuna, si corica angosciata sul giaciglio di Ariuna e si addormenta di un sonno pieno di visioni dolorose. Ma al ritorno di Ariuna essa cede all'amore. Tahana, che ha spiato, decide di avvisare Svarga del tradimento.
Atto 3° - Quadro 1° - Il campo di battaglia. - Ariuna e Damara si aggirano fra i cadaveri in cerca della spoglia del Re Drupada. Trovatala, e costruito rapidamente un rogo, viene data alle fiamme. D'improviso sopraggiunge Svarga con guerrieri. Egli fa arrestare Ariuna e Damara come traditori.
Quadro 2° - L'accampamento dei Kuru. - È sera. Ariuna è legato ad un palo. Svarga ha sentenziato ch'egli venga accecato col fuoco; Damara resterà sua schiava. Per grazia estrema Ariuna chiede che Damara danzi ancora per lui un'ultima volta. Damara, avendo compreso dallo sguardo di Ariuna quale è il suo vero desiderio, nel danzare gli si avvicina e lo trafìgge al cuore con uno spillone avvelenato; indi, tracciati nell'aria con una fiaccola due cerchi si trafigge essa pure. Al segnale convenuto gli assediati irrompono fuori delle mura di Kampylia a far strage dei nemici. I due amanti sono ormai uniti nella morte.
La musica è ricca di pathos e di movimento. Ritmi e motivi caratteristici donano frequentemente alla scena un'ambientazione esotica suggestiva. L'orchestra è ricca di colori in un commento che segue passo passo lo svolgersi dell'azione nei suoi episodi lirici e drammatici. Le voci dei personaggi salgono, a seconda che il testo lo richieda, da un recitativo conciso al canto spiegato, con intonazioni di larga effusione o di robusta forza. Malgrado la densità e varietà della struttura orchestrale, il peso glorioso di tutta una tradizione d'arte ha impedito all'autore pericolose evasioni in campi considerati quali mète del novecentismo. Solo per descrivere in qualche momento, come nel combattimento fra Svarga e Ariuna (atto 1°), la barbarie, la violenza, l'odio che prorompe dall'animo selvaggio di Svarga, la musica accetta dalla tecnica del secolo disegni e armonie aspramente dissonanti.
L'ampliamento e approfondimento dei mezzi espressivi non ha preso la mano all'ispirazione nè ha sopraffatto la vocalità, che si sposa con uguale interesse allo strumentale. Vocalità e strumentale la cui sintesi è sentita con originalità di visione personale. Adriano Lualdi lascia dormire in quest'opera il suo innato umorismo satirico, dal quale nacquero altre opere sue, per aderire al sentimento tragico del soggetto da lui ideato e scritto, così ricco di umanità e di interesse, svolto con dialogo serrato, dove gli episodi nascono naturalmente dagli avvenimenti stessi senza, diluire l'azione.
L'opera presenta una quindicina di temi, che riappaiono ora interi, ora a frammenti, in variazioni armoniche e ritmiche adeguate al momento della loro ricomparsa. Essi creano uno sfondo psicologico unitario nel dramma, e costituiscono come i pilastri di una solida costruzione architettonica. Fra i principali segnaliamo il tema che ricorda il Re Drupada, e l'altro che simboleggia il proposito dei sudditi e della figlia di bruciarne il cadavere. Un altro tema coi suoi rudi scatti discendenti esprime la brutalità di Svarga; un quarto sottolinea la condanna a morte proclamata da Ariuna per chiunque darà alle fiamme la salma del Re vinto. Damara ha un suo tema ritmicamente balzante che sottolinea la sua abilità di danzatrice. Allorchè viene nominato Agni, dio del fuoco, un tema sventolante appare in orchestra, e riapparirà quando si parlerà delle fiamme del rogo o della fiaccola con cui Damara compie la danza finale tracciando nel cielo notturno i cerchi di fuoco, segnale ai suoi di riscossa. Poi ci sono i temi languidi o appassionati dell'amore di Damara e di Ariuna. Il tessuto sinfonico in cui questi temi si alternano o si intrecciano non ha però nulla di wagneriano, sia per il diverso senso armonico, sia per il carattere dei medesimi temi, i quali dell'incisività eroica o dell'incantato misticismo di Wagner non hanno proprio nulla. Essi hanno più che altro impronta impressionistica o realisticamente affettiva. Sul commento sinfonico i recitativi vocali hanno un andamento del tutto personale, ora con tendenza ai melismi di intonazione orientale, ora scattanti in adesione ai sentimenti espressi dalle parole.
Fra le pagine migliori dell'opera ricordiamo la danza-canzone di Damara nel 1° atto: «O tu, Notte, discendi», carica di profumo esotico e di intenso languore sensuale, e la fremente danza della fiaccola nel 3° atto, minacciosa, e alla fine sconvolta da una frenesia disperata.
Il 2° atto è il più bello, il meglio costruito dell'opera. Se, per seguire l'azione, che si svolge rapida e varia nel 1° e nel 3° atto, la musica è costretta talvolta a frantumare la linea e a disperdersi in episodi particolari, nel 2° atto tutto è architettato secondo disegni ampi e con un senso arioso della forma. Alla scena del giuoco dei dadi, dal movimento febbrile, segue il primo drammatico duetto fra Damara e Ariuna, col racconto del giuramento che Damara ha fatto, di dare alle fiamme il cadavere paterno, e la sua pressione per vincere la resistenza di Ariuna, tutto percorso da un sentimento di fatalità e da un'agitazione convulsa. Poi è la scena con Tahana, in cui la durezza austera del sacerdote cozza con la passione della donna che lotta tra l'amore e il dovere. Tra questa scena e l'ultimo tenero e appassionato duetto Ariuna-Damara vi è poi, non vacuo riempitivo, ma integrazione necessaria, l'«Interludio del sogno», intessuto sui temi più dolci dell'amore e i più dolorosi dell'angoscia, elaborato con uno strumentale pieno di colori e chiaroscuri suggestivi.
Questo Interludio e la danza del 3° atto vengono eseguiti anche, come pezzi staccati, in concerti.
IGOR STRAWINSKY (Oranienbaum [Pietroburgo] 1882) - MAVRA: opera buffa in un atto. Prima rappresentazione all'Opéra di Parigi il 3 giugno 1922. Libretto di Boris Kochno, tratto dalla novella di Alessandro Puschkin: «La piccola casa di Kolomna».
Atto unico - Stanza. - Dopo un duetto d'amore fra Paraska e l'Ussero Vassili, questi se ne va, e la madre rientra. Essa manda la figlia a chiedere ai vicini se sanno indicarle una serva a buon mercato. Poco dopo giunge una vicina, alla quale la madre confessa le sue pene per la mancanza di una serva, dopo la morte della vecchia. Mentre le due donne parlano, ritorna Paraska con una cuoca, la quale dice di chiamarsi Mavra. In realtà non è altri che l'Ussero travestito. La madre l'interroga, le piace, l'assume. Ora la vicina si accomiata, e la madre si ritira nella propria stanza a vestirsi per uscire anch'essa, lasciando soli Paraska e Vassili, entusiasti pel successo del loro tranello. Poi la madre ritorna ed esce con Paraska. Vassili, rimasto solo, pensa che sia utile farsi la barba, e vi si accinge; ma d'improvviso la madre ritorna e lo sorprende. Per l'emozione sviene gridando: «Al ladro!». Al grido la vicina rientra spaventata, l'Ussero fugge, mentre Paraska dalla finestra grida disperata: «Vassili! Vassili!».
L'opera è dedicata alla memoria di Puschkin, di Glinka e di Ciaicowski; e la dedica a questi ultimi due, che sono rappresentanti di una operistica tradizionale, fa pensare o a una beffa ironica o a un reale desiderio di Strawinsky di riaccostarsi appunto alla tradizione. Mavra, tuttavia, presenta caratteri che lasciano fortemente perplessi su l'effettiva intenzione del suo autore. Infatti, a una cantabilità vocale diffusa, che talvolta si dilata in melismi e mette capo anche a vere e proprie cadenze, una cantabilità che si vale di motivi da canzonetta o da ballabile, si contrappongono una ritmica quanto mai varia e instabile, che sembra appoggiarsi alle danze novecentiste più epilettoidi, un'armonizzazione per lo meno stravagante per la sua frequente sconnessione con le melodie vocali, e uno strumentale intenzionalmente antiromantico e grottesco. L'orchestra infatti si compone di soli fiati: quattro clarinetti, quattro trombe, tre tromboni e un basso tuba. Neppure nei momenti più patetici, come il duettino d'amore con cui si apre l'opera, e il soliloquio amoroso di Vassili, compare per un solo istante un violino o un violoncello. E mentre il musicista snocciola canzoni, duetti (in cui i personaggi cantano anche insieme come nelle vecchie opere italiane), quartetti concertati in maniera polifonica piena di classica sapienza, mentre cioè sembra cercare di riprendere una tradizione interrotta, armonizzazione, ritmica e strumentale si schierano nettamente insieme contro ogni tradizionalismo. E mentre le voci cantano con senso tonale, l'accompagnamento oppone in modo burlesco una sua dissonante atonalità.
Questo cozzo di elementi contrastanti vale indubbiamente ad accentuare l'espressione grottesca che il compositore ha voluto dare all'interpretazione musicale della commedia. È appunto per mettere bene in evidenza questo carattere grottesco e iconoclasta che, fin dalla prima nota dell'operina «gli strumenti - come osservò esattamente Alberto Savinio - cominciano non tanto a sonare, quanto a chiocciare, a starnazzare, a gargarizzarsi».
Strawinski si è vantato della «disumanità» della propria musica. Disumana in Marva la musica proprio non è; tutt'al più è talvolta inespressiva. Perchè non basta fare a rovescio di quello che tutti fin qui hanno fatto, non basta deformare gli accordi, non basta sopprimere gli archi e tenersi agli istrumenti a fiato dai timbri fra loro più urtanti per dire che si è fatto del nuovo, e si è raggiunta un'espressione tipica. Le dissonanze? Quando sono troppo usuali dicono meno di quello che diceva un temperato uso di esse e soprattutto un «necessario» uso di esse. Del resto, come scrisse il Pannain, «Strawinsky è un perfetto giocoliere che cammina sul taglio afflato della dissonanza senza mai dar sangue». «Con Picasso - aggiunge - ha in comune una sola cosa: l'assurdità. E talvolta anche in Marva per voler essere nuovo ad ogni costo e nello stesso tempo antico, Strawinsky appare, come altrove, assurdo». Meglio perciò quando è primitivo e barbarico. Ma «la novità di ogni creazione artistica veramente originale e significante - così il Capri - è novità non di procedimenti ... ma di vita interiore». Per essere veramente nuova la musica di Marna avrebbe dovuto raggiungere una totale fusione del nuovo e dell'antico, superando l'ibridismo formale, il che non sempre è avvenuto.
Ma non cerchiamo in quest'opera quello che non c'è e che l'autore non volle fare. Marva è un «grottesco», e come tale va preso, e vi si possono riscontrare piccanti trovate musicali di cui la fantasia ironica e scanzonata dell'autore è certamente fertile. Per esempio, l'aria (bipartita e con il «Da capo») nella quale la madre rimpiange la morte della vecchia serva e ne enumera le domestiche virtù, è quasi sentimentale nella melodia, e come tale un po' comica, non perchè si compiange una povera serva, ma per le qualità degli elogi tributatile e il commento strumentale. Il quartetto fra Vassili travestito da cuoca, la madre, Paraska e la vicina, in cui si fanno ancora le lodi della serva defunta, è un altro documento della divertente abilità di Strawinski di servirsi delle vecchie forme polifoniche per fare dell'umorismo. Nel monologo di Vassili: «Attendo, attendo con impazienza», il testo decisamente sentimentale finisce per trascinare anche il musicista verso espressioni largamente cantabili con un più vivo senso di umanità.
Tutto sommato, la minuscola farsa (dirla «opera buffa» è forse troppo) vale assai più dell'Usignolo, ed è in complesso divertente, pur lasciando nell'animo un senso amaro, che nasce dalla visione che l'autore ha avuto della tenue vicenda, in cui sembra che il musicista, non ostante gli sberleffi musicali, abbia pianto più che riso.
ILDEBRANDO PIZZETTI - DÈBORA E JAÉLE: dramma in 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 16 dicembre 1922. Testo dello stesso Pizzetti.
Atto 1° - La piazza superiore della città di Kèdesh di Neftali. - Il popolo ebraico invoca dalla profetessa Dèbora soccorso contro gli assalti sanguinari dei Cananèi. Dèbora ordina a Baràk, capo degli eserciti israeliti, di attaccare Sìsera; ma Baràk non ha fede nella vittoria, poichè l'esercito nemico sta chiuso entro le mura di Haròscet. Dèbora insiste dicendogli di attenderlo al monte Tàbor; indi invia Jaéle a Sìsera affinchè lo induca a uscire dalla città, L'accompagnerà Mara, alla quale i Cananèi hanno sgozzato il padre, il marito e il figlio.
Atto 2° - Una terrazza terrena nel palazzo di Sìsera in Haròscet. - Il Re Sìsera sta banchettando con la sua Corte, allorchè il Kenita Hèver lo informa che gli Ebrei si preparano ad assalirlo e gli tendono una trappola presso il monte Tàbor. Sìsera dà ordine o Talmài di preparare l'esercito pel mattino. Ed ecco Jaéle, ch'egli ama da tempo e che, pure amandolo, lo respinse, viene a offrirglisi. Essa gli dà false informazioni sui preparativi degli Israeliti contro di lui, però il Re scopre l'inganno. Jaéle allora si getta armata di pugnale contro Sìsera, ma questi le ferma il braccio, le perdona e fa appello al suo amore. Essa sta per cedere, allorchè ode la voce di Mara la quale canta una canzone che ricorda il suo bimbo ucciso. La coscienza di Jaéle si risveglia: chiede al Re che la lasci ripartire, e il Re acconsente; verrà a prenderla dopo la vittoria.
Atto 3° - Uno spiazzo erboso nel quercete di Saananim; il bosco si stende intorno, - Mara sta riparando la tenda di Jaéle, sconvolta da un uragano, e racconta a Jaéle, che l'ascolta con pena, la disfatta dell'esercito di Sìsera, Mara poi si allontana, ed ecco giunge Sìsera, lacero, sfinito e disperato. Jaéle lo abbraccia, lo disseta, e lo conduce a riposare nella tenda. Mara li sorprende e ne avvisa Dèbora. La profetessa impone a Jaéle di consegnare al po' polo il vinto e e chiama i soldati Israeliti appostati affinchè lo prendano e l'uccidano. Ma Jaéle, affinchè egli non creda di essere stato tradito da lei, entra nella tenda e l'uccide nel sonno, e al popolo e ai soldati sopraggiunti ne consegna il cadavere.
Il sistema già adottato dal Pizzetti nella Fedra, è più rigidamente applicato e disciplinato nella Dèbora e Jaéle. Il discorso vocale si svolge come un recitativo che cerca l'intonazione più naturale e non conosce che assai di raro e fugacemente abbandoni melici. È quindi un recitativo sillabico rapido quasi altrettanto amorfo quanto lo era quello della Camerata fiorentina. E perciò l'espressione del dramma è da cercare nella trama sinfonica dell'orchestra e nel polifonismo corale. Le parti vocali dei solisti, anche quelle dei protagonisti, non vi concorrono che in minimissima parte.
Un fatto fondamentale sostiene l'azione drammatica: lo sterminio dei Cananèi, nemici del popolo ebraico, e la morte del loro Re Sìsera. I sentimenti che tumultuano nell'animo degli Israeliti, venerazione per la profetessa Dèbora, sospetto, contro l'infido Hèver, volontà di ribellione al tiranno e di vendetta contro lui e i Cananèi, odio feroce, fede religiosa e superstizione, impeto barbarico e mistica esaltazione, speranza, disperazione ed entusiasmo, tutto questo si raccoglie nei motivi corali e nelle loro poderose architetture, che fanno appunto del coro il personaggio principale del 1° atto. I modi arcaici, derivati dai disegni e dalle tonalità gregoriane, donano a questi cori un'intonazione solenne, austera e tutta imbevuta di sacro fervore, pure conservando anch'essi il carattere recitativo. Nel 2° atto i brevi e scarsi accenti corali dei Cananèi non hanno che un'importanza complementare, mentre il popolo ebraico ritorna in primo piano solo nell'ultima scena dell'opera, allorchè accorre con urla di esultanza feroce, per compiere lo scempio del cadavere del Re nemico ucciso da Jaéle.
Sotto al tumulto delle espressioni corali scorre il torrente delle polifonie orchestrali in un mutevole svariare di temi, ora incisivi, ora vaghi, ora centranti l'emozione drammatica con vigore imperioso, ora sfumati ed atti a creare attorno al dramma atmosfere appropriate al succedersi delle situazioni e degli stati d'animo. È in questo elaborato e ricco tessuto orchestrale, dai colori, dalle luci e dalle ombre cangianti, che si condensa la più sostanziosa espressione del dramma. Talvolta forse quest'orchestra vuol dire troppe cose tutte in una volta, e perciò diviene minuziosa e frammentaria facendo perdere il senso della linea o rendendola troppo pesante. Ma non v'ha dubbio che anche per chi non sia in grado di seguirne tutti i fuggevoli e rapidi particolari, essa crea suggestioni ambientali e impressioni drammatiche tali da imporsi per la potenza della costruzione e l'efficacia dei motivi. Ciò però rende più sensibile la debolezza dell'espressione canora, tirannicamente soggetta al principio che spinge l'autore a seguire con veristica aderenza le inflessioni del linguaggio parlato, sia pure colto nei momenti di maggiore concitazione d'animo, ma senza mai trasfigurarlo in melodia, se non in rari istanti; cosicchè non si distingue un personaggio dall'altro, e Dèbora parla come il più umile Ebreo.
Su tutto domina un sentimento religioso alto, che si esprime con solennità biblica di accenti tematici e di strutture polifoniche, e con una ispirazione che se non sempre raggiunge la mèta, è però dettata da un concezione nobilissima. La ieratica figura di Dèbora sembra scolpita in un marmo freddo come un ghiaccio. Com'essa appare su la scena, il suo motivo ci trasporta in una zona che non è più di questo mondo; orchestra e cori ci sollevano con un balzo potente dell'ispirazione verso Dio. Il senso del sovrannaturale ne circonda la persona e l'avvolge in un'aurèola sacra, dolce ma lontana.
A Dèbora si contrappone Jaéle, creatura umana che si dibatte fra l'amore per Sìsera, barbaro e crudele, e nell'istesso tempo generoso e gentile, e il suo dovere di figlia d'Israele. L'amore ha momenti di trepida espansione nel duetto del 2° atto, mentre la voce di Mara, che canta una stanca e dolente ninna-nanna per il bimbo uccisole dai Cananèi, risveglia la sua coscienza e pone nel suo animo una drammatica lotta. Questa lotta diviene tragica nel dialogo con Dèbora all'ultimo atto, allorchè, strumento di un fato più forte di lei, essa finisce per compiere quanto Dèbora voleva. «Hai udito la voce del Signore?» le chiede la profetessa; «Non del tuo Dio, d'un altro, che non conosci!...» le risponde Jaéle. Dèbora non può comprenderla, ma bene la comprende Jèsser, il povero ragazzo cui la sùbita commozione spezza il canto dell'«Alleluia» e fa inginocchiare innanzi a Jaéle e baciarle il lembo della veste. Figura, si suoi dire, derivata dall'Innocente del Boris di Mussorgski, come dalla stessa fonte deriva il movimento corale del 1° atto. È però necessario aggiungere che l'una e l'altro sono trattati da Pizzetti in modo totalmente diverso.
MANUEL DE FALLA - EL RETABLO DE MAESE PEDRO (Il teatrino di Mastro Pietro): adattamento musicale e scenico di un episodio dell'Ingenioso Hildalgo Don Quixotte de la Mancha di Miguel de Cervantes. Prima rappresentazione (privata) nel salone della Principessa Ed. De Polignac a Parigi il 25 giugno 1923. 1a audizione pubblica a Parigi (Concerts Wiéner) il 13 novembre 1923.
Atto unico - Scena 1a - Scuderia d'un albergo nella Mancia d'Aragona, Nel fondo un teatro di marionette; sul davanti il pubblico, fra il quale è Don Chisciotte. La scena principale non muta; cambiano quelle del teatrino. - Mastro Pietro annunzia sommariamente il soggetto della commedia. La liberazione di Melisendra, presunta figlia di Carlo Magno e sposa di Don Gayferos, dai Mussulmani che la tengono prigioniera. Di tanto in tanto, durante tutta l'azione, si presenta al pubblico un Narratore il quale spiega le vicende dell'azione. Dopo una breve sinfonia si alza il sipario del teatrino e appare una sala nel palazzo imperiale di Carlo Magno. Don Gayferos e Rolando giuocano a scacchi. Entra Carlo Magno e rimprovera Don Gayferos per la sua indifferenza nei riguardi della sposa prigioniera. Don Gayfros, dopo una breve disputa con Rolando, che non vuol prestargli la spada, si arma e parte.
Scena 2a - La torre dell'Alcazar di Saragozza. - A un balcone sta pensosa Melisendra. Un Moro l'afferra alle spalle e la bacia. Melisendra grida spaventata e offesa; Re Marsilio, che ha visto l'accaduto, ordina alle guardie di arrestare il Moro. Il Narratore annunzia che il Moro verrà staffilato per ordine del Re, senza bisogno di processo e di testimoni. A questo punto Don Chisciotte avverte il Narratore di continuare il racconto senza far commenti.
Scena 3a - La piazza di Saragozza. - Il Moro viene condotto nella piazza e pubblicamente punito a colpi di bastone.
Scena 4a - I Pirenei. - Don Gayferos attraversa la montagna per recare soccorso alla sposa. Il Narratore annunzia poi gli avvenimenti della scena successiva.
Scena 5a - La torre dell'Alcazar. - Melùendra è al balcone. Appare a cavallo Don Gayferos, col viso coperto dal mantello. Melisendra lo chiama e lo prega di portar sue nuove a Don Gayferos. Questi allora si svela; Melisendra si cala dal balcone; Don Gayferos la pone in groppa al cavallo e parte con lei. Il Re s'accorge della fuga di Melisendra, chiama a raccolta i suoi e si prepara a inseguire i fuggitivi.
Scena 6a - Don Chisciotte a questa vista non resiste; invano trattenuto da Mastro Pietro, egli si lancia con la spada sguainata contro il teatrino mettendo a pezzi le marionette, ed esaltando infine la bellezza di Dulcinea e il valore dei Cavalieri erranti, mentre Mastro Pietro si dispera su la devastazione del proprio teatro.
L'autore ha concepita la commedia come rappresentata interamente da marionette, compresi gli spettatori e Don Chisciotte, il quale - precisa De Falla - dev'essere alto il doppio degli altri.
L'interpretazione musicale è appunto quella che si addice a una commedia marionettistica: musica pittoresca, dai movimenti talora stecchiti, ma che al momento opportuno, palpita anche di un sentimento umano, poichè le marionette non sono altro che la maschera dell'umanità, della quale Don Chisciotte è il più nobile Cavaliere, il cui animo, nella sua esaltazione generosa, nell'intento di fare del sogno la realtà vissuta, si perde nella follia.
Si tratta, dunque, d'un'opera d'eccezione, che esce da ogni formula melodrammatica consueta, e come tale va ascoltata.
Mastro Pietro non ha che poche battute, di non grande importanza, di espressione vivace, ma esente da ogni lirismo.
I personaggi dell'azione: Carlo Magno, Gayferos, Melisendra, il Moro innamorato, Re Marsilio, e tutte le altre figure di contorno, gestiscono soltanto. Il racconto degli avvenimenti è pertanto affidato a un Narratore o Interprete giovinetto, che - dice l'autore - deve avere voce nasale, ed esporre col tono monotono dei contastorie, senza inflessioni liriche, precedendo col racconto l'azione delle marionette.
In contrasto, Don Chisciotte «deve cantare - dice il compositore in una sua nota relativa all'esecuzione vocale - con uno stile nobile che parteciperà ugualmente del comico e del sublime, esagerando fino ai più piccoli dettagli l'interpretazione delle indicazioni musicali». È dunque una parte lirica, in opposizione alla maniera dimessa e - per l'Interprete - recitante con tonouniforme.
Ma nelle scene in cui agiscono le marionette (Entrata della Corte di Carlo Magno, Meditazione di Melisemdra e bacio del Moro, Punizione del Moro, Cavalcata di Gayferos attraverso ai Pirenei, Liberazione di Melisendra, Fuga e inseguimento degli Sposi) è l'orchestra che assume una parte volta a volta narrativa. lirica, ed epica. Una piccola orchestra, della quale fa parte il clavicembalo, e che negli episodi mimati delle marionette interviene con un sapore tra l'arcaico e l'attuale, ricca di armonie asprigne, spesso (come nella sinfonia) parodianti le stonature dei complessi da osterie di paese, di timbri vividi e di ritmi e spunti melodici suggestivi che spiritualmente attingono alla tradizione dei canti e delle danze spagnole antiche. Tipica, nei riguardi dell'espressione arcaica, è la musica della scena in cui appare Carlo Magno, e l'inizio della 5a scena (fuga di Melisendra).
È un incalzare della musica che va di pari passo con l'incalzare degli avvenimenti, con la crescente concitazione narrativa dell'interprete, che conduce lo spirito di Don Chisciotte a una istintiva naturale identificazione della rappresentazione con la realtà, del teatrino con la vita vissuta. La sua esaltazione, a lungo contenuta, ma via via sempre più esasperata, esplode alla fine con forsennata violenza, alla quale si accompagna nel canto e nell'orchestra il sentimento amoroso ed eroico di Dulcinea e della generosa impresa cavalieresca ch'egli crede di aver compiuto, misto a un sottile senso umoristico e burlesco, e fra le esclamazioni di disperazione di Mastro Pietro.
ARRIGO BOITO - NERONE: tragedia in 4 atti. Prima rappresentazione postuma alla Scala di Milano il 1° maggio 1924. Poema dello stesso Boito.
Atto 1° - Un campo presso la via Appia con ruderi e tombe. - È notte: Simone Mago e Tigellino aiutano Nerone a seppellire le ceneri della madre Agrippina da lui fatta uccidere. In lontananza si odono voci, una delle quali, che paragona Nerone ad Oreste, turba l'imperatore. Quand'ecco apparire una figura di donna con in mano una face e il collo avvolto da serpi come un'Erinni. Nerone ne è atterrito; Tigellino lo trascina con sé, ma Simone resta, afferra l'Erinni, la interroga e impara così emessa è donna, Asteria, innamorata follemente di Nerone. Simone le promette di realizzare il suo sogno. Incomincia ad albeggiare: giunge Rubria e s'inginocchia presso una tomba cristiana pregando. Da quella dolce preghiera Asteria è commossa; prende un fiore che Rubria le dona, ma subito fugge; il suo dio è Nerone, Fanuèl, apostolo cristiano, che ama Rubria, viene a salutarla prima. di abbandonare Roma. Rubria sta per confessargli un suo peccato', allorchè Simon Mago, che era sceso in una catacomba cristiana, ne ritorna interrompendo il loro dialogo. La vstta di Simone, noto nemico dei cristiani e sacerdote di una falsa religione, fa presentire a Fanuèl un pericolo ignoto, per cui dichiara che non partirà. Simone vorrebbe che Fanuèl gli vendesse il segreto per compiere miracoli. Sdegnato, Fanuèl lo maledice, e i due si allontanano minacciandosi, Nerone e Tigellino ritornano per completare il seppellimento delle ceneri materne allorchè giunge, preordinato da Tigellino, un corteo che inneggia a Nerone imperatore, e questi, vincendo la paura, si lascia condurre a Roma in trionfo.
Atto 2° - L'interno del tempio di Simon Mago. Un'ampia cortina divide lo spassio riservato ai fedeli dal sacrario dei sacerdoti. - È la fine di una celebrazione religiosa. Mentre i fedeli cantano inni sacri, al di qua della cortina i falsi sacerdoti irridono ai creduli e bevono allegramente. Poscia Simon Mago conduce Asteria sull'altare e le impone di restare immobile. Nerone la crederà una divinità e l'adorerà. Attraverso ad Asteria Simone spera di avere pronto al suo volere Nerone. Questi è turbato dalla vista di Asteria la cui immagine gli appare, in uno specchio, simile al fantasma della Divinità dei Morti. Ma voltosi e scorta Asteria la crede la divinità in persona, e subito concepisce il sacrilego desiderio di possederla, vantandosi di avere già posseduta la vestale Rubria ai piedi dell'ara. Asteria discende verso di lui folle d'amore e si lascia baciare, ma in questo bacio Nerone si accorge che essa è donna mortale e la respinge; quindi reso sospettoso dall'inganno, mette a pezzi gli idoli del tempio, getta una fiaccola nella bocca di un oracolo che pronunciava contro di lui minacce, e arde Dositèo che si trovava nella statua. Indi chiama i suoi pretoriani ai quali consegna Asteria affinchè sia gettata nel vivaio dei serpi, e Simon Mago perchè sia lanciato a volo dall'alto di una torre nel circo. «Sì - esclama Simone - purchè in quel giorno scorra sangue cristiano». Solo Gobrias si salva: egli piace a Nerone per il suo spirito, e perciò lo ascrive al suo teatro. Poi sale su Inoliare, vi si asside come un Dio, e canta.
Atto 3° - L'orto ove s'adunano i Cristiani nel suburbio dì Roma. - Fanuèl ripete ai fedeli il discorso di Cristo su la montagna. Improvvisamente tutti fuggono gridando: «Un fantasma!». Solo Rubria e Fanuèl rimangono. Il supposto fantasma è Asteria, la quale, sfuggita al vivaio dei serpi, viene ad avvertire i Cristiani che Simone sta per farli arrestare. E rapidamente si allontana. Rubria vorrebbe che Fanuèl si ponesse in salvo, ma questi le chiede di confessare il suo peccato. Rubria non vuol rispondere ora, mentre urge il pericolo. Ed ecco Gobrias che conduce Simone invocando il battesimo per un cieco. Fanuèl riconosce Simone, e questi gli chiede di salvarlo con un miracolo. Fanuèl rifiuta; allora Simone lo addita ai pretoriani che lo seguivano. I cristiani, rientrati, tentano di opporsi minacciosi, ma Fanuèl meta loro ogni resistenza, chiede che cantino le lodi di Dio e si incammina fra i soldati senso salutare Rubria. Essa inizia il canto, ma scoppia tosto in lagrime.

Figura 17: Scena di Benois per la Kovancina di Mussorgski.

Figura 18: Scena di Benois per Il Crepuscolo degli Dei di Wagner.
Atto 4° - Parte 1a - L'interno dell'Oppidum. - Nel circo si stanno svolgendo divertimenti popolari con combattimenti di gladiatori, corse di quadrighe, danze, in attesa del martirio dei Cristiani. Mentre questi giungono, una Vestale col volto coperto da un velo s'interpone chiedendone la grazia a Nerone. Per ordine di questi Simone le strappa il velo: è Rubria. Nerone la condanna a morire nel circo, ed anche Simon Mago viene precipitato dalla torre dell'Oppidum. Ma poco appresso si sviluppa un grande incendio, provocato da Gobrias e da Asteria nel vano intento di salvare Simon Mago e i Cristiani. La gente fugge terrorizzata.
Parte 2a - Lo Spoliarium. - Fanuèl, che l'incendio ha salvato da morte, insieme ad Asteria cerca Rubria, colpita dalla freccia di un sagittario. In mezzo a un mucchio di cadaveri, fra cui quello di Simon Mago, vien trovata Rubria ancora in vita. Essa rinviene, riconosce Fanuèl, e finalmente gli confessa di aver servito una falsa fede, tentando di confondere nella stessa vampa Vara di Vesta e la lampada della vergine saggia: ecco il peccato. Fanuèl la benedice, e nell'ora estrema i due si confidano il loro reciproco amore. E nel ricordo cullante della barca di Gesù sul lago di Genèsareth che la parola di Fanuèl rievoca, Rubria spira dolcemente. Asteria tornando ode il nome di Rubria pronunciato da Fanuèl; essa è dunque colei che conobbe l'ardore dei baci di Nerone. Ma Rubria non può più parlare, e con un gesto pio Asteria trae dal seno il fiore che Rubria le donò, e lo lascia cadere sul suo cadavere, invocandole pace.
Il Nerone è l'opera attorno alla quale Boito lavorò oltre quarant'anni, senza decidersi mai a finirla. Alla sua morte l'orchestrazione era ancora incompiuta e dovette essere completata e in gran parte rifatta. Egli mirava ad una libertà di forma e a un'altezza di ispirazione che ben sentiva di non saper raggiungere.
Il Nerone ebbe perciò una rappresentazione postuma, e «occorre dire - scriveva il Gui - che ad esso manca quell'equilibrio perfetto tra sostanza e forma che è il segno dei capolavori; ma è d'altronde sicuro e indiscutibile che la nobiltà della materia immaginativa e la potenza dell'emozione interiore da cui procede è tale che l'opera assurge naturalmente a dignità d'arte, e d'arte di primissima scelta». Perciò non si spiegano le sue troppo rare rappresentazioni, perchè ci sono opere ben più imperfette e prive della nobiltà d'ispirazione di questa, che vengono di frequente rappresentate.
Fra i difetti va annoverato quel voler essere così materialmente aderente con la musica alle parole e ai gesti, nei loro significati intellettuali più che spirituali, realistici più che emotivi, da dare talora l'impressione di un abbandono al cerebralismo più che al cuore, frammentando e inceppando il libero svolgimento del periodo musicale.
Il personaggio che la musica ci ha reso in maniera più scialba e imperfetta è quello di Simon Mago. Il tema che lo rappresenta striscia tortuoso, ma non ha nulla di particolarmente malvagio. E l'altro che lo riguarda, dopo la condanna pronunciata da Nerone, si riferisce alla sua fama di uomo che sapeva miracolosamente levarsi a volo, ed è un breve tema descrittivo comico e fatuo. Ma i suoi canti drammatici, come, ad esempio, quello in cui chiede a Fanuèl di vendergli il miracolo, sono percorsi da una vuota enfasi. L'unico momento veramente indovinato è l'aria dello specchio (atto 2°), in cui però vibra soltanto un senso magico arcano che si riferisce esclusivamente a un lato della personalità di Simone.
Viva, invece, fino dal suo primo apparire, è la figura di Asteria, il cui tema col suo snodarsi serpentino sembra alludere non tanto ai colubri che le girano attorno al collo, quanto al tormento angoscioso della sua anima che si dibatte fra la colpa e la redenzione, arsa per il sanguinoso imperatore dalla febbre di un amore sensuale travolgente. In lei penetra un lieve alito della fede cristiana; e a contatto con Rubria il suo canto si addolcisce e si purifica; ma l'ansia che la turba, l'ardore che la divora, non permettono a questo alito di farsi respiro. Il che avviene invece in Rubria. Nel suo serafico «Padre nostro» (e non è che un recitativo su una sola nota, accompagnato da accordi ribattuti e solcato da una frase dolcissima dei violini) di una religiosità purissima, si beve a pieni polmoni la vivificante luce di Cristo. Solo il motivo del suo peccato, così dolente ed umile, ci porta l'eco dell'errore che l'opprime: la fusione del culto di Vesta con quello di Gesù. Nell'ora della morte invece, sia nella rotta e affannosa confessione «M'odi... La morte a ogni attimo mi strugge...», come poco dopo nell'ormai languente: «Sento che ascende l'ombra d'un vespero strano», vibra il presentimento arcano e mistico dell'al di là. Quest'atmosfera religiosa è la più sentita, e trova nella musica di Boito una espressione alta ed intensa. Non è più lo sgargiante e soggiogante impeto sonoro dell'Empìreo, come nel Prologo del Mefistofele. Qui tutto è mite e contemplativo; così la frase: «Sorgi e spera» che Rubria dice ad Asteria, e che questa traviserà di significato nel ripeterla a Nerone, trascinandola dal cielo in terra; così tutti i cantici del 3° atto, di un candore chiaro, di una freschezza luminosa, quali da tempo non s'udivano non diciamo su le scene, ma neppure nella musica da chiesa (e Boito si diceva ateo!).
Fanuèl vive in questa luce; ma in lui si fondono l'austerità paterna dell'apostolo e la tenerezza dell'amante. Figura complessa, che Boito ha reso con finezza di psicologia e di liricità, specialmente nelle «Benedizioni» e nell'espansivo saluto ai fratelli, in quel 3° atto che è il più ispirato e il più unitario, e nel quale domina uno spirito elevato di poesia religiosa; e infine nell'ultimo duetto in cui Fanuèl culla con la voce la moribonda nell'evocazione del paesaggio di Genèsareth ove su l'onde «oscilla ancor la barca ove pregò Gesù», evocazione di una delicatezza stupenda già nella poesia, e che la musica circonda, coi suoi ritmi cullanti e con la sua melodia trasognata, di una dolcezza e purezza celestiale.
Più complesso, e pure plasticamente scolpito, è Nerone. Nella poetica notte su la via Appia, con i frammenti di canzoni vicine e lontane che il vento porta, attraversate dal sinistro e minaccioso grido: «Nerone-Oreste! Il Matricida!», o dall'altro più solenne e pure minaccioso «Voce dall'Oriente! Voce dall'Occidente! Guai a Roma!», Nerone giunge precipitoso su un motivo affannoso e delirante di terrore. Mentre seppellisce le ceneri materne la musica ce lo presenta a volta a volta declamante con enfasi istrionesca, o preso da sincero rimorso; mormorante pavido e superstizioso, o sotto l'incubo di un arcano fato pauroso, o in preda ad una folle ambizione e pronto a nuovi delitti. Non tutti questi aspetti raggiungono la stessa forza espressiva, e la rappresentazione del suo istrionismo rettorico fa cadere talora anche la musica nel convenzionale e falso che, per quanto sia voluto, non è per questo meno antipatico. Di questa intonazione gonfia e farraginosa si tinge la chiusa del 1° atto che vorrebbe essere soltanto descrittiva e trionfale. La farragine viene dall'averci Boito voluto dare in quest'ultima scena troppe cose più pesantemente accatastate che esteticamente espresse.
Poi verrà nel 2° atto il Nerone sensuale. Questo 2° atto è, col 3°, uno degli atti migliori dell'opera, prima per il burlesco contrastante intreccio fra il greve e pedantesco inno sacro cantato dai fedeli (bassi) e gli ironici commenti contrappuntistici e le libazioni tutt'altro che sacre dei falsi sacerdoti; poi per l'atmosfera di magìa e di sensualità che incombe dall'entrata di Nerone e dall'aria di Simone: «Ecco il magico specchio», fino alla fine del duetto con Asteria. Voluttuoso è il canto di Nerone: «Scendi! Scendi!», che alla frase: «Io rapito dal senso» diviene tutto uno scorrere di brividi, di fremiti, anelanti all'amore sacrilego. Simone spegne la luce che irradiava Asteria; l'oscurità getta sui due amanti il senso dell'incubo magico; il mistero accresce in Nerone il desiderio febbrile che si traduce nello spasimo e nel languore del bacio, tosto fugato dalla coscienza della realtà: «Sei donna!».
Il Mefistofele ha certo ispirazioni più melodiosamente appariscenti, espansive e quadrate, ma non ha un atto di così intensa bellezza e profondità. Le scene successive ci presentano il lato violento dell'Imperatore con l'aggiunta di qualche tratto comico alla comparsa di Gobrias (anche Gobrias ha un suo tema burlesco), e con un tema descrittivo ironico allorchè Nerone dichiara che Simon Mago «volerà» nel Circo. Ma quando alla fine Nerone è ripreso dall'istinto istrionesco, la fantasia del musicista non ha risposto felicemente, e la chiusa dell'atto appare scolorita e strozzata.
Nella ia parte del 4° atto il carattere follemente crudele e sadico di Nerone non trova nella musica rispondenza adeguata. E anche in questa parte gli episodi si accumulano in modo troppo farraginoso. Naturalmente ve ne sono dì preziosi, come, ad esempio, la danza della fanciulla Gaditana, il violento recitativo di Nerone: «Date le Dirci al popolo» (Boito ha raggiunto nei recitativi di quest'opera, e specialmente in quelli affidati a Nerone, un rilievo e una forza espressiva ben superiore a quella del Mefìstofele). Ma più che il canto hanno valore in questo quadro i colori sempre accesi, e tesi in un continuo spasimo, che vanno dai brutali urli della plebe ai gemiti delle vittime, con un robusto pernio centrale nel solenne «Credo» dei Cristiani.
L'ultimo quadro è, come si disse, una visione di morte e di pace. Il rombo dell'incendio che circonda i due amanti e i ricordi dell'orrore del circo rendono più tangibile questa senzazione di riposo e sembrano aprire lo sguardo su la serena luce dell'al di là.
Ripetiamo che quest'opera dovrebbe essere eseguita, se non più spesso, almeno quanto il Mefistofele.
RICGARDO ZANDONAI - I CAVALIERI DI EKEBÙ: dramma lirico in 4 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 7 marzo 1925. Libretto di Arturo Rossato da La leggenda di Giosta Berling di Selma Lagerlöf. - In Ekebù, terra di Svezia. Epoca lontana.
Atto 1° - A destra, un interno d'osteria; davanti, uno spiazzo. Un largo sentiero sale fra gli abeti dalla valle al castello di Ekebù che domina il paesaggio.- Giosta Berlin, giovane prete sconsacrato perchè ubbriacone, è innamorato di Anna, figlia di Sintram; ma, sfiduciato, si ferma all'osteria a bere: vuol morire, Sintram gli dà del denaro perchè si uccida con l'alcool. Ma la vecchia e potente Comandante delle ferriere di Ekebù lo soccorre; sa che Anna lo ama, e vuol salvarlo. Gli racconta che la propria madre la costrinse a sposare un tetro uomo che essa non amava, Samzelius, mentre si era promessa ad altro. Ella schiaffeggiò la madre, che la maledisse. Tornato al paese l'uomo del suo cuore, tradì lo sposo. Poi, l'amante morì lasciandole in dono il castello e le ferriere. Però del dono essa si servì per dare lavoro e per redimere i deboli e i perduti; e fu «la Comandante dal pugno forte e dal selvaggio cuore». Ora essa offre lavoro e redenzione anche a lui come «Cavaliere» (cosi essa chiama i suoi operai). È la vigilia di Natale: al castello ci sarà festa, ci verrà anche Anna. Giosta, rianimato, accetta e sale con lei al castello, mentre gli operai li accompagnano intonando la canzone dei Cavalieri di Ekebù.
Atto 2° - Ampia sala nel castello di Ekebù. A destra un'arcata, chiusa da una tenda, funzionerà da teatro. - Uno sciame di fanciulle sta abbigliando Anna per la commedia; poscia entrano i Cavalieri, e Giosta a braccio della Comandante. Giosta viene consacrato Cavaliere dal «Capitano dei Cavalieri», Cristiano. Si dovrebbe ora dare inizio alla commedia, e la Comandante dice a Giosta che dovrà recitare con Anna. Questa è imbarazzata, ma Cristiano, che ha intuito, fa uscire tutti, lasciando soli Anna e Giosta affinchè si accordino. Giosta vorrebbe riallacciare il suo amore con Anna, ma questa lo respinge rinfacciandogli il suo vizio di beone. Ma, in fondo, essa l'ama ancora, e durante la commedia Giosta riprende le sue invocazioni amorose, ed ella non sa più resistergli, gli cade fra le braccia e lo bacia. Sintram manda un urlo di rabbia e la maledice, avvertendola che la sua casa sarà chiusa per lei; poscia fugge inseguito dalla folla infuriata. Anna e Giosta escono abbracciati, benedetti dalla Comandante.
Atto 3° - La fucina nel castello di Ekebù. - È la notte di Natale. I Cavalieri stanno cenando e bevendo. Uno di essi, Liecrona, suona il violino mentre gli altri cantano una malinconica canzone di Natale. Al primo rintocco della mezzanotte compare Sintram vestito da diavolo. Egli racconta che la Comandante dona ogni anno all'Inferno una delle loro anime per poter conservare il Castello donatole da un amante. Inorriditi e indignati, i Cavalieri, allorchè la Comandante compare accompagnata dal marito Samzelius, si rivoltano contro di lei. Cristiano rinfaccia a Samzelius di vivere su le ricchezze che un amante lasciò a sua moglie. Samzelius è disperato per la rivelazione improvvisa; la Comandante comprende che è venuta l'ora dell'espiazione, e si allontana donando il castello e le fucine ai Cavalieri, già pentiti del gesto irreparabile. Sintram dal fondo sghignazza e fugge.
Atto 4° - Un cortile nel castello di Ekebù. - È trascorso un anno: partita la Comandante, i Cavalieri si sono abbandonati all'inerzia e al vizio del bere. La fucina è deserta, dovunque il senso dell'abbandono e della desolazione. La folla impreca per la mancanza di lavoro e per la miseria sopravvenuta dopo la partenza della Comandante, della quale invoca il ritorno; e impreca contro i Cavalieri, ed anche contro Anna che vivendo con uno sconsacrato ha portata la maledizione, Giosta calma la folla giurando che farà ritornare la Comandante. I Cavalieri sono pentiti di averla scacciata e ne vanno in traccia. Anna è decisa a separarsi da Giosta per annientare la maledizione. Mentre Giosta la implora di non abbandonarlo, si odono grida: la Comandante, agonizzante, è tornata per morire presso i suoi Cavalieri. Come sua madre l'ha perdonata e ribenedetta, così essa benedice Anna e Giosta, al quale trasmette la proprietà del castello. E perdona pure a Cristiano e ai Cavalieri che la cacciarono. Risospinge tutti al lavoro, e muore serena mentre esso riprende al canto fiero e gioioso dei Cavalieri.
Zandonai non si è lasciato prendere troppo dal desiderio di dare alla sua musica un colorito ambientale mediante l'uso di motivi folkloristici scandinavi. Egli è sempre quello di Francesca e delle altre opere precedenti, con il suo amore per le armonie minori e diminuite, con il suo interesse per il colore orchestrale, che talvolta appare anche troppo denso, ma con maggior sapienza e maturità artistica. Un accresciuto interesse si nota per le armonie dissonanti; interesse che aumenterà nell'opera successiva:
Giuliano; ma la vocalità è sempre al sommo dei valori, o quanto meno allo stesso livello dell'espressione armonica e strumentale, e di disegno chiaramente italiano. Non che manchi qualche spunto folkloristico, come, ad esempio, il motivo della «Melodia norvegese» di Grieg, che si intreccia con espressione pastorale al canto delle Fanciulle nel 1° atto. Ma anche senza elementi folkloristici,. anche con la vocalità italiana, Zandonai è riuscito ugualmente a creare l'ambiente con quella sua facoltà poetica di trasfigurare in impressioni sonore il paesaggio. È così che, subito all'apertura dell'opera, egli ci tuffa nel silenzio triste e nevoso di un'atmosfera nordica, con semplicità estrema di mezzi. E, poco dopo, con la fresca canzone delle fanciulle, così contrastante con le amare e cupe scene precedenti, fa prorompere il senso della vita e della gioia. Così, al 3° atto, con la canzone di Natale dei Cavalieri, che il violino di Liecrona commenta con accenti di intensa nostalgia e con singulti di dolore su gli arpeggi della celesta, Zandonai dipinge a colori tenui ma di grande intimità psicologica il senso idillico della sacra Notte, con la sua poesia di bontà che fa presa sui cuori degli strani Cavalieri semiubbriachi. E la sviolinata di Liecrona e il suo pianto e il desiderio disperato della sua casa e del suo bimbo lontano, fanno di questo personaggio secondario una figura indimenticabile, una delle più profondamente sentite dell'opera. Ancora, all'inizio del 4° atto, il Musicista riesce a dipingere il quadro desolato dell'estrema miseria e della disperazione umana, mista a superstiziosa ribellione, con forte rilievo plastico nell'imprecazione della folla contro Anna e Giosta. Sono queste forse le pagine più alte dei Cavalieri di Ekebù.
Ma a proposito di citazioni di motivi, alcuni di questi non sembrano avere molto a che fare col clima scandinavo. Si comprende la citazione del «Te Deum», allorchè Giosta (atto 1°), ricordando le gioiose immagini primaverili che l'alcool desta nell'anima sua, esclama entusiasta: «Ave al Signore, ave alla vita», dove il motivo sacro acquista uno strano sapore ironico nella bocca del prete spretato e ubbriacone. Ma non si capisce affatto il ritorno nell'orchestrina dei Cavalieri (al 2° atto, mentre si prepara la recita) della frase con cui nella Francesca Paolo dice: «Inghirlandata di violette m'appariste ieri», e poco dopo, quella della viola pomposa che si ode pure nella Francesca alla fine del 1° atto. E, più strano ancora e spaesato, il motivo del famoso Minuetto di Boccherini allorchè, nel 2° atto, nella scena della consacrazione di Giosta a Cavaliere, Cristiano nomina «Everardo insidiator di dame». Altri ricordi sono puramente casuali, come il tema della Comandante che fa pensare al grido: «È al Yoshiwara» nel finale 1° dell'Iris di Mascagni. Tuttavia nei Cavalieri di Ekebù il tema della Comandante si appesantisce, acquista un carattere di autorità imperiosa che manca all'analogo spunto dell'Iris, e che scolpisce in maniera efficacemente sintetica la fiera personalità della Comandante. Anche il tema di due note con cui si apre l'opera, e che ritorna con frequenza, ricorda quello con cui si apre la IX sinfonia di Beethoven.
Il soggetto del dramma, con quel misto di leggendario e di umano, con la stranezza fiabesca di certe situazioni, con la bizzarria fantastica di taluni caratteri, ha trovato nella musica un'adeguata espressione. Sintram, mezzo demonio e mezzo uomo, è il più pittoricamente caratterizzato da disegni diabolici e da armonie aspre, e dai suoi recitativi foschi e violenti. Come mai la Lagerlöf ha pensato di farne il padre di una creatura angelica come Anna?
Anche Cristiano, il «Capitano dei Cavalieri», è ben tratteggiato nei suoi atteggiamenti grottescamente cavallereschi e spavaldi, specie nel 2° atto, alla scena della consacrazione di Giosta, e nell'ultimo allorchè decide di andare a cercare la Comandante.
Giosta, che entra la prima volta in scena con una disperata canzone di ubbriaco, poco appresso acquista una fisionomia drammatica nel racconto triste ed esaltato che fa alla Comandante, tutto punteggiato dal breve ritmo simile a un singhiozzo, con cui l'opera si apre, e che gli conferisce un acuto senso di sofferenza. Ma dal 2° atto il suo volto è quello dell'innamorato ardente, redento dall'amore di Anna, figura questa musicalmente più pallida ma anch'essa presa dal soffio lirico dell'amore. È specialmente durante la recita, allorchè la finzione della commedia si trasforma gradatamente in realtà, sul commento dell'orchestrina di corni sgangherata, piena di stonature caricaturali e balorde, e lo sdilinquire improvvisatorio del violino, è qui che l'amore fiorisce in canti ricchi di intima effusione. Canti che se pure denunziano una tendenza al melodizzare mascagnano, non sono per questo meno espressivi. Taluno ha trovato che c'è dell'enfasi, ma bisognerebbe sapere che cosa s'intende con questa parola, perchè ormai è venuto di moda di accusare d'enfasi ogni espressione espansiva dei sentimenti; e occorrerebbe precisare dov'essa comincia e dov'essa finisce per poterne constatare l'esistenza e la natura.
La Comandante ha certo un grande rilievo, non solo nel suo tema perentorio e duro, ma anche, e forse più, là dove essa rivela la sua umanità segreta, sia nel racconto che della propria giovinezza fa, nel 1° atto, a Giosta, sia nel solenne e commovente commiato del 3° atto, e infine nella scena della morte, allorchè trova ancora gli accenti del comando per far riprendere il lavoro, e si addolcisce al pensiero di rivivere in Anna e nell'idea estrema del perdono e dell'espiazione sofferta che l'ha redenta.
Il 4° atto è il più vario e drammatico. Incomincia col tempestoso coro della folla imprecante, cui segue il ravvedimento di Cristiano e dei Cavalieri, il tenero addio di Anna, l'ansioso e travolgente crescendo dell' orchestra a cui si uniscono sempre più vicine le voci del coro allorchè ritorna la Comandante. Risponde il grido di liberazione di Giosta che sente in questo ritorno, ch'egli aveva invocato come un segno di perdono dal Cielo, la propria redenzione; poi le ultime parole della Comandante e la ripresa del lavoro con un ritorno del canto dei Cavalieri in forma solenne. Questa canzone vigorosa e popolaresca che chiude il 1° atto come un richiamo vittorioso e liberatore sul dolore e la degradazione umana, si afferma ancor più gagliardamente nel 2°. Riecheggia infine all'ultima scena dell'opera con un senso eroico, sul fervido contrappunto degli archi e i tonfi poderosi e cadenzati dei magli. Qui veramente la canzone dei Cavalieri dà un significato a tutta l'opera; diventa un inno alla bellezza, alla bontà e soprattutto alla forza redentrice del lavoro.
L'opera aveva un 2° quadro del 3° atto, che fu poi soppresso perchè allungava inutilmente l'azione. Aveva per soggetto il ritorno di Anna alla casa dei genitori e la crudeltà del padre che la respinge.
Perchè quest'opera non si rappresenta quasi più in Italia? Se essa non uguaglia in bellezza la Francesca da Rimini non le è neppure musicalmente di molto inferiore, mentre per l'importanza del coro e per la forza di evocazione dell'orchestra la supera.
MAURICE RAVEL (Ciboure [Bassi Pirenei] 1875 - Parigi 1937). - L'ENFANT ET LES SORTILÈGES: fantasia lirica in due parti. Prima rappresentazione al Teatro di Monte Carlo il 21 marzo 1925. Poema di M.ma G. Colette.
Parte 1a - Una stanza dal soffitto basso. - Un fanciullo siede davanti ai libri, ma non ha voglia di lavorare: si sente svagato e cattivo. Invano la mamma lo sgrida e minaccia. Appena essa si è allontanata, il fanciullo, preso da un impeto vandalico, fa a pezzi i libri e si dà a devastare quanto gli sta attorno; perseguita anche uno scoiattolo e il gatto che fuggono. Allora tutti gli oggetti gli si rivoltano: la poltrona si rifiuta di lasciarlo sedere; l'orologio, al quale ha strappato il pendolo, la tejera e la tazza che ha frantumate, lo minacciano. Anche il fuoco, traboccando dal caminetto, lo insegue e lo respinge. Si è fatta sera: il bimbo ha paura. Pastori e pastorelle di cui erano decorate le pareti di carta ch'egli ha stracciato si lamentano di non potersi più ricongiungere. Ed ecco la Principessa di un libro di favole ch'egli ha lacerato, rimproverarlo con severa dolcezza. Ora è la volta del libro d'aritmetica che gli ricorda i problemi e gli rinfaccia gli errori. Il bimbo vede il gatto nero uscire dalla porta al richiamo della gattina bianca, e lo segue.
Parte 2a - Giardino al chiaro di luna. - Anche qui le piante ch'egli ha ferite, e gli animali, libellule, pipistrelli, scoiattoli, ch'egli ha torturato e ucciso, lo accusano. Per colpa sua una libellula ha perduto la compagna, e pipistrelli neonati sono rimasti nel nido senzala madre. Ora il bimbo incomincia a commuoversi, ma gli animali lo circondano e tutti insieme lo assalgono. Il bimbo chiama invano la madre. Nella rissa un piccolo scoiattolo è rimasto ferito, ma il bimbo, impietosito, lo cura e lo fascia. A questo atto di bontà e alla sua invocazione alla madre gli animali cessano dal perseguitarlo, gli perdonano, e lo riportano su la soglia della casa.
Ascoltando L'enfant et les sortilèges non si deve pensare al comune melodramma. Ravel ha chiamato questa composizione «Fantasia lirica»; in realtà essa è un'opera-balletto. Tutti gli oggetti, le persone e gli animali che prendono parte all'azione cantano spunti di canzonette infantili su ritmi di danza, e si muovono danzando. La maggiore difficoltà che si presentava al musicista era quella di trovare il tono giusto, tale cioè da lasciare alla fiaba la sua leggerezza, agli avvenimenti l'atmosfera di poesia infantile, alla morale il suo senso pieno di commossa umanità e socialità: l'amore per la mamma, l'amore per tutte le cose e per tutti gli esseri viventi. Il compositore ha compiuto il miracolo di trovare e mantenere per tutta l'opera questo tono infantile e fiabesco lieve e umoristico dal primo disegno iniziale che descrive la noia monotona e uguale del fanciullo, alla sua ribellione, alla reazione delle cose e degli animali, alla paura e infine alla commozione del bimbo.
Anche le dissonanze e le sovrapposizioni tonali hanno un loro sapore gustoso, ironico e burlesco, e concorrono a creare una coloritura irreale. Ad essa contribuisce pure la magìa della tavolozza orchestrale raveliana, qui di una iridescenza cangiante stupenda, preziosa e aerea, scaturita da una intelligenza fine che ha assimilato e trasfigurato ogni elemento poetico della fiaba. Anche le pennellate che si ispirano a imitazioni di moti o di suoni esteriori acquistano nella musica un sapore di incantesimo o di bizzarria fantasiosa. Da notare l'assenza degli archi da tutta la 1a parte. I movimenti di danza (fra cui il fox-trot della Tejera e della Tazza; il valzer lento americano delle Libellule, il goffo minuetto delle Poltrone) quando non hanno un valore caricaturale alleviano l'incubo del fanciullo riducendolo a un giucco trasognato.
La paura del bimbo non assume mai un tono drammatico, neppure quando, dopo la burlesca ma assillante persecuzione dell'Aritmetica, cade sfinito. Le persecuzioni sono, in realtà, i rimproveri della sua coscienza di fanciullo che sèguita a vivere una vita ricca di fantasia giocosa, e che, non ostante le apparenze, è fondamentalmente buono. La riuscita perfetta della musica di Ravel sta nell'aver saputo creare questo mondo spirituale infantile denso di poesia e di umanità così nelle birichinate del bimbo come nelle successive rappresentazioni del suo rimorso.
Fra i momenti più vivi sono l'affettuoso canto della Tazza: «Keng-ça-fou»; il delicato episodio della Principessa, nel quale il flauto che accompagna il canto rende ancor più aerea e come soffusa di una misteriosa luce azzurrina l'apparizione; il gentile coro delle Pastorelle; e l'incantesimale vita del giardino.
ADRIANO LUALDI - IL DIAVOLO NEL CAMPANILE: grottesco in un atto. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 22 aprile 1925. Libretto dello stesso Lualdi dall'omonima novella di Edgardo Poe.
Atto unico - La piazza centrale di un paese; dieci case piccole, tutte uguali e ugualmente distanti fra loro, sono disposte a semicerchio attorno a un campanile posto nel mezzo. Delle due case estreme sono visibili gli interni, perfettamente uguali l'uno all'altro. Ogni casa ha nella facciata un orologio con campana. Davanti ad ogni casa, un piccolo giardino, e in ciascuno una sedia su cui sta seduto un vecchione calvo e barbuto. Nella torre è l'orologio maggiore: l'Infallibile. Nel mezzo della piazza un macigno levigato attorno al quale sono disposti quindici scanni di pietra costituenti l'arengo. - Sono le 5,45. I vecchioni dormono e russano. Il Custode dell'«Infallibile» canta le lodi della vita metodica. Gli orologi gli fanno eco. Da una pentola posta sul fuoco nella casa di destra emerge una testa di maiale, da un'uguale pentola della casa di sinistra una testa di bue; entrambe imprecano alla loro sorte. L'orologio maggiore suona le 6; tutti gli altri rispondono; i dieci vecchioni si svegliano tutti in una volta, accendono le pipe e fumano, poi si riaddormentano. La vecchia Irene nella stanza a sinistra e il vecchio Carpo/onte in quella a destra brontolano: Irene contro il marito giovane, Carpofonte contro la giovane moglie. Eunomia, moglie di Carpofonte, entra e canta le lodi dell'ora e dell'ordine, poscia detta le spese della giornata al marito. Nell'altra casa Tallio, il giovane marito di Irene, si dispone a dipingere le sembianze della sposa truccata da divinità greca. Carpofonte litiga con la moglie per essersi comperata uno scialle, e Tallio sbatte il quadro in testa a Irene perchè si agita impaurita da un tafano. Indi Tallio penetra nella casa di Carpofonte nascondendosi, mentre Carpofonte entra in casa di Irene. Nelle altre case succedono scene analoghe. Uscito Carpofonte, Eunomia e Tallio si abbracciano e parlano del loro amore, mentre nella casa di fronte Irene e Carpofonte bevono e criticano rispettivamente Tallio ed Eunomia. Le teste di bue e di maiale si affacciano dalle loro pentole e sghignazzano. Ogni tanto i vecchioni si svegliano tutti insieme e fumano commentando quanto accade intorno a loro, poi si riaddormentano. Anche una schiera di bimbi entra e giuoca con ritmo metodico esatto; e passa una banda. Poscia i vecchioni si alzano e vanno nell'arengo, dove Carpofonte legge un ordine del giorno per sopprìmere tutto ciò che non sia decrepito. A questo punto con un grande scoppio appare il Diavolo, il quale batte i vecchioni su la testa con bacchette da timpani, scompigliando radunata. Indi sale sul campanile, dove sette vecchioni e il custode lo inseguono. Il Diavolo li lega tutti a una corda di campana, suonando poi con le bacchette su le loro teste. Eunomia e Tallio (e come loro molte altre giovani coppie) approfittano della confusione per fuggire. Le ore suonano una dopo l'altra all'impazzata; la luna sorge e tramonta a precipizio. Le persone si affrettano a compiere velocemente ogni azione consueta. Finalmente il Diavolo scaraventa i vecchi e il Custode giù dal campanile. Gli uomini fumando instancabilmente hanno oscurato l'atmosfera; ma il sole sorge e la tinge d'oro.
L'autore ha immaginato però un altro finale che può essere eseguito col soccorso del cinematografo per presentare scene e persone capovolte. Eccone in succinto la trama:
La luna attraversa precipitosamente il cielo; poscia ricompare, ma si arresta allo Zenit «in panna». Il diavolo con un balzo la raggiunge e con le bacchette la percuote costringendola a retrocedere e a tramontare a levante. Allora nella città tutto si capovolge e comincia ad andare a ritroso. Il diavolo inorridito e preoccupato si rivolge ai fanciulli innocenti e sani affinchè facciano riprendere a uomini e cose la loro retta posizione e il loro giusto cammino. Tutto, infatti, ritorna alla normalità: la luna riappare da oriente per tramontare ad occidente. La folla gioisce e danza: spunta il sole!
Quest'opera bizzarra è una satira mordace della vita metodica, abitudinaria, quale si svolge per molta gente tutti i giorni, alle stesse ore, nella stessa monotona maniera. È la satira di coloro che hanno un superstizioso e comodo orrore di ogni novità; una divertente presa in giro del più stucchevole conservatorismo casalingo e intellettuale. Esso trova le sue principali espressioni nella melensa canzone del Custode «L'ora, il sistema, il metodo», che costituisce una specie di comico «Inno nazionale», e nei vari commenti dei vecchioni, pieni di compiaciuta prosopopea o di allarmati brontolii.
Si capisce quindi come, al suo apparire, una tale opera abbia suscitato tante discussioni e tante ire, poichè essa è anche la parodia di tante inveterate e sciocche consuetudini e regole melodrammatiche. Diciamo però sùbito che mentre il soggetto del «grottesco» si toglie dalle consuete forme teatrali e vi si pone contro, la musica non vuol essere un atto di ribellione alle regole d'uso. È una musica che tiene conto delle nostre tradizioni vocalistiche, da quelle madrigalesche (come, ad esempio, nel canto a tre voci: Eunomia, «l'Ora protettrice dell'ordine legale»; Irene, «la Pace»; e Dice, «la Giustizia»), a quelle del teatro operistico moderno, giungendo alle forme modernissime, fra le quali ultime fanno capolino e si danno la mano gli stili di Strauss e StrawinskL Queste forme sono usate indifferentemente a seconda che si presentava all'autore uno scopo puramente lirico od uno satirico, una necessità sentimentale o parodistica, espressiva o descrittiva. Però l'Autore riconosce un limite anche all'audacia modernista, perciò di recente esso ha preparato un nuovo finale nel quale pone in caricatura lo stile dodecafonico. La satira è dunque contro i due estremismi. La partitura è sempre polifonicamente densa e ricca di colori e di atteggiamenti mutevolissimi, con abbondante uso di variazioni ritmiche armoniche, strumentali, melodiche dei principali temi. Talvolta però la linea e lo stile si frantumano contro il continuo svariare dell'azione nei suoi minuti particolari.
Poichè «grottesco», e non «melodramma», lo ha denominato l'autore, saremmo fuor di strada se volessimo cercare ciò che di solito ci diverte in un'opera buffa del nostro vecchio repertorio. Tuttavia la satira sapida, l'ironia piccante, la caricatura, qui a tocchi leggeri, là a chiazze pesanti, riesce di continuo divertente. Ora sono tratti volutamente melodrammatici, secondo i modi rettorici del primo ottocento; ora l'autore si fa gioco del sentimentalismo. Tipica, in tal senso, la marcia funebre suonata da una banda con espressione «esageratamente lagrimosa» allorchè il Diavolo inizia la sua allegra demolizione del quieto mondo dei vecchioni, che vien sepolto in un ridevole funerale. Da notare che il motivo che le donne cantano è ... l'«Inno nazionale», mentre l'orchestra contrappunta con variazioni dello stesso motivo, in un giuoco quasi inavvertibile per la sua naturalezza e spontaneità. Del resto il motivo di questo «Inno» è soggetto nel corso dell'opera a numerose variazioni.
C'è poi la satira del canto fiorito (canto di Eunomia: «O Eunomia, o Dice, o Irene»), ed anche la satira del verismo in musica, come per esempio i gesti di Tallio allorchè dipinge; la satira del ronzìo del tafano. E c'è la satira morale: quella dell'educazione dei bimbi nella marcetta: «Con ritmo pari e rigido», la quale coi suoi ritmi compassati e pedanteschi è il contrapposto preciso della marcia sbarazzina e ritmicamente vivace dei monelli della Carmen. Curiosissima è poi l'interpretazione grottesca che il Lualdi ha dato della scolastica forma della «fuga». Egli fa uso infatti di questa complessa forma contrappuntistica nella scena in cui Tallio veste la vecchia moglie da divinità greca per servirsene come modella; e a piè di pagina il Maestro così commenta: «Quando il pittore Tallio camuffa una vecchia e repellente donna come Irene da statua greca, agisce come un musicista che da un tema romantico e sdolcinato tragga la forma musicale classica per eccellenza: la fuga. E se il tema si trasforma e gonfia sempre più, divenendo ampollosissimo, gli è perchè anche Irene si trasforma e gonfia sempre più, divenendo grottescamente grandiosa». Questa nota, desunta dallo spartito musicale, non c'è nel libretto, perciò l'abbiamo riportata affinchè chi ascolta si renda conto del perchè la «fuga» che il musicista svolge in questo momento, assuma un'espressione tanto enfaticamente ampollosa.
L'ultima satira, che forma il nuovissimo finale, è quella della dodecafonia. Allorchè il Diavolo salta su la luna e la costringe a retrocedere, si ode in orchestra una «Passacaglia del mondo alla rovescia» (così l'ha chiamata l'autore) formata da 13 variazioni costruite su i cinque più importanti motivi dell'opera, ciascuno di essi trasportato in una sua personale serie dodecafonica. Il «basso fondamentale» delle 13 variazioni è dato dal trasporto in serie dodecafonia del motivo d'apertura dell'opera (quello su cui più tardi Carpofonte, Irene e i Quattro Vecchi Mariti canteranno: «Oh, gioventù perversa». La trasposizione dodecafonica di questi motivi ne sconquassa completamente la melodicità rispettandone il ritmo. Da tale massacro sono esclusi i motivi dell'amore, per un rispetto a questo sentimento, forza unica della vita, e come tale non soggetto a satira o a dileggio.
L'effetto di questa «Passacaglia del mondo alla rovescia» è orripilante: l'intera città è rovesciata col cielo e i tetti delle case in basso e la terra in alto; le persone camminano con la testa e ... ragionano coi piedi! Il Diavolo stesso ne inorridisce, e si raccomanda ai fanciulli, che rappresentano l'innocenza, la sanità e la purità dello spirito, di raddrizzare il corso della vita. Si ritorna allora al sistema diatonico, e la vita normale riprende.
In mezzo a tutto questo continuo parodiare, irridere e satireggiare, una cosa si salva: l'amore, che si espande in una felice onda di canto lirico nel duetto fra Tallio ed Eunomia, a cui serve di contrappunto il brontolìo dei due vecchi amici Irene e Carpofonte. Accanto al duetto va ricordata la graziosissima arietta di Eunomia: «Marito mio, marito mio». L'«esagerata timidezza» indicata sul canto dall'autore si traduce in verità in un'espressione tutta vezzi civettuoli.
Ma il colmo del grottesco è raggiunto con la comparsa improvvisa del Diavolo e con le sue gesta che mandano a soqquadro la pacifica e metodica vita dei vecchioni. Anche la musica partecipa, naturalmente, dello scompiglio generale. Non solo campane, campanelli, cariglioni, cucù, e quaglie dei numerosi orologi (la partitura ne sovrappone tredici) si mettono a suonare disperatamente vari motivi in forma di «cànoni infiniti» (fra cui anche la nota canzone: «Fra Martino, campanaro» negli orologi grandi), ma lo xilofono interviene con un'infernale suonata: quella che il Diavolo eseguisce con due bacchette da timpani su le teste dei vecchioni; e l'orchestra impazzisce sovrapponendo anch'essa diversi motivi, tra i quali anche, velocissimo e sonorissimo, quello della serenata del Mefistofele: «La luna immobile innonda l'etere», allorchè la luna sorge e tramonta a precipizio nel cielo. Su tutti naturalmente sovrasta il motivo del custode: «L'ora, il sistema, il metodo», poichè è proprio tutto ciò che va a catafascio. E perchè il finimondo sia più babelico e vertiginoso, tutte queste parti (alle quali si deve anche aggiungere la banda con la Marcia funebre) sono spregiudicatamente in tonalità diverse l'una dall'altra, e mettono capo alle variazioni dodecafoniche di cui dianzi s'è detto, il che potrà anche scandalizzare le anime timorate per il dissonantismo pazzesco che ne risulta, ma in questo caso il risultato è di un effetto esilarante.
GIACOMO PUCCINI - TURANDOT: dramma lirico in 3 atti e 5 quadri. Prima rappresentazione postuma il 25 aprile 1926. Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, tratto liberamente dall'omonima commedia di Carlo Gozzi.
Atto 1° - Le mura di Pekino. A destra il loggiato della Reggia. Presso la porta è appeso un gong. - Un Mandarino annunzia che il Principe di Persia, non avendo saputo sciogliere i tre enigmi proposti dalla Principessa Turandot a chi aspiri alla sua mano, secondo la legge verrà decapitato al sorgere della luna. La folla eccitata dall'idea del sangue si agita tumultuando. Un vecchio è travolto; la ragazza che l'accompagna chiede aiuto, e un giovane accorre e riconosce nel caduto suo padre. Il giovane è il Principe Calaf, e suo padre è Timur, Re tartaro, che ha perduto il regno dopo una sfortunata battaglia, e che la schiava Liù ha condotto in salvo per amore del Principe che un giorno le ha sorriso. Intanto, invocata dalla folla prostrata, sorge la luna, e il Principe di Persia viene condotto al supplizio. Vedendolo giovane e bello, la folla passa dalla ferocia alla pietà, e invoca Turandot affinchè gli faccia grazia. La Principessa appare al loggiato e ripete con un gesto la condanna. Calaf alla vista di Turandot se ne innamora di colpo follemente e vuol suonare il gong che annunzia alla Principessa l'arrivo di un aspirante alla sua mano. Ma i tre ministri Ping, Pang e Pong lo fermano. Invano essi, Timur e Liù lo sconsigliano dal tentare l'impresa; Calaf insiste e batte i tre colpi fatali.
Atto 2° - Quadro 1° - Padiglione decorato da simboliche e fantastiche figure cinesi. - I tre ministri rimpiangono la tranquilla vita dei tempi andati, imprecando alla capricciosa crudeltà di Turandot per la quale già dodici principi sono andati al patibolo. Prevedono prossima la fine della dinastia imperiale, e sognano la pace delle loro case in campagna. Ma squillano le trombe: si prepara la gara degli enigmi, e i tre Ministri se ne vanno malinconici.
Quadro 2° - Vasto piazzale della Reggia. Al centro unenorme scalea di marmo, al sommo della quale sta il trono dell'Imperatore. - La folla invade la piazza e inneggia all'Imperatore, in attesa che abbia luogo la gara. Turandot ricorda che una sua ava lontana fu trascinata schiava da un straniero. Per vendicarla essa ha giurato che nessuno l'avrà. Invano l'Imperatore invita l'ignoto Principe a recedere dal suo proposito mortale: Calaf, insiste. Turandot gli propone tre enigmi che egli scioglie; ma la vinta Principessa si raccomanda al padre affinchè non la dia in balia dello straniero. Calaf allora le chiede di scoprire il suo nome: se prima dell'alba essa riuscirà a conoscerlo, egli morirà.
Atto 3° - Quadro 1° - Il giardino della Reggia. - Per tutta la notte nessuno ha dormito in Pekino. Un editto di Turandot impone, pena la morte, di rivelare prima dell'alba il nome dell'ignoto; ma Calaf si tiene sicuro della vittoria: nessuno lo conosce. I tre ministri gli offrono in dono oggetti preziosi e bellissime fanciulle purchè se ne vada; ma Calaf non accetta: egli vuole Turandot. Alcuni sgherri conducono Timur e Liù, i quali sono stati visti parlare con l'ignoto. La Principessa viene chiamata ad interrogarli. Per salvare Timur, Liù dichiara che essa sola conosce il nome dello straniero, ma che non lo dirà. Sottoposta a tortura, temendo che il nome le sfugga, si uccide, dichiarando che ama il Principe sconosciuto come fra poco lo amerà Turandot., La suicida viene portata via, seguìta dalla folla sgomenta; ma il suo sacrificio non è stato vano. Turandot perde la primitiva durezza; Calaf l'afferra, la bacia e poscia le dice il suo nome.
Quadro 2° - La scalea del 2° atto. - Turandot si presenta all'Imperatore e gli annuncia emessa conosce il nome dello straniero: «Il suo nome è Amore!», esclama, e fra il giubilo di tutti si getta fra le braccia di Calaf!
Ancora una volta Puccini ha fatto tesoro di ogni esperienza tecnica esterna, e con una facoltà più unica che rara ha assimilato quanto di più moderno gli permetteva di accrescere la sua forza espressiva. Il canto vocale però sovrasta sempre nitido su la sinfonia orchestrale. Anche nell'applicazione del politonalismo c'è una linea tonale che emerge su le altre e dona chiarezza a tutto l'edificio. 'Inoltre ad ogni intorbidamento armonico segue una schiarita che toglie lo spasimo e ridona il respiro, senza che perciò ne soffra l'unità stilistica.
Politonalismo, tonalismo, cromatismo, esatonalismo, modi orientali (anche la scala a cinque note già usata nella Butterfly), spunti tematici di melodie cinesi, e perfino dell'inno imperiale cinese, tutto è fuso e trasfigurato in uno stile che, senza annullare la migliore e più antica sensibilità melodica pucciniana, ha acquistato in ricchezza costruttiva, descrittiva ed espressiva. Questi modi nuovi hanno reso necessari adattamenti della melodia a disegni un po' diversi da quelli usati precedentemente, ed anche ritmicamente più sciolti.
Con un soggetto in cui il realistico sconfina nel fiabesco, e dove gli elementi medesimi della favola assumono di volta in volta atteggiamenti drammatici, coreografici, ironici, umoristici, grotteschi e sentimentali, l'orchestra ha una parte che non è più solo di accompagnamento o di commento, ma è la vita del dramma, e si compenetra con il canto che non ha quasi più valore preso a sè. Le forme chiuse non mancano, ma si agganciano le une alle altre, si snodano le una dalle altre, formando un blocco unitario. E il colore tutto amalgama e imbeve di sè; colori densi, decorazioni sovraccariche, timbri sorprendenti, colori-luci e colori-aromi: un insieme di una fantasiosità calda, affascinante.
Dopo il 2° atto della Bohème Puccini non aveva avuto più occasione di dipingere grandi movimenti di masse. Il 1° atto della Turando! gliene ha offerto una nuova. Ma mentre nella Bohème il movimento si limitava al viavai e al vocìo di una folla festante in un quartiere parigino del secolo XIX, qui siamo di fronte a masse di popolo orientali e primitive, ondeggianti da sentimenti di ferocia a quelli di preghiera, da quelli di pietà a quelli di superstizione, in ambiente tra il leggendario e il favoloso. Questo 1° atto è quasi esclusivamente corale. Subito dopo la lettura della condanna del Principe di Persia, ci investono le urla di «morte!» cui seguono il coro barbarico dei servi del boia «Ungi, arrota», e l'estatica e mistica invocazione alla luna sopra un misterioso brusio d'archi, tintinni d'arpe, e scivolamenti di flauti e celeste, simili a vapori che si dissolvano innanzi alla sorgente luna: una delle pagine più nuove e indovinate di tutta l'opera. Poi è la volta del coro di ragazzi: «Là, sui monti dell'Est», la cui melodia diventa il tema di Turandot, cui segue la malinconica processione che conduce il Principe di Persia al patibolo, fra il compianto della folla improvvisamente impietosita, chiusa dalla tetra invocazione dei Sacerdoti: «O gran Koung-tzè». Sorvoliamo sul misterioso coretto delle ancelle: «Silenzio!» e la macabra apparizione dei fantasmi di coloro che morirono per Turandot, e su altri interventi corali minori.
Nel 2° atto il coro ha più che altro valore decorativo, specie all'arrivo del corteo imperiale, il cui sfarzo è reso dall'orchestra con coloriti sgargianti e ritmi energicamente marcati. Ma nel 3° atto il coro partecipa di nuovo alle vicende dell'azione, rendendola più viva.
Una creazione caratteristica è quella delle tre maschere: Ping, Pang, Pong, che rappresentano il buon senso realistico di fronte alla follia amorosa di Calaf, alla crudeltà della donna, e all'irrealtà della fiaba. La loro comparsa nel 1° atto si svolge su melodie a ritmi stecchiti, marionettistici, che differenziano bene questi tre personaggi da tutto il resto. Nel 2° atto la loro conversazione è cesellata con finezza musicale di colori e di armonie a carattere umoristico e sentimentale, su cui si stende un velo di nostalgia che culmina nella melodia: «Ho una casa nell'Honan». Ma nell'ultimo atto l'amore della propria pelle getta anche sulle maschere una smorfia di crudeltà grottesca.
Timur è delineato, nei pochi momenti in cui compare, con tratti di umana bontà e di dolore. Calai, tutto preso dal suo folle e cieco ardore per Turandot, è insensibile ad ogni altro sentimento. Il suo commosso e accorato: «Non piangere, Liù», costituisce un'unica ma notevolissima eccezione. È questa infatti una delle più larghe e belle melodie dell'opera, anche più della pur celebre romanza: «Nessun dorma», in cui vibra il caldo presentimento della prossima vittoria.
Turandot è quasi tutta nel luminoso motivo del coretto «Là, sui monti dell'Est», che ne accompagna ogni apparizione. Ma la sua intimità femminile e la sua fierezza ci sono svelate dalla sua rievocazione dell'ava Lou-Ling, su un motivo sognante (impressione di sogno accresciuta dal movimento ondulato dell'orchestra) a cui segue, mentr'ella grida: «Mai nessun m'avrà», un motivo largo che esprime in modo appassionato l'eccelsa purezza della sua solitudine.
Ma la giovane Liù è figura musicalmente più sentita, piena di umana eroica bontà. Dal tono supplichevole dell'aria: «Signore, ascolta!» si espande un'infinita tenerezza che nel 3° atto, alla confessione: «Tanto amore segreto», assume gli accenti di uno struggimento pronto al sacrificio supremo della vita. Ed ecco che nell'ultimo canto: «Tu che di gel sei cinta», l'accettazione di questo sacrificio detta al musicista una melodia che per la purità del dolore per l'intonazione profetica, per il senso di sublime eroica rinunzia, per quel continuo vacillare del ritmo in cui sembra di avvertire improvvisi mancamenti del cuore, per quegli spasimi continui dei disaccordi che si ripetono su ogni nota, è una delle più suggestivamente intime ed espressive, se non forse la più intima ed espressiva, fra quante Puccini abbia scritto. E fu l'ultima! Con suono quasi immateriale questa trenodia dell'amore eroico accompagna il trasporto del cadavere di Liù, «Liù bontà, Liù Poesia!», e si perde in un sospiro sovracuto e spirituale dell'ottavino. «A questo punto il Maestro è morto».
L'ultimo duetto e la scena finale furono composti da franco alfano valendosi dei fondamentali motivi dell'opera e di qualche accenno di motivo lasciato in appunti dal compositore. Se ne avverte la frammentarietà, e se ne avvertono le connessioni in uno stile che amorosamente si sforza invano di essere pucciniano, ma che ha una sua nobiltà artistica. Tuttavia, dopo la tragedia di Liù, quest'ultima scena, che mira a ricondurci nella favola per risolverla lietamente, appare superflua ed anche urtante. Siamo del parere che l'opera finirebbe meglio là dove la morte fermò la penna del Maestro.
ILDEBRANDO PIZZETTI - FRA GHERARDO: dramma in 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 16 maggio 1928. Libretto dello stesso Pizzetti.
Atto 1° - Parte 1a - Il cortile della casa di Gherardo a Parma sulla fine di maggio del 1260, verso l'Ave Maria. - Il ricco tessitore Gherardo dona ogni suo avere ai poveri in obbedienza a un sentimento religioso che lo spinge a imitare gli Apostoli. Alcuni ricchi gaudenti lo irridono; una fanciulla orfana. Mariola, lo difende, Gherardo rimasto solo con lei è agitato dalla sua bellezza, e temendo in lei un'insidia del Demonio, la scaccia. Ma appena su la strada, due soldati ubbriachi tentano di impadronirsene. Gherardo accorre e la riconduce nel cortile; ma tosto lo assale un impeto di desiderio. Essa, che l'ama, gli si abbandona e Gherardo la conduce in casa.
Parte 2a - La stessa scena. - È l'alba. Gherardo è preso da orrore per quanto ha fatto, e convinto di essere stato vittima di una tentazione del Demonio, scaccia duramente Mariola. Essa parte con dolore perdonandogli. Intanto passa una compagnia di flagellanti alla quale Gherardo si unisce per far penitenza.
Atto 2° - Una piazzetta, centro di stradette e vicoli fra la Porta di Santa Croce e il torrente, presso la casa dei Putagi e la chiesa. Al 16 di luglio 1269, al tramonto. - Dopo nove anni di assenza, Fra Gherardo è ritornato a Parma in fama di Santo. Un frate, Simone, lasciando credere che Gherardo fa miracoli, si fa consegnare alcuni gioielli da una madre che ha un figlio malato; ma Fra Gherardo lo smaschera per ladro e offende la madre che piangeva pel figlio malato. La madre lo maledice. Ma Gherardo si rivolge poi al popolo dichiarando che vuole aiutarlo a combattere contro i signori il Vescovo e il Podestà che lo opprimono, e lo invita a ritornare armato per la lotta. Rimasto solo gli si presenta Mariola, la quale, ancora innamorata di lui, gli racconta i patimenti sofferti dopo ch'gli la scacciò, e la morte del bimbo nato dal loro amore. Gherardo si umilia ai piedi di Mariola col rimorso atroce del male compiuto. Frattanto Frate Simone per vendicarsi di Gherardo lo ha denunciato al Podestà che lo fa arrestare. Mariola allora fa suonare a stormo la campana della chiesa, e alla folla accorsa annunzia l'arresto di Gherardo. Il popolo giura di liberarlo.
Atto 3° - Parte 1a - Stanzone a pian terreno del palazzo vescovile. È la mattina del 18 luglio 1269. - Il Podestà e il Vescovo vogliono convincere Gherardo a dichiararsi colpevole di eresia innanzi al popolo. Per vincerne l'ostinazione gli fanno credere che Mariola è stata arrestata e che solo confessandosi colpevole potrà liberarla. E Gherardo acconsente.
Parte 2a - La piazza maggiore di Parma. A sinistra la facciata del Duomo, in fondo il Battistero, a destra il palazzo Vescovile. - La folla tumultua, trattenuta a stento da alabardieri. Nella mischia un ragazzo è ucciso da un soldato. Intanto Gherardo viene condotto in piazza; egli incomincia la ritrattazione di ogni sua predicazione, ma a un certo punto la sua coscienza si ribella ed egli si rifiuta di continuare. Teme però di avere compromessa la libertà di Mariola, ma essa è là tra la folla, e lo approva. Il Podestà ordina di arrestarla, ma la madre del giovinetto ucciso, la colpisce con una coltellata nella schiena. La sua morte fa ammutolire d'orrore la folla che si inginocchia. Gherardo, come impazzito pel dolore, s'avvia al supplizio.
Il sistema pizzettiano del recitativo aderente alla parola parlata è impiegato con estremo rigore quasi ovunque. Questa forma, che non è recitazione pura e non è canto,' si risolve in una rinunzia alla possibilità di caratterizzare musicalmente i personaggi. È un recitativo sillabico che nella maggior parte dei casi manca di incisività per voler essere troppo più veristicamente attaccato al suono della parola parlata che a quell'intima musica che nasce dall'anima commossa di chi la parola pronuncia. Ma nel Fra Gherardo il recitativo a volte si risolve anche in canto e prende andamento vocale melodizzante, e allora acquista una penetrante forza di commozione. È in queste pagine che noi possiamo trovare la più chiara individuazione dei personaggi. Per Fra Gherardo non sono le sue enfasi predicatorie che più ne pongono in rilievo i lineamenti psicologici, ma gli atteggiamenti più intimamente mistici, come il racconto biblico: «Un giorno Gesù stava a mensa», che si muove su un sognante accompagnamento ondulato (e non importa se è un pezzo chiuso e se arresta un istante la corsa del dramma, che nessuna ragione estetica vieta di soffermare in oasi contemplative come questa); o sono i pensieri suggeritigli dalla sua fantasia erotica, come quando dice a Mariola: «E ti compiacerai vedere accendersi di te la cupidigia dentro gli occhi degli uomini». E più decisamente allorchè, dominato dall'impulso dei sensi, abbraccerà Mariola e la condurrà in casa, mentre l'orchestra svilupperà la supposta scena d'amore nei suoi trasporti passionali, negli abbandoni sensuali, e nei turbamenti mistici, in un brano sinfonico di rara potenza.
Ma la pagina più profonda nei riguardi di Gherardo, quella che esprime la sua dolorante sensibilità di padre e il suo inconsolabile rimorso, che ferma il momento in cui Mariola si trasforma per lui da creatura del Demonio in eroina aureolata dalla maternità e santificata dal martirio, è il suo pianto desolato: «Vorrei che Dio mi concedesse», recitativo che finalmente si trasfigura in canto drammatico. Qui Gherardo non si accontenta di avvolgersi in una più o meno concitata atmosfera orchestrale, ma assume finalmente attraverso al canto una fisonomia che è la rivelazione stessa della parte migliore della sua anima. Nell'ultimo atto invece, allorchè difende Mariola innanzi al Podestà e al Vescovo, è soprattutto il disegno affannoso dell'orchestra, un disegno che sembra uscito dal Don Carlo di Verdi, che ci dice l'intima angoscia di Gherardo; mentre poco dopo, al grido: «Signore Iddio», è di nuovo attraverso al canto che prorompe il suo disperato fervore.
Mariola è disegnata con più intima e delicata sensibilità poetica. Il primo motivo che la caratterizza, e che compare la prima volta allorchè la voce rabbiosa della zia la chiama mentre essa sta parlando con Gherardo, poco dopo che se ne sono andati i mendicanti, è un motivo garrulo e fresco, di uccelletto cui canta nel cuore il sorriso della primavera serena della vita. Quest'emozione di giovinezza riappare poco oltre, allorchè essa esclama: «Son bella, dici». Al ricordo della notte d'amore il suo recitativo si espande e si flette in onde canore, anche fiorite di volute meliche, nell'ultima scena del 1° atto, dalle parole: «Inginocchiato ai miei piedi dicevi». Sono pagine che costituiscono un vero e proprio pezzo chiuso, anche se non stronco. La martire e la madre appaiono invece nel racconto del 2° atto: «Sì, me ne andrò, Gherardo», in cui il recitativo si affida all'intensità espressiva di chi più che cantare deve declamare, ma l'orchestra prende su di sè il dramma, e, attraverso a motivi pieni di stanca sofferenza che si alternano al tema soavissimo e triste del bimbo morto, ci afferra il cuore con un'indicibile tenera angoscia. Quasi da ogni nota sentiamo uscire un tremito di pianto contenuto che preme disperatamente sul cuore della donna e che la sublima. Altrettanto commosso e toccante è il suo canto, anche se gli accenti echeggiano l'intonazione pucciniana, nella breve scena della morte, preparata dall'esclamazione piena di smarrito stupore del coro.
Bene scolpito nei suoi recitativi austeri e nel solenne autoritario squillo dei corni, il personaggio del Vescovo, pure nella sua breve parte. Indimenticabile è poi il pianto disperato della madre a cui viene ucciso il figlio (il suo grido ricorda: «Piccolo iddio» di Butterfly) su una trenodia corale e strumentale, stesa in una densa forma di concertato con un'espressione piena dì grave e penetrante dolore.
Nel 1° atto sono anche ritratti con gustoso realismo i due soldati ubbriachi, specie attraverso alla canzone provenzale: «A l'entrada del tems clar», e alla canzonaccia volutamente più volgare «L'oste di Chiarofonte», con quella caratteristica alzata di voce di uno dei due, come di chi non sa stare in tono o è trascinato dal vino ad urlare.
C'è poi il coro, personaggio dalle molte voci, che secondo la tendenza generale degli operisti del novecento non è più una massa sonora decorativa di sfondo, ma viene in primo piano come attore. Con senso realistico e musicale insieme il Pizzetti tratta il coro polifonicamente, mettendone in rilievo i movimenti non simultanei, a volte anche contrastanti, con l'intreccio delle parti, con l'energia dei ritmi, e sostenendolo con un orchestrale anch'esso ricco di moto polifonico, di timbri e di temi efficaci. Basterà ricordare la fervente animazione del finale 1°: «Chi confessa il suo peccato», il robusto e violento inno di rivolta: «Quando il popolo di Parma», la partecipazione alla trenodia del 3° atto, dove il coro è diviso in due gruppi, uno con espressione di lamentoso compianto, l'altro, in unione al «Rosso» che sobilla la plebe contro Gherardo, d'espressione irritata e torbida. Il coro non è più dunque un manichino più o meno cantante e decorativo, ma è una folla di creature vive ed attive.
Quanto all'orchestra, sempre ricca e varia di colori efficacemente appropriati, essa costituisce il fulcro dell'opera, poichè per nove decimi il dramma è nell'orchestra. È un tessuto polifonico talvolta forse troppo denso, spesso politonale, di temi i quali più che caratterizzare questa o quella figura scenica creano attorno ad esse un'atmosfera di dolore o di amore, di contemplazione o di tempesta, di stupore angoscioso o di risoluzione audace, con una tendenza quasi generale alle. intonazioni tristi, a cominciare dal motivo malinconico che apre e chiude l'opera con un'espressione che non è solamente campeste e popolaresca ma tipicamente emiliana.
OTTORINO RESPIGHI (Bologna 1879 - Roma 1936) - MARIA EGIZIACA: Trittico per concerto. Prima rappresentazione alla Carnegie Hall di New York il 16 marzo 1932. Mistero di Claudio Guastalla.
1° episodio - Un grande trittico chiuso. Due angeli bianchi ne aprono i portelli. Nel primo quadro appare il porto di Alessandria. Una nave è accostata. - Maria, venutale a noia la vita di taverna, chiede ad un marinaio di prenderla a bordo per andare in cerca di nuova gioia: il suo corpo sarà lo scotto. Un Pellegrino mette in guardia il marinaio affinchè la nave non affondi sotto il peso dei peccati della femmina impudica. Ma il marinaio, sedotto dalle lusinghe di Maria, la prende con sè.
2° episodio - Si svolge nel 3° quadro del trittico, che rappresenta la porta del tempio di Gerusalemme, dove nel giorno dell'Esaltazione della Croce si mostra ai fedeli il Legno Santo. - Un povero e un lebbroso entrano nel Tempio. Maria giunge accompagnata da una cieca che entra pure nel tempio. Anche Maria vorrebbe entrare, ma il Pellegrino glielo vieta. Maria noncurante di lui fa per entrare, ma una forza ignota la ferma su la soglia, innanzi alla quale appare un Angelo, che tosto scompare. Maria si prosterna supplichevole, bacia la soglia e si dice pronta a far penitenza. La voce dell'Angelo allora la consiglia a varcare il Giordano e raggiungere l'eremo. Maria, trasfigurata, getta un grido di gioia ed entra nel Tempio.
3° episodio - Si svolge nel quadro centrale del trittico, che rappresenta il deserto e la grotta dell'abate Zosimo. Si vede un leone in atto di scavare una fossa; poi il leone si dilegua, - Zosimo uscendo dalla grotta scorge la fossa e pensa si tratti di un segno inviatogli dal Cielo per annunziargli che è giunto il giorno della morte. Ma ecco, giunge Maria, vecchia, cadente, la quale gli dice che la fossa è stata scavata per lei, e gli rivela il suo nome chiedendogli l'assoluzione dei suoi tanti e gravissimi peccati. Ma Zosimo la dice beata. E Maria spira su l'orlo della fossa, mentre Zosimo la benedice, e in Cielo cantano gli Angeli.
È musica còlta, in cui echeggiano i modi del canto gregoriano, e quelli dell'opera italiana secentesca. Questi modi dànno una patina di antico al trittico, ma spesso la cultura è troppo scoperta e toglie ogni sapore di ingenuità e di spontaneità a questa patina. È l'antico rifatto da un moderno, con abilità e molto buon gusto, ma anche con sensibile erudizione e con qualche preziosità. Talvolta l'amore per Fantico arriva fino all'appropriazione non solo delle maniere ma dai motivi di autori delle epoche passate. È il caso del motivo iroso del Pellegrino allorchè rampogna Maria, tolto di peso (canto e accompagnamento) dall'invocazione di Medea nell'opera Giasone di Francesco Cavalli. I vibrati ripetuti accordi, il tempestoso salire e scendere del canto raggiungono un'efficacia drammatica potente, che il Respighi accresce con opportune varianti, con nuovi sviluppi armonici e melodici, e con uno strumentale robusto e incisivo. Così il musicista fonde agli elementi derivati dalla nostra arte antica, specialmente del Monteverdi e del Cavalli, la sua personale moderna sensibilità, senza che fra le due fonti di ispirazione appaia un qualsiasi attrito. Talvolta anzi la personalità del compositore si afferma in modo più libero, pure conservando un lontano sentore classico sia nella forma generale che nel modo di flettere il periodo melodico. Affiorano allora alcune delle più belle ispirazioni del trittico. Alludiamo specialmente all'espansiva malinconia del marinaio nella canzone del 1° atto, all'irruente scatto di Maria: «Schiuma il tuo furore», all'aria intensamente meditativa: «Che faremo, anima mia», e alla religiosa preghiera: «O bianco astore» nel 2° episodio, cui segue la candida ed umile invocazione: «O Salutare», e l'agitata confessione di Maria, alla quale risponde la voce dell'Angelo, gorgheggiante come la Fata della Cendrillon massenetiana, e il giubilante coro celeste. Sono questi i momenti fondamentali del Trittico, quelli della conversione di Maria; e spirano un commosso fervore che ci rappresenta la peccatrice trasfigurata e redenta.
Un fatto importante resta sempre questo, che non ostante la strumentazione ricca e colorita, secondo lo stile e il gusto finissimo di questo fra i più sensitivi e sapienti coloritori orchestrali nostri, la parte vocale predomina sempre con schiettezza di accenti e semplicità di lineatura, non solo nelle arie e nei duetti, ma anche nei recitativi melodizzanti che, pure echeggiando, come si diceva, il fare del recitativo secentesco, aderiscono al testo con modernità di sentimento lirico.
Infine «Il duetto fra Zosimo e l'Egiziaca - scriveva il Cesàri - è di un respiro largo, possente; la musica s'innalza verso la zona della beatitudine; immune da effetti teatrali, pianeggiante in una atmosfera celestiale. E, nel canto angelico finale, spicca l'ultimo volo». In questo duetto sono da osservare due momenti ben distinti e ugualmente importanti: il primo è il febbrile ed ansioso canto di Maria: «Ah, dimmi che le lagrime», che sembra ispirato al disegno pieno d'affanno e di pena degli archi nella scena della macina nel 3° atto del Sansone e Dalila di Saint-Saëns; il 2° è l'estatico duetto a cànone fra Zosimo e Maria: «L'ombra dei dì perduti».
I tre pannelli del Trittico si seguono senza sosta, malgrado il lungo intervallo di tempo che si immagina trascorso fra il 2° e il 3°, collegati fra loro da due chiari ed espressivi intermezzi orchestrali. Il primo descrive il viaggio di Maria e dei Marinai: tumultuosamente orgiastico (ma senza cadere mai in espressioni voluttuosamente sensoriali), in contrasto con lo sdegnoso motivo del Pellegrino. Il secondo, nell'assillo di un ripetuto insistente gemito, nell'ostinazione dei pedali e nell'intrecciarsi di temi tortuosamente meditativi, descrive l'aspro tormento e la macerazione della peccatrice.
ALFREDO CASELLA (Torino 1883 - Roma 1947). - LA DONNA SERPENTE: opera fìaba in un prologo, 3 atti e 7 quadri. Prima rappresentazione al Teatro dell'Opera di Roma il 17 marzo 1932. Libretto di Cesare Lodovici tratto dall'omonima fiaba di Carlo Gozzi.
Prologo - Miranda, figlia del Re delle Fate Demogorgòn, vuole andar sposa ad Altidòr Re di Téflis. Invano le fate tentano di dissuaderla. Demogorgòn allora decreta che per nove anni e un giorno Altidòr dovrà ignorare chi ella sia. Se egli non la maledirà, anche vedendola compiere le cose più atroci, diventerà sua sposa; se invece la maledirà, essa diventerà serpente, e tale resterà per duecento anni.
Atto 1° - Quadro 1° - Orrido deserto. - Alditruf (Truffaldino) racconta ad Albrigòr (Brighella) che dopo nove anni di convivenza tra Miranda e il Re Altidòr, questi sforzò un cassetto per sapere chi era la sposa e di dove veniva. Immantinenti il castello, la sposa e i due figlioletti scomparvero. Giunge poi Altidòr con l'aio Pantùl (Pantalone). Questi varrebbe farlo tornare presso suo padre per difenderne il regno, stretto d'assedio dai Tartari; ma Altidòr congeda Pantùl dichiarando che non ritornerà a Téflis fino a che non avrà ritrovati la sposa e i figli. Invano il Gran Visir Tògrul fa compiere incantamenti dal mago Geònca.
Quadro 2° - Appare la reggia di Miranda. - Altidòr e Miranda si rivedono, e la sposa gli fa giurare che non la maledirà, qualunque cosa più atroce e nefanda essa abbia a compiere per volontà del destino. Poscia le Fate la trascinano con loro acclamandola Regina.
Atto 2° - Quadro 1° - Deserto come nell'atto 1°, salvo che una montagna ha cambiato posto. - La notte fu piena di prodigi sinistri: tutti ne sono allarmati. Mentre una corifea e un coro di nutrici recano al Re notizie di Miranda, accade un violento terremoto, e su una rupe appare Miranda coi figlioletti, circondata da fiamme. Altidòr e il Gran Visir che si slanciano per salvarli restano di pietra. A un cenno di Miranda alcuni sgherri afferrano i piccoli e li scagliano nel fuoco, ma, pur inorridendo, Altidòr non la maledice.
Quadro 2° - Gran sala nella reggia di Téflis. - La città è assalita dai Tartari. Altidòr apprende che il nemico è guidato da Miranda, e in preda alla disperazione e all'ira maledice la sposa. Miranda allora compare, rimprovera ad Altidòr il suo spergiuro, lo informa del decreto di Demogorgòn, e sotto i suoi occhi si trasforma in serpe e fugge, mentre vivi ritornano i figli.
Atto 3° - Quadro 1° - Oscurità completa. - S'ode la voce di Miranda piangere la propria infelicità e il coro consolarla. Al sopravvenire della luce appare la reggia di Téflis come al 2° quadro dell'atto precedente. - Il popolo festeggia la vittoria contro i Tartari. Re Altidòr, immerso nel suo dolore, fa cessare le acclamazioni e segue la Fata Farzana che. è giunta per condurlo da Miranda. Mentre il popolo corre per salvare il Re che ritiene in pericolo, si odono le voci di Demogorgòn e di Geònca che si sfidano in combattimento.
Quadro 2° - Due altipiani separati da un abisso. Sull'altipiano destro è un sepolcro in forma di tempietto; sull'antipiano sinistro si trova il popolo che ha seguito il Re. - Sull'altipiano a destra appare Altidòr con Farzana. Altidòr batte un gong; appaiono tre mostri; il gigante Giaromiro, il Liocorno e il Toro Ignivomo. Il Re si slancia armato contro i mostri mentre il popolo lo incoraggia; la voce di Demogorgòn grida: «Duecent'anni», e Miranda dal sepolcro chiama lo sposo. I mostri vengono sbaragliati, Altidòr corre verso il tempietto che viene circondato da alte fiamme, ma la voce di Geònca incoraggia il Re che si getta tra le fiamme. Il tempietto crolla, le fiamme inceneriscono un orribile serpente; Demogorgòn si dichiara vinto. - Ora al posto della tomba si vede la reggia di Miranda, e Miranda stessa, risuscitata dalle ceneri del serpe, abbraccia Altidòr mentre il coro inneggia all'amore.
L'opera è composta in apparenza secondo gli schemi del vecchio melodramma a forme chiuse. Le diciture: Sinfonia, Scena, Aria, Duetto, Terzetto, Combattimento, Scena concertata e simili scritte dall'autore sulla partitura, ci riportano con la mente alle forme dell'opera settecentesca; ma la sostanza è modernissima: strumentale ricco e brillante, armonizzazione spregiudicata, canto e declamazione liberamente concepiti. L'uso della polifonia invece, così nell'orchestra come nei cori, in cui ricorrono anche i «fugati», danno alla struttura dell'opera un'impronta di classicità, staremmo per dire vivaldiana per quello che riguarda l'orchestra, e vecchiana per quanto concerne i cori. Questa felice fusione di polifonismo e di monodia, di antico e di moderno, costituisce uno degli aspetti più interessanti dell'opera, in cui Vecchi, Vivaldi, Scarlatti e Rossini danno la mano a Strawinski e a Schönberg.
Si può forse osservare che vi è nella partitura una esuberanza di dissonanze aspre e dure che tiranneggiano il canto e ne turbano la schiettezza, mentre per loro conto taluni motivi sono stranamente e faticosamente contorti. Dissonanze e contorsioni appaiono tanto più ingiustificate in quanto non sempre sono necessarie all'espressione dell'azione o del testo; anzi talvolta appesantiscono in maniera dannosa la grazia ingenua e gentile della fiaba. L'esagerato contorsionismo e dissonantismo non è che un atto di obbedienza alla moda, in quanto oggi si tende a dar meno peso all'espressività dei motivi in se stessi e a far credere che anzi deformando i motivi e portando l'armonizzazione ai più estremi confini della libertà, fino là dove l'audacia rasenta l'anarchia, si siano risolti nuovi problemi artistici. Non è il caso di discutere qui tale questione. Noi ci troviamo di fronte a personaggi e a situazioni comiche e drammatiche che si svolgono in un ambiente fiabesco: l'importante è sapere se la musica ha potuto, non importa con quali mezzi, rendere vivo tutto ciò. Casella scrisse della Donna serpente: «L'opera non può vivere che del sentimento creato dalla musica». Non dunque l'azione e i personaggi in sè ci premono, ma l'alone, l'atmosfera che la musica crea attorno ad essi, e che innegabilmente ha creato.
Lo strumentale getta poi su tutto sprazzi brillanti di colore, luccichi! iridati, bagliori sgargianti, mentre i ritmi donano, a seconda dei casi, agile grazia o vigore di vita. Ne risulta una forma d'arte fantastico-decorativa e grottesca che risponde al desiderio di un nuovo indirizzo melodrammatico antiromantico e antiverista; indirizzo già additato da Strawinski con L'Usignolo, da Busoni con Turandot e da Prokofieff con L'amore delle tre melarance. È un ritorno al teatro dell'arte con le «maschere» che già attrassero anche l'estro di Mascagni e dell'ultimo Puccini.
Citiamo, fra le pagine di più compiuta bellezza, anzitutto la Sinfonia, dalla ritmica di una vivacità rossiniana, e con un tema vibrato e giocoso riscintillante nei vividi lucori strumentali; un tema che i fugati, e la costruzione polifonica generale fanno rimbalzare in modo da renderlo effervescente. Qua e là qualche velatura sentimentale accenna all'altro aspetto della commedia: l'amore di Miranda e del Re. Questa sinfonia - scrive il Belloni - è «fra le più vivide e frizzanti espressioni della nervosa modernità musicale».
Nel 1° atto va notato il duetto fra Alditrùf e Albrigòr, tutto movimenti marionettistici e motivi maliziosi che dipingono con umorismo graziosissimo le due maschere, la cui comicità si giova anche di schietti e semplici spunti di canzoni, come quello de «La fanciulla bella e fresca». Due pagine delicate sono l'aria di Altidòr: «O mia sposa perduta», in cui il pianto del Re trova accenti di una dolcezza toccante; e la delicatissima aerea musica del sogno d'Altidòr.
Nel 2° atto un altro duetto Alditrùf-Albrigòr ci rallegra con lo spirito musicale festevole e furbesco. Nel 2° quadro l'inno di guerra e la battaglia trovano accenti barbarici e impetuosi che si spianano nel mistico e solenne corale: «Téflis nostra». Il finale dell'atto è forse la pagina più bella e commossa di tutta l'opera, e basterebbe il soavissimo: «La mamma in un nembo di fiori» a dirci di quali delicatezze intime di sentimento e di poesia era capace l'ispido Casella.
Il preludio del 3° atto, con quell'oscillare del basso, i lunghi pedali e il canto dolente, rende efficacemente il senso di una profondissima mestizia. La prima scena ha una stupenda patina antica: qui rivive il madrigale drammatico secentesco, e nelle modulazioni vocali si pensa a un moderno Gesualdo, e nei momenti patetici (anche nei cori degli atti precedenti) ad Orazio Vecchie alla sua «Commedia harmonica». Piena di gagliarda energia la battaglia contro i mostri, ed arioso il finale dell'opera in cui sono ripresi i pomposi motivi e le gioiose fanfare con cui si apre il prologo, non senza avervi bellamente innestato un Quintetto burlesco nel quale le maschere sollazzevolmente sognano un pranzo degno della gran vittoria del Re e della gioia per la sposa ritrovata.
ADRIANO LUALDI - LA GRANÇÈOLA: opera da camera in un atto. Prima esecuzione al Teatro Goldoni a Venezia il 10 settembre 1932. Testo dello stesso Lualdi da un soggetto di Riccardo Bacchelli.
Atto unico. - L'azione è a Lucorano, isola della Dalmazia, nella piazza del paese che dà sul mare; epoca moderna.
Schiavone, assai vecchio padrone di barca, è innamorato della giovanissima pescatrice Dalmatina. Ma costei lo respinge, e insieme all'amante Marchetto, marinaio, gli giuoca un tiro facendolo cadere in acqua. Dal mare, con una rete, mene tratto, attanagliato da numerose grançèole. Schiavone implora di essere liberato, ma i due amanti gli fanno prima promettere che rinuncerà all'amore di Dalmatina. Ottenutane la promessa, Dalmatina con un canto affascina le grançèole, che abbandonano Schiavone, il quale vien tratto dalla rete. Dalmatina, Marchetto e i marinai e pescatori accorsi iniziano la danza nazionale del Kolo, alla quale finisce per partecipare lo stesso Schiavone. Al canto della danza le grançèole affascinate vengono a galla e i marinai le pescano ammucchiandole nel centro della piazza.
È uno scherzo assai grazioso e leggero. La sinfonia è spigliata, briosissima, ricca d'humor e di verve in una veste strumentale scintillante. La canzone di Dalmatina «Già tu, pallida», imitata da Marchetto, è piacevole e aggraziata, quanto è volutamente melensa e sciocca la ninna-nanna che canta il vecchio Schiavone: «Dormi, mio bel bambin», il cui tema diventa il motivo del suo canto d'amore a Dalmatina. Burlesca trovata quella degli squilli di tromba marziali ad ogni assalto del vecchio per abbracciare la ragazza. Altrettanto buffo è l'uso del motivo meyerbeeriano della congiura degli Ugonotti allorchè Marchetto e Dalmatina congiurano fra loro di farla al vecchio; e il ritorno del tema d'amore (ninna-nanna) allorchè Schiavone s'infuria ingelosito contro gli amanti, tema che si trasforma in urlo disperato quando cade nell'acqua. Dolcissima la canzone di Dalmatina: «È granchio la grançèola».
La musica della sinfonia ritorna nella scena dove Schiavone, tratto dall'acqua, implora che lo liberino dalle grançèole che lo attanagliano.
Chiude l'opera il fervido e balzante Kolo, che termina in un movimento pieno di slancio vertiginoso.
Alcune parti di quest'opera sono state riunite a formare una composizione sinfonica dal titolo «Suite Adriatica».
OTTORINO RESPIGHI - LA FIAMMA: melodramma in 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro dell'Opera in Roma il 23 gennaio 1934. Libretto di Claudio Guastalla da «The Witch» di G. Wiers Jenssen. L'azione si svolge a Ravenna negli ultimi anni del VII secolo.
Atto 1° - Uno spiazzo, chiuso verso il fondo da una siepe, nella villa dell'Esarca Basilio fra la marina e la pineta. - La vecchia madre dell'Esarca, la patrizia Eudossia, vigila il lavoro delle ancelle; al suo fianco, anch'essa intenta all'ago, è la patrizia Silvana, seconda moglie dell'Esarca. La severa vigilanza della vecchia pesa su le giovani come un macigno sul cuore, cosicchè appena essa esce, scoppia fra le ancelle, come un riso.disole, il loro vivace chiacchierio alternato a canti e a risa. La tetraggine della casa pesa pure su Silvana, la quale avverte nella suocera una sorda e acre ostilità. Improvvisamente si ode fuori un clamore selvaggio. È la folla che insegue la vecchia Agnese di Cervia, ritenuta strega e come tale accusata della morte di un giovinetto. Essa si precipita terrorizzata a implorare Silvana che la nasconda. Silvana, dapprima contraria, finisce per cedere. Ora è annunziato il ritorno da Bisanzio di Donello, il figlio della prima moglie dell'Esarca. Il dialogo fra Donello e Silvana, in un primo momento riservato, si fa via via cordiale, e Donello ricorda che essi si erano già incontrati. La conversazione è interrotta da Eudossia che viene a salutare il nipote; ma d'improvviso la folla che insegue Agnese si affaccia alla soglia e chiede di visitare la casa. Eudossia acconsente e Agnese viene scovata. Pazza di terrore, Agnese profetizza a Silvana ch'essa avrà la stessa sua sorte. E mentre il popolo la trascina al rogo, Eudossia, che sospetta che sia stata Silvana a farla entrare, esclama: «Tal sia di chi ti disserrò le porte».
Atto 2° - A sinistra la loggia superiore del Palazzo di Teodorico in Ravenna; a destra una stanza oscura; una ricca sala al centro. - Donello sul loggiato ciarla e ride con le ancelle, una delle quali, Monica, usa con lui maniere procaci. Silvana ne sente una improvvisa e rivelatrice gelosia. La chiama, e avuta la confessione dei suoi rapporti con Donello, le impone di rinchiudersi nel convento del Salvatore. A Silvana è giunta la voce che Agnese morendo sul rogo ha fatto il suo nome, e vuole che Donello, il quale l'ha udita, ne ripeta di fronte all'Esarca Basilio le parole. E Donello, a malincuore, riferisce che Agnese accusava di stregoneria la madre di Silvana, e soggiungeva che con tale arte aveva legato la figlia all'Esarca. Uscito Donello, l'Esarca conferma a Silvana che egli fu attratto in casa di sua madre da una forza possente che lo soggiogò e lo avvinse a lei. Ma forse questa forza era l'amore. Rimasta sola Silvana vuol provare se anche in lei esiste questa potenza, ed evoca Donello, il quale, come un automa, viene lentamente verso di lei; e i due, ebbri di perdizione, si baciano.
Atto 3° - Parte 1a - La stanza di Donello. - Silvana è con l'amante; ma sull'alba Eudossia li sorprende. Sopraggiunge Basilio: egli è invecchiato e malato. Ordina a Donello di tornare a Bisanzio; ma Silvana comprendendo che questa decisione fu suggerita all'Esarca da Eudossia per allontanare il giovane da lei, rimasta sola con l'Esarca tenta opporvisi. Non riuscendo a smuoverlo dalla risoluzione, sconvolta dall'ira e dalla passione, confessa a Basilio il suo amore colpevole per Donello. A tale rivelazione inattesa l'Esarca cade morto sul colpo. Eudossia accorsa, accusa Silvana di averlo ucciso gridandole: «Strega!».
Parte 2a - L'interno della basilica di San Vitale. - Innanzi al popolo e al clero il Vescovo pronunzia l'accusa di stregoneria contro Silvana, ma essa nega. Donello la difende dicendosi colpevole di averla sedotta; ma allorchè Eudossia ribadisce l'accusa di malefizio contro Silvana, chiamandola «Strega, figlia di strega», Donello tace. Allora anche Silvana, che sente di averlo perduto, non osa più giurare la propria innocenza su la croce che il Vescovo le presenta, e la folla le grida con orrore la tremenda parola di condanna: «Strega!».
L'indicazione «melodramma», posta accanto al titolo dell'opera, vuole avere l'intenzionale significato di un ritorno alla forma ottocentesca, non solo con il predominio dell'espressione drammatica vocale su quella sinfonica, ma anche con le sue forme chiuse e perfino con le cadenze alla fine delle arie. Naturalmente questo ritorno allo schema operistico tradizionale non signifìica una rinunzia alle conquiste armoniche e strumentali moderne, ma solo il loro subordinamento al principio della tradizione, chè anzi le forme del melodramma sono concepite con nuova libertà di disegno e di struttura, e l'orchestra non si limita ad accompagnare ma partecipa all'espressione del dramma con vigore di ritmi, con polifonica elaborazione di temi e con policromia di tinte. E non soltanto la tecnica, ma anche lo spirito di questa musica è del nostro tempo.
Nessuna pedanteria sistematica nell'uso dei temi, anche se taluni siano più di frequente impiegati in quanto personificano motivi fondamentali del dramma. Tal'è, ad esempio, il tema con cui l'opera si apre e che nel suo ritmo violento e nel suo colore cupo e fatale esprime l'elemento «stregoneria». Un altro tema che si ripete sovente è un doppio disegno cromatico sincopato a movimento simultaneo e invertito, che si accompagna agli scatti di insofferenza, come di soffocazione spirituale, di Silvana. Ma tutti i personaggi sono legati a particolari motivi musicali che li caratterizzano; duri e freddi, di natura quasi ieratica quelli di Eudossia; gravi e solenni quelli dell'Esarca; sensuali e molli quelli di Donello, e specialmente quelli che si riferiscono all'amore suo e di Silvana.
Non solo i temi strumentali, ma anche i recitativi di Eudossia hanno qualcosa di disumano che agghiaccia. Nel 2° atto al momento in cui sorprende gli amanti, la sua ostilità si afferma per mezzo di accordi ribattuti che sono una derivazione del motivo magico di Medea nel Giasone di Cavalli, di cui il Respighi già si è servito per il tema del Pellegrino nella Maria Egiziaca. La durezza di Eudossia si addolcisce solo nel 1° atto, quando essa rivede Donello, specialmente allorchè esclama: «Ah, ch'io ti guardi, ch'io ti rimiri», dove il respiro del suo canto si allarga, pur senza perdere in compostezza. L'austerità triste dell'Esarca si fa invece tenerezza mentre si rivolge a Silvana con l'invocazione: «Vieni, mia donna, vieni», e allorchè le ricorda il momento in cui la vide per la prima volta: «E allor ti vidi primamente»; e poichè, stregato o no, egli provò allora per la prima volta nella sua vita il sentimento dolce dell'amore, la sua voce e il suo canto vibrano di un calore umano che viene dal cuore e si esprime attraverso alla melodia.
Non si smentisce anche in quest'opera l'amore di Respighi per i canti gregoriani e per l'arte del recitativo cantabile monte-verdiano. Ma sul carattere dei canti religiosi e sui loro sviluppi polifonici ha esercitato certamente una notevole influenza il riflesso dell'arte bizantina con la sua pesante opulenza di disegni decorativi tutti luccicanti di ori musivi. Questi cori sono, secondo il gusto della chiesa orientale, carichi di melismi; imitazione del gusto senza trapianto o sfruttamento di motivi originali, il che permette al compositore di spaziare con ricchezza di disegni e libertà di fantasia. Eppure l'influenza, se è sensibile per quanto riguarda il colore, non ha impedito la trasparenza delle polifonie strumentali e vocali anche nei momenti di maggiore densità, come nel drammatico finale del 1° atto e nel fastoso e solenne inizio della 2a parte dell'atto 3°. In questi ultimi cori il musicista raggiunge una grandiosità fonica robusta, una luminosità che sa appunto dello sfolgorìo degli ori bizantini.
In questo ambiente di fosca malìa, di feroce superstizione popolare e religiosa, di triste pesantezza domestica, di persecutoria vigilanza, appena rotta da qualche fugace riso e canto delle ancelle nel 1° atto, e dai lascivi racconti di Donello, in questa greve atmosfera, resa ancor più soffocante dal rosso vampeggiare e dall'acre fumo del rogo, si ambientano l'amore di Donello e di Silvana, e il breve sogno amoroso dell'ancella Monica. Allorchè questo sogno le è spezzato dall'ira gelosa di Silvana, il suo pianto sconsolato: «Ma tu che sai l'esilio», si muove su un gemito insistente, mentre gli archi, dopo un lungo pedale di sincopi, ascendono gradatamente con affanno, riprendendo il modo di commento usato da Verdi nella scena fra Amonasro ed Aida.
Donello è figura scialba e incerta; attratto com'è dentro l'orbita della magìa di Silvana, vive musicalmente dei riflessi di lei.
L'amore di Silvana, invece, è avvolto nelle oscure spire dell'incantamento con cui si chiude il 2° atto, ma nasce già dalla nostalgia dei ricordi giovanili rievocati con tanta dolcezza melodica nel 1° atto da Donello sul canto del clarinetto tra il sospiro degli archi (l'unico momento in cui Donello ha un volto musicale suo). Ma l'anima di Silvana è torbida di desideri, ribelle all'oppressione tetra della reggia, avida di voluttà. Quest'ansia non si manifesta solo nel tema dai due disegni sincopati procedenti per moto contrario di cui s'è detto, ma in diverse effusioni liriche, come nel dolorante cantabile del 1° atto: «Ah romper l'aspro tormento», o nello spasimo del pianto angoscioso: «È questo, madre, il tuo segreto», del 2° atto.
La fine dell'atto, con il vittorioso esito dell'evocazione magica, non origina quell'esplosione lirica di gioia e di ebbrezza, quell'inno di esultanza e quel rapimento che ci si sarebbe attesi. Ma la voluttà dell'amore di Donello e di Silvana, coi suoi slanci e con i suoi improvvisi smagamenti, circola, anche se in parte con procedimenti tristaneggianti, nel duetto del 3° atto. che ha per culmine una pagina ispirata al più puro stile monteverdiano, rinnovato attraverso alla sensibilità moderna respighiana: l'estatico arioso di Silvana: «Dolce la morte», su accordi tenuti degli archi e arpeggi d'arpa, arioso che poi si trasforma in «a due».
Dopo la sconvolta scena della morte di Basilio, la musica assume accenti ritmi e colori della grande poesia tragica. Il tumultuoso stupore ed orrore del popolo, la solennità grandiosa dell'inno religioso su le invocazioni della folla, il severo recitativo cantabile dell'interrogatorio, con le energiche negazioni di Silvana e i gemiti dell'oboe e degli archi che ci dicono la reale angoscia dell'animo suo, il commosso compianto del coro, l'aspra drammatica accusa di Eudossia, e infine il dubbio che assale Donello, la fredda formula del giuramento che il Vescovo suggerisce a Silvana, mentre si odono lontano funerei lenti rintocchi di campana, il tragico silenzio che suggella le labbra della donna, incapace di pronunciare la parola «giuro», e il grido di esecrazione che prorompe dalla folla inorridita, tutto ciò forma dell'ultimo quadro una delle pagine più potenti che vanti l'operistica del primo quarantennio del secolo XX.
LODOVICO ROCCA (Torino 1895) - IL DIBUK: opera in un prologo e 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 24 marzo 1934. Libretto di Renato Simoni, tratto dalla leggenda drammatica di Scialom An-Ski.
Prologo - Dietro al velario. - Il Messaggero annunzia il patto d'amore stretto da Sender e da Nissen: se avessero avuto l'uno una figlia e l'altro un figlio li avrebbero congiunti in matrimonio.
Atto 1° - L'interno della Sinagoga di Brinizza. - Hanan figlio di Nissen, è innamorato di Leah, figlia di Sender. Egli ha fatto lunghi digiuni e scongiuri per ottenere dal cielo che Leah non si sposi con altri. Ma il padre di Leah annunzia agli amici che ha fidanzata la figliola. Hanan cade morto mentre gli altri bevono e danzano; ma come si accorgono del cadavere di Hanan dalle cui mani è sfuggito il libro della Càbala, tutti fuggono inorriditi.
Atto 2° - La piazza del villaggio di Brinizza. - È festa in casa di Sender per lo sposalizio della di lui figlia. Una folla di mendicanti è raccolta nel cortile, intenta a mangiare e bere avidamente e a danzare. Leah è costretta a danzare coi mendicanti una danza grottesca, violenta, quasi demoniaca, fino allo spossamento. Il Messaggero le narra che le anime maledette si impossessano dei corpi di viventi per purificarsi m essi: ciò si chiama Dibuk. In realtà al momento del rito nuziale Leah respinge lo sposo, e per sua bocca parla lo spirito di Hanan: è avvenuto il «Dibuk».
Atto 3° - La casa del Rabbi Ezriel. - Sender conduce la figlia alla presenza del miracoloso Rabbi Ezriel affinchè la liberi dal Dibuk. Al rifiuto dell'anima di Hanan di uscire dal corpo della fidanzata, il Messaggero rivela la mancata promessa di Sender. Ezriel raduna il Tribunale della Thorà che condanna Sender, quindi esorcizza il Dibuk e libera Leah. Ma nella solitudine in cui Leah è rimasta lo spirito di Hanan riappare. Fra i due fidanzati si svolge un dialogo dolcissimo, e mentre il corteo nuziale si avvicina, Leah muore e la sua anima vola verso quella di Hanan.
L'ambiente ebraico russo, con tutto quanto vi ha in esso di orientale, di grottesco, di drammatico, di superstizioso e di magico, informa di sè l'ispirazione musicale. Essa infatti, con ammirevole unità stilistica, che si mantiene da un capo all'altro dell'opera, fa proprie cantilene e salmodìe di tipo ebraico-orientale, le quali anzi ne costituiscono uno degli elementi fondamentali. Appaiono fino dai primi recitativi del Messaggero e dai cori che ne ripetono e commentano le parole nel prologo, dominando in ogni momento dei tre atti, nei quali la parte corale ha un ampio sviluppo, e chiudendo l'opera nei cori mistici ultraterreni che accompagnano il volo delle anime di Leah e di Hanan al Cielo. I canti ebraico-orientaleggianti a loro volta si innestano su un sistema di modulazioni e di armonie che ne mettono in rilievo suggestivamente il carattere, mentre l'orchestra, audace, pittoresca, spesso allucinante, come nelle frequenti scene miracolistiche e spiritiche, fa della rappresentazione scenica una realtà spirituale. Nel mistero che avvolge persone ed azioni, la musica approfondisce, ora deformando fino al macabro, ora idealizzando fino al misticismo.
Ricordiamo, fra le cose più suggestive e scultorie, le strascicate cantilene dei Talmudisti nel 1° atto, con quel senso di stanchezza e di umiltà cupa, di sonnolenza indolente e di esagerato pietismo che ne fa delle creature nuove nella storia dell'opera. Ed anche la fatale ed astratta gravità dei recitativi del Messaggero, che è come la voce tremenda del fato, oscuramente minacciosa nei primi atti, tragicamente fredda e spietatamente rivelatrice nell'ultimo. E il cinismo ripugnante di Sender che, mancando a una promessa data, sposa la figlia ad un goffo ricco; e il delirio lirico di Hanan prima di morire. Sono tutte espressioni in cui la nudità quasi scheletrica del recitativo e la vigorìa dell'orchestra danno alle situazioni un'efficacia che avvince. Anche se il Rocca sembra abusare talvolta inutilmente di dissonanze brutali e di durezze timbriche urtanti, è certo che attraverso alla sua orchestra si ci svela potentemente quel mondo occulto e demoniaco che forma lo sfondo del dramma. È soprattutto nelle danze frenetiche degli storpi al 2° atto, specialmente in quelle più bieche e fantomatiche condotte dalla Cieca, che questo mondo riceve dall'arte del Rocca il maggior rilievo.
In questa gretta e sordida verminaia di miserie fìsiche e morali, in questo abbietto brulicame di ebrei luridi, superstiziosi e deformi che gravano come un incubo tetro su tutta la tragedia, la figura di Leah, di una candida purità verginale, resta quasi soffocata. Essa riceve dalla musica le accentuazioni più delicate e commosse, ma non riesce a trovare un proprio respiro che al momento in cui muore.
Infine ricordiamo, nel 3° atto, quel pacato e sereno salmodiare della tromba con sordina, e le risposte corali degli archi nel preludio, riprese poi con mistica dolcezza dalle voci, a sipario levato; la delicata ninna-nanna per i figli non nati, e la solennità sacra piena d'entusiatico abbandono del finale.
ERMANNO WOLF-FERRARI - IL CAMPIELLO: commedia lirica in 3 atti. Prima rappresentazione alla Scala di Milano l'11 febbraio 1936. Libretto di Mario Ghisalberti, tratto dalla commedia omonima di Carlo Goldoni. Epoca: metà del 1700.
Atto 1° - Un campiello con varie case. A sinistra la casa di Gasparina con balcone, più in fondo quella di Lucida con altana; a destra quella di Orsola con terrazza e quella di Gnese con altanella. In mezzo, nel fondo, locanda. - Un forestiero, il Cavaliere Astolfi, fa la corte a tutte le ragazze del Campiello. Il merciaiolo Anzoleto, che l'ha visto parlare con Lucida, fa a questa una scena di gelosia, e Lucieta che ha visto Anzoleto entrare nella casa di Gnese gli risponde per le rime. Lucieta per far dispetto a Gnese chiama in casa il di lei innamorato Zorzeto; ma Anzoleto, ingelosito lo vuol battere. Intervengono le madri e ne nasce una lite, sedata bonariamente dal Cavaliere. Intanto Gasparina, giovane spiritosa, ma un po' caricata, che parlando usa la z in luogo della s, già corteggiata dal Cavaliere, lo incontra ed ha con lui una piacevole conversazione che lo affascina.
Atto 2° - La stessa scena. - Anzoleto ha deciso di sposare Lucieta, e il Cavaliere paga il pranzo di nozze, perciò in campiello c'è grande allegria. Tutti entrano nella locanda schiamazzando. I cuochi che portano le vivande danno origine a un balletto. Vi prendono parte anche graziose servette, e dei pezzenti ai quali vien servita una polenta. Il Cavaliere che è stato trattato in modo sgarbato da Fabrizio, zio di Gasparina, per aver trovata la nipote a parlare in strada con lui, ora vuole spiegazioni. Fabrizio dice che Gasparina è figlia di un suo fratello fuggito da Napoli a Venezia per un duello. Anche il Cavaliere Astolfi è napoletano. Fabrizio è ricco e darà una buona dote a Gasparina quando si sposerà. Questo rallegra il Cavaliere che è finanziariamente rovinato. Intanto si affacciano sulla terrazza i festaioli per brindare, ma finiscono per ritirarsi altercando. Poco dopo tutti escono: sono tutti un po' brilli e si danno a un ballo sfrenato.
Atto 3° - La stessa scena. - Il Cavaliere domanda a Fabrizio la mano di Gasparina. Si ritirano in casa per discutere. Intanto Azoleto dà uno schiaffo a Lucieta perchè è entrata in casa di Orsola, madre di Zorzeto, che egli chiama carogna perchè ne è geloso. Ne nasce una clamorosa baruffa, sedata dall'intervento del Cavaliere, che annunzia le proprie nozze con Gasparina e invita tutti a cena, Gasparina, che l'indomani partirà con lo sposo, saluta commossa Venezia e il campiello.
Quest'opera ripete le caratteristiche già note dell'arte di commediografo musicale di Wolf-Ferrari, e specialmente le qualità stilistiche della sorella maggiore, I quattro Rusteghi. È un'arte personalissima e inconfondibile; bastano poche note per identificare una musica di Wolf-Ferrari. Anche il Campiello è opera di un profumo deliziosamente settecentesco, senza che ci sia imitazione, e nell'istesso tempo di un gusto moderno, senza affettazioni novecentiste. Non manca la melodia di impronta veneziana, che forma il nucleo del preludio al 1° atto, dell'intermezzo al 2° e del ritornello al 3°, e che, cantata da Gasparina, chiude l'opera come saluto carezzevole e nostalgico alla città natale. Ma anche senza questa seducente melodia, veneziano, anzi goldoniano, è tutto l'insieme dei particolari che caratterizzano personaggi e situazioni.
Il recitativo è aderente alla parlata del dialetto veneto (solo il Cavaliere e Fabrizio parlano italiano), e trae dalle inflessioni di esso modi musicali che non sono solo etnofonici ma psicologici. Talvolta però esso si riduce a frasettine corte, quasi senza respiro, intercalate da accordi e da altre brevi frasette di commento orchestrale, e ciò dà a talune scene un aspetto eccessivamente frammentario. C'è inoltre un'orchestra di una finezza sottile, che colorisce e umorizza, trasparente e leggera; che sa a volte tacere lasciando emergere la bellezza del dialogo musicale e la vis della commedia, limitandosi a qualche accenno e commento senza disturbare nè distrarre. Ma quando è necessario, interviene con signorile eleganza sciorinando motivi spiritosi o sentimentali, colorendo rumorosa o aggraziata, talvolta ironizzando con garbo, talvolta sorridendo con malinconia, od anche prorompendo in slanci passionali o schiamazzando strepitosa.
Quello che sono l'orchestra e la fantasia poetica di Wolf-Ferrari ce lo dicono il preludio del 1° atto, l'intermezzo del 2° e il ritornello del 3° testè ricordati, gioielli di perfetta leggiadrìa (specie l'ultimo); e il balletto del 2° atto, di cui la prima parte accompagna il corteo dei cuochi che, con burlesca pomposità, recano le vivande; e la seconda è una gioconda danza di servette, danza dal disegno scorrevole, dal ritmo elastico e dallo strumentale leggero, capolavoro di arguzia e di grazia finemente cesellato. Goldoni qui non è rispettato: d'accordo; il corteo che porta le vivande per Venezia è assurdo: anche questo è pur vero; ma appunto questi elementi d'intrusione un po' farsesca, che stonerebbero nella rappresentazione della commedia, riescono divertentissimi nell'opera in musica. Proprio per quell'assurdo, per quell'essere fuori della vita reale che così bene si accorda con la naturale capacità della musica a dipingere l'irreale, a trascendere la vita, e che ha trovato la sua più totale realizzazione in quella monumentale assurdità che è L'Italiana in Algeri di Rossini.
Un po' farsesco, ma anche ricco di trovate umoristiche, è il finale del 2° atto con le strofe danzate; «Sol, sol, sol, sol,», che nel loro succedersi danno quasi l'impressione di un faceto fugato. E così il balletto finale, in cui il clarinetto fa la satira dei più sguaiati modi di suonare dei balli popolareschi, mentre alle strofe, intonate ora su un «la, la la, la», si intercala con efficacia esaltante il motivo fondamentale dell'opera: quello che esprime l'anima languida poetica e canora di Venezia.
Un'altra scena rumorosa, di una grottesca animazione da opera buffa, è la baruffa dell'ultimo atto, in cui l'autore, dopo averla preannunziata con la rapida citazione del tema della baruffa dei Maestri Cantori di Wagner, fa un uso ridanciano del più spregiudicato dissonantismo. La citazione umoristica anzidetta non è la sola: quando il Cavaliere nel 3° atto, sedata la baruffa, annunzia che l'indomani partirà da Venezia, e invita tutti a cena, si ode in orchestra il motivo dell'ultimo tempo della «Pastorale» di Beethoven: «Grato sentimento dopo la tempesta!».
Fa da contrapposto a queste scene chiassose e spassose il flebile quartettino del 3° atto. Il furioso Anzoleto ha dato uno schiaffo all'innocente Lucieta. Una rapida e violenta scala, simile al gesto dello schiaffo, si arresta su una dissonanza di cui la nota inferiore discende singhiozzando, e lasciando sola in alto una nota acuta, che ha un'espressione mista di stupore e dolore (dolore non della faccia, ma del cuore). Questa nota permane sul dialogo successivo lungamente (38 battute) fino a che si scioglie in un pianto accorato, dal quale nasce il quartetto (Lucieta-Gnese-Cate-Anzoleto) tutto sospiri e trepidante tenerezza.
Le figure delle due vecchie: Donna Cate Panciana e Donna Pasqua Polegana, affidate per maggiore canzonatura alle voci di due uomini, sembrano intagliate da qualche antica opera buffa, e i loro profili sono musicalmente caricaturali, senza però che il senso realistico venga mai meno, anche nei momenti più grottescamente farseschi. Si pensi, ad esempio, al frivolo e arguto motivetto, così maliziosamente civettuolo della strofetta: «Non son più una putela» (motivo che diventerà uno dei fondamentali dell'opera), che Cate canta «sorridendo sorniona e con un ritmico dondolare delle anche» allorchè pensa che, malgrado la vecchiaia, potrebbe ancora sposarsi!
Lucieta e Gnese non hanno una caratterizzazione così marcata che valga a distinguerle nettamente fra loro. Sono fanciulle sentimentali, innamorate, più o meno ingenue; si veda a proposito l'aria di Lucieta: «Anzoleto, mio Anzoleto», e quella di Gnese: «Voria, mi, sposarme». Sono musicalmente le sorelle delle giovani creature femminili delicatamente disegnate e morbidamente colorite da Wolf-Ferrari nelle altre sue opere comiche. Meglio distinti i due giovanotti: gelosissimo e violento Anzoleto, più aggraziato, ma altrettanto ombroso Zorzeto. E gustoso pure il Cavaliere Astolfi, bonaria caricatura del nobile spiantato e generoso, che sa conciliare l'interesse con l'amore.
La figura dominante dell'opera è Gasparina, dipinta subito dalla musica con leziosa ma simpatica affettazione fino dalla prima aria: «Ancuo zè una zornata cuzzi bela», e conservata sempre stilisticamente coerente a se stessa attraverso ai dialoghi con il Cavaliere, nei quali mostra anche signorile arguzia e sentimento. Gasparina sembra simboleggiare il lato più aristocratico dell'anima veneziana, in contrasto con gli altri personaggi plebei; anima veneziana che essa esprime nel saluto finale in un totale nostalgico abbandono espansivo di melodia.
GUIDO FARINA (Pavia, 1903) - TEMPO DI CARNEVALE: opera comica in un atto, due quadri e un intermezzo. Prima rappresentazione al Civico Teatro «Fraschini» di Pavia il 10 dicembre 1938. Libretto di Arturo Rossato.
Quadro 1° - A Venezia, 1700; camera in casa di Bernardo. - Nicoletta, la cameriera della Signora Fabrizia, giovane sposa dell'anziano antiquario Bernardo, rustico e volgare, è di malumore perchè deve starsene a cucire invece di andare a godersi in maschera il carnevale. Anche Fabrizia è presa da vaghi ricordi e desideri d'amore e di gioia. Dalla finestra Nicoletta vede al caffè di fronte il giovane Paolino, un cavaliere che da tempo fa la corte a Fabrizia. Poichè il padrone è a Padova (così ha detto), Paolina propone di divertirsi alle spalle del giovane: lo chiamerà, lasciandolo a colloquio con la Signora, poi all'improvviso rientrerà gridando che è tornato il marito il quale vuole ucciderlo. Fabrizia vorrebbe resistere, ma non è insensibile all'amore del giovane Paolino che vien fatto salire. Però Nicoletta irrompe a un tratto annunciando il ritorno di Bernardo, giùnto davvero. Paolino viene in fretta nascosto sotto un cumulo di drappi sul divano. Bernardo entra con uno spadone antico, che dice di avere acquistato a Padova; pero egli, in verità, non è stato in questa città, ma in cerca di avventure, e teme che Fabrizia lo sappia, mentre questa a sua volta teme ch'egli sappia della presenza di Paolino. Rassicuratasi, per fare a questi paura, chiede a Bernardo se la sua spada può tagliare i broccati posti sul divano. Bernardo si accinge a farlo, ma all'ultimo la sposa e la fante lo fermano. Approfittando del momento in cui Bernardo è andato a spogliarsi, Paolino se ne va, più morto che vivo per lo spavento passato.
Intermezzo. - Marco, il gastaldo di Paolino, dice a Nicoletta che il suo padrone delira e muore d'amore e di spavento. Nicoletta va a prendere Fabrizia, e insieme, mascherate, seguono Marco alla casa di Paolino.
Quadro 2° - Camera di Paolino, con alcova. - Paolino è a letto, immobile. Fabrizia gli si avvicina, gli chiede perdono pel male involontariamente fattogli volendolo burlare, e gli confessa il proprio affetto. Paolo balza dal letto; fingeva: sta benone, e vuol condurla nell'alcova, Fabrizia tenta di resistergli; allora Paolo chiama Bernardo che era in una stanza vicina. Fabrizia si rifugia spaventata nell'alcova tirando le tende. Paolino dà ad intendere a Bernardo che ha tardato ad aprirgli perchè... ha nell'alcova una giovane donna turca. Bemardo si incuriosisce, vuol vederla. Paolo invita la donna a sporgere una mano, e Bernardo va in solluchero. Paolino, dicendo a Bernardo di aver saputo da un marito tradito una sua salace avventura, lo tira a confessargli sguaiatamente il proprio debole per le serve, e la grossolana infedeltà alla moglie allorchè le disse di essere andato a Padova. La confessione di Bernardo è il colpo di grazia agli scrupoli di Fabrissia, che, uscito il marito, finisce per cedere all'amore di Paolino. Essa però fa chiudere prudentemente le finestre e anche... il sipario, dicendo garbatamente al pubblico: «scusateci!».
Musica spontanea, scorrevole, cantante, che alterna il sentimento all'arguzia. Lo stile non si allontana da quello del? opera comica dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento, senza atteggiamenti o pose rivoluzionarie. Musica che si fa ascoltare con piacere perchè fine e piena di buon gusto, mentre per la sua nitida trasparenza e la semplicità della sua tessitura si afferra tutta alla prima audizione. Aderisce alle situazioni e ai personaggi, rivelando di questi la psicologia, interessante anche se non profonda, coi ritmi vivaci, con le melodie suadenti e con uno strumentale colorito, talvolta anche grottesco, leggero come il soggetto della vicenda. Anche nei momenti di più sentita passionalità questa musica non fa la vóce grossa, non tenta di imporre con enfasi barocche a questi personaggi vesti eroiche e truculente, che sarebbero del tutto sbagliate; non c'è mai ombra di gonfiezza. Un fine umorismo, il piacere della burla un po' salace, fluisce da capo a fondo e reca in ogni momento un senso di vita fresca.
La briosa sinfonia si impernia su un motivo agile a terzine che potremmo chiamare il «tema di Paolino» o della «furberia di Paolino». Infatti esso ritorna per accenni nel 1° quadro allorchè Nicoletta parla di lui; e, più ampiamente svolto, nel 2° quadro quando Paolino balza dal letto «guarito» e dà inizio all'astuzia finale per vincere la ritrosia e gli scrupoli di Fabrizia. Qualche altro motivo ritorna pure, ma senza particolare insistenza; fra tutti più significativo è quello dello spadone di Bernardo nell'atto di tagliare in due Paolino, seguìto da un allegretto cantabile che accompagna nel 1° quadro il pietoso arresto da parte di Fabrizia del micidiale gesto dello sposo, e, nell'intermezzo, le parole pietose di Nicoletta «Poverino! Da voi non c'è nessuno?».
Dopo la sinfonia vanno ricordate fra le pagine più belle la sognante melodiosità del canto di Fabrizia: «Dal solitario rio sale una serenata» sull'ondeggiante mormorio degli archi, e il cullante movimento di barcarola che segue; lo scherzoso ed elegante motivo allorchè Nicoletta chiama Paolino; la calda e carezzevole dichiarazione di questi: «Ma ascoltate in bontà le parole»; e l'allegro racconto e la goffa danza di Bernardo.
Nell'Intermezzo la «Voce interna» riprende con senso di poesia un motivo di canzone sensuale già intonato con grossolanità da Bernardo nel 1° quadro.
Nel 2° quadro la tenera confessione di Fabrizia: «Oh! se sapeste! M'è fiorito in cuore» riprende il tono sentimentale. Ma la commedia non langue, anzi, avvicinandosi alla conclusione, si fa più schiettamente festosa. E anche in queste ultime pagine è da notare il tema stupendamente birichino che scatta sotto il dialogo tra Bernardo e Paolino, allorchè questi inizia la burla finale a lui e a Fabrizia con la storiella dell'amante turca.
E la commedia si conclude con la vittoria di Paolino, il cui motivo furbesco e animato scintilla un'ultima volta sonoro nelle battute finali.
LUIGI FERRARI TRECATE (Alessandria 1884). - GHIRLINO: tre atti in quattro quadri per i bimbi piccoli e grandi, Prima rappresentazione alla Scala di Milano il 4 febbraio: 1940. Libretto di Elio Anceschi.
Atto 1° - Interno di una bottega di bottaio. È sera. - Mentre Lumetta, Ghirlino e Piumina giocano, la Mamma esce raccomandando loro di tener ben chiusa la porta. Poco dopo, mentre Lumetta accompagna a letto Piumina, la sorellina minore, dal di fuori Cuordisassa, sotto le spoglie di Ser Nicolà, chiama Ghirlino e, promettendogli dolci e giocattoli, si fa aprire. Invano Lumetta, accorsa, tenta di opporsi ricordando a Ghirlino l'ordine della mamma. Entrato, Cuor disasso chiama i «Nani legacciuoli»; fa legare Ghirlino e Lumetta, va a prendere Piumina che mette in un sacco, poscia fugge seguito dai suoi Nani. La Mamma al ritorno trova, con spavento, i bimbi legati. Informata di quanto avvenne, esce con Lumetta alla ricerca della figliolina rapita. A Ghirlino, spaurito e avvilito dal rimorso, appare il «Grillo parlante» che gli addita due scarpette dorate: se le metta e voli subito a salvare la sorellina. Ghirlino afferra le scarpette e un grosso martello, e corre arditamente fuori.
Atto 2° - Radura davanti all'antro roccioso di Cuordisasso. È notte. - Cuordisasso arriva con un carro, dal quale fa uscire tre bimbe, che porta nell'antro. Giunge Ghirlino; un Lupo da una finestra dell'antro lo chiama; un'Anatra da un'altra lo avverte di non fidarsi. Dalla caverna esce di nuovo Cuordisasso, che chiama a raccolta gli «Spiritelli maligni» e impartisce loro l'ordine di preparargli la cena. Ghirlino, nascosto, implora soccorso dal cielo. Ed ecco un Araldo, apparso d'improvviso, dà fiato a una tromba. Gli Spiritelli fuggono. Ora Buonastella si inoltra col Grillo parlante. Fa comparire gli Spiriti della Vendetta, della Ricchezza e della Giustizia, incanta il martello di Ghirlino, e scompare. Questi batte alla porta della caverna, ma la voce di Cuordisasso che gli risponde lo spaventa. Il Grillo parlante conduce Ghirlino dietro un masso ove si addormenta.. Due Nani, Bentidona e Cuorcontento, gli sottraggono nel sonno il martello e le scarpe; però Ghirlino, destatosi, riesce a riprendere le scarpe; ma una turba rumorosa di nani accorsa gli impedisce di riprendere il martello. Cuordisasso, svegliato dal frastuono, esce furibondo, addormenta i Nani, e rientra ponendo a guardia della caverna il Lupo. Ghirlino sbuca dal nascondiglio in cui si era rifugiato, e riprende a Cuorcontento il martello. Il Lupo lo vede e gli si avventa, ma Ghirlino è pronto a colpirlo col martello e l'uccide. Gli foglie la chiave d'oro che aveva appesa al collo, e con essa apre la porta della grotta e vi entra.
Atto 3° - Quadro 1° - La stessa scena del 2° atto. È l'alba. - I Nani dormono ancora. Ghirlino esce dalla caverna con la sorellina. Si ode Cuordisasso cantare avvinazzato; alla sua voce i Nani si risvegliano e si nascondono. Ghirlino fa celare Piumina. Cuordisasso esce, e vedendo Ghirlino già pregusta la nuova cena, e mentre il bimbo canta deridendolo, Cuordisasso ballonzola. A un tratto si avvede del Lupo morto e di Piumina. Mentre furibondo si precipita contro Piumina, una folla di bimbi e di schiavi liberati da Ghirlino esce dalla caverna, lo afferra e lo rinchiude dentro il carro. E fra le grida ostili dei liberati, il carro viene trascinato via.
Intermezzo. - Mentre il carro con Cuordisasso viene tratto verso la casa di Ghirlino, i «Nani legacciuoli», liberi ormai dalla loro servitù all'Orco, si mettono a danzare, proponendosi da quel momento di far solo nodi d'amore.
Quadro 2° - Vasto spiazzo sul colle davanti alla casetta del bottaio. È mattino. - La mamma e Lumetta interrogano ansiose dei cittadini che si recano al lavoro per sapere se abbiano incontrato un bimbo; nessuno però l'ha visto. Ma ecco giungere il corteo con Cuordùasso. Alla testa è Ghirlino: la Mamma lo abbraccia felice. Ora Ghirlino giudica e condanna Cuordùasso ad essere arso. Ma mentre si sta per appiccare il fuoco al carro, appare Buonastella, la quale invita al perdono e non alla vendetta, e scompare con un gesto di benedizione. Ghirlino allora trae per la mano dal carro non più Cuordisasso, ma un venerando vegliardo: è il «Re delle leggende», cinto il capo di corona d'oro. Egli racconta di essere stato Re e di essere caduto, per le malvagità commesse, nella mani del demonio, il quale lo trasformò nell'atroce Cuordùasso. Solo le mani pure di un fanciullo avrebbero potuto redimerlo. E imponendo le mani sul capo di Ghirlino, lo profetizza Re. E i bimbi inneggiano a Ghirlino Re.
Gli autori (librettista e compositore) hanno affermato che Ghirlino è opera per «bimbi piccoli e grandi», e hanno detto il vero. La semplicità della musica, i facili motivi di canzoncine infantili, le vicende meravigliose della favola, e quel che vi possono aggiungere la fantasia delle scene, i colori, le luci, le coreografie, sono tutte cose che fanno breccia nell'anima dei fanciulli e li incantano. Per i «bimbi grandi» ci sono invece una veste armonica (basata in prevalenza su la scala diatonica) e un vivido giuoco istrumentale che si tolgono dai modi più consueti e banali per ricercare il gusto piccante delle dissonanze umoristiche e anch'esse ricche di uno stupore fiabesco, ispirate a un pittoresco e ben dosato impressionismo. La difficoltà maggiore stava forse nel non soffocare sotto una veste troppo preziosa l'ingenuità fresca dell'ispirazione, nel non diventare leziosi per eccesso di aristocraticità, nel lasciare emergere il canto fra le trine dello strumentale colorito, e ci sembra che Ferrar! Trecate abbia pienamente raggiunto questi intenti. Un'altra difficoltà poteva essere il necessario distacco da qualche precedente: Hänsel e Gretel di Humperdinck, L'enfant et les sortilèges di Ravel; e anche questo scoglio pericoloso è stato evitato; Ferrari Trecate è Ferrari Trecate, forse solo con un pizzico di Dukas.
Su la «Sinfonietta» vispa e arguta con cui si apre l'opera, è segnato: «Allegramente», e questo potrebbe essere il motto dell'intero spartito. Poichè dovunque ferve un'allegrezza schietta, dovunque l'autore vede le cose con la fantasia fiabesca che anima gli occhi e i cuori dei fanciulli e ne gode. Ferrar! Trecate è uomo di alta sapienza musicale che ha saputo mettersi appunto con gli occhi e col cuore alla pari dei fanciulli, conservando al proprio stile la signorilità e il buon gusto artistico che valgano a sollevare le piccole cose intonate, al livello delle manifestazioni d'arte più fini e garbate. E crediamo che non altro sia da cercare in questa musica.
La natura del libretto (specie nel 1° atto) costringe il musicista ad essere necessariamente episodico e frammentario, ma appena se ne presenti l'occasione egli ne approfitta per allargare il respiro melodico. Ha anche avuto il buon gusto di caratterizzare i personaggi della favola in maniera umoristica o grottesca, a seconda dei casi, senza calcar la mano, senza far la voce grossa, e ciòè senza rendere Cuordisasso tronfio o eccessivamente mostruoso, nè Ghirlino troppo fatuo o troppo presuntuoso. Tutto è mantenuto nei giusti limiti di una storiella per bambini, senza drammatizzare. Anche la canzone bacchica di Cuordisasso, con la quale si apre il 3° atto, è gaia e originale, ma non reca traccia di espressioni che possano minimamente incutere spavento. È sempre la favola che prevale e che deve divertire. E le varianti con cui poco dopo questa canzone è ripresa da Ghirlino, le donano soltanto una intonazione più popolaresca e sbarazzina, che prende un andamento più decisamente gioioso e festante al momento della vittoria su Cuordisasso, allorchè questi viene imprigionato nel carro.
Il giuoco dei bimbi nel 1° atto è disinvolto e vivace senza essere puerile; il balletto degli «Spiritelli maligni» è soprattutto pittoresco e bizzarro, e così sono i balletti della Vendetta, dell'Oro e della Giustizia. Quello dell'Oro è di una grazia e di una eleganza seducenti: se Ghirlino non cede alla lusinga di questo valzerino è proprio bravo! Ad ogni modo, sempre più coreografia fiabesca disegnata con tratti lievi e divertenti che minacciose azioni, drammatiche. Il Lupo, l'Anatroccolo, i Nani, sono tenuti in questo medesimo genere di pittura musicale; la quale non dimentica mai che si tratta di una favola per bimbi veri, o per grandi che vogliano abbandonarsi ancora per un momento ai sogni della loro fuggevole e lontana fanciullezza, ai quali il narratore musicale li ripresenta trasfigurati dal suo sogno di artista squisito.
BENJAMIN BRITTEN (Lowestoft [Suffolk] 1913) - PETER GRIMES: opera in un prologo e 3 atti. Prima rappresentazione al Teatro della «Sadler's Wells Opera» a Londra il 7 giugno 1945. Libretto di Montagu Slater dal poema The Borough di George Crabbe.
Prologo. - Stanza del Tribunale - Un giudice interroga il pescatore Peter Grimes su la morte di un apprendista ch'egli è accusato di aver ucciso gettandolo in mare. Peter afferma che il giovane morì di sete. 11 giudice lo assolve, ma la folla, non convinta della sua innocenza, mormora contro di lui, Ellen Orford, vedova, maestra di scuola, che ama Peter, lo incoraggia a pazientare; la sua onestà sarà riconosciuta.
Atto 1° - Scena 1a - Strada nel villaggio: la farmacia, la locanda del «Cinghiale», la chiesa e il tribunale; in fondo la strada del lido. - Peter Grimes domanda aiuto ad altri pescatori per ritirare la barca dal mare mentre sta per scatenarsi una tempesta. Gli mene suggerito di cercarsi un altro apprendista; Ellen si incarica di cercarglielo. Il capitano Balstrode lo consiglia ad allontanarsi dal villaggio e ad evitare che gli accada una nuova disgrazia. Ma Peter risponde che non partirà: farà denaro e allora tutti lo rispetteranno.
Scena 2a - Interno della locanda del «Cinghiale». - Fuori infuria una violenta bufera; nella locanda si sono rifugiati individui di ogni genere. Anche Peter Grimes vi entra e si pone a cantare una canzone. Egli sta per venire a contesa con un ubriaco, ma sono separati da Balstrode. Il farmacista Keene allora si mette a cantare una canzone a ballo alla quale a poco a poco si uniscono tutti. Essa viene interrotta dall'arrivo di Ellen con il nuovo giovinetto apprendista, John, col quale Peter si allontana.
Atto 2° - Scena 1a - Come alla scena 1a dell'atto 1°. - È giornata di sole ed è festa. Dalla chiesa vengono cantici sacri. Ellen parlando con John scopre una lividura sul suo collo, ma il ragazzo non vuol dirne la causa. Sopraggiunge Peter, al quale Ellen chiede conto della ferita di John, ma Peter risponde evasivo e impone al ragazzo di seguirlo: ha visto un branco di pesci e vuol catturarlo. Invano Ellen gli dice che è festa, e gli ricorda il suo impegno a trattar bene il ragazzo; Peter tutto preso dal suo sogno di ricchezza, allontana Ellen sgarbatamente, afferra il ragazzo e parte con lui. Ma alcuni del villaggio hanno udito il dialogo e commentano aspramente il contegno di Peter; indi avvertono il Pastore e con lui s'avviano alla casa di Peter,
Scena 2a - La capanna di Peter, formata da una barca rovesciata: una porta dà sulla strada, un'altra su un precipizio che conduce per un erto sentiero al mare. - Peter sospinge con violenza il ragazzo spaurito a prepararsi per la pesca. John, appressatosi con la rete alla seconda porta, scivola e precipita nel baratro. Peter accorre e discende rapidamente. Intanto il corteo guidato dal Pastore giunge alla capanna, ma trovatala vuota e in ordine si allontana. Solo Balstrode, che ha osservato gli abiti da festa del bimbo sparsi per terra, guarda dalla porta che scende nel precipizio, e vi si inoltra.
Atto 3° - Scena 1a - Come la scena 1a del 1° atto. - Dal tribunale viene una musica di danza. Sono passati diversi giorni dalla tragica fine di John. Grimes ha riportata la barca sul lido poi è scomparso. Ciò fa sospettare che egli abbia compiuto un nuovo delitto, e il giudice dà ordine di cercarlo. Anche Ellen e Bahtrode lo cercano.
Scena 2a - La stessa scena, alcune ore più tardi.- Peter appare, disfatto e delirante. Il destino è contro di lui: il suo sogno di ricchezza è infranto. Cosi lo trovano Ellen e Bahtrode; e quest'ultimo lo consiglia a risalire su la barca, portarsi al largo e lasciarsi affondare con essa. E Peter obbedisce.
Peter Grimes vuol essere un ritorno verso la forma del melodramma, in una cosciente fusione delle vecchie strutture dei pezzi strofici legati da recitativi e delle nuove formule armoniche atonali e politonali. E non mancano neppure le pennellature impressionistiche. I pezzi strofici hanno forme libere e non si distaccano dal contesto, come, ad esempio, nel 1° atto quando Balstrode va ad aiutare Peter a porre la barca al sicuro dalla tempesta imminente, o quando Ellen esclama: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra»; o nel 2° atto quando Keene intona la sua canzone a ballo: «il vecchio Joe è andato a pescare»; o quando Peter riprende il motivo (già intonato alla fine del 1° atto) in cui espone il suo desiderio di ricchezza, la quale gli permetterà di domare le male lingue; o ancora quando, nel 3° atto, Ellen ripensa alla gioia del ricamo allorchè, nella sua giovinezza, ad ogni filo di seta era congiunto un sogno di felicità.
Ma tutto ciò non basta a darci il «melodramma», mentre l'assenza di temi conduttori tiene volutamente ben lontano il compositore anche dal «dramma musicale» wagneriano con la sua «melodia infinita». Del melodramma non ci sono che taluni aspetti convenzionali, così come della tecnica moderna c'è solo la struttura ormai anch'essa divenuta convenzionale; ma scarseggia la novità delle idee che ravvivino l'una e gli altri.
In verità i recitativi del Peter Grimes si allontanano dallo schematismo sillabico dei neo-cameratisti del nocevento. La loro intonazione è in molti casi cantabile, ed appare evidente l'intenzione di rendere non tanto l'accento musicale del linguaggio parlato, quanto il senso comico o lirico o drammatico della frase. Siamo però lontani da quella profondità incisiva di accenti che caratterizza, per esempio, i recitativi verdiani od anche quelli wagneriani o mussorgskiani; e siamo lontani, nei frammenti strofici, da quell'abbandono melico e da quel senso estatico che allarga il respiro all'onda del sentimento in tante arie di vecchie opere. Più che un vero e proprio cantare, quello di Britten è un «cantilenare» scheletrico, scarnito, arido, anche nei timbri orchestrali, disteso su ritmi assai mutevoli e stranamente inconsueti e complicati, imbevuto di una tinta malinconica ed amara. Esso tuttavia in vari momenti non manca di carattere. Così il fraseggio cantabile di Britten riesce a dar corpo alla pomposità pretensiosa e goffa del giudice nella prima scena dell'opera, come schizza gustosamente le fatue Nipoti, il pettegolismo astioso di Mrs. Sedley, la bonarietà grave di Balstrode, l'affettuosità romantica di Ellen, la rozza brutalità di Peter.
Comunque, le voci predominano su l'orchestra (anche questo è proprio dello stile melodrammatico); anzi talvolta l'orchestra tace completamente o mormora appena in un brusìo sommesso e inespressivo, isolando totalmente il canto. Ciò serve soprattutto a rendere ben intelligibile il testo.
Ci sono frequenti intenzioni umoristiche e grottesche le quali si alternano alle espressioni liriche e tragiche determinando felici contrasti d'ombre e luci. La politonalità risponde forse all'intenzione di distinguere diversi piani sonori corrispondenti a diversi stati d'animo dei personaggi. È però una distinzione di natura totalmente cerebrale la quale crea le più aspre quanto inutili dissonanze armoniche. Dissonanze favorite anche dalla violenza del carattere di Peter Grimes e dal torbido ambiente di sospetti, di minaccie, di rancore, di odio che le sue azioni determinano, oltre che dall'urto delle bufere del cielo e del mare che cospirano con le tempeste delle anime. Le quali bufere, unitamente alla terribilità e all'ansia delle situazioni drammatiche, costituiscono i soggetti descrittivi di vari interludi. Ma anche i più sereni di essi, sempre polifonicamente molto complessi, descriventi momenti di calma del mare, o movimenti di gioia relativa dello spirito (come l'interludio tra il prologo e la 1a scena dell'atto 1°, e quelli che aprono il 2° e il 3° atto) sono più o meno aspramente dissonanti; e non è detto che questo sistema di urti sgradevoli sia meno convenzionale delle più limpide e gradevoli armonizzazioni ottocentesche, nè che esso contribuisca con maggiore efficacia all'espressione del dramma o alla pittura del paesaggio e dell'ambiente. E, da Strawinski e Schönberg in poi, questa non è più una novità. Ma ciò che in Strawinski o in Schönberg era un gesto di innovazione ribelle, anche se assurdo o cerebrale, ora è divenuto «virtuosismo», e tutto ciò che è virtuosismo ci allontana dalla sincerità e dalla poesia.
Il coro si muove e interviene nell'azione come un personaggio, ma anche questa non è più una novità da quando Mussorgski lo ha trattato così nel Boris Godunoff, a non tener conto degli esempi precedenti del Mosè di Rossini e del Nabuceo di Verdi. Canti e danze popolari sono anche sfruttati con abilità e con enetti suggestivi, sia pure avviluppati dalle inevitabili dissonanze in attrito col loro arcaismo.
La forza drammatica dell'autore si afferma in effetti di contrasto simultaneo, come, ad esempio, nella 1a scena del 2° atto» dove il dialogo tra Ellen e John e quello successivo tra Ellen e Peter si muovono su lo sfondo dei canti sacri che vengono or sì or no, ora fiochi ora forti, a seconda del vento, dalla chiesa. O come nella 1a scena del 3° atto, allorchè la vista della barca di Peter dà origine a nuovi sospetti, e il dialogo si svolge agitato sul torvo commento dell'orchestra, mentre la banda sèguita a suonare vivaci motivi di danza. O come, infine, nell'ultima scena dell'opera, allorchè il vaneggiare di Peter si scioglie in un ondeggiare dolente di suoni su lo sfondo delle lugubri paurose grida lontane che lo chiamano; contrasto che genera un senso drammatico di umana commozione raggiunto con estrema semplicità di mezzi. Dopo la quale scena l'opera si chiude col richiamo descrittivo del freddo sereno paesaggio nordico sul mare: suoni acuti dei violini, arpeggi scialbi, quasi brividi, delle onde, in altra tonalità, e il canto antico dei pescatori. Nuovo contrasto che determina quel senso di drammatico stupore che si prova sempre allorchè la vita consueta riprende dopo le gravi crisi e le tragedie che sembravano arrestarla.
LUIGI FERRARI TRECATE - BURICCHIO: avventure di un monello in 3 atti e un epilogo. Prima rappresentazione al Teatro Comunale di Bologna il 5 novembre 1948. Libretto di Elio Anceschi.
Atto 1° - Nel bosco: una radura; sul fondo la strada che conduce al paese di Cocciapelata; a destra l'interno della rustica «Scuola degli animali». - Ciuchini, conigli, pappagalli ed altre bestie siedono ai banchi; in cattedra sta il Gatto stivalato. La vecchia Volpe (Rettore) annunzia che gli alunni migliori riprenderanno le loro sembianze antiche, e annunzia pure la venuta di un nuovo alunno somarissimo: Buricchio, che infatti giunge con fare spavaldo e sbarazzino. Due somarelli che il «Padrone dei ciuchini» vorrebbe portar via, fuggono, inseguiti dal Padrone e dal Gatto, fra la gazzarra degli «scolari» rimasti. Ne approfitta Buricchio per salire in cattedra e insegnare che le materie di studio sono tutte corbellerie, e che l'importante è godersi. Tutti si mettono entusiasti a ballare. Ma il Gatto stivalato ritorna e punisce Burìcchio legandolo a un albero. Finita la lezione Maestro e scolari se ne vanno, meno il Ranocchio che, di nascosto. Scioglie Buricchio, Ma gli si presentano la Tavola Pitagorica, il Mappamondo e il Compasso che lo ammoniscono invano. La fanfara di un Circo richiama l'attenzione di Buricchio che vuol fuggire coi pagliacci. La Tavola Pitagorica, il Mappamondo e il Compasso scagliano allora l'anatema contro Buricchio, al quale immediatamente crescono orecchie d'asino. Vedendo ciò gli uomini del Circo se lo prendono festanti, prevedendo dalla sua presenza grandi incassi.
Atto 2° - Il Parco dei divertimenti; a destra il «Circo Buricchio». - Dai vari padiglioni i Banditori annunziano alla folla gli spettacoli che stanno per incominciare. Tutti entrano nel Circo. Il Moretto avverte Tizzo che Buricchio ha suggerito al Direttore del Circo di farlo licenziare. Tizzo allora si accorda con un Ragno affinchè rompa la corda su cui danza Aldina. Egli accuserà del disastro Buricchio. Il Ranocchio che ha udito mette in guardia Buricchio. Infatti, quando Aldina va a danzare su la corda, il Ragno sale a slacciarla. Dall'interno si ode il grido di Aldina che precipita e il vociare della folla spaventata. Ma Buricchio che ha visto il Ragno, lo uccide. Quando Tizzo e il Moretto accusano Buricchio, questi mostra il Ragno morto. D'improvviso appare la Fata dai capelli turchini: essa annunzia che Aldina non è morta, ma dorme ammaliata. Solo chi sappia portare l'acqua azzurrina della «Fonte della Sapienza» e le spruzzi con quella il viso potrà risvegliarla. Buricchio vuol tentare l'impresa; ma chi l'aiuterà? Tizzo invoca Belzebù, che si dice pronto purchè in compenso Buricchio gli lasci l'anima. Buricchio acconsente trattandosi «dell'anima di un ciuco». E sul dorso di un Ippogrifo, Belzebù Buricchio Tizzo e il Moretto partono alla conquista dell'acqua azzurrina.
Atto 3° - L'Isola della Sapienza. Al centro il palazzo dei Sapienti; accanto, sul fondo, il mare; a destra su una collinetta, la fontana dell'acqua azzurrina. - Il Ranocchio per salvare Aldina si sprofonda nell'acqua con un fascio di erbe magiche. Giunge sull'Ippogrifo Belzebù con Tizzo, il Moretto e Buricchio. Questi fa per prendere l'acqua, ma dalla fonte non ne scaturisce una goccia. Il Nano Guardiano lo avverte che per avere l'acqua deve dar prova di sapienza. Buricchio bussa allora alla porta del palazzo. Il Gran Sapiente, la Tavola Pitagorica, il Mappamondo e il Compasso lo interrogano, ma egli non sa come rispondere. Viene allora rimproverato e minacciato di essere gettato in mare. Frattanto giungono i Pirati; i Sapienti si rifugiano nel loro palazzo; anche Tizzo e Moretto si nascondono. Buricchio rimane solo, raccoglie il libro che il Gran Sapiente ha lasciato cadere, e si cela egli pure. I Pirati assaltano il Palazzo e ne traggono i Sapienti: hanno sete e vogliono l'acqua; ma il Gran Sapiente non può nulla senza il libro che ha perduto. I Pirati minacciano di ucciderlo. A questo punto Buricchio sbuca dal nascondiglio e si fa nuovamente interrogare rispondendo esattamente a ogni domanda. Tosto le sue orecchie ritornano normali; dalla fontana sgorga l'acqua.
Epilogo. - Davanti al Circo. - Tizzo e Moretto hanno legato Buricchio a un albero del bosco, e ora vengono con la fiala dell'acqua rapitagli per darsi vanto d'aver essi salvata Aldina. Questa vien portata sul suo lettino, e Tizzo le spruzza con un po' d'acqua il viso, ma essa non si risveglia. L'Indovina dice che l' acqua non fa effetto se non è versata da chi l'abbia veramente attinta; e chiede dove sia Buricchio. Questi giunge; riuscì a sciogliersi dai lacci, ed ora smaschera Tizzo. Versa egli stesso l'acqua sul viso di Aldina che riprende i sensi. Ma ora è Belzebù che viene a reclamare, secondo il patto, l'anima di Buricchio. Mentre sta per afferrarlo, ritorna il Ranocchio che si interpone additando come degno dell'Inferno Tizzo, al quale sono cresciute le orecchie. Buricchio pure addita Tizzo a Belzebù poichè gli aveva venduto l'anima di un ciuco. E Belzebù si porta via Tizzo fra la gioia di tutti.
È musica nata dalla fantasia di un artista che ha saputo ascoltare dentro di sè e ridire musicalmente una favola come se il suo cuore fosse ancora quello di un bimbo. Cosa complicata, ed estremamente difficile se la si compie colla pura volontà «cerebrale» di compierla, ma apparentemente semplice se vi è di mezzo quel raro dono naturale (oggi ormai rarissimo) che si chiama «ispirazione». E l'ispirazione facile e spiritosa ha arriso al musicista, il quale, scrivendo una fiaba per «bimbi», non si è dimenticato dei «grandi», ed ha scritta anzi una partitura di una finezza molto superiore alla normale intelligenza di un bimbo. Cosicchè, alla fine, mentre la fiaba coi suoi episodi vivaci e anche sorprendenti divertirà i piccoli, la musica divertirà soprattutto i grandi. Così pare appunto che sia avvenuto, a leggere le cronache, quando l'opera, scritta nel 1943, fu, passata la tragica bufera della guerra, eseguita nel 1948 a Bologna.
Trascinato dalla sovrabbondanza dei personaggi e degli episodi, Ferrari Trecate ha sciorinato una vera serie di monellerie strumentali, ritmiche e armoniche parodistiche, umoristiche, grottesche e anche sentimentali gustose. Ne è risultata una musica meno semplice, e quindi, per un pubblico non sufficientemente aggiornato, meno prontamente accessibile di quella di Ghirlino, ma certo più preziosa.
Buricchio si presenta, nella sua entrata al 1° atto («Non chiedo il permesso») e nella successiva lezione agli scolari-animali, come un fanciullo spavaldo e petulante; ma dal 2° atto in poi, salvo la birichinata della gonfiatura della donna-elefante, appare come un buon ragazzo. In Aldina il bimbo incontra il suo primo incosciente e innocente affetto, che nel 3° atto, dopo l'esame fallito, (di cui egli mostra di sentire subito il danno e l'umiliazione) lo riavvicina allo studio, gli infonde coraggio e lo redime. Salva la testa del Gran Sapiente dalla scimitarra del Pirata, salva gli altri Savi da una medesima sorte, fa sgorgare l'acqua azzurrina, e perde le orecchie d'asino, risvegliando infine (Epilogo) la giovinetta magicamente assopita. Tutto ciò la musica illustra con garbo; e si capisce come, dopo la vittoria innanzi ai Sapienti e ai Pirati, e ai tre più diretti avversar!: la Tavola Pitagorica, il Mappamondo e il Compasso, orchestra e coro si levino in una perorazione sonora di miracolistico entusiasmo. Quei benedetti personaggi simbolici della Tavola Pitagorica, del Mappamondo e del Compasso, che nel 1° atto si presentano in modo caricaturale pedantesco, cantando su formule quasi da riti funebri sacri, e farebbero scappare la voglia di studiare anche a bimbi meno svogliati e sbarazzini di Buricchio, alla fine del 3° atto sono costretti a prender parte all'entusiamo generale gridando anch'essi: «Miracolo!».
Tra la movimentatissima azione e la ridda dei particolari e delle scenette bizzarre e burlesche, come la marcetta sgangherata del Circo, la vivacità indiavolata del finale 2°, la citazione fredduristica di una Sonatina di Clementi allorchè Belzebù dice ai suoi demonietti: «Non vi voglio mai Clementi», e l'altra dal Ghirlino allorchè il Ranocchio dice di essere stato liberato dalla Fata Buonastella (citazioni, del resto, erudite che non possono essere apprezzate che da musicisti) passano pagine più distese e largamente cantabili. Ecco allora, nel 2° atto, la malinconia dei Banditori che vedono disertati i loro padiglioni dal pubblico che si riversa in massa al Circo; la galante, lieve e graziosissima danza dei Tarocchi; e la soave apparizione della Fanciulla dai capelli turchini di collodiana memoria. L'apparizione di questa è accompagnata dal fascino di una melodia ricca di delicato senso di incantamento. Può sembrare strano che questo stesso canto, il quale più che alla Fata si riferisce all'Acqua azzurrina, ritorni al momento in cui Belzebù propone di aiutare Buricchio a trovare l'Acqua miracolosa, ma è appunto ammantandosi di questo fascino che il diavolo può più facilmente far breccia. Con altri accenti più diabolici avrebbe destata la diffidenza del furbo Buricchio e avrebbe fallito lo scopo.
Naturalmente, essendo presenti sulla scena molti animaletti, nell'orchestra ricorrono frequenti onomatopee delle loro particolari voci, e principalmente e più di frequente, quasi vero leitmotiv, ricorre il raglio dell'asino, che da Buricchio passa alla fine al nuovo orecchiuto Tizzo.
GIAN CARLO MENOTTI (Cadegliano [Varese] 1911) - IL CONSOLE: dramma musicale in 3 atti. Prima rappresentazione al Schubert Theater di Filadelfia il 1° marzo 1950. Libretto dello stesso Menotti.
Atto 1° - Scena 1a - La misera abitazione di John Sorel in una grande città d'Europa: epoca presente. Nel vano d'una finestra sono l'acquaio e il fornello a gas. Da un lato la culla col bimbo. - È mattina presto. John rientra da un convegno politico ove la Polizia irruppe di sorpresa e lo ferì. Mentre la moglie Magda e sua Madre lo curano, giunge la Polizia, John vien fatto salire in un nascondiglio sui tetti. Gli Agenti interrogano, perquisiscono, e se ne vanno senza averlo trovato. John, ridisceso, si decide a fuggire; varcherà nella notte il confine. Avverte Magda che se sarà tirato un sasso alla finestra, chiami il vetraio Assan: da lui avrà sue notizie.
Scena 2a - La sala d'aspetto del Consolato. In un angolo, separato da una balaustra, il tavolo della Segretaria. Dietro lei, la porta dell'Ufficio del Console. - Lo stesso giorno, più tardi. Varie persone si presentano alla Segretaria, sempre rimandate da questa con pretesti burocratici. Anche Magda viene a chiedere di parlare al Console per poter seguire il proprio marito, ed è freddamente respinta dalla Segretaria.
Atto 2° - Scena 1a - La stanza di John, un mese dopo. - È il tardo pomeriggio. Magda rientra affranta da un'ennesima visita al Consolato, e sempre invano. La Madre s'affatica cercando di far sorridere il bimbo, che non sì muove più. Magda si addormenta su una sedia ed ha un sogno pauroso. Poco dopo un sasso spezza un vetro della finestra. Magda si precipita al telefono a chiamare Assan; ma prima di lui entra un Agente della polizia segreta, il quale vorrebbe i nomi degli amici di John, ed esce solo dopo che è giunto Assan. Questi narra che John è ancora sui monti e non ha potuto varcare il confine. Magda consegna al vetraio un pacco per John e gli raccomanda di dirgli che lo raggiungerà. Frattanto la Madre si è accorta che il bimbo è morto.
Scena 2a - La sala d'aspetto del Consolato. - Pochi giorni dopo. Un Illusionista chiede il visto su una carta, e intanto compie vari giuochi di prestigio, ipnotica e fa ballare i presenti. Magda chiede ancora di parlare al Console, e di fronte ai rifiuti della gelida Segretaria dà in escandescenze. La sua disperazione commuove per un momento la Segretaria, che entra dal Console a chiedere il colloquio per lei. Ma al momento di entrare dal Console, Magda vede uscirne l'Agente segreto e cade svenuta.
Atto 3° - Scena 1a - Al Consolato parecchi giorni dopo. - Magda vuol vedere il Console, ma questi è assente. Mentre aspetta giunge Assan, dal quale apprende che John ha saputo che il bimbo e la madre sono morti, e vuol tornare. Se torna lo arrestano; bisogna impedirglielo. Magda scrive un biglietto per John, lo consegna al vetraio e parte. Mentre anche la Segretaria sta per andarsene, compare John. Ma gli agenti di Polizia lo hanno visto, irrompono e lo arrestano. La Segretaria protesta per la violazione del Consolato, e corre al telefono per avvisare la moglie di John.
Scena 2a - In casa di Sorel, subito dopo. - Il telefono suona quattro volte, ma nessuno è in casa. Poco dopo giunge Magda, la quale, turate porte e finestre si siede presso il fornello ed apre il rubinetto del gas chinandovisi sopra e coprendosi il capo con uno scialle per aspirare meglio. Una spaventosa allucinazione la atterrisce: le persone viste al Consolato avanzano spettrali verso di lei, e guidate dall'Illusionista danzano un valzer macabro; poi le appaiono la madre e John che la invitano a seguirli. Il telefono suona ancora: Magda allunga una mano verso il ricevitore, ma cade riversa, estinta.
Su un soggetto con azione quasi nulla il Musicista italo-americano ha composta un'opera di intensa drammaticità, che tiene avvinti per un continuo interesse umano ai casi dei personaggi principali, che sono Magda, suo marito John Sorel, la Segretaria del Consolato, e l'Agente della Polizia segreta. Ma anche le figure secondarie, la Madre di Magda, Assan, i cinque postulanti presso il Consolato» fra cui un Illusionista, giuocano una parte non indifferente nello svolgimento degli avvenimenti e soprattutto nella creazione di un ambiente fortemente suggestivo. E alla creazione di tale ambiente, pieno di smisurata tristezza e desolazione, di miseria materiale e morale, contribuiscono anche il piccolo bimbo di Magda, che si immagina dentro la culla, ove muore alla fine della 1a scena del 2° atto, e la canzone di un disco che sale nella squallida casa di Sorel da un caffè della strada. Il Console, si sa che c'è, se ne vede anche l'ombra alla fine del 2° atto, al di là della porta alle spalle della Segretaria; ma chi fa tutto è costei. Figura gelida, personificazione della più odiosa burocrazia, donna che avrà anch'essa una sua vita affettiva, come si comprende da una breve conversazione telefonica e da un unico attimo di commozione da cui è presa (atto 2°, scena 2a) davanti alla forsennata disperazione di Magda, ma che appare come il simbolo e l'incubo atroce di uno Stato crudelmente meccanizzato, tutto carte, firme e timbri, ostile e senza cuore.
La musica si è assunto il difficile compito di trasfigurare in poesia sonora l'ossessionante spasimo della tragica vicenda di queste anime, che si dibattono nell'ombra opaca di un'atmosfera soffocante, prese fra le morse inesorabili di una volontà malefica e oscura impersonata invisibilmente dal Console o da chi governa più in alto di lui, e dalla visibile Segretaria, esecutrice inflessibile di ordini disumani. Naturalmente, l'asprezza di questi avvenimenti non poteva non trascinare il musicista verso un'espressione dura, che si vale dei più moderni mezzi dissonantistici, per la loro frequenza a volte inefficaci. L'uso logora la dissonanza più presto della consonanza. Nessuno può pensare che la formidabile scena della pendola nel Boris Godunoff di Mussorgski, unica nell'opera col suo allucinante dissonantismo, avrebbe la stessa potente efficacia se fosse soffocata fra altre scene continuamente dissonanti. Nel Console i soli temi che sostengono il peso del dramma e caratterizzano i personaggi sono quelli che, pur con modesta forza, girano in orchestra; perchè nella parte vocale mancano motivi scultoreamente incisivi. Non scarseggiano le pagine in cui armonia e canto si spianano e si addolciscono, come nel terzetto che chiude il 1° atto: «Labbra, ditegli addio», assai bello per la melodia e per la costruzione, anche se di derivazione pucciniana; nel commosso racconto della Straniera (atto 1°, scena 2a) e nel quintetto che chiude questo atto. Così è pure della Ninna-nanna della Madre: «Mentre dormi tu, ninna, oh!» (atto 2°, scena 1a) Il sogno di Magda nello stesso atto si mantiene anch'esso in questa penombra quasi di ninna-nanna fantasmagorica, solo verso la fine agitata da un senso di oppressione paurosa.
Lo scatto di Magda (atto 2°, scena 2a): «Dunque è così: che l'uomo nega il mondo all'uomo», ha un'espressione robustamente drammatica, che si allarga in un respiro di liberazione alle parole: «Oh, giorno verrà, lo so, che i nostri cuori in fiamme le tue carte bruceranno!». È a questo punto che la Segretaria medesima appare scossa dal suo torpore burocratico, dalla sua fredda assenza di umanità.
Fino dall'apertura dell'opera la banalità dolciastra della canzonetta del «disco», così in contrasto con la cieca ostilità e durezza del destino, questa canzonetta con quelle sue parole volgari, eppure, nei due primi e due ultimi versi, quasi profetiche, ci dà un senso di ansia e di malessere acuti. Poi, come nella vita, fra le pieghe oscure della tragedia si insinua la farsa e il grottesco, specialmente nei giuochi di prestigio e di ipnotismo dell'Illusionista alla 2a scena del 2° atto, allorchè i disperati postulanti danzano su una musica tra il valzer e il minuetto, meccanica, malinconica e trasognata insieme, e si abbandonano incoscienti a un'effimera illusione di piacere dentro al severo ambiente del Consolato, dove pure la speranza e la giustizia non sono che illusioni amare. Così pure nella scena 1a del 3° atto, allorchè la Segretaria fa firmare a Vera Boronel le innumeri carte finalmente in regola, la musica svolge una specie di «canzonetta della Burocrazia» umoristica e malinconica insieme.
La scena di più ossessionante suggestione è l'ultima dell'opera, alla quale si arriva attraverso a una specie di grottesca «marcia alla morte», e nella quale l'autore ci fa assistere al suicidio di Magda, in ogni più atroce particolare, e dove la «marcia alla morte» diviene il coro fantomatico delle allucinazioni che accompagnano l'agonia. Dal punto di vista drammatico forse la cosa che più impressiona è quel campanello del telefono, che potrebbe essere la salvezza di Magda, e che fatalmente squilla invano prima del suo arrivo e nel momento della sua morte, nel vuoto desolato di una casa dove non vive più alcuno. Musicalmente, dopo il doloroso preludio della 1a scena di questo atto, nulla uguaglia l'angoscia del macabro valzer che accompagna lo spaventoso sogno, così spiriticamente immateriale, così cupamente spettrale.
Chiude l'opera una perorazione orchestrale in cui ritorna fortissimo il motivo di Magda: «Verrà un giorno»; ma il giorno della Libertà è quello della Morte!
RICCARDO STRAUSS - L'AMORE DI DANAE: gaia mitologia in 3 atti. Prova generale con pubblico al Teatro di Salisburgo il 16 agosto 1944. Prima rappresentazione allo stesso Teatro il 14 agosto 1952. Libretto di Joseph Gregor, il quale si servì di una trama di Hugo von Hofmannsthal modificandola radicalmente.
Atto 1° - Quadro 1° - Sala del trono di Re Polluce, piuttosto rovinata. - Creditori in folla assediano il Re per essere pagati. Essi strappano dal trono gli ultimi pezzi d'oro che ancora vi erano. Il Re cerca di rassicurarli dicendo loro che il ricchissimo Mida, Re di Lidia, sposerà sua figlia Danae e pagherà i débiti,
Quadro 2° - Camera da letto di Danae nell'oscurità. - Dirotta pioggia d'oro cade su Danae, che l'avverte come una carezza voluttuosa, invano contradetta dalla fantesca Xanthe che nulla vede.
Quadro 3° - Cortile a colonne nel palazzo: sul fondo il mare. - I quattro Re nipoti che Polluce aveva inviati alla ricerca di un ricco sposo per Danae, ritornano raccontando le meravigliose ricchezze di Re Mida, il quale trasforma in oro tutto ciò che tocca. Egli ha mandato a Danae un ramoscello d'oro, di cui i creditori tentano di impossessarsi. Ed ecco giungere Re Mida su una nave d'oro. Egli però si presenta a Danae dicendo di essere un messo di Mida, e l'avverte che Mida è incostante in amore. Abbagliata dal sogno d'oro, Danae si lascia condurre incontro a Mida, che altri non è che Giove sotto mentite apparenze; ma alla sua vista Danae sviene.
Atto 2° - Stanza sontuosa. - Le quattro Regine, Leda, Semele, Alkmene ed Europa, stanno ornando il letto nuziale, e riconoscono nel finto Mida il loro antico amante Giove, di cui si sentono ancora innamorate. Giove le invita a tenere il segreto: egli teme l'ira e la vendetta di Giunone. A Mida poscia, rimprovera d'averlo tradito, poichè s'è accorto già che Danae ama lui. Pensi al dono fattogli, di trasformare in oro tutto ciò che tocca, e gli lasci l'amore di Danae. Ma quando, poco. dopo, Mida si incontra con Danae, le dichiara chi egli sia e le rivela la propria potenza e il proprio amore. Poi, dimentico del proprio potere Mida la bacia, e Danae si trasforma in una statua d'oro. Giove sopraggiunge: interroga la statua per sapere chi dei due vuol seguire, e Danae, cui il bacio di Mida ha trasfuso l'amore, dichiara che seguirà quest. Giove allora le ridà la vita e toglie a Mida la sua triste potenza magica. Danae si allontana con Mida.
Atto 3° - Quadro 1° - Strada in oriente. - Perduta col dono magico ogni ricchezza, Mida si avvia con Danae e un asinello verso la propria terra. Ma sono entrambi felici perchè si amano, e ciò vale più dell'oro.
Quadro 2° - Paesaggio boschivo orientale nelle montagne. - Mercurio racconta a Giove le risa che si fecero in Olimpo allorché gli Dei videro che Danae aveva preferito seguire un povero asinaio piuttosto che Giove. Ma le quattro vecchie Regine hanno seguito Giove e vorrebbero ancora il suo amore. Giove, lusingato dalla costanza del loro affetto, fa sorgere dal suolo una ricca tavola d'oro imbandita e con le Regine si siede al desco, prendendo congedo da loro con bontà. Ma sopraggiunge improvvisamente Polluce inseguito dai creditori e accompagnato dai quattro Re, che a lor volta inseguono le mogli infedeli. La reggia arse; i creditori insistono per esser pagati. Mercurio consiglia Giove a pagare, e Giove fa cadere su tutti una gran pioggia di monete. La folla si disperde dietro la pioggia d'oro che si allontana.
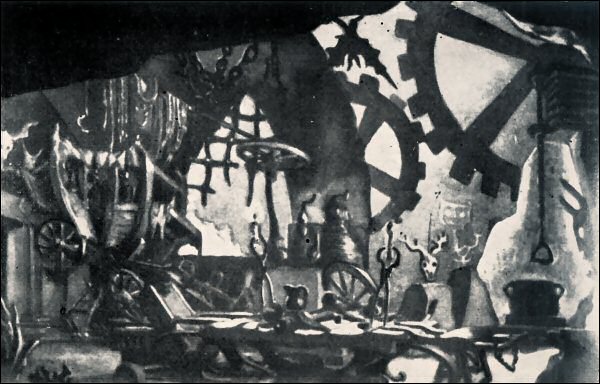
Figura 19: Scena di Zampini per I Cavalieri di Ekebù di Zandonai.

Figura 20: Scena di Mancini per L'amore dei tre re di Montemezzi.
Quadro 3° - L'interno della capanna dell'asinaio Mida.- Danae è felice del proprio stato. Giove entra travestito e non riconosciuto, e apprende da Danae con quale gioia essa abbia rifiutato l'oro per l'amore fedele in onesta povertà. E allo straniero, prima che parta, Danae fa dono dell'unico oggetto d'oro che ancora conservava: un pettine. Giove, commosso, invoca la benedizione di un perenne amore sui due sposi, e s'allontana. Danae s'affretta gioiosa incontro a Mida che ritorna.
Di quest'ultima opera di Riccardo Strauss fu fatta a Salisburgo una prova generale nel 1944 davanti a un pubblico di invitati; ma la guerra e le condizioni disastrose del dopoguerra ne impedirono la rappresentazione fino al 1952, e cioè tre anni dopo la morte del Maestro. L'opera non ha rivelato nessun cambiamento nella tecnica armonistica, strumentale e costruttiva di Strauss; soltanto, se mai, una tendenza a ripiegare su posizioni più palesemente wagneriane, e una minore aggressività delle armonie in confronto di Salomé e di Elettra.
Non vi è, come del resto nelle altre opere, una grande novità di invenzione tematica, chè anzi molti di questi motivi richiamano spontaneamente alla memoria motivi d'altre opere sue e di altri autori passati. Comunque, essi non hanno nè la precisa significazione, nèlo scultoreo rilievo di quelli wagneriani. Ma l'abilità con la quale lo Strauss li sviluppa, li intreccia secondo il suo sistema polifonico prediletto, e li trasforma seguendo il metodo delle variazioni ritmiche, il caleidoscopio delle modulazioni sorprendenti, in una luce strumentale abbagliante, sono sempre qualità prodigiose e confermano una sicura consumatissima sapienza.
De L'amore di Danae è stato detto forse troppo bene da alcuni, troppo male da altri. Chi si aspettava una parola nuova, come solo potè dire un Monte verdi con L'incoronazione di Poppea, e un Verdi col Falstaff, è naturale che sia rimasto deluso. Ma chi ascolta la Danae senza preconcetti, troverà che la vena melodica vocale, anche se non soverchiamente originale, scorre con facile fluidità, che le architetture sono ariose e solide, che i colori sono vividi, che nell'insieme l'opera è piacevole. I difetti maggiori sono forse una certa prolissità di talune parti (che nella recente rappresentazione alla Scala si credette - giustamente - opportuno di amputare), e la quasi totale mancanza di caratterizzazione dei personaggi. La musica commenta e illustra l'azione seguendola momento per momento. Solo qualche volta l'azione stessa suggerisce un disegno che fissa la figura delle persone sceniche. Per esempio, all'inizio dell'opera, i Creditori escono vivi dalla musica che dipinge il loro vociare insistente, prepotente, e anche un poco pettegolo. Giove pure appare tratteggiato con una certa solennità nei suoi recitativi. Le quattro Regine, Leda, Semele, Alkmene ed Europa, che furono amate un tempo da Giove, ma ormai appassite, anche se non si distinguono musicalmente l'una dall'altra, hanno però un loro cicalamento amoroso caratteristico e che richiama un poco le Ondine nel dialogo con Sigfrido dell'ultimo atto del Crepuscolo degli Dei e la Fanciulle-fiori del Parsifal.
Non ostante i rilievi di varia nature che si possono fare a quest'opera, è certo ch'essa contiene molte belle pagine. Ricordiamo il dolce melodioso racconto che Danae fa a Xanthe del proprio sogno (atto 1°), anche se un po' valzereggia. Il motivo, già comparso in forma fugata nell'interludio descrivente la pioggia d'oro che Danae ha sognata, ricorda il «Cigno» di Saint-Saëns ed è uno dei più ampiamente sviluppati, trasformati, e frequentemente ritornanti, poichè diventa un tema fondamentale dell'opera: il tema di Danae. L'arrivo di Mida si svolge in un movimento musicale di vibrante eccitazione. Anche l'arrivo di Giove è pieno di entusiasmo e di slancio; poi dalle solenni parole ch'egli pronuncia, fino alla fine dell'atto, tutto è fresco e piacente.
Nel 2° atto, umanamente e liricamente commosso è il duetto d'amore fra Mida e Danae, soprattutto per la nuova melodia che simboleggia l'amore puro» e che si svolge con largo respiro e con vivo rapimento estatico. Al momento del bacio e della conversione di Danae in una statua d'oro, la musica assume un colorito pieno di stupore magico e tragico insieme efficacissimo. Ma nel 3° atto, su la farsa e la magìa emerge un senso di umanità che ci porta in un piano di più alta poesia. Dopo l'appassionato preludio e il nuovo tenero duetto in cui Danae e Mida cantano la loro felicità, ecco il vivace Mercurio (un po' Till Eulenspiegel); e quindi il Quartetto delle Regine» in forma, curiosamente, di «Cànone». La pittoresca pioggia di monete è l'ennesima variazione del tema di Danae; pioggia fitta e leggera insieme, picchiettante, fortemente suggestiva. Pagina veramente d'oro!
Le ultime pagine, dal morbido e patetico intermezzo del 3° quadro, al dolcissimo «lieder» di Danae, al duetto con Giove, spirano un'aria di sentita e commossa umanità. Nella scena finale questo vecchio Giove libertino che finalmente benedice all'amore puro e fedele, acquista quasi un aspetto cristiano. La musica se ne risente: la densità strumentale si schiarisce, le armonie si rarefanno, l'atmosfera nel racconto della leggenda di Maja diviene idillica. E quando Danae dona a Giove il pettine d'oro, e il Dio si allontana con una estrema rinunzia, una trepida malinconia addolcisce con un senso religioso gli ultimi accenti ed accordi con cui l'opera si chiude.
[Torna all'indice]
APPENDICE
[Torna all'indice]
Prospetti cronologici delle opere più importanti
Diamo in appendice una serie di prospetti cronologici delle principali opere, dall'Amfiparnaso di Orazio Vecchi e dai primi tentativi della Camerata Fiorentina alle opere più recenti. Tali prospetti, oltre che offrire ai lettori riassunti sintetici dello sviluppo del melodramma attraverso ai secoli, sono utili per i raffronti che permettono di fare e le osservazioni che possono suggerire. Si può constatare, ad esempio, come certe epoche siano dominate da .taluni artisti, i quali vi imprimono il suggello del loro genio sovrano, così che le epoche stesse possono prendere nome da loro: 1607-1642 Monteverdi; 1675-1686 Lulli; 1774-1779 Gluck; 1782-1791 Mozart; 1813-1829 Rossini; 1831-1849 Meyerbeer, Bellini e Donizetti; 1842-1893 Verdi e Wagner. Possiamo notare il sorgere delle varie scuole nazionali: la francese con Lulli (metà del sec. XVII); l'inglese, per quanto di effimera vita, con Purcell (fine del sec. XVII); la tedesca con Gluck (seconda metà del sec. XVIII); la russa con Glinka (prima metà del sec. XIX).
Interessanti ed eloquenti sono poi certi accostamenti i quali ci illuminano su le condizioni di gusto e di cultura di talune nazioni od epoche. Ecco, ad esempio, fra il Guglielmo Tell di Rossini (1829) e la Norma di Bellini (1831), il modesto Fra Diavolo di Auber (1830), opera che pure è il suo capolavoro, come Auber è il maggiore musicista francese del tempo. Ed ecco la fragile Marta (1847) di Flotow, o il pure modesto Crispino e la Comare dei Fratelli Ricci (1850), opere che tuttavia non mancano di bellezze ed ebbero grande fortuna, fra l'apparizione di tre opere poderose, ispirate a ben altra e più alta idealità e dignità, quali il Tannhäuser di Wagner (1845) e la Dannazione di Faust di Berlioz (1846) da un lato, e il Lohengrin di Wagner (1850) e il Rigoletto di Verdi (1851) dall'altro. Più stridente ancora la nascita del Tristano e Isotta di Wagner (1865) accanto alla sentimentale e gracile Mignon di Thomàs (1866); i Maestri Cantori di Wagner e Le educande di Sorrento di Usiglio nel medesimo anno (1868); L'anello del Nibelungo di Wagner eseguito nello stesso anno (1876) in cui il pubblico italiano applaude e saluta quasi come una rivelazione La Gioconda di Ponchielli; il Parsifal di Wagner (1882) tra I racconti di Hoffmann di Offenbach (1881) e la Lakmé di Délibes (1883); La Germania di Franchetti, l'Oceàna di Smareglia e il Pelléas et Mélisande di Debussy nello stesso anno 1902! E si potrebbe continuare, e i raffronti sarebbero anche più urtanti e paradossali se avessimo citate nei prospetti le opere più scadenti e gli autori meno noti anzichè quelli più significativi.
Altra osservazione: lunghi periodi privi di opere teatrali insigni non ne esistono. Per contro, capita più volte di trovare numerosi capolavori in un periodo di tempo ristretto; di Gluck nell'intervallo di soli sei anni (1774-1779); Orfeo, Ifigenia in Aulide, Alceste, Armida, Ifigenia in Taurine;di Mozart in due anni (1786-1787): Le nozze di Figaro, Don Giovanni; dal 1831 al 1836, cioè in soli cinque anni: La Sonnambula e la Norma di Bellini, L'elisir d'amore e la Lucia di Donizetti, Gli Ugonotti di Meyerbeer. Dal 1850 al 1854: Lohengrin di Wagner, Rigoletto, Trovatore e Traviata di Verdi; dal 1871 al 1876: Aida di Verdi, Boris di Mussorgski, Mefistofele di Boito (edizione nuova), Carmen di Bizet, i Nibelunghi di Wagner. Nello stesso anno 1893 (per quanto di valore notevolmente diversi): Falstaff di Verdi, Hänsel e Gretel di Humperdinck, Manon Lescaut di Puccini; pure in uno stesso anno (1896) lo Chénier di Giordano e La Bohème di Puccini. Ancora in un periodo di quattro anni (1906-1909) I quattro rusteghi di Wolf-Ferrari, l'Arianna e Barbableu di Dukas, e Salomédi Strauss.
Negli anni 1842 e 1843 Verdi e Wagner, rispettivamente con il Nabucco e con il Vascello fantasma, affermavano in modo preciso e forte la loro così diversa personalità, e nel 1843 Donizetti chiudeva si può dire l'epoca dell'opera buffa e dava al mondo il suo ultimo capolavoro con il Don Pasquale. Nel 1909 accanto alle frenetiche Salamé ed Elettra di Strauss, un italiano di padre tedesco, Wolf-Ferrari, porta in Germania il sorriso gentile ed equilibrato della nostra razza con la graziosa miniatura del Segreto di Susanna.
A pochi anni di intervallo quattro nazioni, Germania, Francia Italia e Russia, per opera dei quattro maggiori loro musicisti ci danno le più perfette affermazioni delle loro diverse indoli artistiche: nel 1882 il misticismo del Parsifal di Wagner, nel 1884 la delicata e aristocratica civetteria e passione della Manon di Massenet, nel 1885 la vigorosa forza popolaresca primitiva della Kovàncina di Mussorgski, e nel 1887 la tragicità veemente dell'Otello di Verdi.
E ci fermeremo per non essere troppo tediosi e pedanti, lasciando ai lettori le facili osservazioni che si possono ancora fare scorrendo le tabelle seguenti, alle quali osservazioni ciascuno può aggiungere i commenti e le conclusioni che, a seconda del proprio punto di vista, sembreranno migliori.
Prospetti delle opere più importanti e più note
| Anno | AUTORE | OPERA | Località della prima rappresentazione |
|---|---|---|---|
| 1594 | Orazio Vecchi | Amfipamaso | Modena |
| 1599 | Jacopo Peri | Dafne | Firenze |
| 1600 | Emilio de' Cavalieri | La rappresentazione di Anima e di Corpo | Roma |
| 1600 | Jacopo Peri | Euridice | Firenze |
| 1602 | Giulio Caccini | Euridice | Firenze |
| 1607 | Claudio Monteverdi | Orfeo | Mantova |
| 1608 | Marco da Gagliano | Dafne | Mantova |
| 1608 | Claudio Monteverdi | Arianna | Mantova |
| 1627 | Enrico Schütz | Dafne | Torgau |
| 1628 | Marco da Gagliano | La Flora | Firenze |
| 1632 | Stefano Landi | Sant'Alessio | Roma |
| 1637 | Francesco Manelli | Andromeda | Venezia (inaugurazione del primo teatro pubblico: il San Cassiano) |
| 1642 | Luigi Rossi | Il palazzo d'Atlante | Roma |
| 1642 | Claudio Monteverdi | L'incoronazione di Poppea | Venezia |
| 1647 | Luigi Rossi | Orfeo | Parigi |
| 1649 | Francesco Cavalli | Giasone | Venezia |
| 1649 | Marcantonio Cesti | Orontea | Venezia |
| 1654 | Francesco Cavalli | Serse | Venezia |
| 1657 | Jacopo Melani | La Tancia, o il Podestà di Cològnole (prima opera buffa) | Firenze |
| 1662 | Francesco Cavalli | Ercole amante | Tuileries |
| 1663 | Marcantonio Cesti | Dori | Venezia |
| 1667 | Marcantonio Cesti | Il pomo d'oro | Vienna |
| 1675 | Giambattista Lulli | Teseo | Parigi |
| 1676 | Giambattista Lulli | Atys | Parigi |
| 1677 | Giambattista Lulli | Isis | Parigi |
| 1679 | Alessandro Stradella | Il Trespolo tutore | ? |
| 1686 | Giambattista Lulli | Armida e Rinaldo | Parigi |
| 1686 | Giambattista Lulli | Aci e Galatea | Parigi |
| 1688 | Enrico Purcell | Didone ed Enea | Londra |
| 1703 | Giovanni Bononcini | Poliremo | Berlino |
| 1707 | Alessandro Scarlatti | Mitridate Eupatore | Napoli |
| 1720 | Giovanni Bononcini | Astato | Londra |
| 1721 | Alessandro Scarlatti | Griselda | Napoli |
| 1722 | Giovanni Bononcini | Griselda | Roma |
| 1727 | Benedetto Marcello | Arianna | Venezia |
| 1733 | Giambattista Pergolesi | La serva padrona | Napoli |
| 1735 | Giambattista Pergolesi | Olimpiade | Roma |
| 1737 | Filippo Rameau | Castore e Polluce | Parigi |
| 1752 | Gian Giacomo Rousseau | L'indovino del Villaggio | Fontainebleau |
| 1754 | Baldassare Galoppi | Il filosofo di campagna | Venezia |
| 1760 | Niccolò Piccinni | La buona figliola, o la Cecchina | Roma |
| 1762 | Cristoforo Gluck | Orfeo ed Euridice | Vienna (2a ediz. Parigi 1774). |
| 1767 | Cristoforo Gluck | Alceste | Vienna (2a ediz. Parigi 1776). |
| 1774 | Cristoforo Gluck | Ifigenia in Aulide | Parigi |
| 1775 | Giovanni Paisiello | Il Socrate immaginario | Napoli |
| 1777 | Cristoforo Gluck | Armida | Parigi |
| 1779 | Cristoforo Gluck | Ifigenia in Tauride | Parigi |
| 1781 | Domenico Cimarosa | Giannina e Bernardone | Venezia |
| 1782 | Giovanni Paisiello | Il Barbiere di Siviglia | Pietroburgo |
| 1782 | Wolfango Amedeo Mozart | Il ratto del Serraglio | Vienna |
| 1784 | Antonio Salieri | Le Danaidi | Parigi |
| 1784 | Andrea Grétry | Riccardo cuor di leone | Parigi |
| 1785 | Antonio Salieri | La grotta di Trofonio | Vienna |
| 1786 | Wolfango Amedeo Mozart | Le nozze di Figaro | Vienna |
| 1787 | Wolfango Amedeo Mozart | Don Giovanni | Praga |
| 1788 | Giovanni Paisiello | La bella molinara | Napoli |
| 1789 | Giovanni Paisiello | Nina o la pazza per amore | Napoli |
| 1790 | Wolfango Amedeo Mozart | Così fan tutte | Vienna |
| 1791 | Wolfango Amedeo Mozart | // flauto magico | Vienna |
| 1792 | Domenico Cimarosa | Il matrimonio segreto | Vienna |
| 1797 | Luigi Cherubini | Medea | Parigi |
| 1800 | Luigi Cherubini | Le due giornate, o Il portatore d'acqua | Parigi |
| 1805 | Ludwig van Beethoven | Fidelio | Vienna |
| 1807 | Etienne Méhul | Giuseppe | Parigi |
| 1807 | Gaspare. Spuntini | La Vestale | Parigi |
| 1809 | Gaspare Spuntini | Fernando Cortez | Parigi |
| 1812 | Gioacchino Rossigni | La pietra del paragone | Milano |
| 1813 | Gioacchino Rossigni | Tancredi | Venezia |
| 1813 | Gioacchino Rossigni | L'Italiana in Algeri | Venezia |
| 1816 | Gioacchino Rossigni | Il Barbiere di Siviglia | Roma |
| 1817 | Gioacchino Rossini | Cenerentola | Roma |
| 1817 | Gioacchino Rossigni | La gazza ladra | Milano |
| 1819 | Gioacchino Rossigni | La donna del lago | Napoli |
| 1819 | Gaspare Spuntini | Olimpia | Parigi |
| 1821 | Carlo Maria Weber | Il franco cacciatore (Der Freischütz) | Berlino |
| 1823 | Gioacchino Rossini | Semiramide | Venezia |
| 1823 | Carlo Maria Weber | Euryanthe | Vienna |
| 1825 | Francesco Adriano Boïeldieu | La dama bianca | Parigi |
| 1826 | Carlo Maria Weber | Oberon | Londra |
| 1826 | Gioacchino Rossini | L'Assedio di. Corinto | Parigi (rifacimento del Maometto II [Napoli 1820]) |
| 1827 | Gioacchino Rossini | Mosè | Parigi (rifacimento del Mosè in Egitto [Napoli 1818]) |
| 1827 | Vincenzo Bellini | Il Pirata | Milano |
| 1828 | Daniele Auber | La muta di Portici | Parigi |
| 1828 | Gioacchino Rossini | Il Conte Ory | Parigi |
| 1829 | Gioacchino Rossini | Guglielmo Tell | Parigi |
| 1830 | Daniele Auber | Fra Diavolo | Parigi |
| 1831 | Vincenzo Bellini | La Sonnambula | Milano |
| 1831 | Ferdinando Hérold | Zampa | Parigi |
| 1831 | Giacomo Meyerbeer | Roberto il Diavolo | Parigi |
| 1831 | Vincenzo Bellini | Norma | Milano |
| 1832 | Gaetano Donizetti | L'Elisir d'amore | Milano |
| 1833 | Gaetano Donizetti | Lucrezia Borgia | Milano |
| 1835 | Vincenzo Bellini | I Puritani | Parigi |
| 1835 | Fromental Halévy | L'Ebrea | Parigi |
| 1835 | Gaetano Donizetti | Lucia di Lammer moor | Napoli |
| 1836 | Giacomo Meyerbeer | Gli Ugonotti | Parigi |
| 1836 | Gaetano Donizetti | Il Campanello | Napoli |
| 1836 | Michele Glinka | La vita per lo Csar | Pietroburgo |
| 1837 | Saverio Mercadante | Il giuramento | Milano |
| 1837 | Alberto Lortzing | Zar e carpentiere | Vienna |
| 1839 | Saverio Mercadante | Il bravo | Milano |
| 1840 | Gaetano Donizetti | La figlia del Reggimento | Parigi |
| 1840 | Gaetano Donizetti | Les Martyrs | Parigi (rifacimento dell'opera Poliuto, scritta nel 1838 per Napoli, e proibita dalla Censura) |
| 1840 | Giovanni Pacini | Saffo | Napoli |
| 1840 | Gaetano Donizetti | La Favorita | Parigi |
| 1842 | Giuseppe Verdi | Nabucco | Milano |
| 1842 | Gaetano Donizetti | Linda di Chamounix | Vienna |
| 1843 | Riccardo Wagner | Il vascello fantasma | Dresda |
| 1843 | Gaetano Donizetti | Don Pasquale | Parigi |
| 1843 | Giuseppe Verdi | I Lombardi alla prima Crociata | Milano |
| 1844 | Giuseppe Verdi | Ernani | Venezia |
| 1845 | Riccardo Wagner | Tannhäuser | Dresda |
| 1846 | Ettore Berlioz | La Dannazione di Faust | Parigi |
| 1847 | Federico Flotow | Marta | Vienna |
| 1849 | Otto Nicolai | Le vispe comari di Windsor | Berlino |
| 1849 | Giacomo Meyerbeer | Il Profeta | Parigi |
| 1849 | Giuseppe Verdi | Luisa Miller | Napoli |
| 1850 | Luigi e Federico Ricci | Crispino e la Comare | Venezia |
| 1850 | Riccardo Wagner | Lohengrin | Weimar |
| 1851 | Giuseppe Verdi | Rigoletto | Venezia |
| 1853 | Adolfo Adam | Si j'étais rois | Parigi |
| 1853 | Giuseppe Verdi | Il Trovatore | Roma |
| 1853 | Giuseppe Verdi | La Traviata | Venezia |
| 1855 | Giuseppe Verdi | I Vespri Siciliani | Parigi |
| 1856 | Carlo Pedrotti | Tutti in maschera | Verona |
| 1858 | Errico Petrella | Jone | Milano |
| 1858 | Pietro Comelius | Il Barbiere di Bagdad | Weimar |
| 1859 | Giuseppe Verdi | Un ballo in maschera | Roma |
| 1859 | Carlo Gounod | Faust | Parigi |
| 1863 | Giorgio Bizet | I pescatori di perle | Parigi |
| 1865 | Giuseppe Verdi | Macbeth | Parigi (2a ediz.- [1a ediz. Firenze 1847]) |
| 1865 | Giacomo Meyerbeer | L'Africana | Parigi (esecuz. post.) |
| 1865 | Riccardo Wagner | Tristano e Isotta | Monaco di Baviera |
| 1866 | Federico Smetana | La sposa venduta | Praga |
| 1866 | Ambrogio Thomas | Mignon | Parigi |
| 1867 | Giuseppe Verdi | Don Carlo | Parigi |
| 1868 | Emilio Usiglio | Le educande di Sorrento | Firenze |
| 1868 | Riccardo Wagner | I Maestri Cantori di Norimberga | Monaco di Baviera |
| 1869 | Giuseppe Verdi | La forza del Destino | Milano (2a ediz.- [1a ediz. Pietroburgo 1862]) |
| 1869 | Filippo Marchetti | Ruy Blas | Milano |
| 1870 | Cario Gomes | Guarany | Milano |
| 1871 | Giuseppe Verdi | Aida | Cairo |
| 1874 | Modesto Mussorgski | Borif Godunoff | Pietroburgo |
| 1875 | Giorgio Bizet | Carmen | Parigi |
| 1875 | Carlo Goldmark | La Regina di Saba | Vienna |
| 1875 | Arrigo Boito | Mefistofele | Bologna (2a ed. - [1a ediz. Milano 1868]) |
| 1876 | Amilcare Ponchielli | La Gioconda | Milano |
| 1876 | Riccardo Wagner | L'Anello del Nibelungo; L'Oro del Reno; La Walkiria; Sigfrido; Il Crepuscolo degli Dei | Beyreuth |
| 1877 | Camillo Saint-Saëns | Sansone e Dalila | Weimar |
| 1880 | Amilcare Ponchielli | Il figliuol prodigo | Milano |
| 1881 | Pietro Ciaicowski | Eugenio Oneghin | Mosca (1a esecuzione in forma privata: Mosca 1879) |
| 1881 | Giacomo Offenbach | I racconti di Hoffmann | Parigi (esecuz. postuma) |
| 1881 | Giuseppe Verdi | Simon Boccanegra | Milano (2a ed. - [1a ed. Venezia 1857]) |
| 1882 | Riccardo Wagner | Parsifal | Bayreuth |
| 1883 | Leo Délibes | Lakmé | Parigi |
| 1884 | Giulio Massenet. | Manon | Parigi |
| 1884 | Luigi Reyer | Sigurd | Bruxelles |
| 1886 | Modesto Mussorgski | Kovàncina | Pietroburgo (esecuz. post.) |
| 1887 | Giuseppe Verdi | Otello | Milano |
| 1888 | Alberto Franchetti | Asrael | Reggio Emilia |
| 1890 | Alfredo Catalani | Lorely | Milano |
| 1890 | Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana | Roma |
| 1890 | Pietro Ciaicowski | La dama di picche | Pietroburgo |
| 1890 | Alessandro Borodine | Il principe Igor | Pietroburgo (esecuz. post.) |
| 1891 | Pietro Mascagni | L'Amico Fritz | Roma |
| 1892 | Alfredo Catalani | La Wally | Milano |
| 189% | Giulio Massenet | Werther | Vienna |
| 1892 | Ruggero Leoncavallo | Pagliacci | Milano |
| 1892 | Alberto Franchetti | Cristoforo Colombo | Genova |
| 1892 | Pietro Ciaicowski | Yolantha | Pietroburgo |
| 1893 | Giacomo Puccini | Manon Lescaut | Torino |
| 1893 | Giuseppe Verdi | Falstaff | Milano |
| 1893 | Engelberto Humperdinck | Hänsel e Gretel | Weimar |
| 1894 | Giulio Massenet | Thaïs | Parigi |
| 1895 | Pietro Mascagni | Guglielmo Ratcliff | Milano |
| 1895 | Antonio Srnareglia | Nozze istriane | Trieste |
| 1896 | Giacomo Puccini | La Bohème | Torino |
| 1896 | Umberto Giordano | Andrea Chénier | Milano |
| 1897 | Vincenzo D'Indy | Fervaal | Bruxelles |
| 1897 | Nicola Rimski-Korsakoff | Sadko | Mosca |
| 1898 | Pietro Mascagni | Iris | Roma |
| 1898 | Francesco Cilèa | L'Arlesiana | Milano (2a ed. - [1a ed. Milano 1897]) |
| 1898 | Umberto Giordano | Fedora | Milano |
| 1899 | Giulio Massenet | Cendrillon | Parigi |
| 1900 | Giacomo Puccini | Tosca | Roma |
| 1900 | Gustavo Charpentier | Louise | Parigi |
| 1900 | Nicola Rimski-Korsakoff | Czar Saltan | Mosca |
| 1901 | Pietro Mascagni | Le Maschere | Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Verona, simultan.; a Napoli, due giorni dopo. |
| 1902 | Antonio Smareglia | Oceàna | Milano |
| 1902 | Alberto Franchetti | Germania | Milano |
| 1902 | Claudio Debussy | Pelléas et Mélisande | Parigi |
| 1902 | Francesco Cilèa | Adriana Lecouvreur | Milano |
| 1903 | Ermanno Wolf-Ferrari | Le donne curiose | Monaco di Baviera |
| 1903 | Umberto Giordano | Siberia | Milano |
| 1904 | Giacomo Puccini | Madama Butterfty | Brescia (2a ed. - [1a ed. Milano lo stesso anno]) |
| 1904 | Franco Alfano | Risurrezione | Torino |
| 1904 | Leo Janacek | Jenufa | Brünn |
| 1905 | Pietro Mascagni | Amica | Montecarlo |
| 1905 | Riccardo Strauss | Salomè | Dresda |
| 1906 | Ermanno Wolf-Ferrari | I quattro rusteghi | Monaco di Baviera |
| 1907 | Paolo Dukas | Arianna e Barhableu | Parigi |
| 1907 | Nicola Rimski-Korsakoff | La leggenda della città invisibile di Kitesc | Pietroburgo |
| 1909 | Riccardo Strauss | Elettra | Dresda |
| 1909 | Ermanno Wolf-Ferrari | Il segreto di Susanna | Monaco di Baviera |
| 1910 | Nicola Rimski-Korsakoff | Il gallo d'oro | Mosca |
| 1910 | Emesto Bloch | Macbeth | Parigi |
| 1910 | Giacomo Puccini | La fanciulla del West | Nuova York |
| 1911 | Riccardo Strauss | Il cavaliere della rosa | Dresda |
| 1911 | Pietro Mascagni | Isabeau | Buenos Aires |
| 1911 | Riccardo Zandonai | Conchita | Milano |
| 1913 | Manuel De Falla | La vida breve | Nizza |
| 1913 | Italo Montemezzi | L'amore dei tre Re | Milano |
| 1913 | Pietro Mascagni | Parisina | Milano |
| 1914 | Riccardo Zandonai | Francesca da Rimini | Torino |
| 1914 | Igor Strawinski | Usignolo | Parigi |
| 1915 | Alberto Franchetti | Notte di Leggenda | Milano |
| 1915 | Ildebrando Pizzetti | Fedra | Milano |
| 1917 | Pietro Mascagni | Lodoletta | Roma |
| 1917 | Ferruccio Busoni | Turandot | Zurigo |
| 1917 | Ferruccio Busoni | Arlecchino | Zurigo |
| 1918 | Giacomo Puccini | Trittico: Il tabarro - Suor Angelica - Gianni Schicchi | Nuova York |
| 1920 | Gian Francesco Malipiero | Sette Canzoni | Parigi |
| 1921 | Pietro Mascagni | Il piccolo Marat | Roma |
| 1921 | Franco Alfano | La leggenda di Sakuntala | Bologna |
| 1921 | Sergio ProkofiefF | L'amore delle tre melarance | Chicago |
| 1922 | Adriano Lualdi | La figlia del Re | Torino |
| 1922 | Igor Strawinski | Mavra | Parigi |
| 1922 | Ildebrando Pizzetti | Dèbora e Jaéle | Milano |
| 1923 | Manuel De Falla | El retablo de Maese Pedro | Parigi |
| 1924 | Arrigo Boito | Nerone | Milano (esecuz. postuma) |
| 1924 | Carlo Jachino | Giocondo e il suo Re | Milano |
| 1924 | Igino Robbiani | Anna Karenina | Roma |
| 1925 | Riccardo Zandonai | I cavalieri d'Ekebù | Milano |
| 1925 | Arturo Honegger | Giuditta | Parigi |
| 1925 | Maurizio Ravel | L'enfant et les sortilèges | Montecarlo |
| 1925 | Adriano Lualdi | Il diavolo nel campanile | Milano |
| 1925 | Ferruccio Busoni | Il Dottor Faust | Dresda (esecuz. postuma) |
| 1925 | Alban Berg | Wozzeck | Berlino |
| 1926 | Giacomo Puccini | Turandot | Milano (esecuz. postuma) |
| 1926 | Arrigo Pedrollo | Delitto e castigo | Milano |
| 1927 | Dario Milhaud | Le pauvre matelot | Parigi |
| 1928 | Giuseppe Mulè | Dafni | Roma |
| 1928 | Ildebrando Pizzetti | Fra Gherardo | Milano |
| 1929 | Franco Casavola | Il gobbo del Califfo | Roma |
| 1930 | Ildebrando Pizzetti | Lo straniero | Roma |
| 1932 | Gino Marinuzzi | Palla de' Mozzi | Milano |
| 1932 | Alfredo Casella | La donna serpente | Roma |
| 1933 | Ildebrando Pizzetti | Orsèolo | Firenze |
| 1934 | Ottorino Respighi | La Fiamma | Roma |
| 1934 | Lodovico Rocca | Dibuk | Milano |
| 1935 | Pietro Mascagni | Nerone | Milano |
| 1935 | Giuseppe Mulè | Liolà | Napoli |
| 1936 | Ermanno Wolf-Ferrari | Il campiello | Milano |
| 1937 | Carlo Orff | Carmina Burana | Francoforte |
| 1937 | Giorgio Federico Ghedini | Maria d'Alessandria | Bergamo |
| 1938 | Giovanni Francesco Malipiero | Antonio e Cleopatra | Firenze |
| 1938 | Paolo Hindemith | Mathis der Maler | Zurigo |
| 1939 | Vito Frazzi | Re Lear | Firenze |
| 1940 | Luigi Ferrari Trecate | Ghirlino | Milano |
| 1940 | Lodovico Rocca | Monte Ivnor | Roma |
| 1941 | Giovanni Francesco Malipiero | Ecuba | Roma |
| 1945 | Benjamin Britten | Peter Grimes | Londra |
| 1947 | Ildebrando Pizzetti | L'oro | Milano |
| 1948 | Giorgio Federico Ghedini | Le Baccanti | Milano |
| 1949 | Ildebrando Pizzetti | Vanna Lupa | Firenze |
| 1950 | Giovanni Francesco Malipiero | L'allegra brigata | Milano |
| 1950 | Gian Carlo Menotti | Il Console | New York |
| 1951 | Gian Carlo Menotti | Amahl | New York |
| 1951 | Juan José Castro | Proserpina e lo straniera | Milano |
| 1951 | Igor Strawinski | La carriera del libertino | Venezia |
| 1952 | Lodovico Rocca | L'Uragano | Milano |
| 1952 | Vito Frazzi | Don Chisciotte | Firenze |
| 1952 | Riccardo Strauss | L'amore di Danae | Salisburgo (esecuz. postuma) |
[Torna all'indice]
Note
[1] Per schiarimenti intorno ai termini tecnici rimando all'altro mio volume Invito alla musica, del quale il presente è complementare.
[2] Madrigale era una forma polifonica cinquecentesca di genere amoroso, il cui stile fu volto poi dagli autori sopra nominati ad espressioni comiche. Le villote erano canzoni popolari, anch'esse a più voci, di carattere più schiettamente gaio o burlesco.
[3] Rimando per una più ampia conoscenza al volume di G. F. Malipiero: I Profeti di Babilonia, Milano, Bottega di Poesia, 1924.
[4] La cosiddetta scala esafonica, costituita da sei note a intervalli di un tono intero l'una dall'altra (es.: do, rè, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis).
[5] Purtroppo le traduzioni italiane delle opere di Wagner sarebbero quasi tutte da rifare perchè infelicissime, e spesso infedeli.