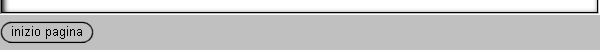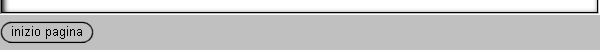|
Nota ai testi
 Contrariamente
alle abitudini di Marx, che ne fu, com’è noto, l’unico
estensore materiale, il Manifest der Kommunistischen Partei
venne scritto in un lasso di tempo sorprendentemente breve. Dal 9
dicembre 1847 – giorno di chiusura del secondo congresso della
Lega dei comunisti, ove Marx ed Engels ricevettero l’incarico di
redigere l’opera – al primo febbraio 1848 – giorno
perentoriamente stabilito dalla Lega per la consegna del lavoro
– trascorse circa un mese e mezzo, nel corso del quale Marx non
smise comunque di tenere lezioni, organizzare riunioni, rinsaldare
i contatti con rivoluzionari di varie parti d’Europa. Ferme
restando le indubbie doti intellettuali e stilistiche marxiane, è
probabile che tale celerità possa essere spiegata dal poter
contare su diversi documenti messi a disposizione dal Comitato
centrale della Lega, su proprie precedenti elaborazioni teoriche,
su alcuni scritti di Engels (in particolare sui Grundsätze des
Kommunismus, quei Princìpi del comunismo scritti e
più volte rielaborati a partire dal giugno 1847), e soprattutto
sull’aver discusso il piano dell’opera con Engels, il quale
riteneva che «bisogna più o meno narrare la storia»
abbandonando la forma di catechismo da lui conferita ai Grundsätze,
e proponeva il titolo che poi sarebbe stato effettivamente scelto. Contrariamente
alle abitudini di Marx, che ne fu, com’è noto, l’unico
estensore materiale, il Manifest der Kommunistischen Partei
venne scritto in un lasso di tempo sorprendentemente breve. Dal 9
dicembre 1847 – giorno di chiusura del secondo congresso della
Lega dei comunisti, ove Marx ed Engels ricevettero l’incarico di
redigere l’opera – al primo febbraio 1848 – giorno
perentoriamente stabilito dalla Lega per la consegna del lavoro
– trascorse circa un mese e mezzo, nel corso del quale Marx non
smise comunque di tenere lezioni, organizzare riunioni, rinsaldare
i contatti con rivoluzionari di varie parti d’Europa. Ferme
restando le indubbie doti intellettuali e stilistiche marxiane, è
probabile che tale celerità possa essere spiegata dal poter
contare su diversi documenti messi a disposizione dal Comitato
centrale della Lega, su proprie precedenti elaborazioni teoriche,
su alcuni scritti di Engels (in particolare sui Grundsätze des
Kommunismus, quei Princìpi del comunismo scritti e
più volte rielaborati a partire dal giugno 1847), e soprattutto
sull’aver discusso il piano dell’opera con Engels, il quale
riteneva che «bisogna più o meno narrare la storia»
abbandonando la forma di catechismo da lui conferita ai Grundsätze,
e proponeva il titolo che poi sarebbe stato effettivamente scelto.
Ad ogni modo, il manoscritto del Manifesto non si è
conservato. Spedito da Bruxelles – dove Marx risiedeva – a
Londra, il testo fu composto con i caratteri gotici che la Lega
aveva comprato in Germania utilizzando parte di una colletta di 25
lire sterline, e – non avendo la Lega una tipografia – venne
stampato nella tipografia di J. E. Burghard, membro dell’Associazione
educativa degli operai tedeschi (Bildungs-Gesellschaft für
Arbeiter) fondata nel 1840 dalla Lega dei Giusti e – a
carattere non segreto, contrariamente alla Lega – veicolo di
arruolamento per la Lega dei Giusti stessa e poi per quella dei
comunisti. Pertanto, la dicitura nel frontespizio che indica l’Associazione
come sede della tipografia è da considerarsi errata, come si
evince anche dal fatto che l’indirizzo citato è quello della
tipografia di Burghard.
Privo del nome dei due autori, il Manifesto venne
stampato nella seconda metà di febbraio 1848 in mille esemplari
di 23 pagine destinati inizialmente non alla vendita, bensì alla
propaganda interna. Le esigenze di quest’ultima, alimentate
dallo scoppio delle rivoluzioni in Europa, e l’avvertita
utilità di una diffusione pubblica, imposero tre ristampe nel
mese di marzo e un’uscita del testo sulla "Deutsche
Londoner Zeitung" (dal 3 marzo al 28 luglio 1848), nonché
una seconda edizione di 30 pagine, apparsa tra aprile e maggio, a
opera dello stesso stampatore della prima, nella quale si
correggevano alcuni refusi e veniva migliorata la punteggiatura.
È il testo di tale seconda edizione – base delle successive
ristampe ed edizioni – che viene qui tradotto e riprodotto,
previo un confronto con il testo presente nel vol. 6 della Marx-Engels
Historisch-kritische Gesamtausgabe (MEGA),
Marx-Engels-Institut Moskau, Moskau-Leningrad 1933, pp. 525-57, e
nel vol. 4 dei Marx-Engels Werke (MEW), Dietz Verlag,
Berlin 1959, pp. 459-93.
Un’ulteriore edizione si ebbe nel 1872, in cui il titolo
veniva mutato in Das Kommunistische Manifest e il testo
preceduto da una prefazione dei due autori; morto Marx, altre due
edizioni (1883 e 1890) vennero prefate dal solo Engels. Tali
prefazioni sono riportate in traduzione nel presente volume, con l’eccezione
di quella del 1890 (alla quale si è preferita la prefazione all’edizione
inglese del 1888, ripresa pressoché in toto nel 1890) e l’aggiunta
della prefazione scritta da Engels appositamente per l’edizione
italiana del 1893 (cfr. infra). La prefazione di Marx ed
Engels all’edizione russa del 1882 e quella di Engels all’edizione
polacca del 1892 – che non presentano sostanziali novità
rispetto alle altre – non sono qui tradotte.
Nonostante quanto affermato alla fine del preambolo del Manifesto,
l’Italia non doveva vedere una traduzione se non con un ritardo
di quarantun’anni. Ciò non significa che l’opera fosse ignota
al pubblico italiano: a partire perlomeno dal 1874, suoi brani
furono oggetto di citazioni più o meno lunghe, di epigrafi, di
una serrata discussione in un corso universitario (quello tenuto
da Antonio Labriola nel 1892-93, sfociato nel suo celebre scritto In
memoria del Manifesto dei Comunisti pubblicato nel 1895, prima
in francese e poi in italiano). Una traduzione fu eseguita nel
1885 da Pasquale Martignetti, ma non venne pubblicata per mancanza
di soldi.
Finalmente, nel 1889, quella che è a tutti gli effetti la
prima traduzione italiana apparve in appendice dal numero 35 del
30-31 agosto al numero 44 del 3-4 novembre su "L’eco del
popolo", un foglio settimanale diretto a Cremona da Leonida
Bissolati. Nell’editoriale di presentazione ci si riferisce all’opera
una volta come Manifesto dei Comunisti, un’altra come Manifesto
dei Socialisti, e si indica il 1847 come anno di redazione.
Non viene fatta alcuna menzione del traduttore, ma diversi
studiosi convergono nell’individuarlo nello stesso Bissolati. La
traduzione è piuttosto infedele al testo originale: manca il
preambolo, alcuni brani dei primi due capitoli vengono riassunti o
omessi (anche in mancanza dei classici puntini di sospensione, che
ricorrono giusto un paio di volte), il terzo capitolo viene
saltato, e del quarto viene dato soltanto l’ultimo capoverso.
Tuttavia, malgrado la sua imperfezione filologica, tale
traduzione conserva un proprio valore intrinseco, posta com’è
all’origine della diffusione italiana del testo fondamentale
della dottrina comunista. Con sporadici miglioramenti nella
punteggiatura e l’eliminazione di qualche refuso, la riprendiamo
nel presente volume, che viene così a contenere la prima e, al
momento, l’ultima traduzione italiana del Manifesto.
Dopo un’ulteriore traduzione – lacunosa e all’epoca
piuttosto criticata – eseguita da Pietro Gori per i tipi dell’editore
Flaminio Fantuzzi nel 1891, l’anno successivo apparve a puntate
sul periodico milanese "Lotta di classe" la prima
traduzione italiana corretta, opera del poeta Pompeo Bettini, che
si poté giovare della revisione di Anna Kuliscioff e Filippo
Turati. Nell’impossibilità di fare fronte alle ripetute
richieste di copie, il testo venne pubblicato in brossura nel
1893, preceduto dalle prefazioni del
1872, 1883, e 1890, nonché da una nuova prefazione espressamente
chiesta a Engels da Turati, il quale – oltre a tradurla insieme
alle altre – la intitolò "Al lettore italiano".
Per quanto sopra, si vedano: F. Cagnetta, «Le traduzioni
italiane del "Manifesto del Partito comunista"», in Il
1848. Raccolta di saggi e testimonianze, a cura di G.
Manacorda, "Quaderni di Rinascita", n. 1, Roma 1848,
pp. 21-30; G. Bosio, «La diffusione degli scritti di Marx e di
Engels in Italia dal 1871 al 1892», in Società, vii
(1951), pp. 268-84 e 444-77; Die Erstdrucke der Werke von
Marx und Engels, Dietz Verlag, Berlin 1955; M. Rubel, Bibliographie
des œuvres de Karl Marx avec en appendice un répertoire des œuvres
de Friedrich Engels, Rivière, Paris 1956; Marx e Engels
in lingua italiana: 1848-1960, a cura di G. M. Bravo,
Edizioni Avanti!, Milano 1962; B. Andréas, Le Manifeste
Communiste de Marx et Engels: Histoire et Bibliographie
1848-1918, Feltrinelli, Milano 1963; D. McLellan, Karl
Marx: His Life and Thought, Macmillan, London 1973, trad.
it. Rizzoli, Milano 1976.
continua...

|